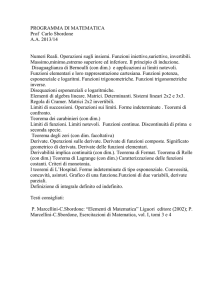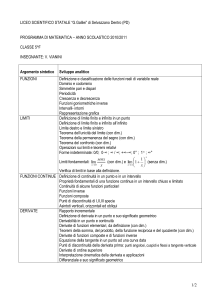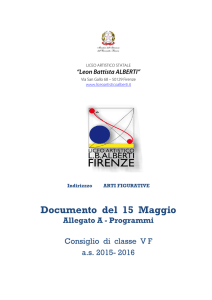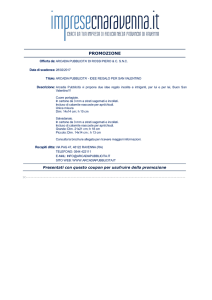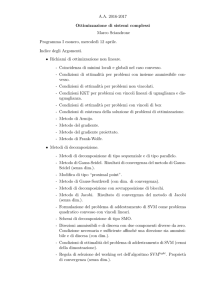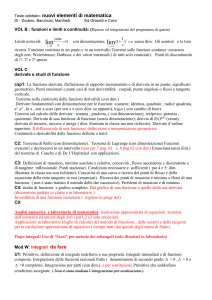LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
-
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DPR 23.07.98 n. 223 art. 5
Anno Scolastico 2013 -2014
Classe V sez. D
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Dirigente scolastico Prof.ssa M. Grazia Faganello
Presidente
Prof.ssa Alessandra Martello
Lingua Inglese
Coordinatore
Prof.ssa Maria Rosa Fontolan
Matematica
Prof. Maurizio Miante
Disegno e Storia dell'arte
Prof.ssa Elisa Depiccoli
Segretario
Storia e Filosofia
Prof. Paolo Vecchione
Italiano e Latino
Prof.ssa Paola Goldin
Fisica
Prof. ssa Tiziana Maneo
Geografia generale
Prof.ssa Giovanna Celio
Educazione fisica
Prof. Oscar Mason
I.R.C.
Via A. De Gasperi 19, 45100 Rovigo - Tel.: 0425410833 – Fax: 0425410835
Pagina 1 di 54
e-mail: [email protected] web: www.liceopaleocapa.it - c.f. 80008180293
SOMMARIO
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Pagina
3
OBIETTIVI
Pagina
4
CONTENUTI
Pagina
5
STRUMENTI, METODOLOGIA, RISORSE
Pagina
5
VERIFICA E VALUTAZIONE
Pagina
7
LA PREPARAZIONE PER L'ESAME DI STATO
Pagina
16
ALLEGATI - A
Pagina
23
Pagina 2 di 54
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione della classe al termine del percorso liceale
numero alunni: 26, di cui 11 maschi e15 femmine, provenienti dalla classe IV D
provenienza geografica: 13 alunni sono residenti nel comune di Rovigo, 13 in comuni limitrofi delle
province di Rovigo e Padova
attività extrascolastiche: 7 studenti praticano attività sportive a livello agonistico - calcio, nuoto e
pallavolo
Continuità didattica
mat.
a. s.
2009/10
2010/11
italiano
latino
inglese
2013/14
storia e
filosofia
IRC
biologia
chimica
geogra. Geograf.
gen.
Ed.fisica
A.Andreotti G. Celio
disegno e
storia
dell'arte
M.C. Pavani
P. Vecchione
A.Martello
A. Giuliani
G.Gasperini O. Mason
M.C. Pavani
R. Beccari
A.Martello
A.Giuliani
R. Valentini
O.Mason
M. Melato
G.Celio
G.Stroppa
P. Vecchione
R. Beccari
A.Martello
E. Camattari
S. Patisso
E.Depiccoli
O.Mason
T. Maneo
G.Celio
G.Stroppa
P. Vecchione
R. Beccari
A.Martello
M.R. Fontolan
P. Goldin
E.Depiccoli
O.Mason
T. Maneo
G.Celio
M. Miante
P. Vecchione
P. Vecchione
A.Martello
M.R. Fontolan
P. Goldin
E.Depiccol
O.Mason
T. Maneo
G.Celio
M. Miante
2011/12
2012/13
mat. e fisica
storia
G.Stroppa
Descrizione della classe
Nel complesso la classe ha dimostrato disponibiltà al dialogo educativo ed un adeguato interesse per gli
argomenti proposti. Per quanto riguarda il comportamento, il C.d.C. più volte ha invitato gli studenti ad una
frequenza più regolare e al rispetto degli orari. L’impegno nello studio è stato proficuo per una parte della
classe. In media gli studenti hanno raggiunto una conoscenza degli argomenti trattati discreta, in alcuni casi
buona e ottima. Le situazioni di fragilità sono circoscritte ad alcuni studenti in alcune discipline. Le valutazioni
nelle diverse discipline oscillano tra sufficiente e ottimo.
All’interno della classe si possono individuare 3 fasce relativamente al livello di conoscenze, competenze e
abilità acquisite:
I fascia:
In un gruppo di ragazzi è presente una buona motivazione che li ha portati, negli anni, a raggiungere una
preparazione personale qualificata in tutte le aree disciplinari, ad acquisire valide competenze conoscitive e
buone abilità di rielaborazione critica.
II fascia:
Un gruppo di alunni ha conseguito risultati più che sufficienti o discreti: i livelli minimi sono stati sicuramente
raggiunti e gli alunni hanno dimostrato di saper lavorare in modo efficace e produttivo, anche se in alcuni casi
l’impegno non è stato sempre costante.
III fascia:
Alcuni alunni presentano difficoltà in alcune discipline; le situazioni di fragilità nel quadro scolastico, per alcuni
studenti sono dovute ad un impegno superficiale e ad uno studio discontinuo ed essenzialmente finalizzato
alle verifiche, per altri, a difficoltà ad organizzare le proprie conoscenze.
Pagina 3 di 54
2. OBIETTIVI
Obiettivi generali
Obiettivi educativi e affettivosociali
La classe ha raggiunto ad un livello mediamente discreto gli obiettivi generali che il C.d.C, ha fissato nella
programmazione annuale di inizio a.s.:
Abitudine all'ascolto, al rispetto dell’interlocutore e delle regole del discorso.
Rispetto delle regole, tramite l’assunzione di un atteggiamento coerente, educato all’abitudine di
compiere scelte consapevoli, orientate in base a valori criticamente assunti.
Rispetto dell'ambiente e riconoscimento del suo valore e della sua importanza come risorsa.
Abitudine alla partecipazione attiva nei vari momenti della vita scolastica, tramite il dialogo
interpersonale.
Miglioramento dell’attenzione e della produttività durante le ore di lezione, tramite l’autodisciplina, il
senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione
Consolidamento dell’interesse per tutte le discipline di studio e sviluppo di interessi culturali ampi e
diversificati.
Obiettivi cognitivi
Ciascuno studente della classe, inoltre, a vari livelli:
ha potenziato il metodo di lavoro
ha seguito con attenzione il lavoro svolto in classe (ascoltare la lezione, prendere appunti, svolgere
esercizi)
sa pianificare il lavoro domestico
è in grado di collegare le informazioni, visualizzandole in schemi/mappe/schede
risponde alla richiesta di applicazione di un metodo di lavoro funzionale ad un apprendimento non
mnemonico e meccanico
è capace di svolgere ricerca in modo autonomo
ha potenziato le abilità di laboratorio
ha sviluppato capacità logiche
ha potenziato le abilità di analisi e di sintesi
è in grado di cogliere analogie, differenze, correlazioni
sa applicare regole e principi
è capace di astrarre contenuti; riflettere, esprimere un'opinione/un giudizio sulla base di un
ragionamento e applicando metodo di indagine
ha sviluppato capacità comunicative
sa comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale, in modo chiaro, ordinato e coerente
ha fatto propria la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina
utilizza il registro formale e dei linguaggi specifici nell'esposizione degli argomenti di studio
un gruppo di alunni ha acquisito capacità critico-argomentativa
ha acquisito conoscenze
dei termini e dei simboli indispensabili e specifici di ogni disciplina
dei contenuti delle singole discipline.
Obiettivi disciplinari e pluridisciplinari
Conoscenze
La classe, a vari livelli, conosce:
in ambito disciplinare: si rinvia alle relazioni delle singole discipline, costituenti parte integrante del
presente documento.
in ambito pluridisciplinare: i contenuti illustrati più oltre, nella sezione dedicata alla preparazione per
l'esame di Stato.
Abilità
Pagina 4 di 54
La classe, a vari livelli, è in grado di:
leggere, analizzare e studiare messaggi, testi, contesti, fenomeni, leggi;
sintetizzare ed esporre (in forma orale / in forma scritta) le conoscenze acquisite;
comprendere le consegne per un lavoro orale / per un lavoro scritto;
affrontare argomenti operando, in modo guidato, confronti, intersezioni e articolazioni interdisciplinari
Competenze
La classe, a vari livelli, è in grado di:
elaborare e gestire un percorso di approfondimento su un tema generale;
utilizzare le conoscenze e le abilità;
esporre una riflessione, partecipare a una discussione (su: concetti, tesi, punti di vista);
esprimere giudizi sostenuti da argomentazioni.
3. CONTENUTI
Contenuti
in ambito disciplinare: si rinvia alle allegate relazioni disciplinari dei singoli docenti (allegato A).
in ambito pluridisciplinare: si rinvia al punto 6 del documento (La preparazione per l'Esame di Stato).
4. STRUMENTI, METODOLOGIA, RISORSE
Lezione
lezione frontale, lezione “laboratorio”, lezione dialogata.
metodologia generalmente applicata:
l’insegnante ha inviato gli “stimoli” (conoscenze, informazioni e istruzioni di lavoro) e ha cercato di
motivare gli alunni (lezione frontale);
l’insegnante ha guidato la lettura di testi e/o l’analisi di fenomeni, ha orientato la ricerca e la
produzione (lezione laboratorio), ha sollecitato gli interventi e la proposta di ipotesi o soluzioni dei
problemi esaminati (lezione interattiva).
Risorse utilizzate
Libri di testo, dizionari
Appunti di lezioni, dispense fornite dall’insegnante
Quotidiani, settimanali, riviste in lingua
Biblioteca d’Istituto
Proiettore in classe
Laboratorio di Informatica e Scienze
Laboratorio di Fisica
Laboratorio linguistico
Aula speciale di Disegno
Impianti sportivi e relative attrezzature
Aula LIM
La risorsa tempo1
1
Il calcolo delle ore effettuate considera le ore di lezione già svolte fino alla stesura del presente documento e
quelle che, in base all'orario previsto, presumibilmente saranno svolte fino al termine delle lezioni.
Pagina 5 di 54
Materie
Italiano
Latino
Matematica
Fisica
Storia
Filosofia
Disegno e Storia dell’arte
Geografia generale
Lingua inglese
Educazione fisica
Religione cattolica
Ore preventivate
132
99
99
99
99
99
66
66
99
66
33
Ore effettuate
123
90
95
92
86
88
63
65
89
54
29
Insegnamenti integrativi facoltativi (organizzati dall’Istituto e frequentati nel corso del V
anno)
corso di Logica Matematica: 20 alunni
Attività di recupero programmate dal C.d.C
sportello di Matematica, all’inizio del secondo quadrimestre, di 5 ore: 7 alunni
Olimpiadi di Matematica e Fisica
Giochi di Archimede ( Novembre 2013 - fase di Istituto): tutta la classe
Olimpiadi di Fisica ( 11 Dicembre 2013 - fase di Istituto):4 alunni
Olimpiadi di Matematica ( Febbraio 2014 - fase provinciale): 1 alunna
Viaggi di istruzione, visite guidate, lezioni fuori sede nel triennio
classe III: viaggio di istruzione a Firenze
classe IV: viaggio di istruzione in Slovenia, Croazia, Ungheria
classe V: viaggio di istruzione a Monaco di Baviera, visita alla 55esima Esposizione Internazionale
d’Arte (La Biennale) di Venezia e alla mostra di Palazzo Roverella “Ossessione Nordica”.
Conferenze e rappresentazioni teatrali
Gli alunni hanno partecipato a
Una conferenza organizzata dal Liceo Paleocapa, nell'ambito della “Settimana della cultura scientifica
e tecnologica”: Prof. R. Ragazzoni, Alla ricerca dei nuovi mondi.
Una conferenza di storia “Il contesto politico-sociale italiano alla vigilia della Guerra”, presso
l'Accademia dei Concordi, relatore Prof. Egidio Ivetic
Una rappresentazione del Teatro del Lemming, dal titolo “Giulietta e Romeo” (tutta la classe)
Una lezione su “Jung: Tra Freud e Nietzche”, presso Aula LIM, relatore Dott.ssa E. Canato
Una conferenza per la presentazione del lavoro “Obliquo Rumore” realizzato dalla classe 4 A/lsa
in Auditorium
Pagina 6 di 54
Stages e corsi
Stages estivo presso il Museo dei Grandi Fiumi: (un' alunna)
Stage estivo di matematica presso l’Università di Ferrara (2 alunni)
Attività di tutor all'interno del Progetto Accoglienza classi prime (3 alunni)
Partecipazione all'iniziativa sul tema del volontariato: (2 alunne)
Partecipazione al progetto Teatro del Liceo Paleocapa (7 alunni)
Partecipazione pomeridiana da parte di 6 alunni al Progetto Teatro Ragazzi del Teatro Sociale di
Rovigo, con l’opera “Tosca”
Partecipazione all’incontro a Roma tra la scuola e Papa Francesco (12 alunni)
Orientamento universitario
Corso di Chimica organica, in preparazione al test di ingresso alla Facoltà di Medicina di Padova: 5
alunni
Orientamento presso Job Orienta di Verona (tutta la classe)
Test di ammissione al corso di laurea in Ingegneria dell'Università di Ferrara : 6 alunni
Test di ammissione al corso di laurea in Ingegneria dell'Università di Padova : 2 alunni
Test di ammissione al corso di laurea in Medicina: 4 alunni
Test di ammissione al corso di laurea in Architettura: 2 alunni
Test di ammissione al corso di laurea in Lingue orientali : un’ alunna
Test di ammissione al corso di laurea in Giurisprudenza: un alunno
Test di ammissione all’Accademia Aeronautica : un alunno
Test di ammissione al corso sottoufficiali della Guardia di Finanza: un’alunna
5. VERIFICA E VALUTAZIONE
Valutazione formativa: volta ad accertare i processi realizzati e per saggiare il grado di apprendimento
degli alunni
Valutazione sommativa: somministrata al termine di un segmento significativo del percorso didattico,
per accertare i livelli raggiunti
Forme di accertamento
prove scritte tradizionali
prove scritte di Matematica sul modello delle prove di esame di Stato degli anni precedenti
prove scritte di Italiano impostate secondo le tipologie previste dalla prima prova scritta dell'esame (A
analisi di un testo letterario di poesia e di prosa e non letterario; B saggio breve secondo gli ambiti
previsti; C trattazione di un tema storico; D trattazione di un tema a carattere generale)
prove scritte di latino: traduzioni dal latino di passi d’autore con quesiti di comprensione a livello
sintattico e tematico; testi d’autore con traduzione in italiano, accompagnati da quesiti di analisi del
testo, comprensione e approfondimenti relativi alla storia della letteratura; una verifica nell’ambito della
simulazione della terza prova scritta dell’Esame di Stato, secondo la tipologia A.
prove scritte di Storia dell'Arte sul modello della III prova dell'esame di Stato
prove scritte di Scienze sul modello della III prova dell'esame di Stato
prove scritte d’Inglese secondo la tipologia A (trattazione sintetica di argomenti) prevista dalla III prova
scritta dell’esame di Stato
colloqui orali.
Simulazioni della prima e della seconda prova dell'Esame di Stato
il giorno 13 maggio è stata effettuata una simulazione della prima prova di esame, Italiano, 4 ore
Pagina 7 di 54
il giorno 26 maggio sarà effettuata una simulazione della seconda prova di esame, Matematica,
4 ore
Simulazione di terza prova dell' Esame di Stato
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova scritta su 4 discipline; la tipologia scelta è la A e sono
state assegnate 25 righe (max.) per la risposta di ogni disciplina; la durata della prova è stata di 3 ore; le
prove sono state effettuate nei giorni:
6 marzo 2014: materie coinvolte storia dell'arte, inglese, filosofia, fisica
28 aprile 2014: materie coinvolte latino, inglese, storia, geografia generale
Griglie di valutazione
Durante l’a.s. sono state utilizzate griglie di valutazione per le prove scritte di Italiano e per le simulazioni di II
e III prova d'esame.
Il C.d.C. ha elaborato e propone alla Commissione griglie di valutazione per tutte le prove, inclusa quella per
il colloquio. Le proposte delle varie griglie sono di seguito riportate.
Utilizzo delle simulazioni
A discrezione dei singoli docenti delle discipline coinvolte nelle prove di simulazione, la valutazione in
quindicesimi, opportunamente convertita in decimi, è stata considerata risultato di prova di verifica
sommativa e registrata sul registro personale del docente.
Pagina 8 di 54
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROPOSTA PER LA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO)
TIPOLOGIA A
DESCRITTORI
INDICATORI
.../10
Conoscenze
Argomento trattato.
Quadro di riferimento
generale.
Background culturale
personale
.../15
Voto
5
Corrette, ampie ed approfondite
3,5
5
........
4
Corrette e discretamente complete
2,5
4
........
3
Sufficientemente corrette ed accettabili
2
3
........
2
Non sempre corrette e lacunose
1,25
2
........
1
Molto scarse
0,5
1
........
Competenze
sviluppo critico.
Capacità
comunicative.
Capacità persuasive.
Capacità
ermeneutiche.
5
Buona capacità di individuazione dei contenuti, rielaborazione personale, valutazione
critica
4
6
........
3,5
5,5
........
Tipologia A
3
4
Corretta individuazione dei contenuti chiave, discreta capacità di valutazione critica
Sufficiente individuazione dei contenuti, semplice rielaborazione personale
5
3
Decodificazione,
analisi,
approfondimento.
2
1
5
Abilità
uso della lingua:
correttezza,
proprietà,
4
rispondenza del
registro stilistico alla
funzione del testo.
Coerenza con la
3
traccia e costruzione
logica del testo.
Organicità e coerenza.
2
1
........
Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità di rielaborazione personale
Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di rielaborazione personale
2,5
4
........
2
3
........
2,5
4
........
15
2.5
........
1,25
2
........
1,5
........
1
........
Abilità adeguate, sicure e autonome
Abilità discretamente adeguate e sicure
Abilità sufficientemente adeguate e sicure
Abilità insicure, non adeguate alle richieste della prova
Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova
VOTO
ASSEGNATO
Pagina 9 di 54
1
0,5
TIPOLOGIA B
DESCRITTORI
INDICATORI
.../10
Conoscenze
Argomento trattato.
Quadro di riferimento
generale.
Background culturale
personale
5
Corrette, ampie ed approfondite
4
Corrette e discretamente complete
3
2
Non sempre corrette e lacunose
2,5
4
........
1,5
2.5
........
1,25
2
........
1,5
........
0,5
1
........
4
6
........
3,5
5,5
........
1
Molto scarse
Competenze
sviluppo critico.
Capacità
comunicative.
Capacità persuasive.
Capacità
ermeneutiche.
5
Buona capacità di individuazione dei contenuti, rielaborazione personale, valutazione
critica
Tipologia B
3
Corretta individuazione dei contenuti chiave, discreta capacità di valutazione critica
Sufficiente individuazione dei contenuti, semplice rielaborazione personale
5
3
Argomentazione
sintesi, rielaborazione.
2
1
5
Abilità
uso della lingua:
correttezza,
proprietà,
4
rispondenza del
registro stilistico alla
funzione del testo.
Coerenza con la
3
traccia e costruzione
logica del testo.
Organicità e coerenza.
2
Voto
Sufficientemente corrette ed accettabili
1
4
.../15
........
Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità di rielaborazione personale
Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di rielaborazione personale
2,5
4
........
2
3
........
3,5
5
........
2,5
4
Abilità adeguate, sicure e autonome
Abilità discretamente adeguate e sicure
........
Abilità sufficientemente adeguate e sicure
2
3
........
Abilità insicure, non adeguate alle richieste della prova
1,25
2
........
1
Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova
VOTO
ASSEGNATO
Pagina 10 di 54
0,5
1
........
TIPOLOGIA C
DESCRITTORI
INDICATORI
.../10 .../15 Voto
Conoscenze
Argomento trattato.
Quadro di riferimento
generale.
Background culturale
personale
5
Corrette, ampie ed approfondite
4
Corrette e discretamente complete
3
2
Competenze
sviluppo critico.
Capacità
comunicative.
Capacità persuasive.
Capacità
ermeneutiche.
3,5
5,5
3
5
2,5
4
2
3
2,5
4
1,5
2.5
1,25
2
1
1,5
0,5
1
3,5
5
2,5
4
2
3
Non sempre corrette e lacunose
Molto scarse
5
Buona capacità di individuazione dei contenuti, rielaborazione personale, valutazione critica
3
6
Sufficientemente corrette ed accettabili
1
4
4
Corretta individuazione dei contenuti chiave, discreta capacità di valutazione critica
Sufficiente individuazione dei contenuti, semplice rielaborazione personale
Tipologia C
Argomentazione e
valutazione
2
1
5
Abilità
uso della lingua:
correttezza,
proprietà,
4
rispondenza del
registro stilistico alla
funzione del testo.
Coerenza con la
3
traccia e costruzione
logica del testo.
Organicità e coerenza.
Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità di rielaborazione personale
Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di rielaborazione personale
Abilità adeguate, sicure e autonome
Abilità discretamente adeguate e sicure
Abilità sufficientemente adeguate e sicure
2
Abilità insicure, non adeguate alle richieste della prova
1,25
2
1
Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova
0,5
1
VOTO
ASSEGNATO
Pagina 11 di 54
TIPOLOGIA D
DESCRITTORI
INDICATORI
.../10 .../15 Voto
Conoscenze
Argomento trattato.
Quadro di riferimento
generale.
Background culturale
personale
5
Corrette, ampie ed approfondite
4
Corrette e discretamente complete
3
4
6
3,5
5,5
........
........
Sufficientemente corrette ed accettabili
5
........
3
2
Competenze
sviluppo critico.
Capacità
comunicative.
Capacità persuasive.
Capacità
ermeneutiche.
valutazione
Non sempre corrette e lacunose
........
1
Molto scarse
5
Buona capacità di individuazione dei contenuti, rielaborazione personale, valutazione critica
4
Corretta individuazione dei contenuti chiave, discreta capacità di valutazione critica
2,5
4
2
3
........
3,5
5
........
2,5
4
........
3
Sufficiente individuazione dei contenuti, semplice rielaborazione personale
2
3
........
2
Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità di rielaborazione personale
1,25
2
........
Tipologia D
Argomentazione,
elaborazione giudizio
critico
1
5
Abilità
uso della lingua:
correttezza,
proprietà,
4
rispondenza del
registro stilistico alla
funzione del testo.
Coerenza con la
3
traccia e costruzione
logica del testo.
Organicità e coerenza.
2
1
Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di rielaborazione personale
0,5
1
........
2,5
4
........
1,5
2.5
........
1,25
2
........
1
1,5
........
0,5
1
........
Abilità adeguate, sicure e autonome
Abilità discretamente adeguate e sicure
Abilità sufficientemente adeguate e sicure
Abilità insicure, non adeguate alle richieste della prova
Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova
VOTO
ASSEGNATO
Pagina 12 di 54
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROPOSTA PER LA IIa PROVA SCRITTA (MATEMATICA)
SESSIONE D'ESAME 2013
Candidato …………………………………………………………………… Classe 5^ ………..Commissione………
LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
Pagina 13 di 54
_______________________
Rovigo, ……………………
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROPOSTA PER LA IIIa PROVA SCRITTA
Candidato …………………………………………………………………… Classe 5^ ………Commissione………
Discipline della IIIa prova:..................................................................................................................................
INDICATORI
Conoscenze
Abilità
Competenze
DESCRITTORI
15mi
Ampie ed approfondite
5
Esaurienti e corrette
4
Essenziali e nell'insieme corrette
3,5
Lacunose e non sempre corrette
2,5
Molto scarse
1,5
Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente a quanto
richiesto, condotta con proprietà linguistica
Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, discretamente
aderente e pertinente, condotta con proprietà linguistica
Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei dati, sufficientemente
aderente e pertinente
Esposizione disordinata e scorretta dei dati, ma aderente e pertinente a quanto
richiesto
Esposizione disordinata e scorretta dei dati conosciuti, non sempre aderente e
pertinente a quanto richiesto
voto
5
4
3,5
2,5
1,5
Buona capacità di rielaborazione personale e utilizzazione dei contenuti
5
Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi adeguata
4
Corretta esplicitazione dei concetti principali, ma sintesi parzialmente
semplicistica
3
Individuazione parziale dei concetti chiave e non adeguata capacità di sintesi
2,5
Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di sintesi
1,5
VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA .................. / 15
LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
Pagina 14 di 54
_______________________
Rovigo, ……………………
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROPOSTA PER IL COLLOQUIO
Candidato……………………………………………………… Classe 5^ …………Commissione………
INDICATORI
Conoscenze
Abilità
PUNTEGGIO
MASSMO
9 punti
9 punti
PUNTEGGIO
AI
DIVERSI
LIVELLI
1-2
3-4
5
6
7
8
9
1-2
3-4
5
6
7
8
9
1-2
3-4
5
Competenze
9 punti
Prima prova
Discussione
degli
Seconda prova
elaborati
Terza prova
6
7
8
9
0
1
0
1
0
1
DESCRITTORI
- Non conosce gli argomenti
- Conoscenze frammentarie
- Conosce solo parzialmente gli argomenti
- Conosce gli elementi fondamentali delle discipline, con
qualche incertezza
- Conosce gli elementi fondamentali delle discipline
- Conosce gli argomenti in maniera ampia
- Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita
- Espone in modo stentato e scorretto
- Analizza e sintetizza parzialmente
- Espone in maniera imprecisa con qualche difficoltà di analisi
- Espone in modo semplice con lessico tecnico essenziale
- Espone in modo corretto con lessico discretamente curato
- Espone in modo chiaro, corretto e sequenziale e usa un
linguaggio tecnico appropriato
- Sa fare collegamenti in modo autonomo, completo, con buone
capacità di analisi e di sintesi
- Non comprende i problemi e i temi proposti
- Comprende solo parzialmente le tematiche
- Comprende con difficoltà i problemi proposti e li risolve
parzialmente
- Comprende i problemi proposti e li risolve, se
opportunamente
guidato
- Comprende i problemi proposti, li risolve e li contestualizza
- Comprende, risolve e sa rielaborare i problemi proposti
- Comprende e rielabora autonomamente i problemi proposti
- Non sa correggere e/o fornire spiegazioni
- Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire
- Non sa correggere e/o fornire spiegazioni
- Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire
- Non sa correggere e/o fornire spiegazioni
- Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire
VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA:
LA COMMISSIONE
/30
IL PRESIDENTE
______________________ ____________________
_______________________
______________________ ____________________
______________________ ____________________
Pagina 15 di 54
Rovigo, ……………………
6. LA PREPARAZIONE PER L'ESAME DI STATO
La preparazione per le prove scritte
I prova d'esame: ITALIANO
Nel corso del triennio gli alunni sono stati abituati a svolgere le prove di verifica previste dall'esame:
classe III: analisi del testo
classe IV: saggio breve, articolo di giornale, tema di argomento generale, tema storico
classe V: ripasso di tutte le tipologie
Il giorno 13 maggio è stata effettuata una simulazione di prova di esame di 4 ore proposta a tutte le classi
quinte del Liceo.
II prova d'esame: MATEMATICA
Durante l'anno scolastico gli alunni sono stati esercitati su argomenti ricorrenti nelle prove d'esame.
Il giorno 26 maggio sarà effettuata una simulazione di prova di esame di 4 ore proposta a tutte le classi quinte
del Liceo.
III prova d'esame: PROVA PLURIDISCIPLINARE
Gli alunni hanno svolto due prove di verifica pluridisciplinare (simulazione della III prova dell'esame di Stato):
6 marzo 2014: materie coinvolte storia dell'arte, inglese, filosofia, fisica
28 aprile 2014: materie coinvolte latino, inglese, storia, geografia generale
Per le prove di verifica pluridisciplinare è stata utilizzata la tipologia A; sono state assegnate 25 righe (max.)
per la risposta al quesito; la durata della prova è stata di 3 ore.
Di seguito sono riportati i testi delle due simulazioni:
PRIMA SIMULAZIONE
Materia: Storia dell’Arte
Cubismo e Futurismo.
Si confrontino questi due movimenti delle Avanguardie storiche del Novecento.
righe)
(max 25
Materia: Inglese
One of the most interesting aspects of Wide Sargasso Sea, by J. Rhys, is intertexuality.
Discuss this point analyzing similarities and differences between the two works you have
studied.
(Max. 25 lines; monolingual dictionary allowed)
Materia: Filosofia
“Conoscere vuol dire andare “al di là del vero e del falso” giacchè nessun criterio
può essere invocato per preferire “una verità” ad un’altra. Non esiste conoscenza al
di fuori della pluralità dei punti di vista che gli uomini aprono sul mondo” (F. Cioffi)
Commenta questa considerazione relativa alla concezione gnoseologica di F.
Nietzsche. (max 25 righe)
Materia: Fisica
Pagina 16 di 54
Il candidato, dopo aver ricavato la formula della forza di Lorentz giustificando in
modo esauriente tutti i passaggi, tratti il moto di una particella che penetra in un
campo magnetico. (max 25 righe)
SECONDA SIMULAZIONE
Materia: Latino
Esercizio da svolgere: guidato dalla sottostante contestualizzazione, l’alunno proponga, in
un testo di 25 righe , dapprima una traduzione del breve brano latino successivo, poi un suo
commento personale in riferimento sia al brano sia all’opera da cui è tratto, nonché allo stile
e alla filosofia dell’autore.
Contestualizzazione: Seneca, nelle Epistulae ad Lucilium, prende tra l’altro posizione sul
problema della schiavitù, enunciando brevemente quali sono, secondo lui e la sua filosofia, i
veri schiavi ed esortando i padroni a cercare, più che il timore, il rispetto dei servi.
“Servus est”. Sed fortasse liber animo. “Servus est”. Hoc illi nocebit? Ostende
quis non sit: alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, <omnes spei>, omnes
timori. Dabo consularem aniculae servientem, dabo ancillulae divitem, ostendam
nobilissimos iuvenes mancipia pantomimorum: nulla servitus turpior est quam
volontaria. Quare non est quod fastidiosi isti te deterreant quominus servis tuis
hilarem te praestes et non superbe superiorem : colant potius te quam timeant.
Materia: Inglese
Most Victorian novels are based on the presence of sound and respectable
personalities.
Explain the reasons of the ambiguous Jeckyll/Hyde relationship and find out a similar
situation or theme in other novels you studied, pointing out similarities and
differences.
(Max. 25 lines; monolingual dictionary allowed)
Materia: Storia
Delinea il ruolo del re Vittorio Emanuele III e del Gran Consiglio del fascismo nella
caduta del regime, ruolo sul quale hanno posto particolare attenzione gli storici che
hanno definito “imperfetto”il totalitarismo italiano. (max 25 righe)
Materia: Geografia Generale
Dopo aver definito cosa si intende per terremoto, spiega qual è la causa più
frequente di un sisma analizzando il comportamento meccanico delle rocce in
relazione alla teoria del “rimbalzo elastico”, formulata da H.F. Reid nel 1906. (max 25
righe)
Pagina 17 di 54
Per la simulazione della terza prova dell’Esame di Stato
Valutazioni in quindicesimi e corrispondenze in decimi
INDICATORI
Conoscenze
DESCRITTORI
15mi
Ampie ed approfondite
5
Esaurienti e corrette
4
Essenziali e nell'insieme corrette
3,5
Lacunose e non sempre corrette
2,5
Molto scarse
1,5
Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente a quanto
richiesto, condotta con proprietà linguistica
Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, discretamente
aderente e pertinente, condotta con proprietà linguistica
Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei dati, sufficientemente
aderente e pertinente
Esposizione disordinata e scorretta dei dati, ma aderente e pertinente a quanto
richiesto
Esposizione disordinata e scorretta dei dati conosciuti, non sempre aderente e
pertinente a quanto richiesto
Abilità
Competenze
voto
5
4
3,5
2,5
1,5
Buona capacità di rielaborazione personale dei contenuti
5
Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi adeguata
4
Corretta esplicitazione dei concetti principali, ma sintesi parzialmente
semplicistica
3
Individuazione parziale dei concetti chiave e non adeguata capacità di sintesi
2,5
Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di sintesi
1,5
Valutazione assegnata alla prova ………./15
Valutazione assegnata alla prova ………./10
Corrispondenza tra valutazione in quindicesimi e decimi
15/mi
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10/mi
0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
15/mi
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
10/mi
6
6,4
6,8
7,2
7,6
8
8,4
8,8
9,2
9,6
10
Pagina 18 di 54
La preparazione per la prova orale
Il percorso pluridisciplinare
Durante l’anno scolastico il lavoro dei docenti ha seguito uno sviluppo disciplinare e un condiviso riferimento
pluridisciplinare. Quale indicazione di metodo da seguire in vista del lavoro che ogni alunno dovrà presentare
all’Esame di Stato il C.d.C. ha sviluppato il seguente modulo pluridisciplinare, che ha un valore paradigmatico
e potrà essere utilizzato per l’avvio del colloquio orale come modello per i percorsi scelti autonomamente
dagli studenti, fermo restando che saranno oggetto di colloquio tutti i programmi svolti nel corso dell’anno per
le varie discipline.
LA DIMENSIONE SPAZIO-TEMPORALE NELLA CULTURA LETTERARIA,
FILOSOFICA, ARTISTICA E SCIENTIFICA
DISCIPLINE COINVOLTE
ITALIANO, LATINO, INGLESE, FILOSOFIA, FISICA, GEOGRAFIA GENERALE, ARTE
ITALIANO
Lo spazio e il tempo del rimpianto e della nostalgia
G.Verga, Fantasticheria e I Malavoglia: l’ideale dell’ostrica e la casa del nespolo; G.
Ungaretti, da Il dolore: Tutto ho perduto; S. Quasimodo, da Acque e terre: Vento a Tindari.
Lo spazio dell’infanzia e della solitudine
G. Leopardi, dallo Zibaldone: Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni, dai
Canti: A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, dalle
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; G. Pascoli, da Myricae: X Agosto,
dai Canti di Castelvecchio: La mia sera.
Spazio e tempo della storia e della vita sociale
A. Manzoni, I Promessi sposi (studio del Seicento); G. Verga, Vita dei campi, Novelle
rusticane, I romanzi del ciclo dei vinti.
Ambienti dell’estetismo
G. D’Annunzio: dagli spazi cittadini romani (con particolare riferimento a Il piacere e a Le
vergini delle rocce) alla Versilia di Alcyone; da Le vergini delle rocce: L’etica del superuomo,
da Alcyone: La sera fiesolana.
La relatività dello spazio e del tempo nel primo Novecento: lo spazio della psiche
G. Pascoli, dai Canti di Castelvecchio: La mia sera; I. Svevo, La coscienza di Zeno; L.
Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.
Il tempo della guerra
G. Ungaretti, da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, I fiumi.
Alla ricerca dello spazio, del tempo e della memoria
G. Leopardi, dai Canti: L’infinito; E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola,
Meriggiare pallido e assorto; da Satura: Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale.
Pagina 19 di 54
Bibliografia
G. M. Anselmi - G. Fenocchio, Tempi e immagini della letteratura, Milano, 2004, voll. 4, 5, 6
LATINO
Spazio
Lucrezio e la natura epicurea: De rerum natura, I, 1-101,
Petronio e lo spazio realistico: Satyricon
La rappresentazione satirica della realtà: Persio, Satira II; Marziale, Epigrammata, I, 10;
VIII, 79; X, 4, 8, 43
L’esilio: Seneca, Consolatio ad Helviam matrem
L’indagine sui fenomeni terrestri: Seneca, Naturales quaestiones;
Tempo
La concezione epicurea del tempo: Lucrezio, De rerum natura, I
Seneca e il problema del tempo: De brevitate vitae, 1; 2, 1-4; 10, 2-5; Epistulae ad Lucilium,
I
Il tempo soggettivo ed interiore: Sant’Agostino, Confessiones
Bibliografia
G. Garbarino, Opera, voll. 1B, 2, 3, Paravia, Milano, 2004
INGLESE
Interazione passato/presente - una nuova dimensione del tempo (flashback, flashforward,
continuum, stream of consciousness, relativism (J. Joyce – Virginia Woolf)
Bibliografia
C. Medaglia, B. A. Young, With Rhymes and Reason volumi 1 e 2, Loescher 2010 (pp. 174-180;
185-188; 189-197)
FILOSOFIA
Kant: spazio e tempo come forme pure a priori . Spazio e tempo assoluti nella concezione
newtoniana. La rivoluzione scientifica di fine ‘800 e il superamento delle categorie kantiane. Dal
meccanicismo laplaciano alla meccanica quantistica. La
crisi del modello meccanicistico.
Mutamenti scientifici e novità epistemologiche tra ‘800 e ‘900. Le geometrie non euclidee. La teoria
della relatività di Einstein e il principio di indeterminazione di Heisenberg. Dal criterio di verificazione
al falsificazionismo di K. Popper. Congetture e confutazioni. L’ epistemologia post-popperiana:
paradigmi e rivoluzioni nella concezione scientifica di T. Kuhn. Bergson e il tempo della coscienza:
la lunga durata. Nietzsche e l’Eterno Ritorno dell’Uguale. Le categorie spazio-temporali nei sogni
analizzati da S. Freud.
Bibliografia
N. Abbagnano–G. Fornero, Il nuovo Protagonisti e testi della storia della filosofia, Paravia, Milano
2007
Cioffi, Luppi, Vigorelli, Il testo filosofico, B. Mondadori, Torino 2000.
Fotocopie fornite dalla docente.
Pagina 20 di 54
FISICA
Postulati della relatività ristretta; relatività ristretta e meccanica newtoniana; concetto di simultaneità;
dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; equivalenza massa-energia.
Bibliografia
U. Amaldi, La fisica di Amaldi, Idee ed esperienze, vol 2, Bologna 2007, pp. 398-445.
GEOGRAFIA GENERALE
La misura del tempo: moti di rotazione e di rivoluzione della Terra, giorno solare e giorno siderale,
misura de tempo , tempo siderale, tempo solare vero, medio, civile; linea del cambiamento di data;
anno solare o tropico, anno siderale.
Bibliografia
Tano Cavattoni, Il cielo sopra di noi, Ferrara 2009, pp. 41-52. Fotocopia fornita dall’insegnante
STORIA DELL’ARTE
IL TEMPO E LO SPAZIO NELLE AVANGUARDIE STORICHE
(movimenti, autori e opere di riferimento)
Movimenti : Cubismo e Futurismo
Autori e opere :
P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Voillard, Natura morta con sedia
impagliata, I tre musici, Guernica.
G.Braque : Violino e brocca, Le Quotidien,violino e pipa, Natura morta con clarinetto.
F.T.Marinetti : Il manifesto del Futurismo.
U. Boccioni : La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.
G. Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile.
Bibliografia
Giorgio Di Cricco, Francesco P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dall’art Noveau ai giorni nostri,
vol. 5, seconda edizione, versione arancione, pp. 780- 814.
Pagina 21 di 54
IL CONSIGLIO DI CLASSE
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M.Grazia Faganello
..........................................................
I docenti della classe V D
Prof.ssa Alessandra Martello
..........................................................
Prof.ssa M. R. Fontolan
..........................................................
Prof.ssa Paola Goldin
..........................................................
Prof.ssa Elisa Depiccoli
..........................................................
Prof.ssa Tiziana Maneo
..........................................................
Prof.
..........................................................
Paolo Vecchione
Prof.ssa Giovanna Celio
..........................................................
Prof.
Maurizio Miante
…......................................................
Prof.
Oscar Mason
…......................................................
Pagina 22 di 54
7. ALLEGATI - A
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
Docente
1.
prof. Paolo Vecchione
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
METODOLOGIE:
Tutte le normali attività didattiche (lezioni frontali, lezioni dialogiche, lavori di gruppo, analisi di
testi, le stesse attività di verifica).
Laboratorio di scrittura: attività teorico-pratica finalizzata alla produzione scritta nelle diverse
tipologie testuali previste dall’esame di Stato.
Relativamente ai contenuti disciplinari sono stati curati:
a) La lettura e l'analisi dei testi letterari.
b) La storicizzazione dei fenomeni.
Le opere narrative sono state analizzate secondo la prospettiva narratologica, ma anche
contenutistico - tematica.
I principali fenomeni letterari sono stati trattati in una prospettiva unitaria all'interno di percorsi
privilegiati, con particolare riferimento alle relazioni fra discipline umanistiche e scientifiche. In
particolare i contenuti sono stati organizzati sulla base dei seguenti nuclei concettuali
interdisciplinari: spazio e tempo soprattutto; inoltre velocità, limite e infinito; infine oggettivo,
soggettivo e relativo.
2.
RISORSE UTILIZZATE:
G.M. ANSELMI – G. FENOCCHIOI, Tempi e immagini della letteratura, Milano, 2004, voll. 4, 5, 6
DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, qualsiasi edizione.
Fotocopie fornite dall’insegnante.
Romanzi letti (v. contenuti disciplinari).
Pagina 23 di 54
3.
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE:
a) verifiche formative durante l’anno scolastico;
b) verifiche sommative
-scritte:
1) analisi e commento di testi in prosa o in poesia;
2) interpretazione e contestualizzazione di un autore (tema
tradizionale);
3) sviluppo di argomenti riguardanti vari ambiti (con o senza dossier
di informazioni in allegato);
-orali:
1) interrogazioni tradizionali;
2) prove strutturate.
I criteri di valutazione miravano ad accertare:
a) prove scritte:
-comprensione e aderenza del contenuto;
-correttezza formale (ortografia, punteggiatura, morfosintassi, lessico);
-competenza testuale;
-conoscenza e articolazione dei contenuti;
-capacità di analisi critica e originalità;
limitatamente alle prove di analisi anche: - capacità di analisi testuale;
- conoscenza della terminologia specialistica;
- sintesi interpretativa e valutativa;
b) prove orali:
-pertinenza della risposta;
-conoscenza dell’argomento;
-comprensione ed elaborazione dei contenuti;
-organizzazione coerente del discorso;
-esposizione chiara ed appropriata;
-eventuale capacità critica ed originalità.
4.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Pagina 24 di 54
1. 1 MODULO
1
2. 1
-Neoclassicismo, Preromanticismo,
Romanticismo (definizione e periodizzazione)
1
TEMPI
U. Foscolo:biografia e opere; tematiche, ideologia e poetica.
Le ultime lettere di Jacopo Ortis.
I Sonetti: A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; Alla sera.
Dei Sepolcri.
Le Grazie
Continuità e opposizione dialettica tra Illuminismo e Romanticismo.
Ore 20
Il Romanticismo: importanza europea del movimento; le polemiche letterarie (classici
- romantici); clima culturale e Risorgimento nazionale; la questione della lingua.
Testi: M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; G. Berchet, La lettera
semiseria di Grisostomo al suo figliuolo: “Il nuovo pubblico della letteratura”; Il
Conciliatore, numero I: “Il programma del Conciliatore”.
2
Il romanzo storico
Caratteri distintivi del genere: il modello scottiano
A. Manzoni: vita, opere, poetica.
L’evoluzione della poetica manzoniana: la scelta del Ore 10
romanzo storico; la problematicità del “vero” e i
rapporti con la storiografia.
Testi: In morte di Carlo Imbonati, vv. 165-186; 202-215; “Poesia e storia” in Lèttre
à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie; “L’utile per
iscopo, il vero per soggetto, e l’interessante per mezzo” dalla Lettera sul
Romanticismo a C. D’Azeglio; I promessi sposi (lettura integrale); Storia della
colonna infame: “I meccanismi del pregiudizio”.
3
4
La lirica romantica: G. Leopardi
Vita, pensiero, poetica e opere.
I Canti: la struttura, i temi e le forme.
Le Operette morali: genesi, caratteri, stile, struttura e
temi.
I Paralipomeni alla Batracomiomachia: l’origine di
Ore 20
un moderno umorismo nel riso leopardiano.
Testi: dallo Zibaldone: Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni; La
teoria del piacere.
Pensieri, XIII, LXVII, LXVIII, CII: “La memoria, la noia e il mito della
fanciullezza”
Dai Canti: L’infinito; Alla luna; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra
o il fiore del deserto.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un
venditore d’almanacchi e di un passeggere.
La lirica risorgimentale e post-risorgimentale
Le coordinate storiche e le idee nell’arte: il secondo romanticismo; il neoclassicismo Ore 2
Pagina 25 di 54
di G. Carducci; la Scapigliatura.
5
Poetiche fra due secoli
Temi, miti e tendenze del Decadentismo:
Simbolismo pascoliano e dannunziano
Le avanguardie: quadro storico-culturale di riferimento
Il Futurismo
Testi: G. D’Annunzio, da Alcyone: La sera fiesolana; Il piacere; L’innocente; Trionfo Ore 10
della morte; Le vergini delle rocce: “L’etica del superuomo”; Il fuoco; Forse che sì
forse che no; La Leda senza cigno; Le faville del maglio; Il notturno.
La poesia crepuscolare:
Testi: G. Gozzano, da I colloqui: Totò Merumeni
G. Pascoli:
6
Vita, pensiero, poetica, opere.
Il simbolismo
Ore 6
L’impressionismo
La poetica del fanciullino
Il tema del nido
Testi:: da Myricae: X Agosto; dai Canti di Castelvecchio: La mia sera; da Pensieri e
discorsi: Il sabato
7
8
La narrativa tra Ottocento e Novecento
Il Positivismo e il romanzo verista:
G. Verga, da Vita dei campi: Fantasticheria, prefazione all’Amante di
Gramigna: “Un documento umano”; da Novelle rusticane: La roba; I
Malavoglia: lettura integrale e analisi testuale della prefazione; Mastro-don
Gesualdo: “L’arrivo alla Canziria”.
L. Capuana, da Per l’arte: “Il vero e la conquista della forma”
Il romanzo della crisi: le premesse scientifiche, filosofiche e letterarie.
Ore 25
Strutture e temi del romanzo della crisi: la centralità del personaggio e le maschere
della crisi: il dandy, l’inetto, il malato, l’escluso.
I. Svevo: la vita, la poetica, il percorso letterario da Una vita a La
coscienza di Zeno.
L. Pirandello: la vita, le opere, la poetica.
Testi: I. Svevo, La coscienza di Zeno: “Prefazione”; “Storia del mio matrimonio”; L.
Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal (lettura
integrale); da L’umorismo: “Vedo una vecchia signora…”, “Il flusso continuo della
vita”; Uno, nessuno e centomila.
La lirica tra le due guerre.
Le due linee della poesia: poesia “pura” e “metafisica”.
L’Ermetismo: G. Ungaretti.
L’eredità dell’Ermetismo: S. Quasimodo.
Testi: G. Ungaretti, da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso,
Soldati, I fiumi; da Il dolore: Tutto ho perduto; S. Quasimodo, da Acque e terre: Ed è
subito sera, Vento a Tindari.
Pagina 26 di 54
Ore 3
9
Eugenio Montale
Ore 3
La vita, le opere, la poetica.
Testi: da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto; da La
bufera e altro: Piccolo testamento; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, un
milione di scale.
10
L'evoluzione del romanzo dagli anni '30 del Novecento al secondo dopoguerra
Tra storia e mito: la parabola neorealista
L’Italia del boom: povertà, lavoro e alienazione nella narrativa del dopoguerra.
Italo Calvino: dal neorealismo al progetto “cosmicomico”
Testi: I. Calvino, da Le cosmicomiche: Tutto in un punto; dalle Lezioni americane:
Leggerezza
11
Divina Commedia, Paradiso
Conoscenza globale della cantica.
Canti I, II, III, VI, XI, XII, XVII, XXII, XXIV, XXXIII
Ore 4
Ore 20
123
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. ………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 27 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI INGLESE
Docente
Prof. Alessandra Martello
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
Buona parte della classe ha dimostrato interesse ed impegno costanti, con una partecipazione attiva al
dialogo educativo, pur con risultati differenziati a seconda delle capacità, dei prerequisiti linguistici, e
del grado di sicurezza nelle abilità di analisi, sintesi e comparazione .
Un buon gruppo di alunni ha sviluppato un metodo autonomo e critico di analisi dei testi proposti ed è
in grado di mettere in relazione un testo letterario al co-testo e al contesto, di operare collegamenti
pluridisciplinari, individuando i concetti chiave e rielaborandoli personalmente.
Il profitto può ritenersi mediamente discreto, in particolare buono e ottimo per alcuni, discreto per un
gruppetto, sufficiente per il resto della classe, ma insufficiente per alcuni alunni, anche a causa di un
impegno discontinuo e superficiale.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
The Romantic Age: The Historical Background and the Literary Context
W. Blake
The Lamb (p.283), The Tyger (p.284), London (p.287)
W. Wordsworth
Composed upon Westminster Bridge (p.293), My Heart leaps up (p.295), I Wandered
Lonely as a Cloud (p.362) Preface to Lyrical Ballads (p.291)
B. Shelley
Ode to the West Wind (p.314)
J. Keats
Ode on a Grecian Urn (p. 321)
M. Shelley
Frankenstein (p. 341)
(da sett. a dic., 34 ore)
TheVictorian Age: The Historical Background and the Literary Context
J. Ruskin
The Degradation and Division of Labour (Only Connect vol 2 E32)
C. Dickens
Hard Times (p.32), Oliver Twist (p. 27)
L. Carroll
Alice’s Adventures in Wonderland (Continuities vol 2 p.222)
C. Bronte
Jane Eyre (p.36)
O. Wilde
The Picture of Dorian Gray (p. 65), The Importance of Being Earnest (p. 70)
Pagina 28 di 54
R.L. Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde (p.110)
A. Tennyson
Ulysses (p. 84)
Documents:
The People’s Charter (Literature and Beyond vol.3, p.300) ; Aestheticism and
Decadence (Only Connect vol2 , E36)
(genn.-mar., 30 ore)
The Twentieh Century- Part I:
The Historical Background and the Literary Context (pp.132-136 e 144-146)
R. Brooke
The Soldier (Only Connect vol. 3, F54)
W. Owen
Dulce et Decorum est (p.226)
J. Joyce
Eveline (p.174) from Dubliners , Ulysses (p.185)
V. Woolf
Mrs.Dalloway (p.192)
T.S. Eliot
The Love Song of J. Alfred Prufrock (p.217)
Documents:
Churchill’s speech ( Fields of Vision vol. 2 G168),
The Twentieh Century- Part II:
S. Beckett
Waiting for Godot (p.357)
J. Rhys
Wide Sargasso Sea (Extra text)
(apr.- mag., 20ore)
Altri argomenti, utili per i percorsi pluridisciplinari, sono stati approfonditi da singoli alunni, ma non c’è stato il
tempo di estenderli all’intera classe.
Sono stati visti i film in lingua originale Frankenstein e Oliver Twist
Ripasso di fine anno…………………………………………………………………….5
Ore di lezione effettivamente svolte ……………..……………………………………89
RISORSE UTILIZZATE
Libri di testo
E’ stato utilizzato il testo in adozione With Rhymes and Reason volumi 1 e 2, di C. Medaglia, B. A. Young,
Loescher, ed., Torino, 2010
Altro materiale didattico è stato presentato in fotocopie tratte da
D. Heaney, D. Montanari, R.Rizzo, Continuities volume 2 , Torino 2009
M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect , Bologna 2000
B. De Luca, U. Grillo, P. Pace, S. Ranzoli, Literature and Beyond vol.3 , Torino 2002
D. Delaney, C. Ward, C. Rho Fiorina, Fields of Vision vol. 2, Longman 2002
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. ………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 29 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI LATINO
Docente
Prof.Paolo Vecchione
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
1. METODOLOGIE:
-
Lezioni frontali, partendo dai testi, soprattutto riguardo all’inquadramento storico-culturale degli
autori affrontati.
-
Traduzione, guidata o come esercitazione domestica (ma sempre controllata), intesa come
momento conclusivo della comprensione e volta alla interpretazione tematica (da una
traduzione letterale ad una resa più libera, fatto salvo il rigore interpretativo).
Individuazione delle regole grammaticali e delle principali strutture linguistiche dei testi
esaminati (con relativo ripasso, quando necessario).
Individuazione dai testi letti dei principali aspetti letterari, culturali e ideologici della
società latina.
Testi offerti in traduzione italiana per cogliere in maniera immediata il pensiero
dell’autore ed agevolarne l’analisi.
Diverse prospettive di analisi.
Percorsi tematici o incentrati su aspetti di analisi e confronto testuale.
Interazione di contenuti con le altre discipline dell’area umanistica (italiano, filosofia,
storia, inglese ed arte) e dell’area scientifica (scienze, fisica, matematica).
-
2. RISORSE UTILIZZATE:
a) Libri di testo.
N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, Comprendere e tradurre – Manuale,
Bompiani, Milano
N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, Comprendere e tradurre – Materiali
di lavoro, vol. II, Bompiani, Milano
G. GARBARINO, Opera, voll. 1 B, 2, 3, Paravia, Torino.
b) Fotocopie integrative di brani d’autore, schemi, appunti e vocabolario.
3. CRITERI, STRUMENTI, TIPOLOGIE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE:
v. Programmazione Dipartimentale e P.O.F. d’Istituto.
Pagina 30 di 54
4. CONTENUTI DISCIPLINARI:
Recupero del programma dello scorso a.s. di lineamenti di storia letteraria:
Lucrezio e il De rerum natura
Ovidio: vita e opere; scelta antologica di letture
Virgilio: vita e opere; scelta antologica di letture da Bucoliche, Georgiche ed Eneide
Orazio: vita e opere; scelta antologica di letture da Satire, Odi ed Epistole
Storia della letteratura latina da Tiberio agli autori cristiani.
Letture antologiche dei seguenti autori (vita e opere):
L. A. Seneca:
- L’esilio:
Consolatio ad Helviam matrem
- La concezione stoica della vita:
De brevitate vitae: 1, 2, 1-4; 10, 2-5
Epistulae ad Lucilium: I.
- L’interesse per la scienza:
Naturales quaestiones.
L’evoluzione della satira:
Fedro, Fabulae, I, 1; IV, 3.
A. Persio Flacco, Satire, II, 1-68.
M. V. Marziale, Epigrammata, I, 10, VIII, 79; X, 4, 8, 43.
La nascita del romanzo:
Petronio Arbiter: Satyricon, 37, 1-10; 38, 1-5; 110,6-112,8
M. F. Quintiliano, maestro di retorica:
Institutio oratoria, I, 2,11-13; X, 1, 125-131.
B. S. Plinio il Giovane e l’epistolario:
Epistulae, I, 15.
C. P. Tacito e la storiografia:
De Germania, 11-12
Historiae
Annales
S. Agostino fra scandaglio interiore e fede:
Confessiones, VIII, 12, 28-29.
Percorsi tematici trasversali di latino:
1. La concezione dell’uomo e della natura.
2. Il tema dell’esilio.
3. L’idea di progresso.
4. La concezione del tempo.
5. Il “barbarus”, ovvero “l’alter”.
6. Epistolari.
7. La satira.
8. La nascita del romanzo.
9. La storiografia.
10. Storia del cristianesimo.
Pagina 31 di 54
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. ………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 32 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
RELAZIONE FINALE DI GEOGRAFIA GENERALE
Docente
Prof. Tiziana Maneo
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
Il gruppo classe ha seguito adeguatamente le proposte didattiche, alcuni alunni in modo attivo,
partecipe e costante, altri con atteggiamento di ascolto e con minore continuità. Anche l’impegno è
stato differenziato: per alcuni metodico e produttivo, per altri alterno e talvolta finalizzato alle
verifiche. Gli obiettivi disciplinari previsti dal piano di lavoro annuale sono stati raggiunti in modo
sostanziale; in particolare, per quanto concerne le abilità e le competenze, un gruppo di alunni
dimostra di avere acquisito un buon grado di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, di
saper rielaborare in modo personale i contenuti appresi e di esporre in modo logico e rigoroso i
concetti fondamentali; un altro gruppo, più ristretto, ha acquisito le conoscenze in modo meccanico
dimostrando, tuttavia, di possedere un’adeguata capacità espositiva e di saper utilizzare
correttamente il linguaggio specifico.
L’attività didattica è stata svolta con regolarità, sia per quanto concerne le ore di lezione
effettivamente svolte che per la frequenza degli alunni.
CONTENUTI DISCIPLINARI (ore complessive di lezione: 31 nel primo quadrimestre – 34 previste
nel secondo quadrimestre)
ASTRONOMIA
LA LUCE:
Spettro elettromagnetico; Misura della luce; Spettroscopia: spettro continuo, modello del corpo nero,
spettro a righe, la serie di Balmer, effetto Doppler.
L’ UNIVERSO VICINO:
La Galassia, classificazione e parametri fisici delle stelle, il diagramma H-R, nascita ed evoluzione
delle stelle.
L’UNIVERSO LONTANO:
Galassie oltre la nostra, la legge di Hubble e l’espansione dell’universo, ipotesi sull’origine
dell’universo, conferme della teoria del big bang, ipotesi sul futuro dell’universo.
IL SISTEMA SOLARE:
Nascita del sistema solare, caratteristiche generali e classificazione dei pianeti terrestri e gioviani.
Il Sole: caratteristiche fisiche e struttura interna, la fornace solare, le reazioni di fusione nucleare, la
catena protone protone, l’attività del Sole.
LA MISURA DEL TEMPO:
tempo solare medio, tempo civile, anno siderale, anno tropico (fotocopia fornita dal Docente).
ELEMENTI DI MECCANICA CELESTE:
modello tolemaico, modello copernicano, modello tychonico, Keplero e le sue Leggi, la legge di
gravitazione universale, moto intorno al comune centro di massa, dinamica del sistema Sole-TerraLuna, precessione luni-solare, nutazione, le maree (fotocopia fornita dall’insegnante).
I MOTI DEL PIANETA TERRA
Pagina 33 di 54
La rotazione e le sue conseguenze, prove della rotazione della Terra, moto di rivoluzione, stagioni
astronomiche, solstizi ed equinozi, i crepuscoli, zone astronomiche, prove del moto di rivoluzione,
aberrazione annua, parallasse annua, i moti millenari della Terra, moto della linea degli apsidi,
precessione degli equinozi, moti millenari secondari (cenni).
LA LUNA:
parametri principali e caratteri geomorfologici, origine ed evoluzione della Luna, i principali moti della
Luna: rivoluzione, rotazione; le fasi lunari, le maree (fotocopia fornita dall’insegnante).
.
GEOLOGIA
LA TERRA SOLIDA:
minerali, la struttura cristallina dei minerali, proprietà fisiche, polimorfismo, isomorfismo, criteri di
classificazione dei minerali, classificazione dei silicati: mafici e felsici, le rocce della crosta terrestre,
il ciclo litogenetico.
I TERREMOTI:
genesi dei terremoti, comportamento elastico delle rocce, onde sismiche, misura delle vibrazioni
sismiche, distribuzione dei terremoti sulla Terra, scale sismiche: Richter e scala MCS; previsione e
prevenzione del rischio sismico.
L’INTERNO DELLA TERRA:
il modello interno della Terra, litologia dell’interno della Terra: nucleo, mantello, crosta; il calore
interno della Terra, il principio dell’isostasia, il campo magnetico della Terra, paleomagnetismo e
inversioni di polarità.
PROCESSO MAGMATICO E ROCCE IGNEE:
processo magmatico, genesi dei magmi, cristallizzazione e differenziazione magmatica,
classificazione delle rocce ignee, rocce ignee nel sottosuolo, plutoni e batoliti.
I VULCANI:
definizione e relazioni geologiche, eruzioni e meccanismo eruttivo, tipi di eruzione: esplosiva ed
effusiva; stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici, manifestazioni gassose, distribuzione dei
vulcani sulla Terra, rischio vulcanico: previsione e prevenzione.
DALLA DERIVA DEI CONTINENTI ALL’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI:
la teoria della deriva dei continenti: la Pangea e le prove a sostegno; morfologia dei fondali oceanici,
le dorsali oceaniche, espansione dei fondali oceanici, il meccanismo dell’espansione. TETTONICA
DELLE PLACCHE:
Concetti generali e cenni storici, morfologia delle placche, i margini delle placche, il mosaico
globale, moto delle placche, margini continentali passivi, trasformi, attivi, punti caldi, collisioni e
orogenesi.
RISORSE UTILIZZATE
Libri di testo
Il manuale in uso: A. Bosellini – T. Cavattoni, CORSO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL CIELOvolume A: Il cielo sopra di noi; volume B: La Terra dinamica. Italo Bovolenta editore- Ferrara 2009
Altro materiale
Laboratorio di scienze: osservazione campioni di minerali e rocce;
fotocopie fornite dal docente;
Proiezione materiali audiovisivi.
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
TIZIANA MANEO
I Rappresentanti di Classe
Pagina 34 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI FISICA
Docente
Prof. Paola Goldin
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
La classe, costituita da 26 allievi, risulta molto eterogenea sia per i tempi di assimilazione individuali
che per le conoscenze acquisite dai singoli studenti.
In alcuni ragazzi è presente una forte motivazione culturale che li ha portati, negli anni, a
raggiungere una preparazione personale qualificata; altri hanno lavorato in modo costante per
cercare di superare alcune difficoltà di assimilazione, mentre alcuni, capaci e intuitivi, si sono
accontentati di capire in classe gli argomenti ma poi non hanno approfondito a casa le conoscenze,
se non nell'ultimo periodo, ottenendo risultati non sempre all’altezza delle loro potenzialità.
Il profitto medio della classe è più che sufficiente: alcuni allievi hanno conseguito ottimi risultati.
Le attività integrative e di approfondimento sono:
Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica (Fase di Istituto) una selezione di alunni
CONTENUTI DISCIPLINARI (ore complessive di lezione: 92)
Settembre 2013
Carica elettrica. Legge di Coulomb.
Elettrizzazione per strofinio. Elettrizzazione per contatto. Isolanti e conduttori. Definizione
operativa della carica elettrica. Legge di Coulomb. Forza elettrica e forza gravitazionale. Forza di
Coulomb nella materia. Elettrizzazione per Induzione. Principio di conservazione della carica.
Gabbia di Faraday. Elettroforo di Volta. Polarizzazione dei dielettrici. (Unità 1)
Ottobre/Novembre
Il campo elettrico
Vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. Campo elettrico generato da
più cariche puntiformi. Linee del campo elettrico. Campo elettrico di una sfera conduttrice carica.
Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. Teorema di Gauss (dim). Applicazioni del
teorema di Gauss:campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (dim),
campo elettrico di una distribuzione lineare infinita di carica (dim), campo elettrico all’esterno di
una distribuzione sferica di carica (dim), campo elettrico all’interno di una sfera omogenea di
carica (dim). Campo elettrico generato da un condensatore piano (dim). (Unità 2)
Il potenziale elettrico
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Differenza di potenziale elettrico. Potenziale di
una carica puntiforme. Superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico dal potenziale.
Circuitazione del campo elettrostatico. (Unità 3)
Fenomeni di elettrostatica
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico (dim). Campo elettrico e
potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico (dim). Teorema di Coulomb (dim). Potere
Pagina 35 di 54
delle punte. Convenzioni per lo zero del potenziale. Capacità di un conduttore. Capacità di una
sfera conduttrice isolata (dim). Condensatore. Capacità di un condensatore piano (dim). Effetto di
un dielettrico sulla capacità di un condensatore. Sistemi di condensatori in serie e in parallelo
(dim). Energia immagazzinata in un condensatore (dim). Densità di energia elettrica nel
condensatore (dim). (Unità 5)
Dicembre /Gennaio
Corrente elettrica continua
Intensità della corrente elettrica. Elettroni di conduzione. Verso della corrente. Corrente continua.
Generatori di tensione e circuiti elettrici. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Resistori in serie e
in parallelo (dim). Leggi di Kirchhoff. Trasformazione dell’energia elettrica. Potenza dissipata
(dim). Kilowattora ed elettronvolt. Forza elettromotrice. Generatore reale di tensione. (Unità 6)
La corrente elettrica nei metalli
I conduttori metallici e la velocità di deriva degli elettroni di conduzione (dim). La seconda legge
di Ohm. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Superconduttori. Carica e scarica di un
condensatore (dim). Lavoro e potenziale di estrazione di un elettrone. Effetto Joule. Effetto
termoionico. Effetto fotoelettrico. (Unità 7, esclusi par. 6 e 7)
Febbraio/Marzo
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Confronto tra
campo elettrico e magnetico. Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday.
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Forze tra correnti: legge di Ampère.
Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo
magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart (dim). Campo magnetico di una
spira e di un solenoide (dim). Motore elettrico (dim). Momento magnetico proprio della spira.
Momento torcente (dim). Amperometro e voltmetro. (Unità 9)
Il campo magnetico
La forza di Lorentz (dim). Forza elettrica e magnetica: selettore di velocità (dim), effetto Hall
(dim). Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (dim), spettrometro di massa (dim),
acceleratori di particelle (appunti). Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il
magnetismo (dim). La circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère e dim. Le proprietà
magnetiche dei materiali, interpretazione microscopica e permeabilità magnetica relativa. Il ciclo
di isteresi magnetica. (Unità 10)
Aprile/Maggio
L'induzione elettromagneticaCorrente indotta. Leggi di Faraday-Neumann e di Lenz (dim).
Forza elettromotrice indotta istantanea. Correnti di Foucault. Autoinduzione elettromagnetica.
Mutua Induzione. Induttanza di un solenoide (dim). Energia e densità di energia in un campo
magnetico (dim). Alternatore e forza elettromotrice alternata (dim). Valore efficace della forza
elettromotrice e della corrente (dim) . Trasformatore statico. Dinamo. Gli elementi circuitali
fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, induttivo e capacitivo. (Unità 11, escluso par.
8)
Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico indotto (dim). Paradosso di Maxwell e
corrente di spostamento (dim). Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Genesi di una
perturbazione elettromagnetica. Onde elettromagnetiche e caratteristiche. Velocità della luce.
( Unità 12, fino pag.375)
La relatività dello spazio e del tempo.
Il valore numerico della velocità della luce. L'esperimento di Michelson-Morley (senza dim). Gli
assiomi della teoria della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei
tempi (dim). La contrazione delle lunghezze (senza dim). invarianza delle lunghezze
perpendicolari al moto relativo. Trasformazioni di Lorentz e confronto con quelle di Galilei.
Pagina 36 di 54
( Unità 13, vol. 2)
La relatività ristretta.
L'intervallo invariante. (senza dim) Lo spazio-tempo. L'equivalenza tra massa ed energia. Massa
relativistica. (Unità 14, vol 2, fino pag. 445, senza par. 3)
RISORSE UTILIZZATE
Libri di testo
U. Amaldi, La Fisica di Amaldi. Idee ed esperimenti (vol. 3°), BOLOGNA 2008
capp. 1-2-3-5-6-7-9-10-11-12 (fino alle onde elettromagnetiche).
U. Amaldi, La Fisica di Amaldi. Idee ed esperimenti (vol. 2°), BOLOGNA 2007, unità 14, pp. 398445 (Relatività ristretta).
ESPERIENZE DI LABORATORIO:
Esperienze fondamentali di elettrostatica; elettroforo di Volta e generatore di Van Deer Graff;
proprietà dei magneti; campo dei magneti rettilinei; effetto magnetico della corrente elettrica;
campi magnetici di bobine percorse da corrente; leggi di Ohm; resistenze in serie e in parallelo;
induzione elettromagnetica; correnti parassite; autoinduzione; mutua induzione; rapporto di
trasformazione e tensione; motori elettrici in CC e CA; alternatore e dinamo.
AUDIOVISIVI:
La legge di Coulomb.
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. ………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 37 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
Docente Prof. Maria Rosa Fontolan
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
Ho iniziato a insegnare in questa classe solo dalla quarta e solo per Matematica. La situazione di
partenza presentava qualche criticità: diffuse carenze algebriche di base, metodo di studio non
adeguato, impegno incostante. La classe era numerosa (29 studenti) e durante le lezioni c’erano
spesso distrazione e confusione. Tuttavia con un lavoro continuo da parte mia di sollecitazioni e
consigli agli studenti, affiancato da attività di ripasso e recupero curricolare durante tutta la classe
quarta, sono riuscita a ottenere risultati positivi. Gli studenti, anche se con impegno diversificato,
hanno cercato di colmare le lacune pregresse e di costruirsi un metodo di studio. Il comportamento è
migliorato e la classe durante quest’ultimo anno ha seguito le lezioni con discreto interesse in un
clima sereno e costruttivo.
In relazione alla programmazione curricolare gli obiettivi conseguiti sono:
Conoscenze
Gli studenti conoscono e hanno compreso i contenuti disciplinari, il linguaggio specifico della
Matematica e i metodi di indagine propri della disciplina.
Competenze
Gli studenti espongono in modo appropriato sia oralmente che per iscritto, riconoscono e applicano
regole, proprietà, formule, ecc. a situazioni specifiche e risolvono esercizi e problemi di varia tipologia.
Abilità
Gli studenti organizzano autonomamente il proprio lavoro, collegano le conoscenze nell’ambito della
disciplina, analizzano testi, fatti e situazioni problematiche e individuano procedimenti risolutivi. A
volte sanno individuare il procedimento ottimale.
Questi obiettivi sono stati raggiunti In media ad un livello più che sufficiente. Nello specifico: un
ristretto gruppo di studenti ha una buona preparazione, circa metà sufficiente, un piccolo gruppo
appena sufficiente con fragilità soprattutto allo scritto.
Attività di approfondimento: la classe ha partecipato ai Giochi di Archimede fase di Istituto e una
studentessa anche alla seconda fase. Un gruppo di 7 studenti ha frequentato uno sportello didattico
di 5 ore per recuperare alcune carenze. 20 studenti hanno frequentato il corso integrativo di “Logica
Matematica e test” di 8 ore pomeridiane in preparazione ai test di ammissione all’Università in ambito
scientifico.
Contenuti disciplinari (ore di lezione 95 = 85 svolte entro il 15 maggio + 10 previste
entro il termine delle lezioni)
FUNZIONI (settembre)
Funzioni: definizione, dominio, codominio, le funzioni reali di variabile reale, classificazione e
proprietà. Composizione di funzioni, la funzione inversa, la funzione reciproca. Grafici di funzioni
Pagina 38 di 54
notevoli. Funzioni associate a coniche. Funzioni pari/dispari. Funzioni crescenti/decrescenti in senso
stretto e in senso lato.
LIMITI E CONTINUITA’ (ottobre-novembre-dicembre)
Limiti. Introduzione al concetto di infinito. Cenni di topologia della retta: intorni di un punto, di infinito,
di infinito. Punti di accumulazione. Nozione di limite. Limite finito. Limite infinito. Limite di una funzione
all'infinito. Limite infinito di una funzione all'infinito. Limite sinistro, limite destro. Teoremi sui limiti con
dim. del teorema di permanenza del segno. Verifiche di limiti. Operazioni sui limiti.
Funzioni continue e calcolo dei limiti. Definizione di funzione continua. Continuità a destra e a
sinistra. Calcolo di limiti. Limite all’infinito di un polinomio. Limite all’infinito delle funzioni razionali.
Teor. continuità di razionali intere e fratte, goniometriche, trascendenti con dim. della continuità di x,
x2, sinx. Risoluzione di
forme indeterminate. Gli asintoti. Primo e secondo limite fondamentale e applicazioni. Dim del primo
limite fondamentale. Teoremi sulle funzioni continue: di Wierstrass, dei valori intermedi, di esistenza
degli zeri. Punti di discontinuità.
CALCOLO DIFFERENZIALE(dicembre-gennaio-febbraio-marzo)
Derivate. Definizione di derivata. Significato geometrico e fisico. Continuità delle funzioni derivabili
(dim).
Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata dell’inversa. Derivate successive.
Definizione di differenziale. Applicazioni alla fisica. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi,
flessi a tangente verticale.
Teoremi del calcolo differenziale. Teorema di Rolle (dim). Teorema di Lagrange (dim). Teorema di
Cauchy. Funzioni crescenti e decrescenti (dim). Corollari del teorema di Lagrange (dim). Teorema di
De L'Hôpital. Teorema del limite della derivata prima (dim).
Massimi, minimi e flessi di una funzione. Massimi e minimi assoluti e relativi. Punti a tangente
orizzontale. Concavità, convessità e flessi. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con
lo studio del segno della derivata prima. Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata
seconda. Studi di funzione. Risoluzione grafica di equazioni. Risoluzione di problemi di massimo e
minimo.
CALCOLO INTEGRALE(aprile-maggio)
Integrale indefinito. Funzioni primitive di una funzione data. Definizione di integrale indefinito e
proprietà. Integrali immediati. Metodi di integrazione: per scomposizione, di funzioni composte,
sostituzione, per parti, razionali fratte.
Integrale definito. Problema dell’area. Area di un trapezoide. Integrale definito e relative proprietà.
Teorema della media (dim) e significato geometrico. La funzione integrale. Teorema di Torriccelli –
Barrow (dim). Regola di calcolo dell’integrale definito (dim). Calcolo di aree di domini piani e di volumi
di solidi di rotazione.
ELEMENTI DI GEOMETRIA SOLIDA (maggio)
Ripasso del teorema delle tre perpendicolari e dei principali solidi. Principio di Cavalieri e
applicazioni. I solidi platonici.
CALCOLO COMBINATORIO (maggio)
Disposizioni semplici. Permutazioni semplici. Combinazioni semplici. Coefficienti binomiali.
Programma da completare dopo il 15-5-2014
Progressioni aritmetiche e geometriche. Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi con il metodo
delle derivate successive. Integrali impropri. Sviluppo del binomio di Newton.
Libri di testo
Bergamini, Trifone, Barozzi, Corso base di Matematica Volumi 5 e 4, ZANICHELLI, Bologna, 2007
Rovigo, 15 maggio 2014
Pagina 39 di 54
Il Docente prof.
……………………………..
I Rappresentanti di Classe
………………………………..
………………………………..
Pagina 40 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente:
Prof. Maurizio Miante
Classe 5^ D
a. s. 2013-2014
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
La classe 5D è stata da me seguita dal quarto al quinto anno di corso. Si è sempre dimostrata
interessata alla materia, Il profitto é sempre stato mediamente discreto. Un buon gruppo (10/12) di
allievi ottiene risultati buoni. La classe ha svolto con il sottoscritto a sfondo culturale-artistico un
Viaggio di istruzione in Slovenia-Croazia-Ungheria (a.s. 2012/13) e un Viaggio di istruzione a Monaco
di Baviera (a.s. 2013/14) oltre ad alcune visite guidate a siti museali e a mostre temporanee d’arte.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Ore effettivamente svolte n° 63
DISEGNO
1-Teoria delle ombre applicata all’assonometria
(Teoria delle ombre applicata a una composizione di soldi in assonometria, con sorgente
luminosa posta a fianco dell’osservatore, di fronte all’osservatore dietro all’osservatore).
STORIA DELL’ARTE
Volume 4°
UNITÀ 24. Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese.
L’Illuminismo. Boullèe (Biblioteca nazionale, Cenotafio di Newton). Piranesi (progetti vari).
Il
Neoclassicismo. Antonio Canova (Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese
come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria).Jaques-Louis David (Donna
con il turbante, Accademia del nudo, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine, Leonida
alle Termopili). Ingres (L’apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, i ritratti). Architetture neoclassiche
(Robert Adam, Leo von Klenze, Giuseppe Piermarini, Giacomo Quarenghi).
UNITÀ 25. L’Europa della Restaurazione.
Il Romanticismo. Neoclassicismo e Romanticismo. F.Rude (La Marsigliese). Théodore Géricault
(Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella
campagna romana, La zattera della Medusa, Alienata con la monomania del gioco). Eugène
Delacroix (La barca di Dante, La libertà che guida il popolo, Giacobbe lotta con l’angelo). Francesco
Hayez. (Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio, I ritratti storici).
Camille Corot e la Scuola di Barbizon. Gustave Courbet e il Realismo (Lo spaccapietre, L’atelier del
pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, La bella ragazza irlandese). Il fenomeno dei Macchiaioli.
Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del’59, La rotonda di
Palmieri, In vedetta, Bovi al carro, Lo staffato). La nuova architettura del ferro in Europa (Paxton,
Eiffel). Eugène Viollet-le-Duc, (Chiesa di Saint-Denis, Carcassonne, Castello di Pierrefond ). John
Ruskin. Il restauro architettonico.
UNITÀ 26. La stagione dell’Impressionismo.
L’Impressionismo. La fotografia. Niepce, Daguerre, Nadar (ritratto di Sarah Bernardt), Alinari.
Edouard Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergieres). Claude Monet (Palazzo
Pagina 41 di 54
Ducale a Venezia, Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee). Edgar
Degas (Lezione di ballo, L’assenzio, La tinozza). Auguste Renoir (La Grenouillére, Moulin de la
Galette, Colazione dei canottieri). Gli altri impressionisti. Pissarro (Entrata del villaggio di Voisins).
Sisley (Neve a Louveciennes). Callebotte (I rasieratori di parquet).
UNITÀ 27. Tendenze post-impressionistiche.
Paul Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire). Georges
Seurat (Una bagnade ad Asniéres, Una domenica al pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo).
Paul Gauguin (Il Cristo giallo, Aha oe fei ?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?). Vincent
van Gogh (La casa gialla, I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Campo di grano con
volo di corvi).Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge).
Volume 5°
UNITÀ 28. Verso il crollo degli Imperi Centrali.
Dalla Belle èpoque alla prima guerra mondiale. I presupposti per l’Art Nouveau, William Morris. Art
Nuoveau, Adolf Loos, Victor Horta. Gustav Klimt (Nudo disteso verso destra, Giuditta, Ritratto di
Adele Bloch-Bauuer, Danae, La culla). L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra
Kunstgewerbeschule e Secessione, Joseph Maria Olbrich (Palazzo della Secessione), Adolf Loos
(Casa Scheu). I Fauves e Henri Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, Pesci rossi).
L’Espressionismo. Il gruppo Die Brücke, Kirkner, Heckel, Nolde. Edward Munch (La fanciulla malata,
Sera nel Corso Karl Johan, Il grido, Pubertà). Oskar Kokoschka (Ritratto di Karl Moll, La sposa nel
vento). Egon Schiele (Autoritratto, Abbraccio).
UNITÀ 29. L’inizio dell’Arte Contemporanea.
Il Novecento delle avanguardie storiche. Il Cubismo. Pablo Picasso (Pasto frugale, Poveri in riva la
mare, Famiglia d’acrobati con scimmia, Les damioselle d’Avignon, Ritratto di Ambrosie Vollard, I tre
musici, Guernica). Georges Braque (Casa dell’Estaque, Violino e brocca, Le quotidien, violino e pipa,
Natura morta con clarinetto). Juan Gris (Ritratto di Picasso, Fruttiera e bottiglia d’acqua).
UNITÀ 30. La stagione Italiana del Futurismo.
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. Umberto Boccioni (La città che sale. Stati d’animo,
Forme uniche nella continuità dello spazio). Antonio Sant’Elia (La centrale elettrica, La Città nuova,
Stazioni d’aeroplani e treni ferroviari). La ricostruzione futurista dell’universo. Giacomo Balla
(Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Compenetrazioni iridescente). Dall’arte
meccanica all’aeropittura. Enrico Prampolini (Composizione B3, Intervista con la materia).
UNITÀ 31. Arte tra provocazione e sogno.
Il Dada. Hans Arp (Die Grablegung der Vogel und Schmetterlinge). Marcel Duchamp (Fontana,
L.H.O.O.Q). Man Ray (Cadeau, Le violon d'Ingres). L’arte dell’inconscio: il Surrealismo. Max Ernst (Le
Pleiadi, La vestizione della sposa). Joan Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Pittura, La scala
dell'evasione, Blu III). René Magritte (L'uso della parola, La bella prigioniera, Le passeggiate di
Euclide, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali). Salvador Dalí (Giraffa infuocata, Venere di
Milo a cassetti, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un volto e
di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape).
UNITÀ 32. Oltre la forma. L’astrattismo.
Der Blaue Reiter. Franz Marc (I cavalli azzurri). Vasilij Kandinskij (Il cavaliere azzurro, La varietà della
vita, Murnau. Paesaggio estivo, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni cerchi). Paul Klee (Il fohn nel
giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Burattini, Fuoco nella sera, Monumenti a G.). Piet Mondrian
(Mulino di sera, Mulino al sole,L'albero blu, Composizione in rosso,blu e giallo, Composizione).
G.Thomas Rietveld (Sedia rosso-blu).
Il Razionalismo in architettura. L’esperienza del Bauhaus (Poltrona Barcellona, Poltrona Vassilij).
Walter Gropius (Prospetti e veduta nuova sede del Bauhaus, Officine della ditta Fagus). Le
Courbusier (Villa Savoye, Schema strutturale a pianta libera, con solai, scale e pilastrini in
calcestruzzo, Schema del Modulor, Unità di abitazione di Marsiglia, Progetto urbanistico per
Chandigarh, Cappella di Notre-dame-du-Haut). Frank Lloyd Wright (Balloon frame, Robie House,
Casa sulla cascata, The Solomon R. Guggenheim Museum).
L’architettura fascista, Giuseppe Terragni (Casa del Fascio), Marcello Piacentini (Palazzo di
Giustizia). Giovanni Michelucci (Stazione di S.M.Novella di Firenze, Chiesa di S.Giovanni Battista).
UNITA’ 33. La metafisica. Il richiamo all’ordine e l’Ecol de Paris
Pagina 42 di 54
Giorgio De Chirico (L'enigma dell'ora, Le Muse inquietanti, Villa romana, La vittoria, Trovatore, Piazza
d'Italia con statue e roulotte). Carlo Carrà (I funerali dell'anarchico Galli, Simultaneità: donna al
balcone, La musa metafisica, Le figlie di Loth, Il pino sul mare). Giorgio Morandi (Natura morta
metafisica, Natura morta di oggetti in viola). Albero Savinio (Apollo, I genitori). Marc Chagall (Re
David in blu). Amedeo Modigliani (Nudo disteso con i capelli sciolti, Ritratti).
UNITA’ 34. Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra.
Verso il contemporaneo. Henry Moore (Figura giacente, Madre distesa con bambino, madre con
bambino). Alexander Calder (Tralcio a forma di ”S”, La grande vitesse). Arte Informale. L’informale in
Italia, Alberto Burri (Sacco 5P, Sacco e rosso, Cretto G1), Lucio Fontana (Concetto spaziale, attese,
Concetto Spaziale, attesa). L’informale in America. Jackson Pollock (Foresta incantata, Pali blu).
Mark Rothko (Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red, N° 301, N° 207, Untitled). Tra New
Dada e Nouveau Rèalisme. Robert Rauschenberg (Bed). Jasper Johns (Flag). Jean Tinguely (MetaMatic N° 14). Pop Art. Roy Lichtenstein (Whoom, M-Maybe, Tempio di Apollo). Claes Oldenburg
(Toilette molle, Gelati da passeggio, Vite arcuata, Volani). Andy Warhol (Marilyn, Sedia elettrica,
Minestra in scatola Campbell’s).
RISORSE UTILIZZATE
Libri di testo
DISEGNO
testo: LINEEIMMAGINI (vol. unico) di Franco Formisani, ed. Loescher –Tema, 2009.
STORIA DELL’ARTE
testi: ITINERARIO NELL’ARTE di G.Cricco e F. P. Di Teodoro, Zanichelli
(vol. 4° parte e vol. 5°) seconda edizione, versione arancione
Altri testi
Rivista d’arte Artedossier, Giunti, Firenze
Altro materiale
Strumenti multimediali
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. Maurizio Miante
…………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 43 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
FILOSOFIA
Allegato A
1.CONTENUTI DISCIPLINARI
RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA
DA KANT A FICHTE:
Dall’Io penso all’Io Assoluto
Oltre il criticismo. Il dibattito post-kantiano
Docente:
Prof. Elisa Depiccoli
Classe 5^ D
IL ROMANTICISMO
a. s. 2013-2014
Caratteri della cultura romantica
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
vitalismo
naturalistico
Gli studentiTitanismo,
della VDironia,
hanno
seguito
con crescente interesse e motivazione le lezioni in
classe. Il profitto
è mediamente
discreto
ed alcuni studenti hanno ottenuto un livello di
La contrapposizione
tra ragione
e intelletto
preparazione ottimo e anche eccellente
J.FICHTE e L' IDEALISMO
I Fondamenti della Dottrina della
scienza. La missione del dotto
CONTENUTI
DISCIPLINARI
complessive di lezione: 88)
I Discorsi
alla nazione(ore
tedesca
F.SCHELLING
FILOSOFIA
La Naturphilosophie
1.CONTENUTI
DISCIPLINARI
La concezione dell'arte
G.KANT
HEGEL
DA
A FICHTE:
Gli scritti
teologici
giovanili.
Dall’Io
penso
all’Io Assoluto
La Fenomenologia
dello Spirito.
Oltre
il criticismo. Il dibattito
post-kantiano
Il sistema hegeliano
delle scienze filosofiche in compendio
ILL’Enciclopedia
ROMANTICISMO
Spirito soggettivo,
oggettivo,
assoluto
Caratteri
della cultura
romantica
La filosofiaironia,
dello vitalismo
storia
Titanismo,
naturalistico
Locontrapposizione
stato. Il dibattito tra
sul ragione
giustificazionismo
La
e intelletto hegeliano
J.FICHTE e L' IDEALISMO
A.SCHOPENHAUER
I Fondamenti
della Dottrina della
L’orientalismo:
il velodel
di Maya
scienza.
La missione
dotto
La Volontà
vivere tedesca
I Discorsi
alladi
nazione
Le vie di liberazione
F.SCHELLING
La Naturphilosophie
S.concezione
KIERKEGAARD
La
dell'arte
Essenza ed esistenza
Il Singolo
Pagina 44 di 54
La Critica all’idealismo
La fede come paradosso e scandalo
G. HEGEL
Gli scritti teologici giovanili.
La Fenomenologia dello Spirito.
Il sistema hegeliano
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto
La filosofia dello storia
Lo stato. Il dibattito sul giustificazionismo hegeliano
A.SCHOPENHAUER
L’orientalismo: il velo di Maya
La Volontà di vivere
Le vie di liberazione
S. KIERKEGAARD
Essenza ed esistenza
Il Singolo
La Critica all’idealismo
La fede come paradosso e scandalo
Da FEUERBACH a MARX
DESTRA E SINISTRA HEGELIANE
Feuerbach: teologia ed antropologia
Marx: filosofia come prassi
Il materialismo dialettico
La critica all’ideologia
Il Manifesto del partito comunista
Il capitalismo: meccanismi e contraddizioni
Il comunismo
IL POSITIVISMO
Il riduzionismo e la critica alla metafisica
Il positivismo francese: Comte
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
L’evoluzionismo inglese
Darwin e Spencer
F. NIETZSCHE
La nascita della tragedia e la fase estetica
La fase illuministica e la filosofia del mattino
Pagina 45 di 54
Metodo genealogico e prospettivismo
La morte di Dio. Il nichilismo
Il superuomo e la Volontà di potenza
Così parlò Zarathustra
L’Eterno ritorno dell’Uguale
L’EPISTEMOLOGIA tra ‘800 e ‘900
La crisi del meccanicismo
IL Circolo di Vienna. Schlick e il verificazionismo
Carnap e la confermabilità
Popper e il criterio di falsificazione
Kuhn: paradigmi e rivoluzioni.
H. BERGSON
Il tempo della vita
S.FREUD E LA PSICOANALISI
Dall’ipnosi alle libere associazioni
La metapsicologia.
Le due topiche. Al di là del principio del piacere
La sessualità infantile
Il disagio della civiltà
E’ stata approfondita, in prospettiva storico-filosofica, la tematica “Intellettuali di area
tedesca durante il nazismo” con particolare riferimento a M. Heidegger e il suo ruolo
accademico negli anni ’30, alle filosofie dopo Auschwitz ( H. Arendt e la banalità del male,
K. Jaspers e il tema della colpa) e alla persecuzione antisemita. .
Sono stati letti ed analizzati in classe i seguenti testi:
“La filosofia che si sceglie dipende dall’uomo che si è”
Il manifesto dell’idealismo da Dottrina della Scienza di J. Fichte
“ La filosofia come pensiero del mondo” da Lineamenti di Filosofia del diritto di Hegel
“Borghesia e proletariato” dal Manifesto del partito comunista” di Karl Marx
“Le tre metamorfosi” da Così parlò Zarathustra di Nietzsche
“L’annuncio di Zarathustra” da Così parlò Zarathustra
“La morte di Dio” da La Gaia Scienza di Nietzsche
“Trasvalutazione dei valori e volontà di potenza” di F. Nietzsche
Pagina 46 di 54
“La morale dei signori e degli schiavi” da Al di là del bene e del male di Nietzsche
“ L’ Il super io ovvero la coscienza morale” e “L’io ovvero il luogo dell’equilibrio tra
desiderio e azione” dalle Lezioni di S. Freud
Da “ Il Nuovo Protagonisti e testi della filosofia” di Abbagnano-Fornero: volume 2B: Unità
8: capitoli I (escluso Jacobi, Hamann ed Herder e la polemica sullo spinozismo e
Humboldt) 2 (escluso La dottrina della conoscenza e la filosofia politica), 3 (esclusi 5,6,7)
Unità 9 ( escluso sezioni della logica). Volume 3 A: Unità 1, Unità 2 (esclusi Ruge e
Bauer, Stirner e Strauss), Unità 3 (esclusi i paragrafi relativi a Filosofia sociale in Francia,
sociocrazia e divinizzazione della storia dell’uomo, J. Stuart Mill, biologia e psicologia in
Spencer, Roberto Ardigò). Unità 4, cap. I, paragrafo 7: Bergson. Tempo durata e libertà.
Unità 6, Unità 7, capitolo 1 e 2,. Volume 3 B: Unità 12. cap. 2 ( escluso Neurath,
Reichenbach e Kelsen), capitolo 3 , Unità 13, paragrafo relativo a T. Khun
STORIA
ORE DI LEZIONE: 86
L’EUROPA NELL’ULTIMO VENTENNIO DELL’800
L’ ITALIA NELL’ ETA’ CRISPINA.
Il socialismo italiano. I congressi, le correnti, il dibattito interno.
Da Leone XIII a Pio X
I tumulti di fine secolo.
NAZIONALISMO E ANTISEMITISMO
L’affare Dreyfuss, i pogrom in Russia, il razzismo
T. Herzl e il sionismo
LA QUESTIONE D'ORIENTE
IMPERIALISMO E RIFORME
Inghilterra,Germania, Francia
Dall’'indipendenza greca ai difficili rapporti
internazionali nella penisola balcanica.
Le guerre balcaniche e le premesse della prima guerra mondiale.
LA REALTA’ DELL'EUROPA INDUSTRIALE
E LA NASCITA DEL MOVIMENTO OPERAIO
’
.
Pagina 47 di 54
Modelli di industrializzazione in Europa
Anarchismo e socialismo. La Seconda Internazionale
La Russia tra industrializzazione e autocrazia
La Francia tra democrazia e reazione
La socialdemocrazia, il modello leninista, il modello inglese
L'ETA' GIOLITTIANA
IMPERIALISMO E COLONIALISMO
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA CRISI DEGLI IMPERI COLONIALI
Il DOPOGUERRA IN ITALIA
LA RIVOLUZIONE RUSSA.
GLI ANNI '20 e '30 in EUROPA
IL FASCISMO ED IL NAZISMO
LA CRISI DEL '29 NEGLI STATI UNITI
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
LA NASCITA DEL BIPOLARISMO
IL DIBATTITO SULL'UNICITA' DEL CRIMINE NAZISTA
Ernst Nolte: Il passato che non vuole passare. Arcipelago Gulag e Auschwitz. Un dibattito.
IL SECONDO DOPOGUERRA
La realtà italiana tra il ’45 e il ’48.
La Costituzione repubblicana.
IL CONTESTO INTERNAZIONALE NEGLI ANNI ’50 E ’60
L’Europa nel secondo dopoguerra. Il rapporto Kruscev e la crisi ungherese. La svolta di
Kennedy negli Stati Uniti. .
L’UNIONE EUROPEA
Aspetti della storia contemporanea negli anni ’60, ’70, ’80 e ‘90
Pagina 48 di 54
EDUCAZIONE CIVICA
10 ore
Sono state analizzate le seguenti parole chiave :
Liberalismo, democrazia, europeismo, razza, razzismo, genocidio, antisemitismo,destra,
sinistra, soviet, totalitarismo
Partecipazione ad eventi:
Incontro in Accademia dei Concordi
sulla prima guerra mondiale, in occasione del
centenario
Iniziative ed approfondimenti:
Lettura del quotidiano in classe
Lezione su Jung e gli archetipi culturali a cura della dott. Emilia Canato
Lettura del Manifesto del futurismo a cura dello studente Manuel Chinaglia
Lezione sulla teoria darwiniana a cura dello studente Fabio Grandi
Lezione dello studente Pietro Bragioto sulle origini della psicologia scientifica
Lezione sulla crisi del meccanicismo tra ‘800 e ‘900 a cura degli studenti di VE Beatrice
Timircan e Alessandro Campice
Sono stati proposti alcuni filmati relativi a:
La soluzione finale e i campi di sterminio
Discorsi di Martin Luther King, Papa Giovanni XXIII, J. Kennedy (a cura dello studente
Andrea Stoppa)
METODOLOGIE
Accanto alla lezione frontale è stato offerto ampio spazio al dialogo in classe. La classe
ha partecipato con interesse alle attività promosse dalla docente e nell’ambito della
“Settimana della cultura scientifica”. Per quanto attiene le scelte metodologico-didattiche
si ritiene che Il punto d'arrivo dell'insegnamento della filosofia e della storia sia la
formazione di menti ricche di nozioni teoriche, capaci di impostare e svolgere in maniera
metodica i problemi, in grado di leggere in modo critico la realtà che li circonda.
Valorizzando il dialogo si cerca di creare nei giovani una ragione aperta, capace di
difendersi da sollecitazioni di carattere irrazionalistico o angustamente pragmatistico: la
ragione aperta è quella che sa di avere in sè tutti i correttivi degli errori che, in quanto
ragione umana, può compiere e che sa individuare itinerari nuovi. In storia il confronto in
classe ha portato il discorso storico sull'attualità e sulle problematiche più interessanti per
gli allievi. Gli alunni hanno sempre dimostrato vivo interesse verso le proposte culturali
della docente, hanno collaborato attivamente, mantenendo nell’intero triennio un
atteggiamento corretto e disponibile.
RISORSE UTILIZZATE
Pagina 49 di 54
Per quanto riguarda la storia i capitoli trattati quest’anno del manuale in adozione “Profili
storici” di Giardina, Sabbatucci, Vidotto sono stati: cap. 21 e cap.23 Stato e società
nell’Italia unita del vol. 2. Del volume 3 sono stati trattati i capitoli: 1, 2, 3 (esclusi
Imperialismo e riforme negli Stati Uniti e America latina e rivoluzione messicana) capitoli
4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (escluso Regimi populisti in America latina), capitolo 13, 14
(escluso la rinascita del Giappone), capitolo 15 ( esclusi i paragrafi Rivoluzione
nasseriana in Egitto, Indipendenza dell’Africa, Terzo mondo, Trasformazioni dell’America
latina), capitolo 16 ( esclusi i paragrafi Gli anni del centrismo e Alla ricerca di nuovi
equilibri, capitolo 17( esclusi Europa occidentale negli anni del benessere e Medio Oriente
e guerra arabo israeliana), capitolo 18 (solo il paragrafo 8 La Cina di Mao) capitolo 19 I
capitolo 20 paragrafo 9 Il Concilio Vaticano II, capitolo 24.
Nel lavoro in classe sono stati
utilizzati, accanto ai manuali in adozione i seguenti testi:
E. Hobsbawm, Il secolo breve (1914-1991) Rizzoli, Milano 2000
M. Revelli, Oltre il Novecento, Einaudi, Torino 2002
V. Castronovo L’eredità del Novecento, Einaudi, Torino 2001
M. Revelli La politica perduta, Einaudi,Torino 2003.
In filosofia oltre al manuale in adozione (Abbagnano-Fornero, Il nuovo Protagonisti e testi
della storia della filosofia, Paravia, Milano 2007) sono stati utilizzati i seguenti testi:
Ciuffi, Luppi, Vigorelli, Dialogos, Milano 2001
Tornatore, Ferrisi, Polizzi, Filosofia. Testi e argomenti, Loescher, Torino 2000
T.Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino 2003
S. Freud, Al di là del principio del piacere, Varese 1999
Boniolo, Vidali, Argomentare,vol.3, Milano 2005
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. ………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 50 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
Allegato A
RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA
Docente
Prof. Giovanna Celio
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
Il livello delle conoscenze della classe è da considerarsi eterogeneo sia in relazione agli interessi
personali che agli argomenti proposti, sia alle capacità individuali. Le conoscenze raggiunte si
possono considerare buone e in alcuni casi ottime per la totalità degli alunni che, per cinque anni, si
sono applicati con diligenza, impegno vivo e disponibilità al lavoro proposto dalla docente.
Gli studenti hanno dimostrato, globalmente, di saper applicare nella pratica le conoscenze acquisite
dal lavoro svolto in palestra. Sanno gestire autonomamente la parte iniziale della lezione
(riscaldamento) ; conoscono il linguaggio motorio specifico all’ interno dei diversi contesti operativi.
Organizzano spazi, tempi, attività motorie di squadra, di gruppo e individuali. Conoscono e applicano
tecniche e tattiche semplici e le regole essenziali di alcuni giochi sportivi di squadra (pallacanestro,
pallavolo, calcetto, pallamano, hockey, baseball, tennis, badminton…).
Il livello delle competenze è da considerarsi mediamente ottimo.
La classe ha così raggiunto complessivamente abilità esecutive buone e in diversi casi ottime.. Solo
pochissimi alunni sono dotati di discrete capacità di esecuzione. In generale si riscontra un buon
livello delle capacità pratiche e operative, anche perchè molti di loro hanno praticato e continuano a
praticare sport di diverso genere a livello agonistico sia di squadra che individuale.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Attività multifunzionali per migliorare e controllare azioni semplici e complesse ed
esercitazioni di coordinazione con piccoli attrezzi e a corpo libero;
Pratica sportiva della pallacanestro, concetti di base, elementi tattici essenziali;
Pagina 51 di 54
Pratica sportiva della pallavolo, fondamentali, ruoli, situazioni di gioco;
Pratica sportiva del calcetto,concetti di base,esercizi individuali, gioco di squadra;
Pratica sportiva della pallamano, concetti di base, esercizi individuali, gioco di squadra;
Attività di pre-atletica generale, di preacrobatica con trampolino elastico, di ginnastica
artistica di base, di resistenza ed esercizi specifici alle diverse specialità sportive;
Pratica sportiva del badminton, dell’ hochey, tennis, baseball;
Esercitazioni di stretching ad ispirazione yoga e di pilates ( guidato da una compagna di
classe);
Ore di lezione effettivamente svolte: n. 46
Le restanti 8 ore saranno dedicate all’ affinamento del gesto nelle diverse attività di squadra.
RISORSE UTILIZZATE
E’ stato utilizzato tutto il materiale a disposizione della scuola depositato in palestra.
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente
prof. ………………………..
I Rappresentanti di Classe
……………………………….
……………………………….
Pagina 52 di 54
Po--
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”
fondato nel 1923
RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE
Docente
Prof. Oscar Mason
Classe 5^ D
a.s. 2013-2014
NOTE DELL’INSEGNANTE RELATIVE ALLA CLASSE
La classe ha dimostrato buon interesse e una vivace partecipazione. Sono stati particolarmente validi i
momenti di discussione a conclusione degli argomenti presentati dal docente o dagli studenti stessi.
Il profitto è mediamente molto buono, con alcune eccellenze.
La classe ha assunto criteri per sapersi orientare nel variegato mondo religioso odierno e per cogliere la
presenza dei valori religiosi nel contesto laico della nostra società.
Gli studenti sono cresciuti nel rispetto delle regole e si sono comportati in modo corretto.
CONTENUTI DISCIPLINARI (ore complessive di lezione: 29
La persona: individuo alla ricerca della felicità.
La ’’regola d’oro’’… Non fare ciò che non vorresti fatto a te.
Risorse: Chi sono io in tutte le mie risorse
Intelligenza libertà e volontà
A cosa oggi sono sensibile?
Chi sono io: ambiente materiale
Chi sono io: l’influenza del mondo esterno umano (aspetto religioso)
Differenza fede e religione
’’Stranezze’’ di tante religioni (3 lezioni)
Il nostro corpo: discussione sui comportamenti sessuali
Predisposti lavori di gruppo su tematiche di bioetica
Fecondazione assistita
Cellule staminali posizioni e dibattito per le religioni.
Clonazione 1 parte essere ’’Uomo essere unico e irripetibile?’’
Clonazione 2 parte
Video ’’Custode di mia sorella’’ Problemi etici (2 lezioni)
La clonazione: implicanze etiche
Aborto confronto e dibattito in classe
Eutanasia: confronto e dibattito in classe
Eutanasia discussione in classe
Vita come Vocazione a cose grandi.
Riguardando al percorso di I.R.C di questi cinque anni…
RISORSE UTILIZZATE
Libri di testo
L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI, Torino.
Altri testi
La Sacra Bibbia, documenti del Magistero Cattolico (Evangelium Vitae, Pacem in Terris)
Altro materiale
Video da Internet, spezzoni di film, articoli di quotidiani.
Pagina 53 di 54
Rovigo, 15 maggio 2014
Il Docente prof.
……………………………..
I Rappresentanti di Classe
………………………………..
………………………………..
Pagina 54 di 54