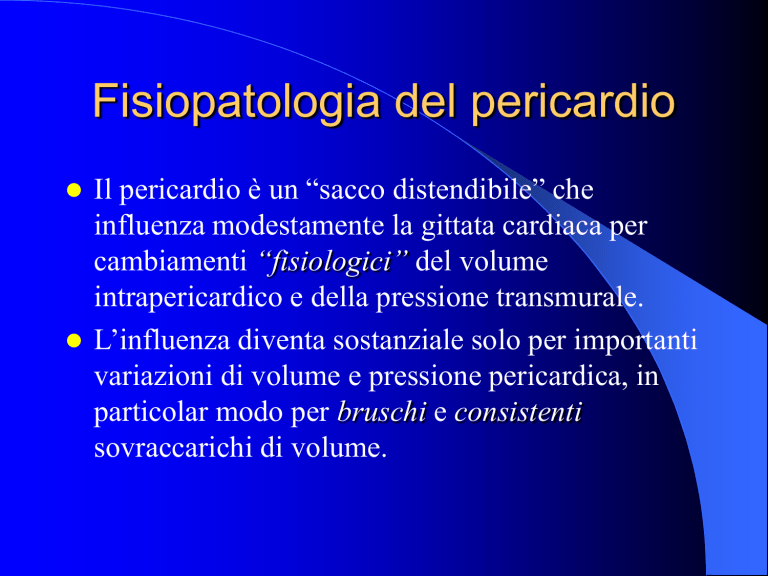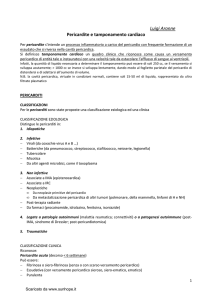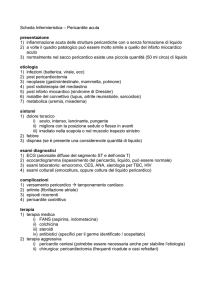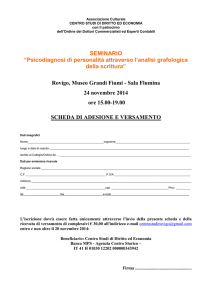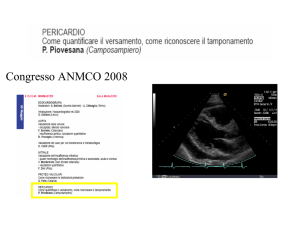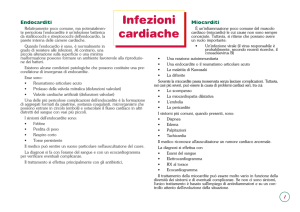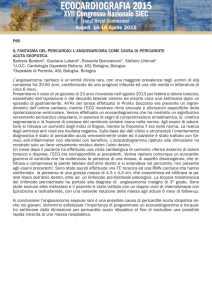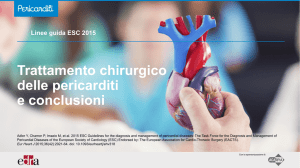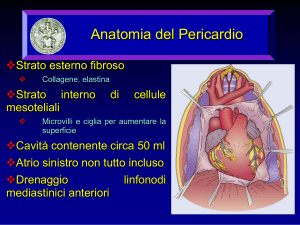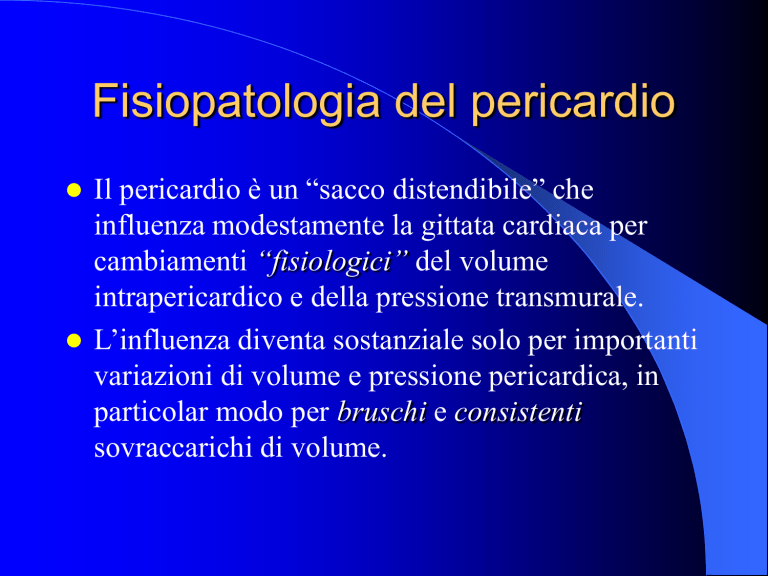
Fisiopatologia del pericardio
Il pericardio è un “sacco distendibile” che
influenza modestamente la gittata cardiaca per
cambiamenti “fisiologici” del volume
intrapericardico e della pressione transmurale.
L’influenza diventa sostanziale solo per importanti
variazioni di volume e pressione pericardica, in
particolar modo per bruschi e consistenti
sovraccarichi di volume.
Curva pressione/volume del
pericardio
Pressione (mmHg)
25
20
15
normale
10
sovraccarico
di volume
5
10
0
15
0
20
0
25
0
27
0
27
5
35
0
40
0
45
0
50
0
55
0
57
0
58
0
60
0
0
Volume (ml)
In caso di bruschi e consistenti sovraccarichi di volume la curva pressionevolume raggiunge la porzione esponenziale: la pressione pericardica
aumenta, il pericardio limita fortemente una successiva dilatazione cardiaca e
si contrappone al riempimento diastolico.
Definizione di pericardite
acuta
Sindrome dovuta all’infiammazione dei
foglietti pericardici; è caratterizzata da:
Dolore toracico
Sfregamenti pericardici
Alterazioni ECGgrafiche
Epidemiologia
Mancano
dati certi di prevalenza ed
incidenza delle pericarditi nella
popolazione generale.
Diagnosi in 1/1000 ospedalizzazioni.
Incidenza 2-6% su casistiche
autoptiche.
Classificazione
Eziologica
Patogenetica
Istopatologica
Classificazione eziologica
1.
2.
Idiopatica
Infettiva (virali, micobatteriche, batteriche, fungine, protozoi, rickettsie,
parassiti, anaerobi, altri)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Infarto miocardico acuto (S. di Dressler)
Uremia (uremia non trattata, associata ad emodialisi)
Neoplasie (k polmonare e mammario, leucemia, LDH, linfomi)
Traumi (toracici, impianto PM, procedure diagnostiche cardiologiche)
Malattie autoimmuni (RAA, LES, AR, Sclerodermia, connettivite mista)
Farmaci (procainamide, INI, penicillina, doxorubicina, dantrolene)
Radiazioni
Aneurisma dissecante dell’aorta
Mixedema
Chilopericardio
Classificazione
istopatogenetica
Sierose (idiopatiche, virali, da patologie sistemiche)
Fibrinose e sierofibrinose (post-chirurgiche, postinfartuali, uremiche e da collagenopatia)
Emorragiche (tubercolari, neoplastiche)
Purulente (batteriche, micotiche)
Caseose (tubercolari)
Sintomi e segni clinici
Dolore toracico (infiammazione dei foglietti pericardici e spesso della
pleura, e/o distensione del sacco pericardico in caso di abbondante
versamento)
Tachicardia
Febbre
Tosse
Dispnea (correlata a necessità di respiro superficiale per evitare dolore o a
ripercussioni emodinamiche da abbondante versamento)
Sfregamento pericardico (patognomonico; la sua assenza non
esclude la diagnosi)
Perdita di peso (se malattia sistemica sottostante)
Confronto clinico tra il dolore nella
pericardite e nella cardiopatia ischemica
Pericardite
Localizzazione
Tipo
Influenza dei
movimenti toracici
Durata
precordiale, margine
sinistro del trapezio
acuto, pleuritico, raramente
sordo o oppressivo
dai movimenti toracici
ore o giorno
Sforzo
nessuna relazione
Influenza della
si allevia con inclinazione
postura
in avanti e in ortostatismo
Fenomeni neurovegetativi
assenti
Cardiopatia ischemica
retrosternale, braccio sinistro
costrittivo, gravativo
nessun effetto
angina fino a 20 min,
IMA da 30 min a ore
angina stabile, instabile, IMA
nessun effetto
nausea, vomito, sudorazione
Diagnosi eziologica in 100
pazienti con pericardite acuta
Pericardite
acuta idiopatica
Pericardite neoplastica
Pericardite tubercolare
Distiroidismo
Piopericardite
Collagenopatie
Aneurisma dissecante dell’aorta
78%
7%
4%
4%
3%
3%
1%
Strumenti diagnostici
Elettrocardiogramma
Radiografia
del torace
Indici bioumorali
Ecocardiogramma
Pericardiocentesi
Elettrocardiogramma
Il test diagnostico più semplice ed
utilizzato.
Le alterazioni sono dovute ad una corrente
di lesione per l’infiammazione miocardica
subepicardica o dell’atrio e possono
manifestarsi dopo ore o giorni dall’esordio
del dolore.
Segni elettrocardiografici nella
pericardite acuta
Sopraslivellamento concordante del tratto ST nella
maggioranza delle derivazioni, tranne aVR e V1.
Assenza di sottoslivellamento del tratto ST, tranne che nella
derivazione aVR, e occasionalmente in V1.
Sottoslivellamento del tratto PR.
Ritmo sinusale (di solito); occasionalmente FA o flutter
atriale.
Le onde T diventano negative solo dopo che i tratti ST
ritornano all’isoelettrica.
I voltaggi del QRS diminuiscono se è presente un
versamento pericardico considerevole.
Alternanza elettrica occasionale (più frequente nel
tamponamento pericardico)
Fasi evolutive elettrocardiografiche
nella pericardite acuta.
Fasi
I
II precoce
II tardiva
III
IV
ST
Onda T
Segm PR
elevato
positiva
depresso o isoelettrico
isoelettrico positiva
isoelettrico o depresso
isoelettrico appiattita
isoelettrico o depresso
isoelettrico invertita
isoelettrico
isoelettrico positiva
isoelettrico
Nel 50 % dei casi l’ECG non è suggestivo, non presentando la
classica evoluzione nelle 4 fasi.
Condizioni di sopraslivellamento del
tratto ST oltre all’IMA.
Condizioni varie
Ipertrofia ventricolare
sinistra
BBS
Pericardite acuta
Iperpotassiemia
Radiografia del torace
Scarso valore diagnostico nella pericardite
acuta, non complicata da versamento.
Utile nel definire l’eziologia (pericardite
secondaria a TBC, neoplasia o polmonite).
Se presente versamento abbondante (> 250
ml) caratteristico aspetto dell’ombra
cardiaca a “bottiglia d’acqua”.
Indici bioumorali
Emocolture (per escludere batteriemie)
Tampone faringeo e feci (se si sospetta eziologia virale)
Test cutaneo alla tubercolina
Analisi istologica del liquido pleurico, succo gastrico,
espettorato (se si sospetta infezione specifica)
TASL
Crioglobuline (infezione da mycoplasma)
Test per la mononucleosi e la toxoplasmosi
Indici tiroidei (ipotiroidismo)
Azotemia e creatinina (eziologia uremica)
ANA, ENA, ANCA e fattore reumatoide (LES e artrite
reumatoide)
Ecocardiogramma
E’ possibile
evidenziare un’iperrifrangenza
dei foglietti pericardici come segno di
pericardite pregressa o in atto.
Tecnica estremamente accurata e rapida
nella valutazione di un versamento
pericardico.
Pericardiocentesi
Poco utile ed affidabile a scopi diagnostici
routinari (alta incidenza di FP e FN).
Buona accuratezza diagnostica quando
utilizzata a scopo terapeutico, modesta
quando adottata unicamente a scopo
diagnostico.
Complicanze
Miocarditi
Versamento pericardicotamponamento
Pericardite costrittiva
Recidiva
Versamento pericardico
Si distinguono due forme:
Senza compressione cardiaca
Con compressione cardiaca
L’aumento della pressione intrapericardica dipende
da:
1. volume assoluto del versamento
2. Velocità di formazione del versamento
3. Caratteristiche fisiche del versamento
Versamento non iperteso
Può essere asintomatico o dare dolore sordo,
costante e oppressivo o manifestare sintomi da
compressione di strutture vicine: disfagia, tosse,
dispnea, singhiozzo, raucedine.
Radiografia del torace: ombra cardiaca a bottiglia
d’acqua.
ECG: riduzione voltaggio del QRS.
Ecocardiogramma: spazio ecoprivo tra epicardio e
pericardio parietale (per l’intera sistole e diastole).
Tamponamento cardiaco
Aumento della pressione intrapericardica tale da
limitare il riempimento diastolico ventricolare e
determinare ipotensione e ridotta perfusione
d’organo.
Se il versamento pericardico supera il volume di
riserva pericardica la pressione pericardica salirà
in modo notevole determinando una caduta quasi a
zero della pressione transmurale del VD.
Il tamponamento cardiaco può non evidenziarsi in
caso di ipovolemia e determinare una condizione
emodinamica di tamponamento a bassa pressione,
senza segni di ipertensione venosa.
Cause di tamponamento
cardiaco
Neoplasie maligne
Pericardite idiopatica
Uremia
IMA
Perforazione cardiaca iatrogena
Infezioni batteriche
Tbc
Radiazioni
Mixedema
Aneurisma dissecante dell’aorta
32-58%
14%
9-14%
9%
7,5%
5-7%
1-5%
4%
4%
4%
Reperti obiettivi di
tamponamento cardiaco
Pressione venosa sistemica elevata (100%)
Polso paradosso (98%)
Frequenza respiratoria 20/min (80%)
Frequenza cardiaca 100 bpm (77%)
Pressione arteriosa sistolica < 100 mmHg (64%)
Toni cardiaci attenuati (34%)
Rumori di sfregamento pericardico (29%)
Rapido calo della pressione arteriosa (25%)
Polso paradosso
Caduta della PA > 10 mmHg o totale scomparsa
del polso durante l’inspirazione.
E’ un’esagerazione della lieve normale riduzione
inspiratoria della pressione transmurale del VS
(diminuisce la pressione intratoracica e
pericardica; aumenta il riempimento atriale dx e
del VD e la gittata sistolica dx, il SIV si sposta a
sinistra; poiché il cuore opera in un volume finito,
il riempimento del VS e la sua gittata sistolica ).
Si osserva anche in: BPCO, TEP, shock
emorragico o settico, pericardite costrittiva,
cardiomiopatia restrittiva.
Ecocardiogramma e
tamponamento cardiaco
M-mode:
- Reciproche variazioni respiratorie nei ventricoli (aumento
inspiratorio nelle dimensioni del VD e decremento nel VS)
- Compressione della cavità ventricolare destra
- Pseudo-prolasso della valvola mitrale
Bidimensionale:
- Collasso protodiastolico VD e diastolico AD
- Collasso AS
- Variazioni reciproche nella dimensione delle camere
ventricolari con gli atti respiratori
- Vena cava inferiore dilatata
- Aspetto a cuore oscillante (“swinging heart”)
Pericardiocentesi
Il liquido pericardico può
essere evacuato tramite:
1. Pericardiocentesi
percutanea con ago o
con catetere
2. Pericardiotomia
attraverso finestra
pericardica
3. Pericardiectomia
parziale o estesa
Rischi e complicanze della
pericardiocentesi
Complicanze
mortali < 5%
Emopericardio acuto
Aritmie
Gravi crisi vagali
Pericardite costrittiva
Si verifica quando una densa fibrosi,
calcificazione e adesione dei foglietti
pericardici creano un guscio rigido
attorno al cuore limitandone il
riempimento.
Eziologia della pericardite
costrittiva
Idiopatica
Post-attinica
Post-cardiochirurgica
Post-pericardite non specifica
Post-infettiva
Neoplastica
Uremica
Post-traumatica
Sintomi e segni della
pericardite costrittiva
Sintomi
Segni
-astenia
-ortopnea
-tosse
-dispnea da sforzo
-disturbi addominali
-distensione addominale
-edema
-ascite
-epatomegalia
-versamento pleurico
-polso paradosso (1/3)
-segno di Kussmaul
-pressione venosa elevata
-Knock pericardico
-Retrazione sistolica itto
della punta
Differenze tra costrizione
cronica e tamponamento
Costrizione cronica
-Durata dei sintomi
-Dolore toracico
-Segno di Kussmaul
-Polso paradosso
-Ombra cardiaca al telecuore
-Calcificazione pericardica
-Knock protodiastolico
-Versamento pericardico
-Fibrillazione atriale
-Polso venoso (atrio dx)
mesi-anni
raro
spesso presente
lieve o assente
normale, raramente
spesso presente
spesso presente
assente
spesso presenti
XY profonde (onda W)
Tamponamento
ore-giorni
frequente
assente
notevole
di solito
assente
assente
sempre presente
assenti
X o XY
Knock pericardico: tono aggiunto protodiastolico
lungo la marginosternale di sinistra, corrisponde
alla brusca cessazione del riempimento rapido.
Segno di Kussmaul: turgore delle vene del collo in
inspirazione per aumento della pressione atriale
destra (presente anche nell’IMA dx, nella stenosi
della tricuspide, nelle cardiomiopatie restrittive;
non nel tamponamento cardiaco).
VERSAMENTO PERICARDICO
CRONICO IDIOPATICO
NON SI RISCONTRA CAUSA DEL VERSAMENTO
NO PROGRESSIONE DI MALATTIA DURANTE
PERIODO DI OSSERAVAZIONE
ALL’ECO: VERSAMENTO ANTERIORE
+VERSAMENTO POSTERIORE>20 MM A FINE
DIASTOLE
PERSISTENZA PER PIU’ DI TRE MESI
RACCOMANDAZIONI PER
VERSAMENTO PERICARDICO
CRONICO
PERICARDIOCENTESI, NON
OSSERVAZIONE
PERICARDIECTOMIA SOLO SE RECIDIVA DI
VERSAMENTO DOPO PERICARDIOCENTESI
Pericardite acuta recidivante
Definizione: attacchi ripetuti di pericardite in
pazienti senza evidenza di malattie sistemiche.
Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
1. La pericardite deve essere idiopatica
2. Deve essere documentata dalla presenza di
versamento pericardico, sfregamenti pericardici,
tipiche alterazioni ECGrafiche.
Patogenesi
Uno stimolo iniziale potrebbe determinare una
flogosi che si automantiene con meccanismi
immunologici:
1. E’ stata riscontrata un’alta prevalenza di
anticorpi antimiocardio nelle recidive di
pericardite idiopatica o postinfartuale.
2. E’ stato suggerito un meccanismo da citolisi da
linfociti T (natural killer).
3. E’ stata ipotizzata un’infezione virale persistente
da enterovirus.
Decorso
La frequenza delle recidive è del 15-32%.
Il problema delle recidive è di qualità della
vita per il dolore toracico che può essere
invalidante.
Il decorso è benigno e nel 40% dei casi si ha
una remissione spontanea: raramente è stata
segnalata l’evoluzione in costrizione o
tamponamento cardiaco.
Terapia delle pericarditi (1)
Scopo della terapia:
1. Alleviare i sintomi.
2. Ridurre o guarire l’infiammazione.
3. Rimuovere o curare la causa patogena
responsabile, se riconoscibile.
4. Intervenire sulle complicanze.
Terapia delle pericarditi (2)
Nella pericardite acuta idiopatica e virale la terapia è
basata sull’uso di:
FANS: -ASA (5-6 g/die)
-indometacina (100-200 mg/die)
Prednisone: 40-60 mg/die per 1-3 sett. (25 mg/die
in media). Graduale e lenta riduzione del dosaggio
fino a 0,15 mg/kg/die per ancora 2-4 sett. E poi
sospendere in tre mesi.
Terapia delle pericarditi (3)
La terapia delle recidive è difficile, perché spesso
inefficace e frustrante. La maggior parte degli
autori sconsiglia l’uso degli steroidi, tuttavia
esistono dati favorevoli sull’uso degli steroidi se
ad alti dosaggi (prednisone: 1 g/die e.v. per 3
giorni o 1-1,5 mg/kg/die per 4 sett.), perché in tal
modo avrebbero efficacia antimmunitaria e non
solo antinfiammatoria.
Risultati incoraggianti si sono ottenuti con la
colchicina (1 mg /die).