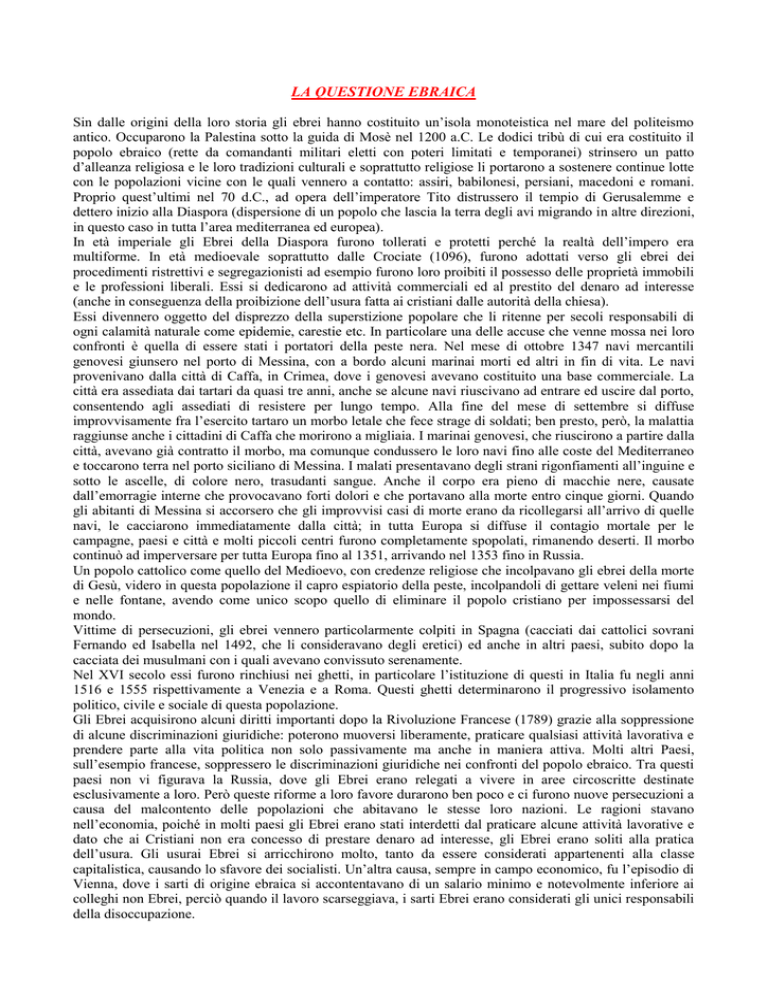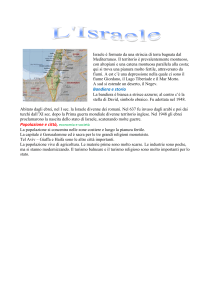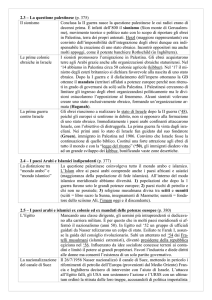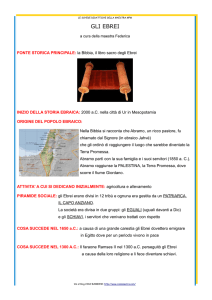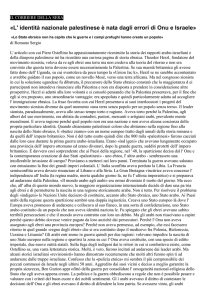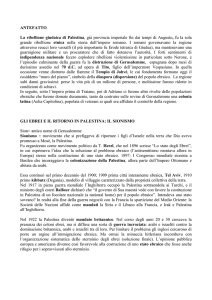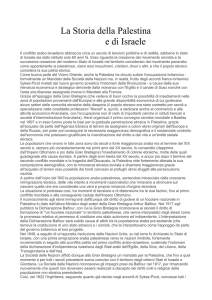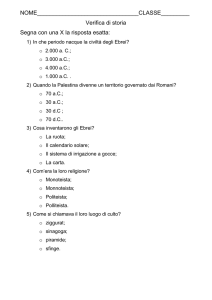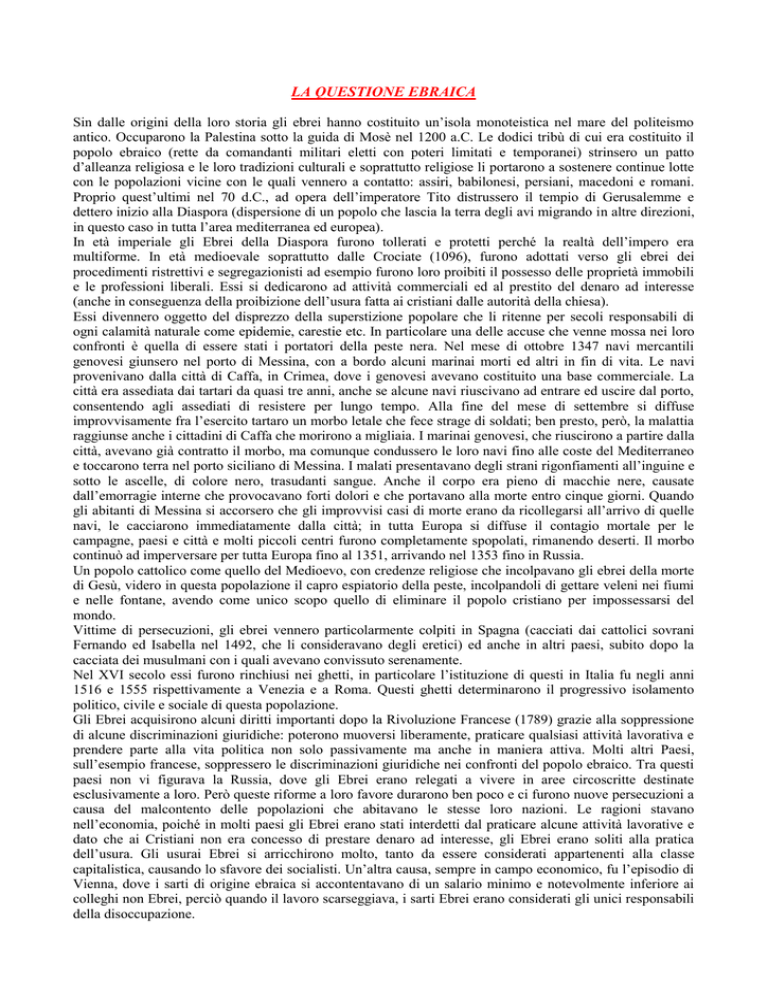
LA QUESTIONE EBRAICA
Sin dalle origini della loro storia gli ebrei hanno costituito un’isola monoteistica nel mare del politeismo
antico. Occuparono la Palestina sotto la guida di Mosè nel 1200 a.C. Le dodici tribù di cui era costituito il
popolo ebraico (rette da comandanti militari eletti con poteri limitati e temporanei) strinsero un patto
d’alleanza religiosa e le loro tradizioni culturali e soprattutto religiose li portarono a sostenere continue lotte
con le popolazioni vicine con le quali vennero a contatto: assiri, babilonesi, persiani, macedoni e romani.
Proprio quest’ultimi nel 70 d.C., ad opera dell’imperatore Tito distrussero il tempio di Gerusalemme e
dettero inizio alla Diaspora (dispersione di un popolo che lascia la terra degli avi migrando in altre direzioni,
in questo caso in tutta l’area mediterranea ed europea).
In età imperiale gli Ebrei della Diaspora furono tollerati e protetti perché la realtà dell’impero era
multiforme. In età medioevale soprattutto dalle Crociate (1096), furono adottati verso gli ebrei dei
procedimenti ristrettivi e segregazionisti ad esempio furono loro proibiti il possesso delle proprietà immobili
e le professioni liberali. Essi si dedicarono ad attività commerciali ed al prestito del denaro ad interesse
(anche in conseguenza della proibizione dell’usura fatta ai cristiani dalle autorità della chiesa).
Essi divennero oggetto del disprezzo della superstizione popolare che li ritenne per secoli responsabili di
ogni calamità naturale come epidemie, carestie etc. In particolare una delle accuse che venne mossa nei loro
confronti è quella di essere stati i portatori della peste nera. Nel mese di ottobre 1347 navi mercantili
genovesi giunsero nel porto di Messina, con a bordo alcuni marinai morti ed altri in fin di vita. Le navi
provenivano dalla città di Caffa, in Crimea, dove i genovesi avevano costituito una base commerciale. La
città era assediata dai tartari da quasi tre anni, anche se alcune navi riuscivano ad entrare ed uscire dal porto,
consentendo agli assediati di resistere per lungo tempo. Alla fine del mese di settembre si diffuse
improvvisamente fra l’esercito tartaro un morbo letale che fece strage di soldati; ben presto, però, la malattia
raggiunse anche i cittadini di Caffa che morirono a migliaia. I marinai genovesi, che riuscirono a partire dalla
città, avevano già contratto il morbo, ma comunque condussero le loro navi fino alle coste del Mediterraneo
e toccarono terra nel porto siciliano di Messina. I malati presentavano degli strani rigonfiamenti all’inguine e
sotto le ascelle, di colore nero, trasudanti sangue. Anche il corpo era pieno di macchie nere, causate
dall’emorragie interne che provocavano forti dolori e che portavano alla morte entro cinque giorni. Quando
gli abitanti di Messina si accorsero che gli improvvisi casi di morte erano da ricollegarsi all’arrivo di quelle
navi, le cacciarono immediatamente dalla città; in tutta Europa si diffuse il contagio mortale per le
campagne, paesi e città e molti piccoli centri furono completamente spopolati, rimanendo deserti. Il morbo
continuò ad imperversare per tutta Europa fino al 1351, arrivando nel 1353 fino in Russia.
Un popolo cattolico come quello del Medioevo, con credenze religiose che incolpavano gli ebrei della morte
di Gesù, videro in questa popolazione il capro espiatorio della peste, incolpandoli di gettare veleni nei fiumi
e nelle fontane, avendo come unico scopo quello di eliminare il popolo cristiano per impossessarsi del
mondo.
Vittime di persecuzioni, gli ebrei vennero particolarmente colpiti in Spagna (cacciati dai cattolici sovrani
Fernando ed Isabella nel 1492, che li consideravano degli eretici) ed anche in altri paesi, subito dopo la
cacciata dei musulmani con i quali avevano convissuto serenamente.
Nel XVI secolo essi furono rinchiusi nei ghetti, in particolare l’istituzione di questi in Italia fu negli anni
1516 e 1555 rispettivamente a Venezia e a Roma. Questi ghetti determinarono il progressivo isolamento
politico, civile e sociale di questa popolazione.
Gli Ebrei acquisirono alcuni diritti importanti dopo la Rivoluzione Francese (1789) grazie alla soppressione
di alcune discriminazioni giuridiche: poterono muoversi liberamente, praticare qualsiasi attività lavorativa e
prendere parte alla vita politica non solo passivamente ma anche in maniera attiva. Molti altri Paesi,
sull’esempio francese, soppressero le discriminazioni giuridiche nei confronti del popolo ebraico. Tra questi
paesi non vi figurava la Russia, dove gli Ebrei erano relegati a vivere in aree circoscritte destinate
esclusivamente a loro. Però queste riforme a loro favore durarono ben poco e ci furono nuove persecuzioni a
causa del malcontento delle popolazioni che abitavano le stesse loro nazioni. Le ragioni stavano
nell’economia, poiché in molti paesi gli Ebrei erano stati interdetti dal praticare alcune attività lavorative e
dato che ai Cristiani non era concesso di prestare denaro ad interesse, gli Ebrei erano soliti alla pratica
dell’usura. Gli usurai Ebrei si arricchirono molto, tanto da essere considerati appartenenti alla classe
capitalistica, causando lo sfavore dei socialisti. Un’altra causa, sempre in campo economico, fu l’episodio di
Vienna, dove i sarti di origine ebraica si accontentavano di un salario minimo e notevolmente inferiore ai
colleghi non Ebrei, perciò quando il lavoro scarseggiava, i sarti Ebrei erano considerati gli unici responsabili
della disoccupazione.
Nell’800 sorge una nuova forma di antisemitismo cioè un’attività anti- ebraica organizzata politicamente e
fondata su precise basi scientifiche.
Una delle questioni più importanti di questa continua persecuzione nei confronti degli Ebrei, è “L’Affaire
Dreyfus”: il capitano Albert Dreyfus venne accusato, nel 1894, di spionaggio e tradimento per aver
trasmesso ai tedeschi documenti segreti relativi all’esercito francese. Questo caso divise la Francia in due
schieramenti: i dreyfusardi e gli antidreyfusardi. I primi denunciarono l’alleanza dell’esercito e della Chiesa
e reclamarono la revisione del processo nel nome del rispetto del diritto e della verità. Riunitisi nella “ Ligue
des droits de l’homme”, fondata nel 1898, furono a poco a poco raggiunti dalla sinistra radicale o socialista,
laica e antimilitarista. Gli antidreyfusardi invece privilegiarono l’onore dell’esercito a scapito della verità.
Provenienti dalla destra cattolica, nazionalista ed antiparlamentare, essi non videro in Dreyfus che una spia
ed un traditore che, per le sue origini ebree, minacciò l’integrità nazionale. Si riunirono nella “Ligue de la
patrie française” e nella “Ligue des patriotes”.
L’antisemitismo nacque in Germania e si diffuse in Europa dando origine, come reazione, al movimento del
sionismo, movimento a carattere politico-religioso volto a riunire la Palestina a tutti gli ebrei dispersi nel
mondo. Fondatore fu Theodor Hertze il quale nel 1897 organizzò a Basilea il primo congresso sionista (dopo
aver assistito al processo contro Dreyfus, dove rimase scandalizzato dall’iniquità delle due parti) e collaborò
alla fondazione della banca nazionale ebraica i cui fondi sarebbero dovuti servire all’acquisto e alla messa in
valore dei terreni in Palestina (incentivare le attività produttive).
Nel 1909 sorse la prima città ebraica Tel-Aviv. La Gran Bretagna cercò di appoggiare questo movimento
tanto che nel 1917 il sionismo ottenne dall’Inghilterra la dichiarazione di Belfast, in questo documento ci si
impegnava a costruire un focolare ebraico in Palestina protetto da Londra secondo i programmi elaborati da
Hertze e dai suoi successori. Così si ebbe una notevole immigrazione ebraica che precedette la formazione
di colonie agricole, alla costituzione di centrali e di impianti per utilizzare e sfruttare le acque del Giordano.
Questo flusso immigratorio dette fastidio agli Arabi i quali si risentirono e da qui scaturirono violente lotte,
aggravatesi dopo il 1933 per la presenza ebraica che in Palestina andava sempre più aumentando a causa
delle persecuzioni naziste in Europa. Infatti, negli anni successivi alla prima guerra mondiale in Germania
l’antisemitismo si affermò come dottrina ufficiale del nazismo, teorizzato da Hitler e Rosemberg, il quale
nell’opera intitolata “ Il mito del XX secolo” teorizzava i principi che sfociarono nelle leggi razziali di
Norimberga (1935) alle quali dal 1938 si uniformò anche se in forma più blanda pure l’Italia fascista.
Durante la seconda guerra mondiale l’antisemitismo hitleriano (teorizzato oltretutto nella “soluzione zero”,
studiata da Hitler e quattordici ufficiali di stato il 20 gennaio 1942) toccò il suo apice con l’eliminazione
fisica di sei milioni di ebrei, ma anche di tre milioni di polacchi, 20 milioni di russi e persino degli oppositori
del nazismo, nei campi di sterminio. Questo annientamento degli Ebrei fu concepito come un fatto di pulizia
biologica, condotta infatti in modo industriale. Riguardo alla deportazione degli Ebrei nei campi di sterminio,
rimangono tutt’oggi molti interrogativi e questioni non chiare: potevano l’Europa, la Croce Rossa
internazionale, gli alleati di Hitler, gli Stati Uniti d’America, non sapere? Perché la Chiesa non si dichiarò
fermamente contraria a questo genocidio? Era veramente più importante occuparsi della costituzione dello
Stato di Israele?
Si crede che effettivamente gli USA sapessero, ma la questione degli Ebrei non era rilevante quanto la
vittoria su Hitler e il Giappone, così sottovalutarono il problema. Per quel che riguarda lo Stato di Israele, si
pensava questa fosse l’unica soluzione per mettere la parola fine a pogrom ed olocausti.
I tedeschi affermavano che anche se avessero perso la guerra, la vittoria sarebbe stata loro comunque poiché
sarebbero riusciti nel loro intento di sterminare il popolo ebraico e se per caso qualche sopravvissuto avesse
confessato l’accaduto, nessuno gli avrebbe creduto. Per molti tedeschi però questo problema non sarebbe mai
esistito, non credono o vogliono negare, poiché effettivamente il problema è rinascente, in quanto vediamo
che in Germania, ma non solo, stanno rinascendo gruppi o partiti politici di estrema destra, con riferimenti
chiari a Hitler e al nazismo, che creano problemi sociali molto pesanti, se pensiamo persino che l’Austria è
governata da un politico che si rifà alle idee dell’antisemitismo, col consenso del popolo. E ancora non sono
da dimenticare lo sterminio da parte di Milosevic nei confronti del popolo bosniaco e kosovaro, o tutti gli
stermini dei popoli più poveri dei quali si tratta sempre più di rado.
Il movimento sionista che ebbe un ruolo particolare durante e dopo la seconda guerra mondiale , vide
realizzare le proprie attese nel 1947 quando l’ONU decise la spartizione della Palestina tra Arabi ed
Ebrei, e soprattutto nel 1948 quando venne proclamato lo stato di Israele. La nascita dello stato di Israele ha
portato tragiche conseguenze cioè quattro guerre arabo-israeliane: la prima nel 1947-49, la seconda nel 1956,
la terza nel ’67 e la quarta nel ’73.
La creazione dello Stato fece incrementare l’afflusso degli ebrei dall’Europa centrale ed orientale e ribaltò la
consistenza della popolazione locale ponendo gli arabo- palestinesi in situazione di inferiorità giuridica e
numerica. In quel periodo pur di non sottostare al potere israeliano 750mila palestinesi abbandonarono il
paese rifugiandosi negli stati arabi confinanti (1948).
I successi riportati dagli israeliani nei confronti degli eserciti che si erano riuniti nella lega Araba, portarono
nel 1949 ad un armistizio con il quale si delinearono i territori del nuovo stato. La fascia costiera , il deserto
del Negev, l’alta e bassa Galilea , una parte della Giudea e della Samaria: Gerusalemme venne divisa in due
parti, la parte occidentale ad Israele e quella orientale venne annessa alla Giordania. Nel 1988 Yasser Arafat
dell’OLP (organizzazione liberazione Palestina) ha programmato ad Algeri la costituzione dello stato
indipendente della Palestina sui territori della Transgiordania e della striscia di Gaza occupati dagli israeliani.
Gran parte degli arabo-palestinesi vive in campi profughi soprattutto in Libano e Giordania, il loro capo
Arafat conduce da anni una battaglia per il ritorno del suo popolo in Palestina, la sorte dei palestinesi ha
causato un continuo stato di guerra tra Israele ed i Paesi Arabi confinanti, soltanto l’Egitto ha firmato un
trattato di pace con Israele.Anche ultimamente ci sono stati scontri tra le due popolazioni , i problemi sono
sempre gli stessi , la capitale Gerusalemme , il territorio , i profughi arabi ed i vari insediamenti .
Dopo la seconda guerra mondiale l ‘ONU ha cercato di ridare terre agli Ebrei , terre che non gli
appartenevano più , terre che erano state conquistate legittimamente dagli Arabi ed erano diventate loro ;
prepotentemente gli Ebrei una volta dato loro il diritto di avere una loro vera patria dopo tanti anni hanno
cacciato via coloro che avevano sempre vissuto lì , costringendoli a rifugiarsi in piccole strisce di terre
limitrofe alle loro case , costretti a vivere come profughi nelle loro stesse terre . Agli Ebrei sono state date
queste terre solamente perché 1000 e più anni prima i loro antenati avevano casualmente abitato in quei
territori , ma non riescono a capire che Israele è loro quanto lo è per gli Arabi , che hanno bisogno comunque
anche loro di un posto dove possono riconoscere le loro origini e dove possono professare liberamente la loro
religione .
__________________
_____________________________________________________
__________
Una terra contesa, due popoli in cerca di una nazione, i tentativi di portare avanti un colloquio e il continuo
ricorso alla violenza. Dal crollo dell'Impero ottomano alle vittime di oggi. Date, luoghi e protagonisti di una
storia tutt'altro che chiusa.
1917-1949: La fine dell'Impero ottomano, il mandato britannico e la creazione dello Stato di Israele
In una dichiarazione del 2 novembre 1917, il ministro degli Esteri britannico Arthur James Balfour
esprimeva il consenso del proprio governo alle "aspirazioni sioniste ebraiche" e alla creazione di un "focolare
nazionale ebraico" in Palestina.
L'11 dicembre, l'entrata in Gerusalemme del generale Allenby poneva fine a quattro secoli di dominio
ottomano in Terrasanta e dava inizio ad un mandato britannico sulla Palestina che sarebbe durato trent'anni.
Durante tale periodo l'immigrazione degli ebrei in Palestina si intensificò enormemente, alimentata
soprattutto dalle centinaia di migliaia di ebrei che fuggivano precipitosamente dall'Europa orientale a seguito
della rivoluzione d'Ottobre e della guerra civile russa. Se fino a quel momento la comunità ebraica in
Palestina era cresciuta assai lentamente (gli ebrei a Gerusalemme erano 17 mila nel 1880, 25 mila nel 1890,
35 mila nel 1900, 45 mila nel 1910), ora gli insediamenti sionisti iniziavano ora ad aumentare enormemente.
Ebrei e arabi, che fino ad allora avevano convissuto pacificamente, iniziavano a diventare più sospettosi e
ostili. Disordini si verificarono nel 1920, 1921, 1929 e dal 1936 al 1939, anno in cui l'Inghilterra assicurò
agli arabi la sospensione dell'immigrazione ebraica e l'indipendenza della Palestina entro dieci anni.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale e il succedersi degli eventi ad essa connessi fecero sorgere
all'interno della comunità ebraica due opposte correnti: una sostenitrice degli Alleati e una di resistenza
armata contro la decisione del governo mandatario di chiudere le frontiere palestinesi ai profughi superstiti
della persecuzione nazista (i milioni di vittime della Shoah creeranno tra l'altro di lì a poco un elemento di
"pressione" morale sull'Onu).
Al termine della guerra, l'intensificarsi del terrorismo ebraico contro il governo britannico e l'incapacità della
Gran Bretagna di assicurare la pace nei territori palestinesi, condussero alla decisione dell'assemblea
dell'Onu (29 novembre 1947) di spartire la Palestina in uno stato ebraico e in uno stato arabo e di
internazionalizzare per dieci anni Gerusalemme, ponendola sotto il controllo delle Nazioni Unite. La
risoluzione fu accettata dagli ebrei, ma respinta dai palestinesi sotto la forte pressione dei Paesi arabi (il 17
dicembre successivo la Lega araba dichiarò che si sarebbe opposta con la forza alla spartizione). Seguirono
mesi di guerriglia tra forze irregolari arabe ed ebraiche. Il governo britannico decise di ritirare le proprie
truppe; il mandato britannico sulla Palestina terminò ufficialmente il 15 maggio1948. Il giorno precedente un
governo provvisorio ebraico capeggiato da Ben Gurion aveva proclamato lo Stato d'Israele.
Seguì la guerra dell'indipendenza che terminò nel 1949 con i trattati d'armistizio di Rodi (febbraio-luglio
1949).
Il governo d'Israele fu tenuto da una serie di coalizioni di centro-sinistra dirette da Ben Gurion, leader del
partito laburista.
Anni '50: Tra accordi e conflitti si intensifica il rapporto Occidente-Medio Oriente
Negli anni Cinquanta si assistette ad un graduale avvicinamento di Israele agli Stati Uniti, causato
principalmente dalla politica antisionista ed antisemita adottata da Stalin negli ultimi mesi del proprio
regime; ciò portò alla rottura delle relazioni diplomatiche fra Unione Sovietica e Israele e al miglioramento
dei rapporti tra Urss e i paesi arabi.
Il 23 gennaio 1950, in contrasto con le risoluzioni delle Nazioni Unite, Israele trasferì la propria capitale da
Tel Aviv alla parte est di Gerusalemme.
Nel 1956, la nazionalizzazione del canale di Suez da parte del presidente egiziano Gamal Abdel Nasser e,
più in generale, la politica panaraba intrapresa (una politica, cioè, che perseguiva l'unità del mondo arabo e
che mirava alla rinascita della grandezza araba contro la supremazia occidentale) diedero luogo ad una crisi
che sfociò nella guerra del Sinai, che vide contrapposte Francia, Inghilterra e Israele da una parte ed Egitto
dall'altra. Il conflitto terminò con la vittoria militare israeliana, ma in realtà favorì il trionfo politico di Nasser
e non apportò risultati duraturi per Israele.
Anni '60: La guerra dei sei giorni e l'occupazione dei territori
Le lotte politiche al suo interno, infatti, si susseguirono e raggiunsero una tale durezza da indurre, nel 1963,
Ben Gurion alle dimissioni. Il nuovo primo ministro, Levi Eshkol, continuò come aveva fatto il suo
predecessore, a sviluppare con successo rapporti con Stati Uniti, Europa occidentale e Terzo Mondo, ma
dovette anche affrontare gravi problemi sia di politica interna che di sicurezza militare per l'intensificarsi
delle incursioni e delle azioni di guerriglia delle forze arabe.
Nel 1967, la politica panaraba di Nasser giunse ad un nuovo apice: chiese il ritiro delle forze di sicurezza
dell'Onu poste a presidiare il confine del Sinai, proclamò la chiusura del Golfo di Aqaba alle navi israeliane
(di fondamentale importanza per gli approvvigionamenti di Israele) e siglò un patto militare con la
Giordania. La reazione non tardò. Israele sferrò, nel giugno del medesimo anno, un attacco aereo simultaneo
contro le forze arabe e diede inizio ad un conflitto che durò poche ore (guerra dei sei giorni) e che si concluse
con una sbalorditiva vittoria militare. Le forze israeliane occuparono Gerusalemme est, la Cisgiordania, la
striscia di Gaza e le alture del Golan. Circa trecentoventimila profughi palestinesi fuggirono dai territori
occupati riversandosi in Egitto, in Giordania e in Siria.
Anni '70: Verso l'accordo di Camp David
Nei primi anni Settanta la rivendicazione dei profughi palestinesi residenti nei Paesi arabi (circa due milioni
e mezzo in totale) di aver riconosciuto uno Stato nazionale otteneva consensi anche nei Paesi occidentali.
Israele si trovava così sempre più isolato sul piano diplomatico internazionale. La guerra dello Yom Kippur
(ottobre 1973) inoltre evidenziò la debolezza politica ed economica dei tre milioni di israeliani di fronte alla
coalizione araba, resa ancor più forte dall'appoggio sovietico e dalle ricchezze petrolifere utilizzate come
arma di ricatto con i sostenitori occidentali di Israele. La crisi toccò particolarmente il Partito laburista che
dovette sempre più appoggiarsi alle frazioni conservatrici. Il nuovo governo Rabin, tuttavia, riuscì a
raggiungere importanti obiettivi sia in politica estera (accordo con l'Egitto) che in politica interna
(potenziamento capacità militare e riforme finanziarie). Ciononostante, a causa dei dissensi interni alla
coalizione, nel dicembre 1976 Rabin si dimise e convocò nuove elezioni.
Nel maggio 1977 il Partito laburista perse la maggioranza che deteneva da quasi trent'anni; salì al potere una
coalizione di centro-destra guidata dal Partito Likud il cui leader Menahem Begin divenne primo ministro.
Fautore di una politica intransigente verso il mondo arabo, appoggiò e favorì l'insediamento di coloni
israeliani nella Cisgiordania occupata. Nel novembre 1977 il presidente egiziano Anwar Sadat compì un
gesto sensazionale recandosi in visita a Gerusalemme dove ebbe un colloquio con Begin e tenne un discorso
alla Knesset. Il mese successivo lo stesso primo ministro israeliano ricambiò la visita recandosi in Egitto.
Ma il sostanziale fallimento di queste visite creò la base per un accordo che portò gli Stati Uniti al centro del
processo di pace. Dopo otto mesi di intensa diplomazia Begin, Sadat e il presidente americano Jimmy
Carter si incontrarono, nel settembre 1978, a Camp David siglando un accordo diviso in due parti: nella
prima si stabilivano le basi per un trattato di pace fra Israele e ciascuno dei suoi vicini; nella seconda parte,
solamente fra Egitto e Israele. Ma solo questo secondo punto fu sottoscritto, a Washington, nel marzo 1979.
Mediante tale accordo l'Egitto ottenne la restituzione del Sinai, mentre l'anno seguente vennero ristabilite le
relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il mondo arabo, tuttavia, fu in tal modo spaccato e la questione
palestinese rimase irrisolta e ancor più complessa.
Anni '80: L'invasione del Libano e la nascita dell'Intifada
Nei primi anni Ottanta entrò in scena un piccolo stato fino ad allora rimasto ai margini del conflitto araboisraeliano, il Libano. Scosso all'interno dagli attriti delle diverse fazioni religiose, era anche sede, dopo che
furono espulsi nel "settembre nero" (1970) dalla Giordania, della leadership dell'Organizzazione per la
liberazione della Palestina (Olp) e di molti suoi militanti. Dal Libano l'Olp compì, con una intensificazione
sempre maggiore a partire dal 1981, bombardamenti e raid che minacciavano gli insediamenti israeliani del
Nord. Israele rispose nel giugno 1982 con l'invasione del Libano, avanzando fin verso la stessa Beirut per
cacciare le basi dell'Olp. Venne inviata una forza multinazionale di pace da parte di Stati Uniti, Francia,
Italia e Gran Bretagna che ha consentito l'evacuazione (verso la Tunisia) dei combattenti dell'Olp, ma che
non ha consentito di riportare la calma nel paese. La forza venne ritirata nel 1984.
A partire dalla fine del 1987 i palestinesi dei territori occupati diedero vita ad una lunga e diffusa rivolta
(Intifada) contro Israele, che reagì con una dura repressione. L'Olp, che sosteneva tale rivolta nata comunque
spontaneamente, abbandonò il suo ruolo di aperta lotta armata contro Israele e nel dicembre 1988 il suo
presidente, Yasser Arafat, annunciò uno storico cambiamento nella politica dell'Organizzazione che
abbandonava la strategia del terrorismo.
Anni '90: Arafat e Rabin si stringono la mano
Il 18 gennaio 1991, ventiquattr'ore dopo l'inizio della Guerra del Golfo, missili Scud lanciati da una
postazione al confine iracheno-giordano colpivano i sobborghi di Tel Aviv. Fu un attacco a sorpresa contro
una popolazione inerme ed estranea alle ragioni del conflitto. I calcoli di Saddam Hussein di porsi come il
difensore della causa araba - e palestinese in particolare - e di mettere in difficoltà la coalizione antiirachena,
non portarono i risultati sperati. George Bush, infatti, si era premunito facendo accettare al primo ministro
israeliano Shamir l'impegno a non scatenare rappresaglie.
Il 20 agosto 1993 rappresentanti di Israele e dell'Olp si incontrano ad Oslo per un accordo di pace.
Rispettivamente il 9 ed il 10 settembre successivi Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak
Rabin si scambiano lettere di mutuo riconoscimento. Nella sua lettera a Rabin, Arafat riconosce "il diritto
dello Stato di Israele ad esistere in pace e sicurezza" e rinuncia all'"uso del terrorismo e della violenza". Nella
sua lettera, Rabin riconosce l'Olp come "rappresentante del popolo palestinese". Il 13 settembre a
Washington ha luogo la famosa stretta di mano tra Arafat e Rabin i quali firmano una Dichiarazione dei
principi alla presenza del presidente statunitense Bill Clinton.
Il 4 maggio 1994 Israele e l'Olp siglano un accordo riguardante la striscia di Gaza e l'area di Gerico. Il 1°
luglio Arafat torna in Palestina; arriva a Gaza il 12 dello stesso mese e qui stabilisce il proprio quartier
generale, accolto e acclamato da decine di migliaia di palestinesi. Il 26 ottobre un Trattato di Pace viene
siglato anche da Israele e Giordania.
Il 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin - al quale l'anno precedente era stato consegnato il premio Nobel per la
pace insieme a Yasser Arafat e al ministro degli Affari esteri di Israele Shimon Peres - viene assassinato a
Tel Aviv da un estremista israeliano.
Il 30 maggio 1996 viene eletto primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e viene formato un governo
di destra. Per decisione di tale governo il 24 settembre si inizia ad aprire un tunnel sotto la Città Vecchia in
Gerusalemme Est. Seguono scontri nella città e nei territori occupati tra polizia e civili palestinesi da una
parte e esercito israeliano dall'altra. Il 28 settembre il Consiglio di Sicurezza dell'Onu adotta una risoluzione
per la cessazione dell'apertura del tunnel.
Il 23 ottobre 1998, alla presenza di Bill Clinton e del re Hussein, Arafat e Netanyahu siglano l'accordo di
Wye River attraverso il quale si impegnano ad adempiere agli accordi precedenti. Sulla stessa linea si pone
l'accordo di Sharm el-Sheikh del 5 settembre 1999.
Nei primi mesi del 1999, il primo ministro Netanyahu viene indagato per illeciti finanziari. L'inchiesta, dalla
quale comunque uscirà assolto, provoca la crisi del governo e lo costringe a presentare le proprie dimissioni.
Vengono indette le elezioni anticipate che, tenute il 17 maggio dello stesso anno, vengono vinte dal laburista
Ehud Barak che, con il 56 per cento dei consensi, viene eletto primo ministro di Israele.
2000: l'Intifada di al-Aqsa
L'11 luglio 2000 ha luogo una conferenza a Camp David che però non sembra portare a risultati
soddisfacenti per il processo di pace. La situazione si aggrava enormemente a partire dalla fine del settembre
successivo: il 28 il presidente del Likud Ariel Sharon (che verrà poi eletto primo ministro d'Israele nel
febbraio 2001) si reca in visita alla Spianata delle Moschee, un'azione provocatoria tendente a ribadire la
sovranità israeliana sulla zona. Ne segue la cosiddetta "Intifada di al-Aqsa" che alla metà del maggio 2001 fa
registrare, quali vittime degli scontri fra palestinesi e milizie israeliane, più di 500 morti, per massima parte
arabi.
ORIGINE, ASCESA E DECLINO DELL’OLP
Fino al 1967 i palestinesi non avevano avuto una rappresentanza autonoma, ed erano oppressi sia da Israele,
sia dai regimi arabi, che ne assumevano per esigenze interne una poco efficace difesa, prevalentemente
verbale.
Formalmente l'OLP (Organizzazione di Liberazione della Palestina) era stata costituita nel 1964, ma era un
organismo burocratico - creato soprattutto dall'Egitto - alla cui testa era stato collocato Ahmed al-Shuqeiri,
un personaggio senza credibilità, che non esitava a riprendere vecchi argomenti della propaganda antisemita
fascista.
è proprio dopo la penosa sconfitta dei paesi arabi nella guerra del 1967 che emerge al Fatah, guidata già
allora da Yasser Arafat.
Il suo nucleo centrale si era formato al Cairo nel 1957, sotto l'impressione della sconfitta militare egiziana (il
successo iniziale di Israele era stato però fermato dalla resistenza delle masse egiziane, e dall' intervento
politico dell'URSS e degli Stati Uniti).
Peserà anche molto l'esempio della lotta armata algerina, iniziata subito dopo la sconfitta francese a Dien
Bien Phu nel Vietnam.
Al Fatah conquista un grande prestigio con qualche azione di guerriglia fin dal 1965 (in particolare il
sabotaggio degli impianti israeliani per la deviazione delle acque del Giordano), e poi nel 1968 con la
battaglia di Karameh, che ferma una colonna israeliana entrata in Giordania, e rappresenta l'unica azione
militare vittoriosa realizzata dagli arabi in quella fase. Conquistata la direzione dell'OLP, Arafat cerca di
coinvolgere altre organizzazioni, come il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina di George Habbash
(FPLP o più brevemente FP) e il Fronte Democratico Popolare di Liberazione della Palestina di Nayef
Hawatmeh (FDPLP o FD), entrambi laici e di tendenza più o meno marxista.
Il rapporto sarà sempre difficile, con frequenti rotture e nuove convergenze; le divergenze sono sulle tattiche
di lotta, ma anche sulla necessità di sottrarre i palestinesi alla tutela dei regimi reazionari arabi.
L'OLP si trasforma presto in un grosso apparato statale senza uno Stato, e ha quindi sempre più bisogno di
contributi da parte dei paesi della Lega Araba, soprattutto dell'Egitto, dell'Iraq e dell' Arabia Saudita.
In questo contesto i contributi dei palestinesi della diaspora, alcuni dei quali hanno raggiunto posizioni di
rilievo soprattutto nei paesi del Golfo, diventano determinanti non solo per la sopravvivenza dell'apparato,
ma anche per l'accettazione da parte dell'OLP delle pressioni dei paesi arabi"
Così, per non irritare i regimi che finanziano il costoso apparato, la maggioranza dell'OLP guidata da Arafat
teorizza la "non ingerenza" negli affari interni dei paesi arabi che, oltre ad essere in stridente contraddizione
con le diffuse aspirazioni all'unità araba, è praticamente impossibile, soprattutto in Giordania, dove i
palestinesi sono la maggioranza della popolazione e influenzano inoltre i settori giordani più avanzati,
mentre il re Hussein (nipote di quell'Abdallah che era stato scelto dagli inglesi) si appoggia solo sulle
armatissime tribù beduine, come lui fatte venire dal cuore dell'Arabia saudita.
Il risultato è che i palestinesi vengono ugualmente coinvolti nei conflitti interni, risolti da Hussein facendo
bombardare i quartieri poveri di Amman nel settembre 1970 (la risposta palestinese, tardiva ed esasperata,
sarà l' ondata di terrorismo in tutti i paesi che hanno protetto Hussein, e prenderà il nome di "settembre
nero").
La stessa situazione si riproporrà nel fragile Libano, dominato da uno strato reazionario e filoimperialista,
che ha chiesto aiuto alla flotta e ai paracadutisti degli Stati Uniti nel 1958 (quando una sollevazione popolare
aveva spazzato via il sovrano filo britannico dell'Iraq, e la rivoluzione araba sembrava dilagare ovunque).
Israele prepara pazientemente una rete di notabili al suo servizio e, nel 1978, in concomitanza con le
trattative di pace con l 'Egitto, creerà un sedicente "Libano Libero", affidato alle feroci milizie del maggiore
Haddad, un disertore libanese armato e stipendiato dal governo di Tel Aviv.
La zona occupata da Haddad e dagli israeliani arriva al fiume Litani, ricco di acque che vengono dirottate
verso la parte settentrionale di Israele, che è al contrario piuttosto arida.
La propaganda sionista e reazionaria ripete che Arafat è un terrorista e un estremista.
è semplicemente assurdo: all' inizio della sua attività politica, Arafat ha scelto la lotta armata perché non
aveva altra scelta, e perché aveva di fronte a sè l'esempio di come i sionisti si erano impossessati della sua
terra, con la lotta armata e un terrorismo spietato verso le truppe di occupazione britanniche, i palestinesi, e
anche tra le stesse formazioni sioniste concorrenti.
Ma ha scelto poi la strada della trattativa, della ricerca di un'intesa anche attraverso un compromesso, al
punto di provocare lacerazioni tra gli stessi palestinesi.
Arafat può essere definito "un terrorista" come lo è stato Nelson Mandela nei ventisette anni detenzione, fino
al giorno in cui la classe dominante bianca ha dovuto tirarlo fuori dalla prigione e chiedergli di tenere a bada
le masse africane (rimaste prive del potere economico, proprio grazie alla buona disponibilità di Mandela e
degli altri dirigenti neri dell'ANC all'accordo e alla coesistenza basata sullo status quo).
Per questo gli israeliani, che lo attaccano sui mass media istericamente, hanno evitato di ucciderlo, pur
avendo i mezzi per farlo, come hanno fatto con tanti suoi collaboratori.
Lo hanno fatto nel 1983 con Issam Sartawi (che era per giunta un uomo che cercava l'intesa con le
componenti più ragionevoli della società israeliana), nel 1988 con Abu Jihad, e con moltissimi altri, anche in
questa fase; ma hanno evitato di ucciderlo sapendo che, morto Arafat, anche le masse palestinesi più
moderate esploderebbero in una rivolta esasperata e distruttiva.
GERUSALEMME - E' la guerra degli uomini talpa. E si combatte lungo una striscia di terra
che corre tra Gaza, in area palestinese, e l'Egitto. Da mesi gli attivisti dell'Intifada cercano
di procurarsi armi e munizioni facendole passare attraverso dei tunnel segreti costruiti sotto
la zona di confine. Gli israeliani cercano di impedirlo con la realizzazione di una trincea
profonda dieci metri che dovrebbe interrompere il tracciato delle gallerie. Una lotta di pala e
piccone che fa sorridere gli abitanti di Gaza: «Ma cosa volete che passi là sotto. Qualche fucile,
delle cartucce. Mica i carri armati».
DAI VIETCONG AL
LIBANO - La passione
dei tunnel tra i
palestinesi risale
all'esperienza del
Libano ed è stata
copiata dai guerriglieri
vietcong. Quando i
fedain, negli anni '70,
operavano sul territorio
libanese avevano creato
una estesa rete di
depositi e rifugi
Rafah, la trincea scavata dagli israeliani
per bloccare i tunnel palestinesi
smantellati
dall'invasione israeliana
dell'82. Un sistema tornato in auge con l'intifada. I membri di
varie fazioni hanno iniziato a scavare le gallerie imitando i
contrabbandieri che per anni hanno usato questa tecnica.
I TUNNEL - Ne esistono due tipi. Il primo è un tunnel,
situato ad una profondità di 3-4 metri, lungo tra i 50 e i
150 metri. I trafficanti vi calano dei recipienti (grosse
bacinelle, scatole in legno) che vengono tirati, da una parte
all'altra del confine, con delle corde. Il secondo sistema meno usato - prevede la realizzazione di una galleria più
ampia, sorretta da strutture in legno: l'ingresso ha un
diametro di circa 80 centimetri. Lungo il percorso vengono
creati piccoli buchi per consentire l'areazione. L'accesso è
verticale ed è facilitato da scalette in corda. Nella parte
palestinese il tunnel può terminare all'interno di una
abitazione, in modo da assicurare protezione a chi è
coinvolto nel contrabbando. Oppure lo sbocco - tra i 30-50
centimentri di diametro - viene mimetizzato e coperto con
un telone ricoperto di sabbia.
Tunnel per trasportare armi
MESI DI SCAVI - La realizzazione dello scavo può durare qualche mese, un periodo che si
riduce nel caso vengano riattivate vecchie gallerie. Nel tentativo di bloccare i tunnel gli
israeliani hanno formato una unità speciale che opera nel settore di Rafah e agisce lunga la
cosiddetta «Philadelphia road» che segue il confine. In base agli accordi di Oslo a Israele è
affidato il compito di controllare la frontiera usando appunto la striscia d'asfalto. Gli esploratori
beduini sono capaci di «leggere» il terreno e scoprire avvallamenti sospetti, i genieri invece
usano bulldozer e sonde.
LA TRINCEA - Per motivi di sicurezza, i soldati hanno distrutto molte case palestinesi e piante
in una fascia compresa tra i 50 e i 150 metri sostenendo che venivano usate per nascondersi
dai guerriglieri. Nelle ultime settimane è quindi scattata la costruzione della trincea. Ora
aspettiamo la risposta degli uomini-talpa.
Guido Olimpio
Israele, con Sharon tornano i «falchi»
TEL AVIV (ISRAELE) - Il leader dell'opposizione di destra Ariel Sharon è il nuovo primo
ministro di Israele, grazie alla schiacciante vittoria sul rivale laburista - e premier uscente Ehud Barak.
I dati ufficiali finali assegnano il 62,5% dei voti a Sharon contro il 37,4% di Barak.
Quest'ultimo ha ammesso la sconfitta e si è dimesso dalla presidenza del partito laburista,
lasciando anche il seggio in parlamento. L'affluenza alle urne è stata pari al 62%, la più bassa
dalla nascita dello stato israeliano nel 1948.
Il primo atto di Sharon è stata l’offerta al partito laburista di entrare in un goverrno
di unità nazionale. In caso di risposta negativa infatti Sharon sarebbe costretto a fare i conti
con i partiti di matrice religiosa per trovare una maggioranza in Parlamento.
LA REAZIONE DEGLI ARABI - La reazione del mondo arabo alla nomina di Sharon è stata
estremamente negativa. Soltanto l'Egitto, il primo Paese del fronte arabo a fare la pace con lo
Stato ebraico, ha scelto la linea della cautela. «Aspetteremo di vedere cosa farà Sharon. Se la
sua sarà una politica di pace o di repressione», ha detto ai giornalisti il presidente egiziano
Hosni Mubarak prima di rientare dal Kuwait al Cairo. Il leader egiziano non ha mancato di
ricordare che nel 1982 Sharon, ministro della Difesa nel governo di Menachem Begin, fu
complice indiretto del massacro compiuto nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila dai
falangisti cristiani.
Nessun commento ufficiale sulla nomina di Sharon da parte dei palestinesi, ma Marwan
Barghuti, il segretario di Al-Fatah, la principale componente politica palestinese ha
dichiarato che il nuovo primo ministro non è altro che «l’ultima pallottola» degli israeliani.
LA CAUTELA DEI LEADER OCCIDENTALI - L’elezione di Sharon è stata accolta con
dichiarazioni prudenti da parte dei più importanti leader europei.
“Solo la pace può dare sicurezza e benefici economici e culturali ai popoli della regione”:
sottolinea il presidente della Commissione europea Romano Prodi nel messaggio di
congratulazioni al nuovo primo ministro. Un concetto ripetuto anche dal presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi secondo il quale «nessuno deve dimenticare che non c'è
alternativa al negoziato e alla pace».
Messaggi analoghi sono giunti dal cancelliere tedesco Gerard Schroeder e dal presidente
francese Jacques Chirac.
Ora la parola passa ai fatti: sarà dai comportamenti concreti del nuovo leader che Sharon
verrà giudicato dall’Occidente.
Marco Letizia
La pace, il cavaliere e l'armatura svuotata
4 novembre 2001 - di Barbara Spinelli
Più volte, ripensando alle dispute suscitate dal mio articolo sui mancati mea culpa
nell’ebraismo, mi è venuto in mente quel che ha scritto David Grossmann, scrittore
israeliano, poco dopo l’attentato di Manhattan: "Se non arriverà la pace in Medio Oriente, a
poco a poco ci trasformeremo tutti in una sorta di armatura vuota, priva del proprio
cavaliere". Non saremo capaci di ascoltarci l’un l’altro, perché l’armatura parlerà al nostro
posto. Non saremo capaci di metterci in questione, di interrogare il nostro passato, le
nostre parole, le nostre conoscenze storiche, le nostre certezze, perché tutto questo passato, parole, conoscenze, certezze - sono diventate l’armatura che abbiamo messo fra
noi e i fatti reali, fra noi e la nostra coscienza. In alcuni momenti ho perfino avuto
l’impressione che questo esistere a partire dall’armatura restringesse la vocazione al
pensiero individuale, solitario.
Il collettivo Noi prendeva il sopravvento sul più scabroso io penso, io dubito. Non poche
lettere inviate alla Stampa - e per le quali vorrei comunque ringraziare: ogni dissenso aiuta
a pensare - sono firmate da piccoli collettivi, da persone che reagiscono in gruppo. Da
piccole chiese, che si mobilitano contro l’eresia di individui non ortodossi. Un epiteto mi ha
colpito, per la sua singolarità e per le assonanze che risveglia: "rinnegato". Questo vuol
dire che discorrere su diaspora e Israele è oggi impresa ardua, sia fuori che dentro
l’ebraismo. Ne fecero l’esperienza spiriti ebrei liberi come Hannah Arendt, Arthur Koestler,
Henri Bergson, Simone Weil, Gershom Scholem, Ernst Gombrich, Raymond Aron, Judah
Magnes, in tempi travagliati.
Per parte mia non ho mai pensato che l’ebraismo fosse un monolito, e ho memoria delle
voci dissidenti da esso scaturite, a cominciare dalla denuncia del bellicismo israeliano
pronunciata da Primo Levi nell’82, su questo giornale. È di prese di posizione come la sua
che oggi - dopo l’11 settembre - si sente crudelmente la mancanza. Anche negli altri epiteti
non mi riconosco: antisemita, seguace di Göbbels, filo-terrorista, e senza pretendere di
replicare a tutte le accuse - non ho competenza teologica - vorrei tentare alcune risposte
provvisorie che chiariscano un poco la mia posizione. In primo luogo il mea culpa, che
forse ha suscitato più sdegno. Non ho trovato altro termine, per esprimere qualcosa che
secondo me non rimanda solo alle tradizioni della liturgia cristiana: le due parole latine
possono esser tradotte in vari modi, ma restano un tratto costitutivo della cultura
occidentale.
Nei suoi momenti migliori - che sono sempre stati momenti di esame di coscienza,
soprattutto dopo le guerre di religione - la cultura occidentale ha saputo coniugare lo
spirito critico, un’alta idea del diritto, una vocazione a farsi piccoli di fronte all’enormità
degli errori compiuti. Il mea culpa di Giovanni Paolo II sullo sterminio degli ebrei ha
concentrato l’attenzione del pubblico su un male estremo, ma il ravvedimento riguarda
anche mali diversi, e non a caso il Pontefice ha pronunciato molti mea culpa, non uno
soltanto. Non mi sembra giusto aggrapparsi a un termine per respingere compiti che tutti
siamo chiamati a assumerci - ebrei e non ebrei - se vogliamo fondare le nostre azioni
sull’etica, la coscienza e la ragione.
Chiedere scusa per le sofferenze arrecate, guardare il dolore dell’altro oltre quello proprio
e dei propri cari: qui è la nobiltà degli esseri umani, quale che sia la loro appartenenza
religiosa o etnica. Ho detto che gli ebrei faticano ad assumersi tale compito, sia in Israele
sia nella diaspora, e che questa riluttanza può rivelarsi nefasta, all’indomani dell’11
settembre: per la prima volta infatti il destino di Israele è veramente in pericolo. L’America
è stata la sua fondamentale garanzia di sopravvivenza, ma oggi l’ombrello protettivo si
chiude: sono bastati tre aerei terroristi, scaraventati contro le Torri Gemelle e il Pentagono,
perché gli Usa smettessero di essere la superpotenza invulnerabile che avevano voluto
rappresentare. Non lo sono più, non si sentono più tali, e in prospettiva il loro
comportamento diverrà più europeo: dunque più impaurito, negligente verso lo Stato
ebraico.
Questo espone gravemente Israele: la sua solitudine non è mai stata così grande e il suo
sgomento si può comprendere. Ma dallo sgomento toccherà pure uscire e ripensare
l’intera situazione e rimeditare anche sul passato, perché il tempo non lavora in favore
della nazione israeliana. Il tempo, se lo si lascia passare senza iniziative forti anche sul
piano simbolico (il ravvedimento è una di esse, oltre a gesti di pace unilaterali come il ritiro
dai territori) lavora in favore delle forze di distruzione, e di un terrorismo cui urge far fronte
sollecitamente. Mettiamo che Arafat abbia in mente una deportazione degli ebrei fuori
dalle loro terre. Un modo sicuro per secondarlo è quello di dare tempo al tempo: dunque
non fare nulla, aspettare che sia lui a fare la prima mossa. Dal suo punto di vista, sempre
che abbia in mente la distruzione di Israele, sarebbe la soluzione ideale: gli basterebbe
aspettare.
Quello che mi preoccupa nelle lettere e negli articoli dei miei critici è la scarsa inquietudine
che essi sembrano provare per la sorte effettiva degli abitanti d’Israele. Il fatto è che non
c’è tempo per discutere sull’orgoglio degli ebrei e sulla vera giustizia. Israele è condannata
a fare il primo passo, proprio perché più matura e più razionale delle élite arabopalestinesi, pena una catastrofe. Ma il vero punto controverso riguarda la natura delle
colpe israeliane, e se esistano colpe, e se le élite politiche e religiose - in Israele e fuori siano disposte ad alcuni atti di contrizione o ripensamento. Atti certamente difficili, perché
nulla di simile sembra venire da parte palestinese o araba. Ma atti ineludibili, e che non
possono ridursi alle prese di posizione isolate di alcuni storici eterodossi, peraltro malvisti
nel mondo accademico israeliano, come Tom Segev o Benny Morris. Sono le classi
dirigenti (politici, rabbini) che a mio parere potrebbero utilmente aiutare Israele e
l’ebraismo a uscire dall’età dei miti, e a entrare nella nuda storia dei fatti.
Nella storia dei fatti non esistono persone o popoli esenti da colpe, errori. Né si capisce
come mai Israele dovrebbe, unico, sottrarsi a quest’umana ventura. È il motivo per cui ho
parlato di mitologia ebraica, e di un’antica tendenza a vivere nella metastoria piuttosto che
nella storia: storia che è sempre fatta di cadute e riprese, errori e correzioni, dogmatismi e
ritorno alla razionalità. Uno dei miti che mi sono apparsi ricorrenti è quello
dell’antisemitismo eterno, che caratterizzerebbe la storia ebraica dai tempi della
distruzione del Tempio ad opera dei romani, nel 70 d.C., ai giorni d’oggi. Mito temibile,
perché esso ingenera l’illusione - come diceva Hannah Arendt - di "un’identità ebraica
eternamente buona, la cui monotonia è stata turbata solo dall’altrettanto monotona
cronaca di persecuzioni e di pogrom". Ne consegue l’incapacità di tanti israeliani di
guardare la propria storia passata, e non solo passata. Penso in particolare alla genesi di
Israele e ai rapporti tra ebrei e palestinesi, fin dall’inizio inesistenti o impossibili. E penso
anche a vicende recenti: al dilatarsi di un integralismo ebraico che non di rado è sfociato
nel terrorismo, entrando in una dialettica micidiale col terrore palestinese; alla
condiscendenza di tanta parte della diaspora verso i molti rabbini che in Israele
propugnano l’integralismo e ne legittimano le violenze.
L’eccidio perpetrato dal medico colono Baruch Goldstein nella moschea di Hebron, il 25
febbraio ’94 (29 morti, tutti in preghiera come i 16 protestanti trucidati da fanatici islamici in
Pakistan, il 28 ottobre scorso) è stato approvato da un certo numero di rabbini, alcuni dei
quali hanno addirittura chiamato Goldstein "santo vendicatore". Le omelie del rabbino
Yussuf Ovadia a Gerusalemme prendono regolarmente di mira l’Islam e i "serpenti
musulmani": "Dio si è pentito di aver creato gli arabi", ha detto il 5 agosto 2000, senza
esser condannato dai principali rabbini della diaspora. È la ragione per cui ho suggerito un
mea culpa non solo verso i palestinesi ma anche verso l’Islam, non senza sperare che il
mea culpa venga un giorno anche dai palestinesi e dall’Islam. Ma le obiezioni più forti
riguardano la nascita di Israele, e la guerra successiva alla proclamazione dello Stato il 14
maggio ’48.
Molti lettori sono convinti anche in questo caso che l’innocenza sia tutta dalla parte di
Israele, e le colpe tutte da parte degli arabi-palestinesi, che avrebbero "rifiutato" di
convivere con gli ebrei. Alcuni ripropongono addirittura l’originario mito sionista di un
"popolo senza terra in una terra senza popolo", quasi che la Palestina fosse un paese
vuoto quando gli ebrei cominciarono a trasferirvisi nell’800. La verità dei fatti è diversa
dalla leggenda su cui Israele ha costruito la propria identità.
La politica di espulsione e spesso deportazione dei palestinesi non è successiva
all’offensiva militare degli stati arabi, il giorno dopo la proclamazione dello Stato, ma la
precedette, nel corso di quella che Benny Morris, in un lucido libro sulla nascita di Israele,
chiama la guerra civile nella Palestina sotto mandato britannico (Benny Morris, Le Vittime,
Rizzoli 2001). L’esodo di circa 700.000 palestinesi dai villaggi, prima e durante la guerra,
non nacque da una strategia araba di rifiuto delle buone intenzioni israeliane. Fu attizzata
da attentati terroristici ebraici (condotti a Haifa dalla Banda Stern e dall’Irgun di Begin) ma
innanzitutto da un eccidio, a Deir Yassin il 9 aprile ’48, che costò la vita di 350 civili e che
si incuneò come un incubo nelle memorie palestinesi e arabe, fin dall’esordio della guerra
scoppiata nel maggio ’48. Sono fatti noti, prima ancora che i nuovi storici israeliani li
riscoprissero.
Nell’ottobre 1948, in una lettera al direttore di Commentary, Judah Magnes, presidente
dell’Università ebraica, fu il solo a ergersi contro il mito della piccola nazione incolpevole:
"Se gli arabi di Palestina hanno abbandonato i loro territori "volontariamente", sotto l’urto
della propaganda araba e in preda a un autentico panico, non si può dimenticare che
l’argomento più potente, in questa propaganda, era la paura di una ripetizione delle
atrocità compiute dal gruppo Irgun-Stern a Deir Yassin, dove le autorità ebraiche furono
incapaci di prevenire l’azione o di punire i colpevoli, o non vollero farlo". Fu Magnes stesso
a porre, fin da allora, la questione morale: "Ogni tentativo di affrontare una situazione
umana tanto ampia da un punto diverso da quello umano e morale ci porterà in un
pantano". E ancor oggi è cruciale per Israele darsi quella legittimazione etica che allora
vacillò, per tanti ebrei e non ebrei.
D’altronde questo è vero sempre: non si può agire né governare senza fare appello alla
coscienza, specie la propria. L’idea stessa di morale non ha senso al di fuori di una
qualche visione della colpa, o della responsabilità per gli sbagli commessi. È in questo
quadro che ho accennato al cristianesimo cattolico, come modello europeo di
apprendimento dagli errori e di responsabilizzazione personale. E non per sostenerne la
superiorità o irreprensibilità, o per spingere gli ebrei a conversioni o acculturazioni, ma
solo per costatare come un solo monoteismo sia stato capace di una secolarizzazione
autentica, mutando strutture e natura della propria religione. È la tesi sostenuta
dall’orientalista Bernard Lewis, secondo cui Islam e ebraismo sono, da questo punto di
vista, più simili di quanto si creda. C’è da domandarsi se l’ebraismo sia in grado di
affrontare simile secolarizzazione, ma per quanto riguarda il passato la risposta è
negativa.
La stessa Aufklärung ebraica (l’età dei Lumi che faceva capo a Moses Mendelssohn) fece
una scelta di secolarizzazione - propugnando la separazione tra potere civile e religioso,
l’indipendenza della cultura dalle certezze della fede - ma i suoi esponenti si sentirono
costretti a abbandonare l’ortodossia, anche quando conservarono la consapevolezza delle
proprie origini. È quello che sostiene Hannah Arendt: "Il laicismo e il sapere laico furono
identificati esclusivamente con la cultura non ebraica, cosicché a questi ebrei non venne
mai in mente di avviare un processo di secolarizzazione relativo alla loro stessa eredità".
Accadde in tal modo che l’eredità spirituale della religione di Mosè divenne più che mai
monopolio dei rabbini.
Un altro punto dolente è quello che concerne la doppia lealtà nella diaspora. L’espressione
è magari infelice e me ne scuso ma non è, la mia, un’argomentazione antisemita.
Inquietudini analoghe - sulla società tribale che può nascere da un multiculturalismo
legalistico - furono formulate da Raymond Aron e, nel 1996, dallo storico dell’arte Ernst
Gombrich, in un discorso che suscitò scandalo perché negava l’esistenza di una specifica
cultura ebraica in Europa ("Queste definizioni preferisco lasciarle alla Gestapo: io parlo di
cultura europea"). Invece di indignarsi converrebbe forse chiedersi cosa significhi oggi
essere ebrei. So che non esiste praticamente risposta, ma un tentativo lo si può fare.
Secondo molti, e io tenderei a aderire a tale posizione, è essenzialmente una fede
religiosa. Il resto - razza, popolo nazionale, legame di sangue - è tutta materia
incandescente, alla luce dei nazionalismi e di Auschwitz.
Per quasi due millenni, la Terra è stata di fatto marginale nel pensiero ebraico. Era
sostituita dal Libro. E certo si può capire il nazionalismo ebraico, dopo la catastrofe
immane che sono stati i Lager. Si può capire anche la crisi della religione: per alcuni Dio
velò il proprio volto e perfino scomparve, nella cenere dei forni. Ma siamo sulla terra per
interrogare e interrogarci, e anche l’identità di un popolo o una religione possono divenire
oggetto di indagine. Ci si può domandare se non sia nazionalismo etnico, quello che resta
dell’ebraismo. Se le sue forme non siano perniciose, nella politica israeliana come
palestinese, anche il giorno in cui fra i due Stati s’innalzerà quel muro che tanti auspicano,
illudendosi che esso scioglierà ogni nodo di ieri e di oggi. Pernicioso perché in ambedue i
casi lo sciovinismo si collega al concetto religioso di popolo eletto.
Ci si può domandare se Israele e la diaspora facciano bene a vedere il mondo come
raffigurazione di un antisemitismo eterno, e se sia giusto che la shoah continui a essere
elemento fondante dell’ebraismo statuale e spirituale. Infine ci si può chiedere se gli ebrei
non siano in qualche modo affezionati al proprio dolore: paradossalmente, a forza di
chiamarlo destino, molti di loro dimenticano il pericolo concreto che hanno di fronte. Ci si
può chiedere se l’antisemitismo non sia durevolmente divenuto un "elisir di vita"
(Lebenselixier), come lo chiamava Theodor Herzl quando fondò il sionismo: una minaccia
che conferisce identità all’ebreo, quasi più della preghiera.
Sono domande che questa polemica giornalistica ha reso ancora più attuali, ed è il motivo per cui vale la
pena sforzarsi insieme e tentare di attenuare il timore di tanti pensatori ebrei: il timore che l’ebraismo abbia
bisogno di crearsi sempre nuove emergenze, per provare la propria esistenza individuale o collettiva. Il
timore che non ci sia più il cavaliere, dentro l’armatura vuota.