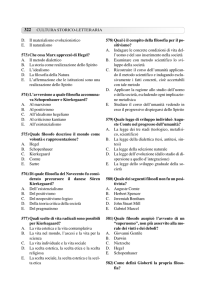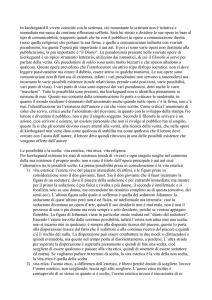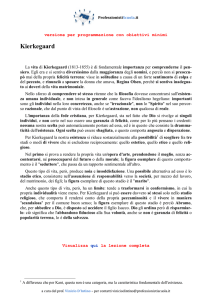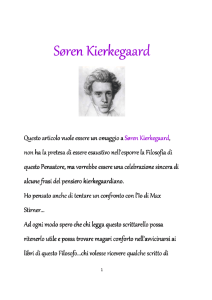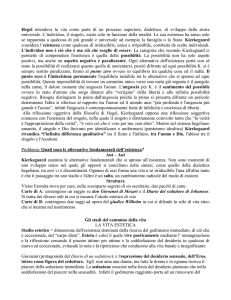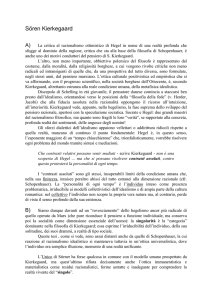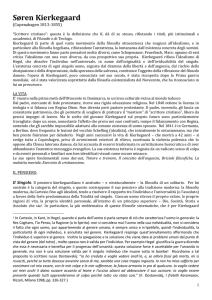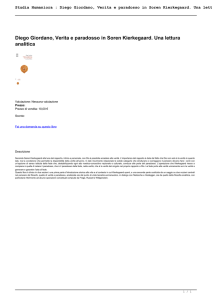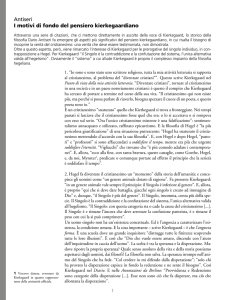Søren Kierkegaard - l’esistenza estetica e la sua logica
(1813-1855)
1. Come premessa: al centro dell’attenzione il finito, la singolarità.
2. L’esistenza: uscita dalle forme e scoperta della possibilità.
3. fenomenologia delle esistenze: estetica, etica, della fede
4. la definizione di estetica nelle forme dell’esistenza
Kierkegaard Søren 1843, Aut-Aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, A.
Mondadori, Milano 1993
Kierkegaard Søren 1843, Diario del seduttore, Rizzoli, Milano 1990, 2005
Kierkegaard Søren 1843, Timore e tremore. Lirica dialettica di Johannes de Silentio, edizioni di
Comunità, Milano 1971
Kierkegaard Søren 1843, La ripresa. Tentativo di psicologia sperimentale di Constantin
Constantius, edizioni di Comunità, Milano 1971
Kierkegaard Søren 1844, Prefazioni. Lettura ricreativa per determinati ceti a seconda dell’ora e
della circostanza di Nicolaus Notabene, Rizzoli, Milano 1996
Kierkegaard Søren 1844, Il concetto dell’angoscia. Semplice chiarimento psicologico preliminare
al problema del peccato originale, di Vigilius Haufniensis, Paravia,Torino 1982
[nei due volumi di Aut-Aut, 1843, sono ordinati in due parti i vari saggi pubblicati anche
autonomamente; nel primo volume saggi di tema estetico (Don Giovanni, Diario del seduttore),
nel secondo volume saggi di carattere etico (in forma di due lunghe lettere: Etica ed estetica nella
formazione della personalità)
1. Come premessa: al centro dell’attenzione il finito, la singolarità.
Per tutta la prima metà dell’Ottocento, nel corso di una stagione di sicuro successo ufficiale e
accademico della filosofia hegeliana, cioè del progetto generale di un sistema logico del mondo e
della storia, la filosofia esprime un dilemma generale culturale irrisolto: 1. continuare nella
costruzione sistematica della realtà, affinandone i settori allo scopo di attribuire una natura logica
dialettica definitiva ai vari ambiti (dalla fisica alla politica, all’arte…); 2. trovare una via di uscita
dal sistema, vissuto come luogo di necessità e di costrizione, per ridare l’iniziativa all’esistenza, al
finito, al concreto, al singolare. In questo bivio si colloca lo scontro storico tra la filosofia di Hegel
e la riflessione (che egli si ostina a definire non filosofica, per marcare la propria distanza dalla
dominante filosofia hegeliana) di Kierkegaard; in questo stesso bivio l’estetica (e l’arte come sua
sede considerata pertinente) percorre nuove strade. Kierkegaard le individua, le apre e le propone
con perizia analitica.
1.1. Uno scontro tra filosofie a partire da uno che si considera esterno e inadatto ad essa
(storicamente: esterno a quello che allora si considerava filosofia o che era filosofia dominante).
«Lo scopo dunque mio è di servire la filosofia; la mia qualifica attinente è che sono idiota
abbastanza da non capirla, anzi più idiota ancora – idiota abbastanza da rivelarlo. E nondimeno, la
mia impresa può solo giovare alla filosofia; che danno infatti avrebbe se si mettesse a capirla
persino il più idiota? Proprio così ottiene la sua vittoria più completa e dimostra quanto sia fondato
rendere tutti filosofi.» (S. Kierkegaard, Prefazioni, Rizzoli, 1996, 123)
1.1.1. Contro il “divieto” di Hegel: «Ma che il finito sia assoluto è una posizione di cui nessuna
filosofia o opinione e nemmeno l’intelletto si lascerà certo incolpare.» (Hegel Scienza della logica
129), l’affermazione di Kierkegaard «La personalità diviene allora l’assoluto che ha la sua
teleologia in se stesso». «Egli è l’assoluto solo come singolo» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed
1
etica nella formazione della personalità 104, 114) «L’autore di queste righe è tutt’altro che un
filosofo; non ha capito il sistema» (Kierkegaard Timore e tremore 33)
1.1.2. Anche le opere del filosofo danese Søren Kierkegaard si oppongono, nei contenuti e nel
metodo, alla moda trionfante della filosofia hegeliana: all’enfasi di uno sviluppo oggettivo, reale e
universale dello spirito, egli contrappone la singolarità assoluta dell’esistenza soggettiva individuale
(«ciò che veramente mi manca è di capire chiaramente me stesso, quello che devo fare, quello che
devo conoscere»); al carattere fittizio della dialettica hegeliana, tutta giocata all’interno di un
sistema razionale necessario in cui non potrà mai accadere nulla di nuovo o di non prevedibile o di
non già previsto (la dialettica hegeliana si configura come una “ideologia del risentimento”, nei
confronti di una vita che accade senza che ci interpelli preventivamente, come se non avessimo la
rilevanza di esser degni di una consultazione; e come una filosofia del ricordo che vive di se stessa e
rammenta a se stessa i propri successi), Kierkegaard contrappone la dialettica ben più tragica ed
essenziale della scelta di sé e delle “ripresa” (termine opposto a “ricordo”). Alla pretesa hegeliana di
tradurre lo sviluppo della ragione e della realtà nei trattati sistematici della filosofia speculativa,
Kierkegaard oppone la scoperta dell’esistenza singola come possibilità infinita; e la possibilità,
essenza dell’esistenza, pone le forme di vita (estetica, etica, fede) al centro dell’esistenza e al centro
della riflessione filosofica. Tutto è perduto in partenza se nel sistema è persa la singolarità, tutto
allora, infatti, diventa sempre ed eternamente necessario, senza eventi e senza libertà.
1.1.3. La presa di posizione filosofica di Kierkegaard è, in modo più esteso, critica nei confronti di
opere che hanno di mira il successo e il consenso, nascono perciò solo dopo una indagine intorno ai
gusti diffusi, uno studio dei modi formali e dei tempi editoriali adatti ad assecondare, lusingare e
quindi abilmente manipolare il sentire comune e potersi così accreditare come l’opera del momento,
quella che offre finalmente, nel tempo presente, vertice di un lungo progresso, il sistema del mondo
per l’umanità e per l’eternità. In tal caso la filosofia è sonno delle menti, il tempo e le occasioni
sono annullate, sacrificate a momenti necessari di un sistema unico e totale. «Quale delizia è l'aver
scritto un libro che non debba i suoi natali a un oscuro stimolo interiore e quindi ignori s'è davvero
opportuno in questo mondo, timido e vergognoso come il testimone equivoco d'un amor
peccaminoso, no!, ma un libro che sia il frutto d'un matrimonio combinato tra editore e pubblico,
fatto come l'editore comanda e l'epoca esige, un libro la cui gestazione risulti nota a tutti previo
tempestivo annuncio, un libro per il quale la critica tenga già pronta una balia asciutta, un libro
ch'esca fuori nel momento giusto a vantaggio di tutti: dell'autore, dell'editore, dello stampatore, del
rilegatore, del recensore, del lettore. […] A tal riguardo, i più saggi e valenti sostengono unanimi
che il momento è Capodanno […] Quando si vuole pubblicare un libro, ci si assicura poi che giovi.
Al qual fine si chiede a un editore, o a una testa filosofica, o al suo barbiere, o a qualcuno per strada
cos'è che esige l'epoca. In mancanza ci s'inventa da soli qualcosa, senza scordar di dire che è quanto
l'epoca esige. Non a tutti è infatti data la forza d'animo per capire l'esigenza dell'epoca, tanto più che
all'incerto l'esigenza può sembrare plurima, ed a più voci l'epoca… […] E dunque, io giuro: di
realizzare al più presto un progetto coltivato per 30 anni dando alle stampe un sistema di logica, e di
adempiere al più presto la promessa da me fatta 10 anni or sono di un sistema di estetica; inoltre
prometto un sistema di etica e dogmatica, e buon ultimo il Sistema. Appena uscito questo, i posteri
non avranno nemmeno bisogno d'imparare a scrivere, che più nulla ci sarà da scrivere; basterà saper
leggere — il Sistema.» (S. Kierkegaard, Prefazioni, Rizzoli, 1996, 65-67)
1.2. La singolarità intesa come ricerca (continua) della singolarità.
Nelle opere di Kierkegaard viene esercitato il gioco letterario degli pseudonimi, gioco che è lui
stesso a svelare ironizzando (o giocando) sul gioco: «… il grande ciclo pseudonimico. «Io sono,
come si dice, autore di 0-0 [Enten-Eller] (Victor Eremita), Copenaghen, febbraio 1843; Timore e
tremore [Frygt og Bœven] (Johannes de silentio), 1843; La ripetizione [Gjentagelsen] (Constantin
Constantius), 1843; Sul concetto di angoscia [Om Begrebet Angest] (Vigilius Haufniensis), 1844;
Prefazioni [Forord] (Nicolaus Notabene), 1844; Briciole filosofiche [Philosophiske Smuler]
(Johannes Climacus), 1844; Stadi sul cammino della vita [Stadier paa Livets Vei] (Hilarius
2
Bogbinder, William Afham, l'Assessore, Frater Taciturnus), 1845; Postilla conclusiva alle "Briciole
filosofiche" [Afsluttende Efter skrift til de philosophiske Smuler] (Johannes Climacus), 1846, SV
VII 616. Così Kierkegaard in «Una prima e ultima spiegazione», ossia nell'ultima pagina, non
numerata e datata Copenaghen febbraio 1846, della Postilla.» (Borso Dario in prefazione all’opera
di Kierkegaard Søren 1844, Prefazioni. Lettura ricreativa per determinati ceti a seconda dell’ora e
della circostanza di Nicolaus Notabene, Rizzoli,Milano 1996) Lo stile e gli stratagemmi forse son
ben riassunti nelle parole e nella citazione con cui Kierkegaard chiude le Prefazioni: «vo col mio
passo sghembo sulla via del pensiero “morto alle tante cose di questo nostro mondo, / alle più varie
e strane, /alle solenni, alle quotidiane” (J. Baggesen)» (Kierkegaard, Prefazioni, 144)
1.2.1. In modo programmatico Kierkegaard presenta gran parte delle proprie opere con pseudonimi
bizzarri e ironici, misurati sullo stile, sul tema e sulle tesi dell’opera. In tal modo egli può presentare
e mettere in narrazione forme e modelli diversi di esistenza, prendendo la giusta distanza di
osservazione e contemporaneamente (o con questo stratagemma) immedesimandosi in esse e
descrivendole nei più minuti particolari, nelle convinzioni, nei vezzi e nelle abitudini; infatti egli ne
compare come l’autore adatto anche per il nome. Ma al tempo stesso Kierkegaard crea un distacco
da quelle forme, nega l’identificazione che esse esprimono non attribuendosene la paternità, infine
svelando quel nome / autore che le accompagna come uno pseudonimo. Il distacco dell’autore dalle
forme di esistenza narrate le trasforma allora in esistenze possibili; esse escono da una logica della
necessità per collocarsi all’interno di una logica della possibilità, della scelta; la logica
dell’esistenza. Dunque quelle narrazioni, e la filosofia che le mette a disposizione, non definiscono
né impongono ma inaugurano percorsi alla ricerca e costruzione della propria (mutevole) identità.
«La ripresa è uno dei tanti libri che Kierkegaard ha scritto velandosi sotto uno pseudonimo. È noto
che l'uso che egli fece degli pseudonimi non è una misura di prudenza o di difesa, ma rappresenta
realmente lo sforzo di parlare per conto di un altro; è estremamente significativo, per quel tentativo
che egli fece di staccare da sé uno alla volta i vari personaggi che coesistevano in lui, di affrontarli
uno per uno, di consentire ad ognuno di loro di spiegarsi e di giustificarsi; il ricorso agli pseudonimi
lo aiutò ad esercitare più abilmente quella maieutica, di cui usò con gli altri per meglio chiarire se
stesso e con se stesso per servire meglio gli altri. Mi sforzo di rendermi utile a te, benigno lettore,
trasformandomi in un'altra persona.» (Kierkegaard, La ripresa, premessa del traduttore Angela
Zucconi, 151).
1.2.2. L’opera citata Prefazioni. Lettura ricreativa per determinati ceti a seconda dell’ora e della
circostanza di Nicolaus Notabene, è emblematica per questa direzione. Si tratta di un’opera
composta di sole prefazioni che i riferimenti storici trasformano in ironia nei confronti di recensioni
critiche alle sue opere, ma sono anche prefazioni per libri che non ci sono (come segnalato nella
prefazione alle Prefazioni) o per libri possibili, come ad indicare direzioni possibili di opere. Una
proposta letterariamente filosoficamente difficile da classificare (ironico critica propositiva
psicologica… lo stesso Kierkegaard ironizza qui la mania del definire e classificare, di voler
«assegnare all’opera di ciascun singolo autore un posto nell’epoca sua, e all’opera dell’epoca sua un
posto in quella del genere umano» p. 49), in cui a partire dalla constatazione che una prefazione ha
una sua autonomia, ha un suo volto, che essa dice spesso molto più di un autore di quanto sia in
grado di fare l’opera stessa e a volte contiene elementi più importanti della stessa opera, propone
una analisi storicamente completa delle prefazioni quasi a costruire tutta un’altra storia, più umana,
più veritiera, più aperta al mondo come possibilità.
«Quest'ordine di cose mi ha messo in condizione di notare che la prefazione è un tipo assolutamente
specifico di prodotto letterario, e siccome viene maltrattato, è ora che si emancipi come tutto il
resto. Così può esserci ancora pace. L'incommensurabile, che in tempi più remoti era depositato
nella prefazione a un libro, può adesso trovare il suo posto in una prefazione che non lo è ad alcuno.
In questo modo, credo, la vertenza è felicemente risolta a contentamento mutuo delle parti; se la
prefazione e il libro non riescono a sopportarsi, che l'una dia all'altro avviso di separazione. […] Se
adesso però anche senza di ciò può venire voglia di scrivere una prefazione, allora si capisce che
questa non può trattare di un argomento, poiché nel caso la prefazione stessa si fa libro e la
3
questione del libro e della prefazione viene a cadere. La prefazione in quanto tale dunque, la
prefazione emancipata non deve avere argomenti da affrontare, ma trattare di niente…»
(Kierkegaard, Prefazioni, 50-52) Una prefazione emancipata, separata dal testo, non in necessaria
coerenza e convergenza con esso, come una possibilità introduttiva ad una esistenza plurima, una
prefazione o possibilità senza testo che si deve confrontare con il nulla.
1.3. il sorprendente incontro ( possibile) tra singolarità e universalità. «Nel singolo vedrà molto
più di quello che vi è immediatamente; per lui esso è l'universale.»
«Se gli uomini divenissero coscienti di sé con più energia, forse non pochi giungerebbero al
risultato che la realizzazione dell'universale è loro preclusa. Poi analizzerà se stesso per vedere se il
suo dolore per la sua posizione eccezionale è genuino. Egli dovrebbe realizzare l'universale nel
singolo, perché l'universale astrattamente non sussiste. Se non riesce, può dolergli o perché non può
realizzare nel singolo l'universale o perché non riesce a raggiungere il singolo mediante la
realizzazione dell'universale. In quest'ultimo caso egli soffre solo per la difficoltà casuale e non per
quella essenziale della sua posizione; e la vile indolenza dell'uomo può indurlo a mutare il dolore
essenziale in uno non essenziale. Egli però, la cui anima è nobilitata dall'amore per l'universale
umano, vorrà venire in chiaro, con tutta l'energia della sua coscienza, se egli nel singolo vuole
realmente l'universale o solo il singolo. Forse una riflessione del genere non gli parrà sufficiente e
vuol fare un tentativo. Vedrà facilmente che se il tentativo lo porterà allo stesso risultato, avrà la
verità tanto più inculcata; e se volesse risparmiare se stesso forse farebbe meglio a tralasciare il
tentativo stesso, perché finirebbe per soffrire ancora di più. Egli saprà che l'universale non è nulla di
singolo. Se dunque non vuol deludere se stesso, trasformerà il singolo nell'universale. Nel singolo
vedrà molto più di quello che vi è immediatamente; per lui esso è l'universale. Egli verrà in aiuto al
singolo e gli darà il significato dell'universale. Se sente che il tentativo non riesce, avrà messo tutto
bene a posto, cosicché quello che lo ferirà non sarà il singolo ma l'universale. […] Così egli, a
questo punto, si sarà emancipato dall'universale. In nessun momento sarà incosciente circa il
significato di un tale passo; poiché veramente fu lui stesso che rese la sconfitta completa e le diede
un significato; poiché sapeva dove era il suo punto debole ed egli stesso si indisse quelle ferite che
il singolo come tale non era in grado di infliggergli. Egli così sarà certo che vi è qualche cosa di
universale che non può tradurre in realtà. Ma, acquistata questa certezza, la partita non è chiusa,
perché coltiverà un profondo dolore nel suo animo. Si rallegrerà per gli altri ai quali è stato
concesso di realizzare l'universale; forse ne vedrà meglio degli altri la bellezza; ma egli stesso non
vorrà rattristarsi in un senso vile scoraggiato, ma con animo profondo, libero, forte. […] Neppure
con questa chiarezza che ha raggiunto, la partita è chiusa. Egli sente infatti che si è caricato di una
grave responsabilità. In questo punto, dirà : mi sono messo fuori dell'universale, mi sono privato
della guida, della fiducia e della tranquillità che dà l'universale; sono solo, senza simpatie, perché
sono una eccezione. Ma non diventerà vile e sconsolato. Andrà con sicurezza per il suo cammino
solitario; ha dato la dimostrazione della correttezza del suo modo d'agire, ha il suo dolore. Egli vuol
essere bene in chiaro con se stesso. […] Egli sente che quell'educazione che gli è toccata in sorte è
dolorosa : l'universale è un signore esigente, quando lo si ha fuori di sé, tiene continuamente
sospesa la spada del giudizio sopra lui e gli rimprovera di non saper rientrare nella legge, ed anche
s'egli risponde che non è colpa sua, glielo addebita e non recede dalle sue esigenze. Egli ritornerà
sempre al medesimo punto, rinnoverà continuamente la sua dimostrazione, di esser senza colpa, e
poi, intrepido, tirerà per la sua strada. […] Ciò che importa è realizzare l'universale con viva
intensità quando appena ciò è possibile. Se questo riesce, l'uomo che costituisce eccezione vedrà
scomparire nuovamente il suo dolore e dissolversi in armonia. Egli capisce che la sua posizione di
eccezione è solo l'espressione della limitatezza della sua individualità. Egli sa bene che ogni uomo
si evolve con libertà, ma sa anche che l'uomo non crea se stesso dal nulla, ed ha se stesso nella sua
concretezza come proprio compito; si concilierà di nuovo coll'esistenza, quando capirà che, in un
certo senso, ogni uomo è un'eccezione, e nello stesso tempo rappresenta l'universale umano.»
4
(Kierkegaard Søren 1842, Aut-Aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, A.
Mondadori, Milano 1993, 180-183)
1.3.1. La negazione della pretesa dell’universale ad esistere come sostanza e come sistema non si
traduce nella negazione dell’universale, ma nella restituzione dell’universale alla sua sede reale: il
singolo e la sua esistenza come possibilità: «Egli dovrebbe realizzare l'universale nel singolo,
perché l'universale astrattamente non sussiste.» L’esistenza dell’universale come assoluto è dominio
della legge e del potere, la negazione di ogni singolarità come luogo di scelta; Kierkegaard ha ben
presente il passo di San Paolo: la legge non salva ma condanna; «Infatti in virtù delle opere della
legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la
conoscenza del peccato.» (Romani 3,20); e come afferma Kierkegaard: «l'universale è un signore
esigente, quando lo si ha fuori di sé, tiene continuamente sospesa la spada del giudizio sopra lui e
gli rimprovera di non saper rientrare nella legge, ed anche s'egli risponde che non è colpa sua, glielo
addebita e non recede dalle sue esigenze». L’universale entra nel progetto del singolo in modo da
proclamare così, di ciascuno, l’assoluta singolarità di esistenza (estetica, etica e di fede): «Ciò che
importa è realizzare l'universale con viva intensità quando appena ciò è possibile. […] ogni uomo è
un'eccezione, e nello stesso tempo rappresenta l'universale umano.»
1.4. i termini estetici dell’arte in prima e universale comparsa, nella filosofia della possibilità.
Termini quali singolare e universale, scelta, libertà, possibilità, l’attimo e l’eternità… appartengono
a molti campi della riflessione generale e della filosofia; compaiono nei diversi ambiti con diversa
centralità e diversi significati; forse il loro campo privilegiato è quello della metafisica, della logica
e dell’etica. Ma sono le parole che pongono con chiarezza ed in modo esplicito per Kierkegaard il
problema della sensibilità estetica e in essa del ruolo dell’arte. Il campo dell’estetica è in particolare
delineato dai termini singolare universale e dalla specifica dialettica che si delinea nella loro
relazione. Si tratta di un’impostazione che risale ad autorevoli e classiche riflessioni filosofiche.
1.4.1. Occorre riprendere la riflessione di Platone (e a proposito di Platone) sulla bellezza e
sull’amore nella bellezza. Quando Diotima, il cui discorso viene riportato da Socrate nel Convito
platonico, parla di colui che iniziato, «giunto che sia ormai al grado supremo dell'iniziazione
amorosa, all'improvviso gli si rivelerà una bellezza meravigliosa per sua natura», in grado di
«contemplare la stessa bellezza divina nell'unicità della sua forma», afferma con chiarezza come
può realizzarsi una tale esperienza estetica contemplativa: «la contempli con il mezzo che le
conviene … mirando la bellezza per mezzo di ciò per cui è visibile»; (altrettanto esplicitamente nel
dialogo Fedro: «quando scorga un volto d'apparenza divina, o una qualche forma corporea che ben
riproduca la bellezza» Fedro 250a). La bellezza in sé, restando in sé, compare nella concretezza del
sensibile, e di un evento storico di bellezza, con la singolarità propria dell’universale; singolare
universale che si dà come astratto sì, tuttavia non come esistente in sé (non esistono sostanze
universali!) ma sempre nell’evento sensibile che costituisce il suo momento opportuno e qui il suo
accadere singolare. Per questo motivo, Diotima, parlando di colui che è giunto a contemplare la
bellezza in sé, ricorda come ciò si verifichi «mirando la bellezza per mezzo di ciò per cui è
visibile».
1.4.2. Paradossalmente le parole di Kierkegaard sulla esistenza come situazione che si iscrive nel
rapporto tra singolare e universale, pur presentando questo tema in dichiarata funzione anti-Hegel,
cioè contro le filosofie del sistema, utilizza le stesse categorie di Hegel. Il contrasto tra le due
impostazioni si gioca sulle stesse coordinate: universale e singolare; ma la sfida è consegnata al
ribaltamento della possibile relazione tra di loro. Nel campo dell’arte tuttavia, prendendo ad
esempio preliminare le riflessioni di carattere estetico, la posizione generale di Kierkegaard, che
pone alla base il finito, il singolare, sembra richiamare la concezione dell’arte espressa proprio da
Hegel. Per Hegel l’arte è manifestazione dell’Assoluto in forma immediata; perché così collocata,
secondo Hegel, l’opera d’arte acquista i tratti dell’unicum assoluto e irripetibile; un universale
singolare e assoluto: «La forma di questo sapere è, in quanto immediata (il momento della finità
dell’arte), da una parte un dirompersi in un’opera di esistenza esterna e comune, nel soggetto che
5
produce l’opera e in quello che la contempla e l’adora; dall’altra parte essa è l’intuizione concreta e
la rappresentazione dello spirito assoluto in sé come dell’ideale…» (Hegel G.W.F. 1817
Enciclopedia delle scienze filosofiche § 556.)
1.4.3. La distanza tra Hegel e Kierkegaard, proprio nell’esperienza e nell’esistenza estetica, è
tuttavia radicale. Il legame tra singolarità e universalità definisce l’esperienza estetica ma
contemporaneamente inserisce questa stessa esperienza in contesto e cammino completamente
diverso da quello costruito filosoficamente da Hegel. L’arte e l’esperienza estetica in essa non sono
la prima e immediata espressione dell’Assoluto come tappa di un cammino sistematico in cui
l’Assoluto realizza se stesso come pienezza di razionalità dialettica e di realtà ontologica, ma
delineano una forma dell’esistenza, quella estetica. E si tratta di una esistenza non priva di una sua
portata universale in termini di possibilità. Se l’esistenza estetica è una forma di vita dotata di una
propria determinatezza ed autonomia, è tuttavia anche in grado di mettere in atto potenzialità di
esperienza che non definiscono unicamente e in modo riservato solo una particolare tipologia di
esistenza, l’esistenza dell’esteta, ma esplorano la campo della possibilità irrinunciabile all’esistenza
nella sua assoluta singolarità. L’estetica rivela dunque la propria presenza efficace dinamica nei
campi e nelle forme di esistenza in cui il singolo si assume come compito e progetto, cioè anche
nella realizzazione etica di sé e nella fede e nei modi con cui l’esistenza si rapporta alla singolarità e
imprevedibilità degli eventi.
2. L’esistenza: uscita dalle forme e scoperta della possibilità.
2.1. La scoperta dell’esistenza in termini di possibilità: la possibilità è l’essenza dell’esistenza.
2.1.1. esistere nelle forme sociali. L’esistenza è sempre concretamente collocata in forme
determinate, socialmente definite e note nelle loro coordinate di comportamento e di valore; la
domanda «chi è», osserva polemicamente Kierkegaard, è solitamente soddisfatta da risposte che
indicano il ruolo sociale di una persona, come ad esempio: «è un amico di famiglia», «è il padre»,
«è il direttore». Gli stessi processi educativi sono per lo più impostati come una introduzione ai
ruoli sociali accettati, condivisi, dominanti e apprezzati. Tuttavia non è possibile pensare che le
forme sociali nelle quali il singolo è inserito ne definiscano essenzialmente l’esistenza. Ridurre
l’esistenza alle sue forme mondane significa sfuggire al compito filosofico di riflettere
sull’esistenza stessa.
2.1.2. oltre le forme e i ruoli definiti: la possibilità. È necessario dunque andare oltre le forme nelle
quali l’esistenza è calata; solo così l’esistenza ha modo di mostrarsi nella sua nudità e purezza, nella
sua essenza; questa essenza ha il nome di “possibilità”. È ora possibile ridefinire il compito della
filosofia: consiste nello studiare le condizioni perché la possibilità si realizzi nella scelta e nella
decisione e venga sempre garantita come essenza dell’esistenza.
2.1.3. A partire da questa tesi centrale Kierkegaard attua una rivoluzione delle categorie filosofiche
dell’esistenza e della realtà. Il possibile non viene più considerato come l’antecedente logico e
storico della realtà, ma come la sua essenza; la necessità non può presentarsi come una categoria
dell’essere, ma solo come una categoria logica: la realtà infatti nella sua essenza storica è
possibilità; la possibilità è dunque la categoria dell’essere, della esistenza nella sua singolarità.
L’esistenza, di conseguenza, non è un semplice attributo di un’essenza metafisica universale in sé
definita secondo forme eterne e necessarie, ma è la vera definizione dell’essere se viene considerato
nella sua storica e autentica singolarità e dunque nella sua possibilità.
2.2. il tema del nulla e il sentimento di angoscia. Non iscritta in un sistema razionale necessario,
né ridotta a forme comuni codificate, imposte a ogni individuo come modelli universali di vita,
l’esistenza non trova la propria definizione nelle categorie con le quali solitamente l’uomo si orienta
nel mondo; non gode più del protettivo conforto dell’universale («In questo punto, dirà : mi sono
messo fuori dell'universale, mi sono privato della guida, della fiducia e della tranquillità che dà
l'universale; sono solo, senza simpatie, perché sono una eccezione.» (Aut-aut, 182) Allontanata dai
sistemi convenzionali di riferimento, l’esistenza diviene l’esperienza della libertà infinita, della
6
possibilità pura, ma anche del totale sradicamento e del nulla. Non è possibile incontrarsi con la
propria esistenza singola, scoperta come possibilità, senza un processo di azzeramento e
nullificazione delle forme universali con cui la ragione sistematica e le abitudini sociali tendono a
classificare, secondo codici generali e modelli precostituiti, ogni singola esistenza; ridurre al nulla
le forme mondane significa assistere alla propria mondana nullificazione, vivere
contemporaneamente e paradossalmente l’esperienza della possibilità infinita e del vuoto totale.
«Ma quale effetto ha il nulla? Esso crea l’angoscia.» (Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, 51)
«L'origine dell'angoscia è la pura e semplice esistenza, intesa come fonte del possibile. L'angoscia è
il sentimento del potere; privo, ancora, della consapevolezza di un fine ultimo: in, altri termini è la
coscienza della libertà; libertà tuttavia di nulla.» (Aut-Aut, prefazione Remo Cantoni, X)
2.2.1. Il sentimento dell’angoscia. Kierkegaard indica questa esperienza con il nome di angoscia;
egli ne chiarisce il significato distinguendola dall’esperienza della paura. Mentre la paura, il timore,
è il sentimento che l’uomo prova di fronte a un pericolo concreto e a un impegno determinato, il
timore di non riuscire a far fronte ad un impegno preso, l’angoscia è il sentimento di smarrimento
totale che l’uomo prova di fronte al nulla fronte alla scoperta della non giustificabilità del proprio
esistere, nella sua singolarità ed unicità, a partire dalle forme sociali condivise e apprezzate.
L’angoscia che l’uomo prova di fronte alla propria esistenza come possibilità infinita, diventa un
sentimento totale, radicale, difficile da sopportare; perciò è spinto a trasformare l’angoscia in paura,
elude la propria esposizione all’angoscia preoccupandosi di compiti ben definiti: riempie l’esistenza
di impegni, di responsabilità e di compiti; egli tende così a eludere l’insostenibile sentimento di
angoscia che pone l’uomo di fronte alla sua nuda, singola esistenza, sostituendola con il timore per
insuccessi mondani, con la preoccupazione per le cariche assunte e con il compiaciuto sentimento di
autostima che accompagna sempre colui che si carica di compiti e di responsabilità.
Ma l’angoscia è qualcosa di completamente diverso dal sentimento di paura; questa accompagna un
uomo totalmente immerso in ruoli e compiti sociali, esterni a sé seppure da lui fatti propri e assunti
come propria definizione e dedizione non solo professionale; l’angoscia, invece è il coraggio di
stare di fronte a sé avvertendosi nella pienezza delle possibilità, senza giustificazioni mondane.
L’angoscia è infatti l’esperienza del nulla e della possibilità e quindi il sentimento dell’esistenza
autentica, pura, «ritrovata» dalle forme mondane; si tratta dell’individuo posto di fronte alla propria
decisione, al proprio infinito e al proprio nulla. «Colui ch’è formato dall’angoscia, è formato
mediante possibilità; e soltanto chi è formato dalla possibilità, è formato secondo la sua infinità.
Perciò la possibilità è la più pesante di tutte le categorie.» (S. Kierkegaard, Il concetto
dell’angoscia, 137)
2.2.2. l’angoscia diventa sintesi (come schema, cammino e processo) tra singolarità e universalità,
tra tempo ed eternità (l’attimo come luogo dell’incontro tra tempo ed eternità; luogo in cui tempo e
eternità si realizzazione in forza della loro negazione), momento estetico, etico e movimento della
fede. «L'attimo è l'ambiguità nella quale si toccano la temporalità e l'eterno. Così si pone davvero
anche la temporalità nella quale il tempo mai cessa di tagliare l'eternità e l’eternità mai cessa di
penetrare nel tempo. […] La pienezza dei tempi è l'attimo compreso come l'eterno e questo eterno è
tuttavia sia il futuro che il passato... […] La sintesi dell'anima e del corpo deve essere posta dallo
spirito. Ma lo spirito è l'eterno che non ha esistenza se non quando pone anche la sintesi del
temporale e dell'eterno. Finché non è posto l'eterno l'attimo non esiste. […] Come lo spirito quando
doveva essere posto nella sintesi, o meglio, quando doveva porre egli stesso la sintesi, si
manifestava come la possibilità di se stesso o della libertà, nell’individuo, e si esprimeva
nell'angoscia, così il futuro è la possibilità dell'eterno, è la possibilità stessa della libertà.» (Il
concetto dell’angoscia , 80-81)
3. fenomenologia delle esistenze: estetica, etica, della fede
La filosofia diventa una analitica dell’esistenza, della esistenza come possibilità, dei modi con cui
nelle diverse forme di esistenza viene gestito il rapporto con la realtà.
3.1. l’esistenza dell’esteta.
7
3.1.1. Estetica e arte di gestire l’istante, l’attimo, la circostanza. L’esteta vive i momenti
dell’esistenza come attimi piacevoli, colti nell’immediatezza. Immediatezza del desiderio, inteso in
senso temporale: «Nel desiderio l'individuo è immediato, e, per quanto il piacere sia raffinato,
ricercato, studiato, l'individuo è pur sempre in esso come immediato. Chi gode è nel momento, e per
quanto molteplice sia questo godimento, egli è sempre immediato, perché è nel momento. Pertanto
vivere per soddisfare i propri desideri è una posizione molto raffinata nella vita, e, grazie a Dio, è
raro vederla realizzata.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità,
30) Immediatezza in termini di valore e valutazione: senza mediazioni, al di fuori di ogni regola,
quesito, scrupolo etico o religioso; egli gode la vita nella sua immediatezza, senza sottoporre le
circostanze e le proprie azioni all’esame di valori morali universali; tutto è per lui egualmente
indifferente. «Ciò che l'esteta teme è la continuità che lo priva della possibilità di ingannare se
stesso, e gli altri. Egli raggiunge nell'attimo una impensata grandezza, perché vi porta tutta l'anima e
persino l'energia del volere. Nell'attimo egli ha in potere tutto il suo essere; ma cos'è egli l'attimo
dopo?» (Kierkegaard, Aut-aut. Postfazione, Remo Cantoni, 191)
3.1.1.1. Non si tratta tuttavia di una semplice passiva fruizione dell’attimo, l’esteta è un “tecnico”
della vita, possiede una capacità particolare: «Egli è l'uomo che vuol vivere poeticamente, dotato
com'è di una raffinata sensibilità che gli permette di cogliere sempre il lato interessante della vita.»
(Remo Cantoni, Introduzione a Diario del seduttore, 9). La sua perizia consiste nel saper
trasformare ogni istante e ogni circostanza in momento piacevole nel quale investire pienamente
l’impeto straordinario, la passione calcolatrice e la raffinata sensibilità che lo contraddistinguono.
Una sintesi ben orchestrata di immediatezza e calcolo, capace di unire il massimo della
piacevolezza dell’accadere finito con la pacatezza dell’attesa e con il silenzio di ogni precipitazione
densa di affanno e di smanie di successo. «Niente impazienza, niente avidità, tutto sarà goduto a suo
tempo» (Kierkegaard Søren 1843 Diario del seduttore 1990, 30). La destrezza dell’esteta non è
perdita dunque della fruizione piacevole dell’attimo. «Quando si diviene più esperti in un certo
senso si guadagna, giacché certo si perde l'impaziente desiderio e il turbamento che ne nasce, ma si
acquista la padronanza necessaria per rendere l'attimo effettivamente delizioso.» (Kierkegaard
Søren 1843 Diario del seduttore 1990, 34); «Chi vive eticamente non distrugge lo stato d'animo, ma
lo considera un attimo; questo attimo lo salva dal vivere nel momento, questo attimo gli dà la
padronanza sul piacere. L'arte di signoreggiare il piacere non sta tanto nel distruggerlo o nel
rinunziarvi completamente, quanto nel determinare il momento. Prendi qualsiasi piacere tu voglia; il
suo segreto, il suo potere sta nel fatto che esso è nel momento assoluto. Si sente spesso la gente dire
che l'unico mezzo è di astenersi completamente dai piaceri. Questo è un metodo assai errato,che può
avere successo solo per un certo tempo.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione
della personalità, 78). Né perdita dell’immediatezza: «… per quanto il piacere sia raffinato,
ricercato, studiato, l'individuo è pur sempre in esso come immediato.» (Kierkegaard, Aut-aut.
Estetica ed etica nella formazione della personalità, 30). Perizia perfetta dell’attimo, pur con il
timore dell’attimo a seguire, quello che subentra all’estinguersi del piacere: «Tu sei nell'attimo, e
nell'attimo sei di una grandezza soprannaturale; vi sprofondi con tutta la tua anima, anche
coll'energia della volontà, poiché nell'attimo hai il tuo essere assolutamente in tuo potere. Chi ti
vede solo in un istante come questo, è assai facile che venga ingannato, mentre chi attende l'istante
che segue, potrà facilmente trionfare su te.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella
formazione della personalità, 48)
3.1.2. Estetica e disperazione. Totalmente proiettato verso le circostanze l’esteta si identifica con
ciò che gli accade; egli vive quindi all’esterno di sé, inseguendo e moltiplicando ad arte le occasioni
piacevoli allo scopo di allontanare la disperazione che accompagna il pensiero, anzi la
consapevolezza e l’esperienza della loro precarietà e del loro rapido deterioramento.
La logica del piacere è quella della scomparsa e dell’urgenza per una sua reiterazione. La fugacità
dell’istante incombe sull’esistenza estetica come un tratto a lui esterno, incalza l’esteta verso una
continua ricostruzione della piacevolezza; una ricostruzione sempre più artefatta, sofisticata e, a
volte, diabolicamente raffinata e complessa, in cui l’esteta finisce per irretirsi come in un bozzolo
8
che fatalmente e consapevolmente dipana attorno a sé. Processo che Kierkegaard descrive con
letteraria perizia fenomenologica nell’opera che più di altre tratteggia la figura dell’esteta: Diario
del seduttore. Su quella febbrile e calcolata ricerca del piacere nelle circostanze incombe il rischio
del fallimento e il conseguente stato di disperazione; ricerca spasmodica e incubo della disperazione
che si alimentano reciprocamente.
3.1.3. Estetica della disperazione come reazione all’incontro fatale di estetica e disperazione.
L’estetica annovera tra i propri colpi di genio una reazione di carattere ancora di tipo estetico, forse
estetico al sommo grado, proprio nei confronti della disperazione: estetizza la disperazione. La
disperazione stessa viene trasformata e ostentata dall’esteta nelle forme di una esperienza di dolce
tristezza, illanguidita melanconia; i movimenti, i gesti, lo sguardo ostentano una infinita tristezza,
come a dimostrare che l’animo dell’esteta ospita l’infinito, frequenta l’assoluto e vive l’esperienza
del sublime; una disperazione che si pone così all’esterno del soggetto, come se fosse una semplice
circostanza, e viene ostentata come la più alta e raffinata sensazione estetica. Una disperazione
estetica frutto di pregevole tecnica che porta Kierkegaard a parlare di «una forma di disperazione
intellettuale» (Kierkegaard Søren 1843, Aut-Aut. Estetica ed etica nella formazione della
personalità, 42). Tutta la sensiblerie romantica viene indirettamente richiamata, e posta in ironia, da
Kierkegaard a descrivere la perizia estetica attivata nel trasformare la disperazione nella massima e
più raffinata esperienza estetica; sentimento che Kant avrebbe etichettato come “piacere negativo” e
vicina all’esperienza del sublime e Kierkegaard enuncia il paradosso: «Si tratta, niente di meno,
della concezione che il dolore sia il vero significato della vita; l'essere più infelice di tutti sarebbe
appunto il più felice!» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità,
80) L’arte dell’esteta è qui in massima attività: «Siccome hai esercitato il tuo spirito a concepire
tutta l'esistenza in categorie estetiche, è naturale che il dolore non sia sfuggito alla tua attenzione,
perché esso è di per se stesso interessante non meno della gioia. L'intrepidezza colla quale afferri
l'interessante dovunque esso appare, dà costantemente motivo a chi ti circonda di giudicarti male; a
volte ti considerano assolutamente senza cuore, altre volte un uomo veramente bonario, benché tu
non sia veramente né l'uno né l’altro.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione
della personalità, 81) Afferma Kierkegaard: «nessuna ebbrezza è bella quanto la disperazione,
nessuna è così decorativa, esercita tanto fascino, specialmente agli occhi delle fanciulle, (e ne sei
molto bene informato) soprattutto quando contemporaneamente si possiede l'arte di saper reprimere
le espressioni più incolte, permettendo che la disperazione venga solo presentita come un incendio
lontano e traspaia solo segretamente. Essa dà un leggero tocco al cappello ed al portamento di tutto
il corpo; lo sguardo diviene orgoglioso e ribelle; il labbro sorride arrogante. Essa dà una
indescrivibile leggerezza alla vita, una regale superiorità su tutto. E quando una figura simile si
avvicina a una fanciulla, quando questo essere così orgoglioso si inchina solo davanti a lei, per lei
sola tra tutti, essa si sente adulata, e, peggio ancora, vi potrebbe essere una fanciulla tanto innocente
da credere a questo inchino.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della
personalità, 41-42); «… con poche esclamazioni misteriose, che solo lei può capire, lasci
intravedere come spiegazione di tutto una lontana malinconia. Ti apri solo con lei, ma tanto
prudentemente che essa veramente non arriva mai a sapere qualche cosa di più preciso, lasci che la
sua fantasia immagini la profonda tristezza che nascondi nel più profondo del cuore. Sei astuto, non
lo posso negare, ed è vero quello che una fanciulla mi disse di te, che probabilmente finirai per
diventare un gesuita. Quanto più astutamente sai, scherzando, tirare tra le loro mani le fila che
conducono sempre più in fondo ai ripostigli della tua tristezza, tanto più sei contento, tanto più sei
certo di attirarle a te. Non fai dei lunghi discorsi, non palesi il tuo dolore con cordiali strette di mano
o con romantici sguardi negli occhi romantici di un'anima sincera, sei troppo intelligente per farlo.
Sfuggi i testimoni, e solo in rari istanti ti lasci sorprendere. Per le fanciulle vi è un'età in cui non v'è
veleno più pericoloso della tristezza, e tu lo sai, e questa tua conoscenza, come ogni altra, di per se
stessa può essere abbastanza buona; ma io non posso lodare l'uso che ne fai.» (Kierkegaard, Autaut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, 80-81)
9
3.1.4. L’aut-aut: lo stare nella scelta. A interrompere e smascherare questa «tristezza estetica»
(Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, 51, disperazione
estetica o estetizzata, «dolore estetico», di un esteta «geloso del dolore» Kierkegaard, Aut-aut.
Estetica ed etica nella formazione della personalità, 83, 82), può, osserva Kierkegaard, «accadere la
gioia» (e anche il ridicolo di fronte alla inopportunità di una simile, drammatica e manierata,
ostentazione di tristezza e malinconia): l’irruzione nella vita dell’uomo di momenti piacevoli,
cogliendo di sorpresa il raffinato esteta, ne smaschera il gioco delle ostentazioni.
3.1.4.1. Nel sottile gioco dell’esteta, scaltro nel trasformare in apparizioni estetiche ogni attimo e la
stessa tristezza, la disperazione e il dolore, questi, in realtà ne escono progressivamente alimentati.
A generare e corroborare la disperazione è l’essenza stessa dell’esistenza estetica: collocare la vita
al di fuori del soggetto, riporla nelle circostanze inseguite e ricostruite in continuazione con perizia
manipolativa senza fine, sotto la certezza del loro sicuro svanire crea disperazione; vivere
all’esterno di sé, viversi come insieme continuo di circostanze esterne, questo è già disperazione e
alimento continuo della disperazione: «… ogni concezione che fa dipendere il senso della vita da
qualcosa di esteriore è disperazione. » (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione
della personalità, 83). «…le idee intorno al godimento sono varie, ma sull'espressione che si deve
godere la vita, tutti sono d'accordo. Ma chi scorge nel godimento il senso e lo scopo della vita,
sottopone sempre la sua vita a una condizione che, o sta al di fuori dell'individuo, o è nell'individuo
ma in modo da non essere posta per opera dell'individuo stesso. Ti prego, riguardo a quest'ultimo
punto, di fissare bene in mente le espressioni, poiché sono state scelte con cura. […] Incontriamo
concezioni di vita che insegnano che bisogna godere la vita, ma metterne la condizione al di fuori
dell'individuo. Questo è il caso di ogni concezione di vita in cui ricchezza, onori, nobiltà, ecc.
vengono elevati a compito e contenuto della vita.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella
formazione della personalità, 26, 29) Il tarlo della sconfitta e della liberazione è nell’essenza
dell’esistenza estetica.
3.1.4.2. L’esistenza, nella dinamica estetica, non è nelle mani di chi sembra condurla, ma è nelle
mani delle circostanze. «La sua concezione di vita è dunque legata a una condizione che non è in
suo potere; infatti non è proprio in potere dell'uomo rinunciare alla gioia o al dolore.» (Kierkegaard,
Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, 83). In quella commedia della
tristezza e del “dolore estetico” può accadere la gioia. Nella lunga lettera che costituisce il testo di
Aut-aut, Kierkegaard presenta analiticamente il tema e il passaggio: «È una cosa sulla quale non
occorre che io attiri la tua attenzione, perché puoi impararla dal tuo maestro Scribe, che molto
spesso ha schernito quei sentimentali che credevano ad un dolore eterno. Chi dice che il dolore è il
significato della vita ha da temere la gioia al di fuori di sé, come chi vuole essere felice ha da
temere il dolore al di fuori di sé. La gioia lo può sorprendere precisamente nello stesso modo in cui
il dolore può sorprendere quell'altro. La sua concezione di vita è dunque legata a una condizione
che non è in suo potere; infatti non è proprio in potere dell'uomo rinunciare alla gioia o al dolore.
Ma ogni concezione che fa dipendere il senso della vita da qualcosa di esteriore è disperazione.
Così volere il dolore è disperazione proprio allo stesso modo che volere la gioia, perché è sempre
disperazione avere la propria vita in qualcosa il cui senso è quello di svanire. Sii pure astuto e
perspicace quanto vuoi, scaccia pur la gioia con un aspetto piagnucoloso e, se lo preferisci,
tradiscila col tuo aspetto per conservare il dolore, la gioia ti potrà sempre sorprendere.»
(Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, 83)
3.1.4.3. Svelato il gioco, l’esteta è posto di fronte alla vuotezza della propria esistenza che si rivela
priva di trama, dominata dall’inconsistente e parossistico inseguimento di circostanze piacevoli ma
fugaci; è una presa di coscienza che si traduce ancora in disperazione, ma questa non è più
estetizzabile. «Guarda, mio giovane amico, questa vita è disperazione. Nascondilo agli altri, ma a te
stesso non lo puoi nascondere : è disperazione. Sei troppo frivolo per disperare, e troppo
malinconico per non venir a contatto colla disperazione. Sei come una partoriente, eppure continui a
procrastinare il momento e rimani sempre colle doglie.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica
nella formazione della personalità, 52) Non funziona il vecchio gioco di gestire la disperazione
10
ponendola all’esterno, trasformandola in mostra di sé, facendola diventare una circostanza e una
ostensione estetica di sé. Non si colloca più all’esterno dell’individuo, come una semplice
circostanza da trasformare in momento di piacere, in momento estetico, esibito come “sublime”; ma
accade dentro l’esistenza dell’esteta e ne mostra il vuoto. Solo accettando la disperazione come
fatto interiore, il vuoto e il nulla delle forme che intrinsecamente la caratterizza, l’esteta è posto di
fronte alla scelta come inizio e centro di una nuova esistenza; riconoscere nella vita la centralità e il
ruolo della scelta come condizione di fedeltà a se stessi e alla propria possibilità; restare fedeli
all’angoscia. Si tratta di una nuova situazione di esistenza: quella etica.
3.2. l’esistenza etica.
«Chi vive esteticamente non sceglie, perché vivere esteticamente è vivere nell'indifferenza. La
personalità dell'esteta in sé non è nulla, ed è solo in rapporto ad altri; diviene tutto, perché in tutto
può disperdersi, ma in sé non è nulla. Eppure nella vita giunge l'ora della mezzanotte, in cui ognuno
deve gettare la maschera. La vita non è un gioco continuo e non si può fuggir via qualche minuto
prima della mezzanotte, in silenzio e senza smascherarsi. Niente è più terribile di questo dissolversi
della personalità. Essa, prima, gioca colle possibilità, ma poi sono le possibilità che si prendono
gioco di lei, e noi rimaniamo privati di ciò che di sacro e più intimo è nell'animo : la forza
centralizzante della personalità. Ciò che dà valore all'uomo non è la cultura dello spirito, ma la
maturità della personalità e l'etica consiste appunto nella ricerca della personalità. […] Ma non
potremmo, nell'alternativa, scegliere la vita estetica? Se riflettiamo bene, vediamo che la scelta
estetica non è una vera scelta, semplice e radicale come la scelta etica. Essa non pone antinomie
radicali, non s'impegna, e si riserva sempre, di poter scegliere, nel momento successivo, qualcosa di
diverso da ciò che ha già scelto. Nella scelta etica ciò che importa non è scegliere giusto, quanto
mettere tutta la propria energia e la propria serietà nella scelta. […] L'Aut-Aut non è la scelta tra
bene e male, ma la scelta con cui si accetta o no il contrasto di bene e di male. Chi l'accetta non può
scegliere che il bene. L'estetica non è il male, ma l'indifferenza etica, e per questo motivo solo
l'etica è veramente in grado di scegliere, e il carattere etico non viene conferito dalla riflessione, ma
dalla volontà. L'estetica nell'uomo, è ciò per cui l'uomo è immediatamente ciò che è, e cioè natura.
L'etica è ciò per cui egli diventa ciò che diventa.» (Kierkegaard, Aut-aut. Postfazione, Remo
Cantoni, 189-190)
L’esistenza etica consiste nell’accettare la scelta, l’aut-aut, abbandonando l’esistenza consegnata
all’indifferenza. Mentre nell’esistenza estetica il gioco della vita è condotto dalle circostanze che
l’esteta insegue senza scelta e di cui diviene una tragica vittima, l’esistenza etica nasce
dall’accettare la scelta. L’aut-aut di cui parla Kierkegaard, come condizione di esistenza etica, non
va inteso come contrasto tra bene e male e non si traduce quindi in uno scontato e inutile invito a
scegliere il bene; è proprio l’aut-aut infatti a essere oggetto di scelta. Accettare l’aut aut significa
accettare la scelta, stare nella scelta, avere sempre il coraggio della scelta (è il coraggio etico); solo
così l’uomo giunge alla sua concreta realizzazione; l’etica, infatti «è ciò per cui l’uomo diventa
quello che diventa».
Ma sul tema dell’etica Kierkegaard tratteggia due opposte situazioni.
3.2.1. etica nella ripetizione e nella fedeltà alle regole
L’atto di scelta è un atto etico; esso avvia un’esistenza che non si affida alle circostanze e al loro
occasionale accadere, ma poggia sulla decisione di assumere responsabilità, compiti, impegni. La
continuità, la ripetizione è qui vissuta come un valore: è la scelta di possedere e gestire il tempo
confermando nel presente il passato nella forma di assunzione di compiti e garanzia di
responsabilità nel loro adempimento. Assumere il tempo nella ripetizione e nella fedeltà ai compiti
diventa la forma mondana dell’eternità. La vita etica è l’esistenza di chi si attribuisce dunque un
ruolo sociale, tiene fede agli impegni, non si sottrae alle scelte e alle responsabilità familiari,
professionali, sociali, accetta di confermare ogni giorno il passato con alto senso del dovere,
sorretto e confortato dal pubblico riconoscimento.
11
3.2.1.1. Questa prima forma di esistenza etica ha il proprio fondamento in valori e leggi universali,
norme astratte che si collocano all’esterno dell’individuo: l’uomo talvolta subisce queste norme
conformandosi in modo cupo e passivo ai doveri, talvolta vi aderisce in modo superficiale e
compiaciuto, ostentando una condotta che non nasce da una convinzione interiore, ma da una
opportunità sociale. Di fronte ai doveri sentiti come imposizioni esteriori, l’uomo è spinto alla
trasgressione o all’indifferenza: la violazione, il peccato acquistano, sullo sfondo dell’obbligo e
della coercizione, il carattere accattivante della sfida e dell’autoaffermazione, oggetto di vanto per
sé di fronte al mondo dell’opinione, quindi in un’etica della trasgressione che ha comunque bisogno
di pubblico e che ha nella sua ammirazione / riprovazione un riconoscimento di esistenza personale
vissuto talvolta con (diabolico e irrinunciabile) piacere. È una condizione scritta nella natura a suo
modo paradossale della legge, della regola, della norma: la violazione della regola deve restare
operante (altrimenti non c’è bisogno della norma) e non ammessa (altrimenti si annulla la norma)
perché la regola stessa possa funzionare; nell’etica della legge non c’è salvezza per il peccato, per
colui che trasgredisce; ritorna qui la tesi espressa da San Paolo nella Lettera ai Romani: «per mezzo
della legge si ha solo la conoscenza del peccato. […] La legge infatti provoca l’ira; al contrario
dove non c’è legge non c’è nemmeno trasgressione.» La legge impone e condanna non salva, la
legge che salva dal peccato è la legge che distrugge se stessa. (Romani, 3,20; 4,15)
3.2.1.2. Per inciso e ripresa a distanza. L’etica della ripetizione, sostenuta dal godimento
narcisistico individuale e sociale della pubblica e personale stima, è assegnata da Freud alla
pulsione di morte, la cui efficacia è garantita dal suo accordo funzionale con l’impulso del piacere
(il piacere autodistruttivo; la simbiosi di eros e thànatos); pulsione di morte nel consegnarsi del
soggetto, con ansia e gratitudine per premi, giudizi e meriti, alla legge, al sistema.
3.2.2. etica della scelta di sé
Nell’etica autentica l’uomo sceglie se stesso: posto di fronte alla propria singolarità e, quindi, alla
propria concreta finitudine, l’uomo assume la piena responsabilità di se stesso come risultato e
come compito, si apre con concretezza alla dimensione della possibilità. Si tratta di una seconda
presentazione dell’esistenza etica
3.2.2.1. dai principi assoluti alla singolarità come un assoluto. Ai principi etici universali e astratti,
che nel loro assoluto valore si collocano al di fuori dell’aut-aut e sono quindi esterni all’individuo e
fuori dall’etica autentica, Kierkegaard contrappone una seconda situazione etica: l’esistenza
individuale nella concretezza della sua storia, nella propria assoluta e unica singolarità, quale si è
venuta formando attraverso le scelte altrui e proprie. Chi compie tale scelta «ha allora se stesso
come un individuo con determinate doti, determinate passioni, determinate inclinazioni, determinate
abitudini, esposto a determinate influenze esteriori, sollecitato ora in un senso ora in un altro. Egli
ha se stesso come compito». All’assoluto dei valori morali astratti, propri di un’etica inautentica,
Kierkegaard contrappone dunque l’assoluto di ogni concreta esistenza: chi sceglie se stesso nella
concretezza della propria personalità si sceglie come assoluto: «La personalità diviene allora
l’assoluto che ha la sua teleologia in se stesso». (Il riferimento è al passaggio del testo di
Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, 99-104)
3.2.2.2. L’esistenza etica autentica non consiste nel rapportarsi a valori e leggi universali, astratte ed
esterne, né nel cercare per sé le grandi occasioni, nel poter lasciare il segno («Molti, che pure hanno
un’idea di cosa sia la vita umana, desiderano d’esser contemporanei di grandi avvenimenti, di essere
coinvolti in importanti circostanze di vita.»). Sono direzioni dell’etica che possono generano effetti
devastanti: una totale riduzione del singolo al generale; un ostentato compiacimento
(autocompiacimento) del proprio “essere a posto” (esser qualcuno); la percezione di un cupo senso
del dovere e della legge come fattori esterni e oppressivi; il fascino conseguente della trasgressione
e del peccato visti ed esaltati come contesto di libertà… l’etica autentica è fedeltà a se stessi; il
valore assoluto compete al singolo e non all’universale.
3.2.2.3. il singolo assoluto come risultato e compito. «Egli è l’assoluto solo come singolo».
(Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della personalità, 114) Tale assoluto non
comporta però una sterile accettazione di sé come se il soggetto fosse un dato di fatto ingiudicabile;
12
implica invece che l’individuo si assuma a un tempo come principio e conclusione. «Nessuno si
scopre concretamente e non astrattamente come progetto se non si scopre e non si accetta anche
come prodotto.» La scelta di sé, della concretezza che caratterizza l’esistenza singola è piena
assunzione di responsabilità, senza presunzioni e senza fughe. Il motivo della concretezza e dello
scegliersi secondo la propria concretezza è la radice di un’etica autentica. Si ribadisce, dunque, il
tema del finito, rispettato nella sua determinazione storica; e proprio il motivo del finito diventa la
base per condannare fughe verso l’infinito, che è un fuggire dalla scelta dalla responsabilità; fughe
che hanno alla radice il mancato rispetto della base unica in cui una scelta autentica e densamente
operativa può avvenire: la scelta di sé come risultato e come compito.
Il passaggio di Kierkegaard: «Solo quando nella scelta si entra in possesso di se stessi, si ha
indossato se stessi, si ha penetrato se stessi, totalmente, in modo che ogni movimento è
accompagnato dalla coscienza di una responsabilità, solo allora si ha scelto se stessi eticamente,
solo allora ci si è pentiti di se stessi; solo allora si è concreti, solo allora si è nel proprio isolamento
totale in assoluta continuità con quella realtà alla quale si appartiene. Questa determinazione che
scegliere se stessi è identico a pentirsi di se stessi non la ripeterà mai abbastanza spesso, per quanto
semplice sia di per sé. Infatti tutto si aggira intorno a questo. […] Chi invece sceglie se stesso
eticamente si sceglie concretamente, come questo individuo determinato, e raggiunge questa
concretezza coll’esser questa scelta identica al pentimento, che sanziona la scelta. L’individuo
diventa cosciente di sé come questo determinato individuo, con queste doti, queste tendenze, queste
passioni, questi ardori, influenzato da questo determinato ambiente, come questo determinato
prodotto di un mondo circostante determinato. Ma mentre diventa cosciente di sé in questo modo,
egli assume tutto sotto la sua responsabilità. Non esita se debba prender o no con sé anche il
particolare, perché sa che qualche cosa di molto più alto va perso se non lo fa. Così nel momento
della scelta egli è nel più completo isolamento, perché si ritira da quel che gli è attorno; eppure
nello stesso momento è in assoluta continuità perché sceglie se stesso come prodotto; e questa scelta
è la scelta della libertà, così che mentre sceglie se stesso come prodotto, si può anche dire che
produce se stesso. Egli così al momento della scelta è alla conclusione, perché la sua personalità si
racchiude; eppure nello stesso momento è proprio al principio perché sceglie se stesso secondo la
sua libertà. Come prodotto è premuto nelle forme della realtà, nella scelta rende se stesso elastico,
trasforma tutta la sua esteriorità in interiorità. Egli ha il suo posto nel mondo; nella libertà sceglie
egli stesso il suo posto, cioè, questo stesso posto che egli ha. È un individuo determinato; nella
scelta rende se stesso un individuo determinato: cioè questo stesso individuo che egli è. Poiché egli
sceglie se stesso. L'individuo sceglie perciò se stesso come una concretezza molteplicemente
determinata, e perciò si sceglie secondo la sua continuità. Questa concretezza è la realtà
dell'individuo; ma poiché la sceglie secondo la sua libertà, si può anche dire che è la sua possibilità,
o, per non usare un'espressione così estetica, che è il suo compito. Chi vive esteticamente infatti non
fa che vedere ovunque possibilità, queste costituiscono per lui il contenuto del futuro; mentre chi
vive eticamente vede dappertutto compiti. L'individuo dunque vede questa sua reale concretezza
come compito, come scopo, come fine. Ma che l'individuo veda la sua possibilità come il suo
compito esprime proprio la sua sovranità sopra se stesso, alla quale non rinuncerà mai, anche se
d'altra parte non prova gusto nella sovranità del tutto indisturbata che è sempre del re senza regno.
Questo dà all'individuo etico una sicurezza che a chi vive solo esteticamente manca del tutto. Chi
vive esteticamente attende tutto da fuori. Da ciò il terrore malsano col quale molti parlano
dell'orrore di non aver trovato il loro giusto posto nel mondo. Nessuno vorrà negare la gioia che
deriva dall'aver trovato il proprio posto; ma un terrore come quello denota sempre che l'individuo
attende tutto dal suo posto e nulla da se stesso. Chi vive eticamente saprà anche sceglier bene il suo
posto; se invece sente che ha sbagliato o che si elevano gli ostacoli che non sono in suo potere, non
perde il coraggio, perché non rinuncia alla sovranità su se stesso. Egli vede subito il suo compito, e
perciò è immediatamente attivo. […] Qui voglio richiamare la mia definizione dell’etica: essa è ciò
per cui l’uomo diventa quello che diventa. Essa non vuole che l’individuo diventi un altro, ma se
stesso; non vuole distruggere l’estetica, ma illuminarla. Perché l’uomo possa vivere eticamente è
13
necessario che divenga cosciente di sé tanto radicalmente che nessuna casualità gli sfugga. L’etico
non vuole cancellare questa concretezza dell’uomo, ma vede in essa il suo compito, vede ciò da cui
deve formare e ciò che deve formare. Di solito si considera l’etica in modo assolutamente astratto e
perciò si ha un segreto terrore di essa. L’etica vien considerata come qualche cosa di estraneo alla
personalità, e ci si duole di doversi affidare ad essa, perché non si può mai sapere con certezza dove
essa finirà col condurci. Così molti temono la morte perché hanno idee oscure e vaghe che l’anima
colla morte debba passare in un altro ordine di cose … […] Il vero individuo etico perciò ha una
calma ed una sicurezza in sé, perché non ha il dovere fuori di sé ma in sé.» (Kierkegaard, Aut-aut.
Estetica ed etica nella formazione della personalità, 99-103)
3.2.2.4. L’etica della propria singolarità prende avvio dalla consapevolezza dell’uomo di non poter
mai rispettare totalmente la legge e quindi dalla inevitabile esperienza del peccato. Si tratta di una
situazione che apre una strada completamente nuova. In questa situazione non è tanto il peccatore a
cadere sotto la condanna etica, ma la legge per la sua pretesa di valere più della singolarità e di
valere come un assoluto all’esterno e ignorando ogni singolarità.
3.2.2.4.1.Colui che ha peccato va incontro alla condanna espressa dalla legge; la legge non può fare
nient’altro oltre la condanna, se infatti accettasse il peccatore e lo giustificasse annullerebbe
contemporaneamente se stessa. (È evidente il ricordo della lettera di Paolo ai Romani: «in virtù
delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui [Dio], perché per mezzo della
legge si ha solo la conoscenza del peccato»; la legge ha il ruolo storico di evidenziare il peccato e
creare l’urgenza, il tempo opportuno, della salvezza). Il peccato e la conseguente condanna hanno
l’effetto di espellere il peccatore dalla norma, dall’universale, dal generale e dal conforto, dalla
giustificazioni in cui essi collocavano il singolo.
3.2.2.4.2. Ma a cadere sotto la condanna a cui espone il peccato è dunque sia il peccatore, sia la
legge: questa evidenzia il proprio fallimento, è incapace di salvezza, è in difetto di fronte
all’esistenza e alla sua singolarità; consegnata alla necessità, la legge non conosce la possibilità, ed
è questo il suo maggior peccato, il peccato della legge. L’etica condanna il peccato, ma non libera
l’uomo da esso; anzi ribadendo la legge lo evidenzia e spinge “zelanti pastori” a trasformarsi in
pedanti archivisti del peccato e delle sue molte facce (e a renderlo indirettamente seducente).
3.2.2.4.3. Prende allora forma un’altra direzione etica: l’etica della scelta di sé, della fedeltà alla
possibilità e quindi alla propria esistenza. La condanna rimanda l’individuo a se stesso; la
singolarità espulsa dalla norma, dall’universale, dal generale è posta di fronte al nulla e alla
possibilità; la scoperta del peccato, accanto all’espressione del pentimento, diventa rilancio della
possibilità. Torna al centro il tema della scelta: la scelta di sé; si apre quindi una nuova etica, quella
della fedeltà a se stessi, alla propria esistenza nella possibilità della propria concretezza.
3.2.2.4.4. Correttamente inteso, allora, il peccato non consiste nella trasgressione della legge, ma
nel non volere «intensamente e profondamente» la propria esistenza, nel rifiutare la scelta di sé, che
è rifiuto della propria storia e dell’intera storia dell’umanità. La scelta della propria storica
singolarità passa attraverso il pentimento (pentirsi significa assumere la responsabilità di se stessi,
nella concretezza) e scegliere se stessi implica riconoscere come iscritta nella propria singolarità
concreta, senza rimozioni e senza alibi, la propria storia e ciò che l’ha resa possibile, l’intera storia
dell’umanità con i suoi errori e le sue occasioni mancate.
3.2.2.5. Scegliersi nella responsabilità. Pentirsi del peccato in modo autentico, e non solo formale,
significa dunque pentirsi di se stessi, ma anche assumere e scegliere se stessi, porre al centro
dell’etica la scelta della propria singolare continuità con il passato e della propria infinita libertà. La
malattia mortale dell’uomo è la disperazione in quanto assenza di responsabilità, cioè la mancata
accettazione e scelta di sé. «Chi ha scelto e trovato se stesso eticamente, ha determinato se stesso in
tutta la sua concretezza. Egli allora ha se stesso come un individuo con determinate doti,
determinate passioni, determinate inclinazioni, determinate abitudini, esposto a determinate
influenze esteriori, sollecitato ora in un senso ora in un altro. Egli ha se stesso come compito, e tale
compito consiste sopratutto nell'ordinare, educare, temperare, infiammare, reprimere, in breve, nel
raggiungere nell'anima un equilibrio, un'armonia che è frutto delle virtù personali. Lo scopo della
14
sua attività è qui lui stesso, ma non seguendo il suo arbitrio, bensì come un compito che gli è stato
posto, anche se è diventato suo perché l'ha scelto. Ma benché egli stesso sia il proprio scopo, pure
questo scopo è un altro: poiché quell'io che è lo scopo, non è un io astratto che va bene dovunque e
perciò in nessun luogo, ma un io concreto che sta in una viva reciproca comunione con un
determinato ambiente, con certe circostanze, con un determinato ordine di cose. Questo io, che è lo
scopo, non è soltanto un io personale, ma un io sociale e civile.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed
etica nella formazione della personalità, 111)
3.3. l’esistenza nella fede.
L’angoscia (non la disperazione, né la tristezza, tanto meno quando viene estetizzata in melanconia)
è il sentimento della possibilità infinita che, paradossalmente, si presenta con il fallimento delle
forme di esistenza alle quali l’uomo aveva affidato la propria realizzazione e come alternativa
radicale al peccato e alla condanna che la legge emette nei confronti di colui che, nel peccato, si è
posto al di fuori di ogni possibile giustificazione. Collocato al di fuori dell’universale, di ogni
categoria e di ogni giustificazione, l’uomo è posto di fronte alla propria singolarità; isolato dal
mondo delle relazioni generali, etiche e sociali, egli è solo di fronte alla nuda esistenza, di fronte
alla possibilità pura, di fronte al nulla; il sentimento della possibilità infinita, del nulla si rivela nella
forma dell’angoscia: «Colui che è formato dall’angoscia è formato mediante la possibilità; e
soltanto chi è formato dalla possibilità, è formato secondo la sua infinità.» (Kierkegaard, Il concetto
dell’angoscia, 137) È questa la situazione di una nuova forma di esistenza, quella della fede:
l’angoscia che salva per mezzo della fede. Sola la fede sottrae l’esistenza al gioco dei sotterfugi
messi in atto per ingannare la possibilità (quindi ingannare l’angoscia e perciò la stessa esistenza) in
forza del suo doppio movimento: di annullamento e di ripresa. [i richiami biblici sono numerosi e
centrali: Abramo, Giobbe, Cristo]
3.3.1. Distingui tra fede e religione. Nella società “borghese” che Kierkegaard analizza, la religione
è diventata strumento sociale di conforto e di controllo. Si è tradotta in dettami morali, in dottrine
consuetudinarie diventate luoghi comuni di orientamento (spaccio dogmatico di verità), in riti e
momenti finalizzati ad ostentare il proprio di esser per bene nel sociale e sostenere il diritto ad
essere collocati in rispettabili gradi della gerarchia. È diventata dunque uno strumento di conformità
e un potente sistema di annullamento dell’esistenza come possibilità. Si è tradotta in «prudenza
delle cose finite», morale laica della ripetizione, in essa la fede non ha alcun ruolo e, intesa per se
stessa, è completamente bandita come fattore di disturbo. Anche se il riferimento al divino continua,
con disinvolta empietà, a ricorrere nei discorsi privati e ufficiali, nello stile ormai noto degli “atei
devoti”, si tratta ormai di una religione senza fede, ridotta a costume, consuetudine e legge;
copertura ipocrita e immorale di leggi consuetudinarie ingiustificate e assurde.
3.3.2. È necessario richiamare il carattere di evento salvifico della fede, la sua assoluta
intraducibilità in discorsi e opere mondane, la gratuità teorica e pratica della salvezza nella fede, la
natura di paradosso e di contraddizione dell’annuncio. La fede è stare in solitudine e silenzio (fuori
dalla norma) di fronte a Dio, fedeli alla infinita possibilità. La guida alla scoperta della fede è la
figura biblica di Abramo, padre della fede, che il comando di Dio pone in totale solitudine, al di
fuori di qualsiasi giustificazione etica del gesto che per comando divino e fede si accinge a
compiere: il sacrificio del figlio Isacco. In questo episodio biblico fondamentale nella storia di
Israele, il porsi del singolo di fronte a Dio nella fede è tener ferma la possibilità, esperienza di
libertà, di nullificazione e di angoscia, luogo dell’esistenza autentica.
3.3.3. il doppio movimento della fede. La fede, la solitudine del singolo di fronte a Dio, significa
qui allora restare fedeli alla possibilità, all’infinito e non consegnare l’esistenza alle forme sociali
preordinate (anche quelle proprie della religione, trasformata in istituzione del e nel sociale) come
se da loro debba derivare la nostra definizione e la nostra essenza. Tuttavia, contrariamente a quanto
sembrerebbe risultare a prima analisi, tale distanza infinita dai ruoli e dalle circostanze non si
traduce affatto in separazione e disprezzo del quotidiano e dei suoi rituali, ma in una loro libera e
gioiosa fruizione; l’uomo di fede è totalmente di questo mondo proprio perché da esso è
15
infinitamente distante; egli acquisisce e mantiene nei suoi confronti, in forza della possibilità, una
infinita distanza e di conseguenza una libertà di partecipazione.
Con l’esame analitico di più casi, tra loro eterogenei, Kierkegaard analizza l’esperienza e l’esistenza
definita dal movimento della fede (l’effetto è anche quello di metterne in luce la forte componente
estetica). In particolare 1. L’episodio biblico di Abramo invitato da Dio a sacrificare il figlio Isacco
(messo a confronto e contrasto con la vicenda apparentemente analoga di Agamennone e il
sacrificio della figlia Ifgenia); 2. La figura del cavaliere della fede (messo a confronto e contrasto
con l’eroe tragico, il cavaliere dell’eterna rassegnazione; 3. Il suo rapporto con Regina Olsen nel
tormentato e breve fidanzamento (messo a confronto e contrasto con la storia del Tritone e di
Agnese). Così nelle opere del 1843 Timore e tremore. Lirica dialettica di Johannes de Silentio, e La
ripresa. Tentativo di psicologia sperimentale di Constantin Constantius.
3.3.3.1. Al centro della riflessione che svolge sulla fede Kierkegaard colloca la figura di Abramo, il
padre della fede. La sua singolare esperienza incarna e rappresenta, senza mediazioni e senza
compromessi, il paradosso della fede. «E avvenne che Dio provò Abramo. E disse: Prendi ora il tuo
figliolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moriah, e offrilo quivi in
olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Era mattina: Abramo si levò, fece sellare gli asini, lasciò
la sua abitazione insieme a Isacco; e, dalla finestra, Sara li guardò scendere lungo la valle finché
non li perdette di vista. Camminarono tre giorni in silenzio; alla mattina del quarto giorno Abramo
non disse parola, ma, levando gli occhi, vide in lontananza le montagne di Moriah. Rimandò
indietro i suoi servi e, preso Isacco per mano, salì la montagna. …» (Kierkegaard, Timore e
tremore, 36). In più modi Kierkegaard scrive l’incipit dell’episodio cercando la forma giusta…
introvabile per narrare la fede. «Si ha un bel formulare in concetti tutta la sostanza della fede…»
(Kierkegaard, Timore e tremore, 33)
3.3.3.1.1. la fede e il paradosso con l’etica. Dio invita Abramo a sacrificargli il figlio Isacco, ma nel
momento in cui egli si avvia a compiere il sacrificio, aderendo nella fede al comando di Dio, si pone
al di fuori dell'etica; non vi è infatti nessun sistema morale che possa comprendere e giustificare la
sua azione, contraria a ogni regola e priva di alcuna finalità sociale (questa, almeno, compariva
nella vicenda di Agamennone). «Io mi propongo ora di ricavare dalla storia di Abramo, sotto forma
di problemi, la sua dialettica; per vedere quale inaudito paradosso è la fede, paradosso capace di
trasformare un delitto in un atto santo e gradito a Dio, paradosso che restituisce ad Abramo suo
figlio, paradosso che nessun ragionamento può dominare, perché la fede comincia là, appunto, dove
la ragione finisce. » (Kierkegaard, Timore e tremore, 77)
3.3.3.1.2. il doppio movimento della fede. L’episodio di Abramo, padre biblico della fede, consente
a Kierkegaard di identificare e descrivere nella fede il significato autentico dell’esistenza come
doppio movimento tra finito e infinito. Abramo, decidendo di sacrificare Isacco, rinuncia alla
propria dimensione finita (individuale e universale, estetica ed etica, l’etica della legge) per affidarsi
all’infinito; Dio, evitando il sacrificio di Isacco, restituisce all’uomo il finito che riaccade come
dono, grazia, perenne inizio.
Da una parte l’esistenza autentica nella fede si presenta come rifiuto di identificare l’esistenza con
le forme mondane in cui è impegnata, dall’altra, proprio il movimento dell’infinita rinuncia a ciò
che è finito, compiuto nella fede e non nella rassegnazione e nella disperazione, rende possibile la
scoperta e la ripresa del finito come dono ed evento gratuito: «Ora se egli non inganna la possibilità,
se non abbindola l’angoscia, gli viene restituito tutto come non avviene mai a un uomo nella realtà,
anche se ricevesse dieci volte tanto»; «la fede fa il contrario: dopo aver compiuto i movimenti
dell’infinito, essa fa quelli del finito» (Kierkegaard, Timore e tremore, 60).
Solo il «salto» nella fede, dunque, e la decisione di accettare la propria solitudine di fronte a Dio, al
di fuori di qualsiasi conforto etico, permette all’uomo di mantenersi fedele al senso della possibilità
e dell’infinito e, in questa dimensione, ancora paradossalmente e per assurdo, di non perdere, ma di
scoprire e vivere il finito come possibilità (come infinita possibilità). Il finito riaccade e viene
restituito in forza dell’infinita rinuncia. «Ma Abramo credette e non dubitò. Credette l’assurdo. […]
Credette per assurdo, perché non si poteva trattare di un calcolo umano. E l'assurdo era nel fatto che
16
Dio, domandandogli quel sacrificio, avrebbe revocato la sua esigenza un momento dopo. Salì il
monte, e persino nell'attimo in cui levò il coltello credette — che Iddio non gli avrebbe chiesto
Isacco. Certo Abramo fu sorpreso per la soluzione della cosa; ma, con un doppio movimento, egli
aveva già raggiunto la sua con dizione originaria; e perciò ricevette Isacco con gioia anche più
grande della prima volta. […] … il movimento della fede deve sì costantemente essere effettuato in
virtù dell’assurdo, ma (particolare essenziale) in modo da non perdere il mondo finito e anzi da
guadagnarlo integralmente» (Kierkegaard, Timore e tremore, 46, 58, 60)
3.3.3.2. La figura del “cavaliere della fede” e dei suoi movimenti, figura scovata da Kierkegaard
dopo lunga e minuziosa ricerca.
«Si fa presto a riconoscere i cavalieri della infinita rassegnazione: essi camminano con un passo
elastico e ardito. Ma quelli che portano il tesoro della fede ingannano facilmente perché il loro
aspetto esterno offre un'impressionante somiglianza con quanto è profondamente disprezzato sia
dalla infinita rassegnazione sia dalla fede: vogliamo dire, con lo spirito borghese. Diciamolo
sinceramente: durante le mie osservazioni, non ho trovato un solo esemplare autentico di cavaliere
della fede, senza perciò voler negare che forse un uomo ogni due ne sia un campione. Eppure, per
molti anni ne ho cercato le tracce; ma sempre invano. Si suol fare il giro del mondo per veder
montagne e fiumi, nuovi astri, uccelli multicolori, pesci mostruosi, bizzarre razze umane; ci si
abbandona ad uno stupore animale, si sgranano gli occhi davanti al mondo e si crede d’aver veduto
qualcosa. Tutto ciò mi lascia indifferente. Ma se io sapessi dove si trova un cavaliere della fede,
andrei anche a piedi e subito, in cerca di questo prodigio che per me ha un interesse assoluto. Non
lo lascerei un istante; ad ogni minuto scruterei come fa a compiere i suoi movimenti e,
considerandomi ormai ben provveduto per tutta la vita, dividerei il mio tempo in due parti, una per
osservarlo, l’altra per esercitarmi. Tutta la mia vita passerebbe ammirandolo. Lo ripeto: un uomo
simile, non l’ho trovato, eppure posso assai bene rappresentarmelo. Eccolo: abbiamo fatto
conoscenza, gli sono stato presentato. Ma nel momento medesimo che io lo considero, ecco che mi
tiro indietro, giungo le mani, e dico a mezza voce: «Gran Dio! È quest’uomo qui, è proprio lui? Ha
tutta l’aria di un agente delle imposte! ». Eppure, è proprio lui. Mi avvicino un poco, sorveglio ogni
suo minimo movimento per cercar di sorprendere qualcosa di un’altra natura, un minuscolo segno
telegrafico trasmesso dall’infinito, uno sguardo, un’espressione della fisionomia, un gesto, un’aria
melanconica, un sorriso che riveli l’infinito nella sua irriducibilità rispetto al finito. Macché! Nulla.
Lo esamino dalla testa ai piedi, cercando la fessura attraverso la quale si riveli l’infinito. Nulla! È
solido in ogni punto. Il suo passo? Tranquillo, interamente confidato al finito. Nessun borghese
vestito a festa che faccia la sua settimanale passeggiata a Fresberg ha un’andatura più sicura della
sua. È completamente di questo mondo, come nessun bottegaio saprebbe esserlo di più. Nulla che
riveli quella rara e altera natura alla quale si riconosce il cavaliere dell’infinito. Si rallegra d’ogni
cosa, si interessa a tutto; ed ogni volta che lo si vede intervenire in qualche luogo, lo fa con la
perseveranza caratteristica dell’uomo terrestre, il cui spirito è legato a simili cure. È in quel che fa.
A vederlo, lo si crederebbe uno scriba che abbia perso l’anima nella contabilità in partita doppia,
tanto è meticoloso. Santifica la domenica. Va in chiesa. Nessuno sguardo celeste, nessun segno
dell’incommensurabile lo tradisce; se non lo si conoscesse, sarebbe impossibile distinguerlo dal
resto dell’assemblea; perché il suo modo sano e forte di cantare i salmi prova, tutt’al più, che ha
buoni polmoni. Nel pomeriggio, va in campagna. Si diverte di tutto quel che vede, del movimento
della folla, dei nuovi omnibus, della vista del Sund; e quando lo si incontra sulla Strandvej, lo si
scambierebbe con un droghiere in vacanza tanto si diverte. Perché non è affatto poeta; e invano ho
cercato di sorprendere in lui l’incommensurabile della poesia. Verso sera, torna a casa; il suo passo
non rivela maggior fatica di quello di un fattorino. Cammin facendo, pensa che sua moglie gli ha
preparato per cena un buon piatto caldo, una vera e propria novità, una testina di capretto arrosto,
per esempio, con contorno, forse. […] Vive senza pensieri, come un fannullone, eppure paga al più
caro prezzo il suo buon tempo, con ogni istante della sua vita: perché non fa nulla se non in virtù
dell’Assurdo. Eppure (è una cosa da diventar furioso, almeno di invidia) quest’uomo ha compiuto e
compie ad ogni istante il movimento infinito. Egli vuota nell’infinita rassegnazione la melanconia
17
profonda della vita. Conosce la beatitudine dell’infinito. Ha provato il dolore della totale rinunzia a
quanto si ha di più caro al mondo. Nondimeno, gusta il finito con la pienezza di godimento di chi
non ha mai conosciuto nulla di più elevato. Vi dimora senza traccia del tirocinio che l’inquietudine
e il timore fanno subire; e ne gode con tale certezza che sembra non vi sia per lui nulla di più sicuro
che questo mondo finito. Eppure tutta l’immagine del mondo che egli produce è una creazione
nuova, dovuta all’Assurdo. Si è infinitamente rassegnato a tutto, per poter tutto riacquistare in virtù
dell’Assurdo. Compie costantemente il movimento dell’infinito ma con una tale precisione e
sicurezza che ne ricava incessantemente il finito, senza che neppure per un istante sia possibile
supporre qualcosa di diverso. […] I cavalieri dell’infinito sono dei ballerini, non mancano di
elevazione. Saltano in aria e ricadono; passatempo non sgradevole né spiacevole a vedersi. Ma ogni
volta che ricadono, non possono ritrovarsi subito sulle loro gambe, vacillano un istante, in
un’esitazione che mostra quanto essi siano estranei al mondo. Quel vacillare è più o meno sensibile,
a seconda della bravura; ma neppure il più abile fra di loro può dissimularlo. È inutile guardarli
mentre sono in aria; basta vederli al momento in cui toccano il suolo. Allora è possibile riconoscerli.
Ma ricadere in modo tale, che si paia, al tempo stesso, dritti e in moto; trasformare in marcia il salto
nella vita, esprimere lo slancio sublime nella più comune andatura, ecco ciò di cui è capace soltanto
il cavaliere della fede, ecco il prodigio unico. […] Esaminiamo ora un po’ più da vicino la
sofferenza e l’angoscia contenute nel paradosso della fede. L’eroe tragico rinunzia a se stesso per
esprimere il Generale; il cavaliere della fede rinuncia al Generale per diventare Individuo. L’ho
detto, tutto dipende dalla situazione in cui ci si trova. Se si crede cosa relativamente facile essere
l’Individuo, si può esser sicuri che non si è il cavaliere della fede; perché gli uccelli in libertà e i
geni vagabondi non sono uomini della fede. Al contrario, il cavaliere della fede sa che è cosa
magnifica appartenere al Generale. Sa che è bello ed utile essere l’Individuo che si traduce nel
Generale e che, per così dire, offre di se stesso un’edizione pura, elegante, corretta al massimo,
intelligibile a tutti; conosce il conforto di diventare comprensibile a se stesso nel Generale, in modo
da comprendere quest’ultimo e in modo che ogni individuo che comprenda lui stesso comprenda
anche il Generale, ambedue trovando la loro gioia nella fiducia del Generale. Sa come è bello esser
nato quale Individuo che nel Generale ha la propria patria, la propria dimora amica, sempre pronta a
riceverlo quando voglia abitarla. Ma sa anche che sopra quella regione serpeggia un cammino
solitario, stretto e ripido; sa quanto sia terribile essere nato solitario fuori del Generale, e camminare
senza incontrare mai un solo compagno di strada. Sa perfettamente dove egli è, e come si comporta
verso gli uomini. Per essi, è un pazzo, e nessuno può comprenderlo. Eppure, pazzo, è il meno che si
possa dire. Se non lo si considera pazzo è allora un ipocrita; e tanto peggiore, quanto più in alto va il
suo pensiero.
Il cavaliere della fede sa quale entusiasmo dia la rinuncia, nella quale ci si sacrifica per il Generale e
quale coraggio essa richiede; ma sa anche che c’è, in una simile condotta, una tranquilla sicurezza,
appunto perché essa è rivolta al Generale. Sa che è magnifico esser compreso da ogni anima nobile
e in modo tale che colui che lo consideri si faccia ancora più nobile. Sa tutto questo, e si sente come
avvinto; desidera talvolta che sia questo il compito assegnato a lui. Abramo avrebbe così potuto
talvolta desiderare che il suo compito fosse quello di amare Isacco come conviene ad un padre, di
un amore intelligibile a tutti e indimenticabile; avrebbe potuto desiderare che il suo compito fosse
quello di sacrificare Isacco nell’interesse generale e di dare ai padri l’entusiasmo delle gesta
gloriose. Ed era quasi atterrito pensando che quei desideri non erano per lui altro che crisi e che
dovevano essere considerati come crisi; perché egli sapeva di seguire un cammino solitario, di non
far nulla nell’interesse generale, ma di essere soltanto provato e tentato. […] Ma Abramo credette.»
(Kierkegaard Søren 1843 Timore e tremore, edizioni di Comunità, Milano 1971, pp. 60-61,63,64,
98-100)
3.3.3.2.1. Nei tratti descrittivi del Cavaliere della fede la definizione estetica dell’arte: la capacità di
cogliere, salvare, valorizzare e gustare il finito, il momento, la singolarità come assoluto. Ciò in
forza dell’infinita distanza, della rinuncia, dell’assurdo, della possibilità e dell’angoscia che
permettono di cogliere il finito come singolare e come evento. «Ha provato il dolore della totale
18
rinunzia a quanto si ha di più caro al mondo. Nondimeno, gusta il finito con la pienezza di
godimento di chi non ha mi conosciuto nulla di più elevato. […] … tutta l’immagine del mondo che
egli produce è una creazione nuova, dovuta all’Assurdo. […] Compie costantemente il movimento
dell’infinito ma con una tale precisione e sicurezza che ne ricava incessantemente il finito, senza
che neppure per un istante sia possibile supporre qualcosa di diverso.» (Kierkegaard Søren 1843
Timore e tremore)
3.3.3.3. Kierkegaard e Regina Olsen: la fidanzata, storicamente di breve periodo, di quattordici
mesi (10 settembre 1840 - 11 ottobre 1841); la fidanzata perenne nell’esistenza secondo la logica
della fede e della ripresa.
«Kierkegaard cerca di ritrovare il carattere originario del primo istante, dell'inizio; vuol riscoprire la
fanciulla, la fidanzata, sotto la donna. Impossibile giungervi sul piano estetico, mediante sensazioni
rinnovate. Don Giovanni o Edoardo il seduttore saranno sempre delusi; non giungeranno mai al
reale (ecco quanto cerca di provare il Diario di un seduttore); impossibile anche, almeno per
Kierkegaard, giungervi sul piano etico con la costanza della volontà. Non rimane che andare al di là
delle sensazioni, e anche al di là della volontà; non rimane che varcare i limiti dell'immanenza e
arrischiarsi, avventurarsi sul piano religioso, aiutati da una specie di volontà santificata. È quanto ci
lasciano intendere La ripresa e Timore e tremore. Ecco infatti la risposta che Kierkegaard ci
proporrà: se ho fede bastante, se sono veramente degno di Abramo, il padre della fede, sì, potrò
sposare Regina. Posso rinunciare a lei, e, per un miracolo incomprensibile, Iddio me la renderà;
questo matrimonio mi sarà possibile, come fu possibile ad Abramo ritrovare il figlio cui aveva
rinunciato. E anche il tempo sarà mutato; così che sarà al di sopra del tempo ordinario, in un tempo
maturato dove nulla accade e nel quale la fanciulla rimarrà presente nella donna. Ma sono io
Abramo? E si sa che Kierkegaard ha risposto «no» a questa domanda. E questo è il motivo per cui
non ha sposato la donna cui si era promesso.» (Timore e tremore, prefazione di Jean Wahl, 9-10)
Regina Olsen avrebbe dovuto capire che doveva tornare da Kierkegaard proprio perché da lui era
stata allontanata, cioè in forza di quella rinuncia; allora vi sarebbe tornata o sarebbe comparsa come
un dono, una grazia, una apparizione capace di restare infinitamente prima o originaria, fuori dalla
ripetizione, dal ricordo, dalla mera conferma del passato.
3.3.3.3.1. Ricordo e ripresa. «… ciò che si ricorda è stato, ossia si riprende retrocedendo, mentre la
vera ripresa è un ricordare procedendo» (Kierkegaard, La ripresa, 157)
Ricordo è vivere del passato in una nostalgia del non ritorno; è confermare il passato consegnandolo
ad una ripetizione che ha i tratti della necessità per l’assoluta assenza di eventi reali che lo
caratterizza; nulla accade e nulla vi è di vero che non sia prevedibile. Il sistema assoluto della
filosofia è deduzione secondo necessità, ripetizione e negazione di ogni autentica singolarità, una
filosofia della necessità.
Ripresa è considerare il passato come luogo in cui l’esistenza, che è possibilità, trova la propria
concretezza e singolarità e permette al soggetto una autentica scelta etica di sé come risultato e
compito; il passato e il suo accumulo è il solo modo per definire l’esistenza con singolarità e non
con categorie prese da enunciati generali. Di conseguenza, la nostalgia ostacola la ripresa, introduce
nell’esistenza la rinuncia a se stessa e la consegna al già accaduto.
«Come i greci insegnavano che conoscenza è reminiscenza, così la filosofia moderna insegnerà che
tutta la vita è una ripresa. Leibniz è il solo filosofo moderno che ne abbia avuto il presentimento.
Ripresa e reminiscenza rappresentano lo stesso movimento ma in direzione opposta, perché ciò che
si ricorda è stato, ossia si riprende retrocedendo, mentre la vera ripresa è un ricordare procedendo.
Perciò la ripresa, ammesso che sia possibile, rende l'uomo felice, mentre la reminiscenza lo rende
infelice, a condizione però che l'uomo si dia tempo di vivere e non cominci appena nato a trovare un
pretesto per riandarsene, magari con la scusa di aver dimenticato qualcosa.
Il solo amore felice è l'amore-ricordo, ha detto un certo scrittore [Kierkegaard si riferisce a se stesso
in Enten-Eller, I, p. 28]. Bisogna convenire che è giusto, purché non si dimentichi che esso al
principio ha reso l'uomo infelice. L'amore-ripresa è in verità il solo amore felice perché non porta
con sé, al pari dell'amore-ricordo, l'inquietudine della speranza, né la venturosa trepidazione della
19
scoperta, né la commozione della rimembranza, ma soltanto la felice certezza del momento. La
speranza è un vestito nuovo fiammante, che non fa pieghe né grinze, ma non puoi sapere se ti va, né
come ti va, perché non l'hai mai indossato. Il ricordo è come un vestito smesso, per quanto bello
non puoi indossarlo, perché non ti entra più. La ripresa è una veste che non si può consumare, che
non stringe né insacca, ma dolcemente aderisce alla figura. […] Chi vuole soltanto sperare è vile;
chi vuole soltanto ricordare è un voluttuoso; chi vuole la ripresa è un uomo, tanto più degno di
questo nome quanto più vigorosamente ha saputo proporsela. Ma chi non comprende che la vita è
una ripresa, e che in questo consiste tutta la bellezza della bellezza della vita, merita soltanto il
destino che lo attende: perire.» (Kierkegaard, La ripresa, 157-158).
4. la definizione di estetica nelle forme dell’esistenza o l’estetica trova definizione
nelle forme dell’esistenza.
L’estetica in Kierkegaard non è una teoria; nelle sue opere non vi sono intenti e progetti di una
teoria sul bello o sull’arte, ma una presentazione dell’esperienza estetica in figure, personaggi o
modelli che descrivono in forme di esistenza i loro progetti e il loro destino. In questa impostazione
emergono netti e operativi i caratteri dell’esperienza estetica e risalta con evidenza la sua capacità di
presentarsi come funzione culturale ampia e totale, sociale e individuale, non considerata solo
propria di settori determinati ed autonomi come può accadere all’estetica collocata in teorie o storie
specifiche dell’arte.
Radicata sul tema dell’esistenza, e dell’esistenza come possibilità, l’estetica in Kierkegaard diventa
una esplorazione dei modi di gestione della esperienza che fa riferimento e coinvolge, con diversa
rilevanza e modalità, tutte le forme possibili di vita del soggetto. Il risultato di questo
coinvolgimento è di reciproca scoperta e chiarificazione tra estetica e forme di vita: da una parte, è
solo nella varietà delle forme di esistenza, fenomenologicamente narrate e ricostruite, che l’estetica
evidenzia la propria dinamica e la propria aperta efficacia; dall’altra, grazie alla dinamica propria
dell’estetica, che non si separa settorialmente ma opera nelle diverse forme di vita, queste portano a
pieno effetto teorico e pratico la loro natura e la loro produttività. Afferma Kierkegaard: «Con
queste considerazioni credo di aver abbastanza chiaramente tracciato il territorio della concezione
estetica; tutti gli stadi hanno in comune che si vive per ciò che immediatamente si è; poiché la
riflessione non giunge mai tanto in alto, da oltrepassare questo limite. È solo un fugacissimo
accenno che ti presento, ma non desideravo nemmeno fare di più; per me non sono importanti i
diversi stadi, ma solo il movimento che si deve necessariamente compiere per trarsene fuori, come
ti dimostrerò, ed è su di esso che ti prego di fermare la tua attenzione.» (Kierkegaard, Aut-aut.
Estetica ed etica nella formazione della personalità, 38)
Il movimento di cui parla Kierkegaard come elemento più importante e centrale della propria
riflessione può essere richiamato riprendendo l’affermazione di Kierkegaard, in Timore e tremore:
«…perché è grande cosa rinunciare al proprio desiderio più caro, ma è cosa più grande serbarlo
dopo averlo abbandonato. Grande cosa è cogliere l'eterno, ma è più grande riavere il transeunte,
dopo averne fatto rinuncia.» (Kierkegaard, Timore e tremore, 43). È il movimento che può
considerarsi la chiave di comprensione delle forme di esistenza nei diversi stadi cui essa si consegna
alla ricerca di una autenticità come possibilità ed è anche il modo per comprendere la natura
autenticamente estetica di ogni forma di esistenza.
4.1. i tratti dell’estetica (dell’esteta, dell’essere esteta, dell’esistenza estetica)
4.1.1. l’immediatezza in senso temporale e di esperienza: vivere l’istante, l’attimo nel suo accadere
unico, nella sua assoluta singolarità e nella dimensione del piacere. «…succhia il suo nettare dai
fiori dell’immediato» (Diario del seduttore, Remo Cantoni, Introduzione, 6). La singolarità e il
finito sono qui colti nella dimensione dell’assoluto (per quanto fugace), dell’universale, dell’unico,
dell’in sé; un universale singolare o un singolare universale.
20
4.1.2. la distanza in senso temporale e come strategia per il piacere: «Niente impazienza, niente
avidità, tutto sarà goduto a suo tempo» (Kierkegaard Søren 1843 Diario del seduttore 1990, 30)
Estetica è l’esperienza del piacere in termini di abile capacità percettiva, raffinata costruzione,
strategica fruizione; «…filtra sottilmente il piacere liberandolo da ogni impurità grossolana, lo
incanta e costituisce per lui una perenne attrattiva spirituale» (Diario del seduttore, Remo Cantoni,
Introduzione, 6).
4.1.3. Nell’istante, nell’attimo e nella sua fruizione piacevole si incontrano gli estremi:
dell’immediatezza e del calcolo; della prossimità e della distanza; della vicinanza e del distacco…
poiché la distanza è qui l’arte dello sguardo nella giusta prospettiva, della scelta del tempo
opportuno, della presenza nell’istante come soggetto delle possibilità;della possibilità qui vissuta
nella dimensione del piacere, della immediata ma completa soddisfazione sensibile nel momento
dell’accadere. Riprendendo la nota di Kierkegaard: «Quando si diviene più esperti in un certo senso
si guadagna, giacché certo si perde l'impaziente desiderio e il turbamento che ne nasce, ma si
acquista la padronanza necessaria per rendere l'attimo effettivamente delizioso.» (Kierkegaard
Søren 1843 Diario del seduttore 1990, 34). «La realtà viene da lui inseguita e desiderata, ma, nello
stesso tempo, superata, distaccata, vissuta nei filtri del ricordo e dell'immaginazione. Egli soffre di
una exacerbatio cerebri per la quale la realtà non contiene abbastanza eccitamenti o li contiene solo
per attimi. Non appena la realtà non è più stimolo o eccitamento, l'esteta si affloscia e disarma.
Questo personaggio tutto cervello e schermaglia non è un seduttore nel senso comune della parola.
Non tanto gli importa possedere la donna quanto goderne esteticamente il cedimento e l'abbandono.
Per questi seduttori la donna è l'oggetto di una strategia erotica studiata e prevista nei minimi
particolari. L’arte consiste nell'incantarla con le doti dello spirito, con il magistero della parola,
portandola a quel punto di turbamento in cui essa smarrisce il proprio equilibrio ed è pronta a
qualsiasi sacrificio. L'amante gode dell'incanto che nasce da questa passione, ma per conto suo non
si abbandona mai e tiene in serbo l'arma terribile dell'ironia. In questo giocare e speculare sulla
passione della donna, variando la propria tattica erotica, alternando slanci e freddezze, si rivela un
egoismo raffinato che vuoi trarre per sé il massimo piacere con il minimo di sacrificio.» (Diario del
seduttore, Remo Cantoni, Introduzione, 10)
4.1.4. Nell’istante estetico del piacere la realtà è vissuta come bellezza pura, lontana da fini o scopi
sia di parossisitica (e volgare) reiterazione del piacere, sia ispirata a intenzioni di profitto artistico,
sia sostenuta da progetti di sistema razionale del tutto. L’esteta vive ciò che accade in quanto
accade, come finito, come evento, come dono… non in quanto dedotto, conseguenza, merito, frutto
di calcolo, momento di progetto mezzo per altri fini. L’amore e la sua piacevolezza immediata, la
bellezza e la sua piacevolezza immediata sono colti e vissuti “alla greca”, di per sé e non sottoposti
al giudizio di valore formulato a partire dalla nobiltà (sociale o reale) dell’oggetto o del fine. Il tema
dell’immediatezza ha qui una valenza etico sociale e non solo una accezione temporale.
4.1.5. La inesorabile discontinuità di una forma di vita incentrata sull’attimo, sull’evento si traduce
anche nella percezione di una esistenza segnata da una perenne dipendenza dalle circostanze, quindi
proiettata all’esterno di sé; in essa prevale l’urgenza perenne di stare al’esterno, di abitare fuori di sé
e la conseguente paura della solitudine, la separazione da sé, la paura della presenza a se stessi. Su
questo sfondo compare una nuova realtà e una nuova e raffinata dinamica estetica: 1. si affaccia la
disperazione; 2. la prima e calcolata reazione dell’esteta è quella di scongiurarne i possibili effetti
devastanti estetizzando la disperazione, trasformandola in “tristezza estetica”; fino allo smacco del
finito che impone la sua autentica natura: accade. E l’accadere è essenza pura dell’estetica.
4.2. etica ed estetica: nella descrizione della esistenza etica compaiono i tratti “estetici” della
singolarità e dell’assoluto, della prossimità e della distanza, dell’immediatezza (fedeltà a se stessi) e
della gestione (scelta di sé), delle circostanze e del tempo complessivo, dell’esterno e dell’interno
(interiorità).
4.2.1. Quando la colpa ha svolto il proprio vero compito, non quello di esporre il colpevole alla
condanna, ma quello di svelare l’inautenticità di una vita morale condotta all’insegna di valori
21
generali, universali, sempre esterni per quanto interiorizzati, allora l’etica sorge nei termini dello
stare nella scelta, nell’aut-aut, nel salvare l’esistenza come possibilità. Declinata con concretezza e
onestà, questa direzione etica si traduce nella fedeltà a se stessi, da parte del singolo, nella
concretezza della propria storia, nella unicità della propria singolarità, cioè nel carattere assoluto
della propria singolarità. Scegliersi come assoluto significa scegliersi secondo una propria
dialettica, cioè come risultato e compito, come prodotto e progetto, come principio e conclusione.
«… mentre sceglie se stesso come prodotto, si può anche dire che produce se stesso. Egli così al
momento della scelta è alla conclusione, perché la sua personalità si racchiude; eppure nello stesso
momento è proprio al principio perché sceglie se stesso secondo la sua libertà. Come prodotto è
premuto nelle forme della realtà, nella scelta rende se stesso elastico, trasforma tutta la sua
esteriorità in interiorità.» (Kierkegaard, Aut-aut. Estetica ed etica nella formazione della
personalità, 100). I binomi ripetuti e ripresi (risultato / compito, prodotto / progetto, principio /
conclusione) attestano ad un tempo la fedele prossimità dell’individuo alla propria concreta
esistenza e la distanza da quella concretezza nelle linee di un progetto segnato da un forte finalismo
interno. Il peccato non ha sede nella trasgressione della legge o di precetti universali ma nel «non
volere profondamente e intensamente la propria esistenza» (la trasgressione della legge è colpa in
quanto e se quella trasgressione annulla o mette a rischio l’esistenza come possibilità).
4.2.2. l’esito “estetico” dell’etica: l’assoluto come singolarità. L’assoluto compete al singolo e non
all’universale, non al sistema. Nell’etica autentica come fedeltà alla possibilità nella concretezza del
proprio percorso (risultato e progetto), è il finito a prendere forma e a diventare soggetto, è il suo
apparire, il suo manifestarsi e realizzarsi, a costituire l’autentico accadere storico; sono le
circostanze, i momenti, gli eventi a diventare il terreno della manifestazione di questo assoluto che è
la singolarità affermata nella fedeltà alla propria possibilità.
Si riscontrano qui, in campo etico,come già in campo estetico, le affermazioni classiche (espresse
dallo stesso Hegel) circa la natura dell’opera d’arte momento di sintesi unica e senza eguali di
concretezza e idealità, di immediatezza e di idealità, di materia e Spirito. Afferma Hegel, l’opera
d’arte «è l’intuizione concreta e la rappresentazione dello spirito assoluto in sé come dell’ideale; —
della forma concreta, nata dallo spirito soggettivo, nella quale l’immediatezza naturale è soltanto
segno dell’idea, per la cui espressione è così trasfigurata mediante lo spirito formatore, che la forma
non mostra altro in lei fuori dell’idea. Tale è la forma della bellezza.» (Hegel G.W.F. 1817
Enciclopedia delle scienze filosofiche § 556)
4.3. fede ed estetica. La fede e il recupero del finito in nome della distanza infinita e dell’assurdo:
«la fede… dopo aver compiuto i movimenti dell’infinito, essa fa quelli del finito».
Non vi è una graduatoria nella fenomenologia delle esistenze delineata da Kierkegaard con perizia
letteraria – drammaturgica e con l’“ironia” della lettura a distanza; si tratta di una attenzione
analitica descrittiva che intende far parlare l’esistenza presentata nelle scelte che la consegnano alle
proprie diverse forme e ai variati stili di vita. Nel susseguirsi delle tipologie descritte, esistenza
estetica, etica, della fede, quest’ultima si definisce, in senso non religioso, come la capacità di
restare fedeli (più delle altre forme di esistenza) alla propria singolarità in totale solitudine etica o,
addirittura, anche sotto la condanna dell’etica; la fedeltà all’assurdo della fede, all’infinita
possibilità, all’angoscia ma nella fede.
4.3.1. La fede, restituendo l’esistenza alla dimensione dell’infinita possibilità, diventa movimento in
forza del quale all’uomo è paradossalmente resa possibile sia la scelta autentica di sé e dei valori
dell’etica, sia la libera, distaccata e perciò intensa, fruizione delle circostanze e delle opportunità;
cioè perfino di quei momenti piacevoli che l’esteta, vittima delle circostanze, rincorreva
collocandosi all’esterno di sé, esponendosi perennemente al rischio della disperazione e del non
senso. Solo l’uomo di fede («il cavaliere della fede») si apre infatti all’infinita gratuità del finito
sino ad apparire, di fronte agli occhi comuni (che non colgono nell’uomo di fede il movimento
dell’infinita distanza che egli prende da ciò che è mondano), il più raffinato fruitore di ciò che è
occasionale e finito; egli riesce a «trasformare in marcia il salto nella vita».
22
4.3.2. L’incontro e il potenziamento reciproco tra fede ed estetica: nella fede l’estetica trova la
propria redenzione, nell’estetica si verifica la massima realizzazione della fede (della fede e non
della religione, direbbe Nicolaus Notabene). La distanza dal finito mantenuta dall’esteta come
strategia di piacere («Niente impazienza, niente avidità, tutto sarà goduto a suo tempo… si acquista
la padronanza necessaria per rendere l'attimo effettivamente delizioso.» (Kierkegaard Søren 1843
Diario del seduttore 1990, 30, 34) diventa qui distanza infinita portata fino all’assurdo della
rinuncia assoluta nella fede, ma l’effetto è pieno. Là era il ritorno dell’attimo piacevole, e quindi il
riaccadere dell’occasione, qui è la restituzione del finito come un inizio eterno, la forma che
l’eternità assume nella temporalità.
4.4. Kierkegaard: l’arte (estetica, etica, fede) o la gestione del finito come possibilità
A dominare e realizzare i tre ambiti e le tre forme di esistenza analiticamente scandagliate da
Kierkegaard è uno stesso movimento definito e sorretto dai termini: singolarità e assoluto.
Una sintesi ben orchestrata di immediatezza e calcolo, di prossimità e distanza. Se rischia di
diventare calcolo raffinato (astuto e a volte perverso) nell’esteta fermo allo stadio della passione
amorosa, diventa, pur con logica ed esito estetico, il supremo atto dell’esistenza etica (etica della
singolarità e non della legge), ed è espressione massima della fede, anzi il movimento della fede:
quel calcolo diventa qui il movimento della rinuncia infinita e della ripresa del finito come grazia,
in forza dell’assurdo.
4.4.1. L’estetica, attenta al finito e alla “felice certezza del momento”, ripresa nell’etica e nella fede,
è un movimento che restituisce all’uomo il finito nella dimensione della possibilità, dell’apertura,
dell’attesa (cioè riporta l’uomo all’essenza della propria esistenza) e che restituisce alla realtà il
carattere dell’accadere dal nulla come evento e come grazia; cioè riporta ogni evento alla gratuità
dell’essere, ai tratti del dono, all’essenza del divino che è grazia.
4.4.2. Ma la dimensione della grazia, dell’apparire come dono, è il tratto che la realtà assume nella
bellezza dell’arte. E l’estetica è la capacità di stare nel dono dell’apparire della realtà.
23