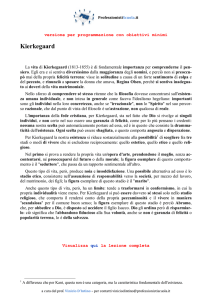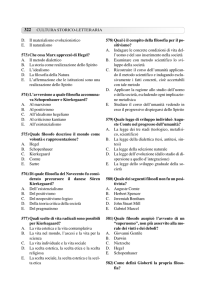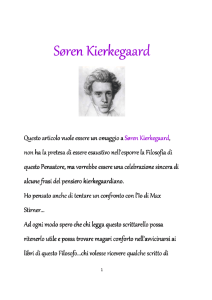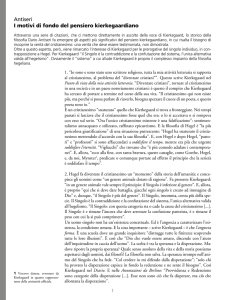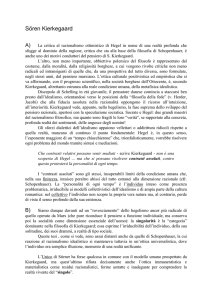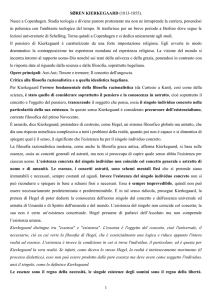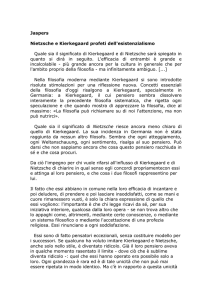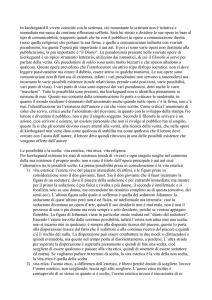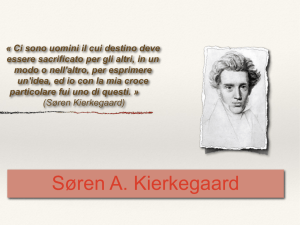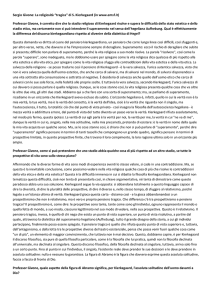Søren Kierkegaard
(Copenahagen 1813-1855)
“Scrittore cristiano”: questa è la definizione che K. dà di se stesso, rifiutando i titoli, più istituzionali e
accademici, di Filosofo o di Teologo.
Kierkegaard fa parte di quel vasto movimento della filosofia ottocentesca che reagisce all’idealismo, e in
particolare alla filosofia hegeliana, rifiutandone l’astrattezza, la lontananza dall’esistenza concreta degli uomini.
Di questo movimento fanno parte pensatori molto diversi, come Schopenauer, Feuerbach, Marx: ognuno di essi
critica l’idealismo con una voce diversa, da una prospettiva sua propria. Kierkegaard rifiuta l’idealismo di
Hegel, che dissolve l’individuo nell’universale, in nome dell’originalità e dell’irriducibilità del singolo.
L’esistenza concreta di ogni singolo uomo, segnata dal dramma della libertà e dell’angoscia, dal rischio della
dissipazione e della disperazione, dalla speranza della salvezza, costituisce l’oggetto della riflessione del filosofo
danese; l’opera di Kierkegaard, poco conosciuta nel suo secolo, è stata riscoperta dopo la Prima guerra
mondiale, ed è stata valorizzata soprattutto dalla filosofia esistenzialista del Novecento, che ha riconosciuto in
lui un precursore.
LA VITA.
E’ vissuto nella prima metà dell’Ottocento in Danimarca, in un’area culturale vicina al mondo tedesco
Dal padre, mercante di fede protestante, riceve una rigida educazione religiosa. Nel 1840 ottiene la licenza in
teologia e si fidanza con Regina Olsen. Non diventa però pastore protestante. Il padre, morendo, gli lascia un
consistente patrimonio, che gli permette di scegliere di praticare il “mestiere” di “scrittore cristiano”, libero da
precisi impegni di lavoro. Ma le scelte del giovane Kierkegaard sul proprio futuro sono particolarmente
travagliate: dopo un anno, nonostante l’affetto che prova nei suoi confronti, rompe il fidanzamento con Regina,
sentendo che gli sarebbe impossibile adattarsi alla comune esistenza di uomo sposato. Nel 1841 è in Germania,
a Berlino, dove frequenta le lezioni del vecchio Schelling (idealista), che inizialmente lo entusiasmano, ma che
ben presto finiranno per deluderlo. Negli anni successivi la vita di Kierkegaard – che morirà a 42 anni – si
svolge tutta a Copenhagen, priva di avvenimenti esteriori di rilievo, eccettuata la violenta polemica che lo
oppone alla Chiesa luterana danese, da lui accusata di essersi trasformata in un’istituzione burocratica e di aver
abbandonato l’autentico messaggio evangelico. La sua esistenza tuttavia è segnata da un radicato senso di colpa
e da eventi personali e familiari non ben identificati vissuti come oscure minacce.
Le sue opere fondamentali sono Aut-aut, Timore e tremore, Il concetto dell’angoscia, Briciole filosofiche, La
malattia mortale, Esercizio di cristianesimo.
IL PENSIERO.
Il Singolo. Il pensiero kierkegaardiano è anzitutto – e strutturalmente – la filosofia di un solitario. Per lui
centrale è la categoria del singolo, e questo contrappone il suo pensiero alla tradizione moderna: la filosofia
moderna, da Cartesio fino agli idealisti, tende a risolvere il rapporto tra l’individuo e l’universalità (o l’assoluto)
a favore della forte predominanza della Totalità sul singolo. Ciascun uomo ritrova il proprio valore, le proprie
ragioni di vita, la propria identità personale, all’interno di un principio superiore – Dio, Società, Storia o
Assoluto che sia1. In particolare, la più emblematica di queste filosofie sistematiche, che è per Kierkegaard
1
In Cartesio, in Kant, in Hegel, quando si parla dell’uomo si parla sempre di ciò che caratterizza l’uomo in generale: la
Res Cogitans, l’Io Penso, la Ragione (o lo Spirito): non si considera mai l’uomo nella sua individualità, non si considera
il fatto che ogni uomo, pur appartenendo al genere umano, è sempre unico e irripetibile, quindi l’individualità, la
particolarità di ogni individuo, è annullata nel genere. Kierkegaard respinge quest’annullamento affermando che
l’individuo è superiore al genere. Inoltre la spiegazione e la soluzione che viene data ai problemi umani dal punto di
vista del genere (del tutto) , molto spesso non è valida per l’individuo. Per esempio Hegel giustifica la guerra dicendo
che essa è necessaria e benefica per il progresso dell’umanità: questa soluzione forse è accettabile per l’umanità in
generale, ma non è una soluzione valida per il singolo individuo che muore sotto le bombe! Ricordiamo a tal
proposito lo scrittore russo Dostoevskij: “Io ho creduto e voglio vedere anch’io, e, se allora fossi già morto, mi si
risusciti, perché se tutto dovesse avvenire senza di me, sarebbe una cosa troppo ingiusta. Io non ho mica sofferto per
concimare col mio essere, con le mie colpe e le mie sofferenze, la futura armonia in pro di qualcuno. Io voglio vedere
coi miei occhi il daino ruzzare accanto al leone e l’ucciso alzarsi ad abbracciare il suo uccisore. Io voglio essere
presente quando tutti apprenderanno di colpo perché tutto sia stato così.” (F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov,
Rizzoli, Milano 1998, pp. 326-327.)
1
quella di Hegel, tende a risolvere tutti i problemi del singolo riproponendoli al livello della razionalità dialettica
del tutto. Per questo l’hegelismo (con la sua affermazione dell’identità di reale e razionale) è visto da
Kierkegaard come una filosofia “tranquillizzante”: per tutti i problemi umani ci sono un senso e
un’interpretazione chiara, razionalmente comprensibile. Ma per Kierkegaard quest’annullamento del singolo
nella totalità è impossibile e illusorio, occorre restituire l’uomo singolo al dramma della sua responsabilità e al
rischio della sua condizione (il rischio di un’esistenza inautentica, incompiuta).
Per Kierkegaard la filosofia ha inizio nel singolo, che deve prendere una decisione su come comportarsi e non
può sfuggire alla scelta, anche se non sa che cosa deve scegliere. Da questo non sapere nasce la filosofia, intesa
non più come scienza dell’Assoluto, ma dei rapporti tra il singolo uomo e il suo mondo. E tale posizione non è
data dal fatto che Kierkegaard non avverte il problema dell’Assoluto (è anzi vero il contrario), ma perché
contesta la possibilità di collocarsi dal punto di vista del tutto, di conoscere la realtà in termini di ragione
universale. Nell’affrontare la vita e le responsabilità che essa comporta, l’uomo si trova nel punto di vista più
lontano dall’Assoluto: nella sua esistenza è radicalmente un singolo. Egli è solo nella scelta, e porta la
responsabilità di ciò che farà. “Che fare?” Di fronte al singolo si aprono delle possibilità, e la scelta è sempre tale
che, qualunque cosa l’uomo faccia, il suo comportamento esclude radicalmente altri modi di comportarsi, altre
possibilità etiche. La categoria della possibilità, e non quella hegeliana della necessità, caratterizza – secondo
Kierkegaard – l’esistenza dell’uomo. Kierkegaard esprime la assoluta radicalità che è implicita in qualsiasi
scelta con l’espressione latina aut-aut (o questo o quello!) che si oppone all’ et-et hegeliano, vale a dire la sintesi
dialettica, la conciliazione degli opposti nella sintesi.
Gli stadi della vita: L’analisi delle scelte che contraddistinguono l’uomo esistente getta luce sul significato
dell’esistenza stessa, e permette di coglierne la verità e il valore; Kierkegaard esemplifica le possibilità di scelta
attraverso tre stadi (modi, momenti qualitativamente diversi) di vita: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo
stadio religioso.
A) Don Giovanni e la vita estetica. Di fronte alla vita ci si può comportare come Don Giovanni (il
personaggio dell’opera di Mozart), interpretandola come una continua seduzione. Egli si muove nel mondo
senza metter mai radici, interponendo tra sé e gli altri un sottile velo di immagini seducenti. Il seduttore non
mostra mai se stesso: mostra sempre un’immagine cangiante, in modo da potersi nascondere dietro di essa e
apparire come la donna che corteggia vuole che egli sia, senza in realtà essere mai nessuna delle maschere di
cui si riveste. Il suo è il mondo della pura esteriorità, dal quale è stata eliminata ogni dimensione di profondità,
di certezza, di stabilità: la vita di Don Giovanni è senza spessore. Egli vive della sua seduzione; essa gli permette
di non radicarsi mai in un rapporto durevole, di non costruire mai nel mondo dei punti di riferimento stabili.
Tutto ciò che tende a cristallizzare i sentimenti e le abitudini, a costruire una quotidianità ordinata fatta di
impegni e di doveri, tutto questo viene rigettato. Don Giovanni non ha una moglie: vuole tutte le donne, vuole
sedurle ma non legarsi ad alcuna per non dover scegliere. Egli paga questa non-scelta (che si rivelerà
apparente, perché egli sceglie in realtà di fuggire da ogni scelta) con l’impossibilità di costruire legami e affetti
costanti, col vivere nell’esigenza continua del nuovo. Se si ferma è perduto. E’ assalito dalla disperazione. Don
Giovanni è un esteta, ricerca il godimento immediato, ma la vita estetica è una vita letteraria, una finzione
buona per il teatro… Se Don Giovanni smette di recitare e guarda lucidamente a se stesso, scopre soltanto il
vuoto: non ha accettato di fare delle scelte (ha creduto di poter sfuggire alla necessità di scegliere) e scopre di
essere nulla. La vita estetica dunque ha come esito la coscienza del vuoto, del nulla, cioè la disperazione.
B) Il marito e la vita etica . La scelta di Don Giovanni ha come propria antitesi l’atto con cui l’uomo accetta
di scegliere, aderendo a un mondo etico. L’uomo che accetta il matrimonio permette alle profondità dell’amore
di penetrare in lui, rifiutando la superficialità della seduzione. È un salto radicale, è la scelta di una possibilità
totalmente diversa. Con la profondità di sentimenti stabili, con la moglie e i figli, persone di cui accetta la
responsabilità nell’ordine borghese della società moderna, l’uomo sposato trova una propria identità. A partire
dai punti fermi del suo mondo (la famiglia, il lavoro, la responsabilità che ne deriva, l’adesione a un ordine di
regole sociali che gli garantiscono il rispetto degli altri e così via), l’uomo sposato costruisce un’esistenza
regolare, fatta di diritti e di doveri accettati; ne è contento, acquisisce abitudini, aderisce a un sistema collettivo
di valori, costruito dalla generalità dei suoi simili nella società in cui vive. Tuttavia questa generalità è anonima:
nessuno in particolare stabilisce le regole del vivere sociale, definisce positivamente cosa è bene e cosa è male.
È la società nel suo complesso a farlo. L’uomo etico aderisce ai valori impersonali di una collettività. Mentre il
seduttore vive sempre nell’istante e non si fa mai carico del proprio passato e delle responsabilità che ne
derivano, l’uomo sposato ha un rapporto del tutto opposto con il presente. Tutto ciò che egli fa non è limitato
all’istante, ma deriva dall’assunzione delle responsabilità che gli derivano da scelte passate (dall’aver sposato
2
quella donna, avere messo al mondo quei figli) in vista di progetti futuri ben chiari e predeterminati. Tuttavia
neppure l’uomo sposato è al riparo dal vuoto dell’esistenza, anch’egli ha una libertà che si rivela vuota. Questo
accade perché ciò che egli chiede è proprio di essere liberato dal rischio della scelta e di potersi affidare a un
sistema oggettivo di valori da tutti accettato. Il punto è che l’uomo sposato si accorge di essersi liberato dalla
responsabilità soggettiva della scelta accettando la responsabilità etica della famiglia, un ordine generale di
valori -, ma di avere così solo coperto la sua più profonda libertà, basata sulla radicale soggettività di ogni decisione. Rifugiarsi dietro le scelte dell’anonimo prossimo, aderire a valori superiori, è solo un nascondersi dietro
di essi. L’individuo rimane egualmente il soggetto responsabile di ciò che fa anche se si trincera dietro la sua
rispettabilità borghese. Quando si accorge di questo, l’uomo sposato entra nella dimensione dell’angoscia, vive
cioè il vuoto reale della sua esistenza. Pertanto, se la superficialità del seduttore genera disperazione e la
profondità dell’uomo etico genera angoscia, esiste un’alternativa per l’uomo singolo per sopravvivere nello
spazio tra queste due possibilità?
c) La fede e la scelta come salto. L’alternativa è Dio. Non il Dio tranquillizzante della filosofia della
religione hegeliana, non il Dio razionale del deismo; non il Dio kantiano. Piuttosto il Dio di Abramo e di Isacco, il
Dio la cui esistenza non si dimostra con la ragione, ma si accetta con la fede. L’uomo, posto di fronte alla scelta,
una volta scoperto che ogni suo gesto è in fondo vuoto di senso - perché l’esistenza è tutta nella dimensione
della possibilità e non in quella della necessità - sceglie di compiere l’unico gesto che possa permettergli di dare
un senso all’esistenza: si pone di fronte a Dio, nella pienezza del suo essere, e con la fede "salta" il limite
dell’esperienza e della ragione, accetta la finitezza del suo essere uomo di fronte alla infinità di Dio, accetta il
suo nulla di fronte alla totalità infinita di Dio. Pone se stesso e la sua identità nella fede. Si affida a Dio, ponendo
nelle sue mani la sua vita. Nessuna razionalità permette di superare l’infinito spazio che divide l’uomo da Dio:
nessuna ragione umana potrà mai dare ragione dell’esistenza e della natura di Dio. L’atto religioso della fede
appare folle tanto all’esteta quanto all’uomo sposato. Lo mostra la narrazione biblica di Abramo: come potrebbe
non essere giudicato folle Abramo che accetta di diventare l’assassino di suo figlio (un delitto tremendo, che
nessuna morale può giustificare)? Abramo non comprende il senso dell’ordine con cui Dio gli impone di
uccidere il figlio. Non discute, non chiede nulla. Sceglie di accettare il suo nulla di fronte all’essere infinito di
Dio. E obbedisce. L’angelo che ferma la sua mano non cambia la scelta di Abramo: anche se il sacrificio viene
interrotto, Abramo ha già accettato di uccidere suo figlio. E tutto questo senza che nessuno, nemmeno Abramo
stesso, possa davvero dimostrare che Dio esiste, o possa dire di capire il suo essere. Egli ha aperto il suo animo
a una adesione totale a Dio, scandalosa per la ragione e per la stessa etica che guida l’azione di coloro che
rimangono in un orizzonte umano. La fede allora è scandalo e paradosso. C’è infatti qualcosa di più scandaloso
per la ragione dell’unione del divino e dell’umano in un persona storicamente vissuta, in Cristo? C’è qualcosa di
più paradossale del “salto” verso la fede che l’uomo compie nell’aderire al messaggio evangelico?
In questo modo Kierkegaard porta alle estreme conseguenze alcune tematiche proprie della Riforma
protestante, tematiche assai lontane dalla tranquilla serenità della religione borghese, per la quale la coscienza
è pacificata dall’adesione ai riti e dalla verità dei dogmi. Il senso della vita religiosa è tutto affidato al recupero
della propria intima individualità, che acquista senso nell’accettare la propria nullità di fronte a Dio. Non ha
senso aderire al cristianesimo per tranquillizzare la propria coscienza; non ha senso dire di essere buoni
cristiani perché si seguono i precetti della Chiesa. Il cristianesimo non dà garanzie, non è la via indicata perché
dona serenità e pace. E’ solo la possibilità più autentica per la vita dell’uomo.
Angoscia e disperazione. Negli stadi della vita estetica e della vita etica abbiamo incontrato i concetti di
“disperazione” e di “angoscia”. Definiamo più precisamente questi stati d’animo, all’analisi dei quali
Kierkegaard ha dedicato specifiche opere (Il concetto dell’angoscia e La malattia mortale).
L’angoscia è la condizione esistenziale generata dalla “vertigine” della libertà e dalle infinite possibilità negative
che incombono sulla vita e sulla personalità dell’uomo. Per questi suoi caratteri l’angoscia è diversa dalla paura
che si prova al cospetto di una situazione determinata e ad un pericolo preciso. Inoltre, essa è un sentimento
tipicamente umano.
Con l’angoscia fa il paio, nell’uomo, la disperazione: quella si apre sul vuoto delle possibilità esterne, questa
sulla precarietà irrimediabile della sua costituzione interna. La disperazione è la “malattia mortale” che affligge
l’uomo quando, riconoscendosi finito, si scopre incapace di farsi da sé e, al tempo stesso, incapace di sciogliersi
dal rapporto che ha con sé: all’uomo non è possibile né rendersi autosufficiente né evadere da se stesso.
La fede religiosa costituisce l’unica “terapia” possibile ed efficace contro i tormenti dell’angoscia e contro la
“malattia mortale” della disperazione: nella fede l’io, pur orientandosi verso se stesso e pur volendo essere se
stesso, non si illude sulla propria autosufficienza, ma riconosce la propria dipendenza da Colui che lo ha posto e
che, solo, può garantire la sua realizzazione: a Dio “tutto è possibile”.
____________________________________________________________________________________________________________________
3