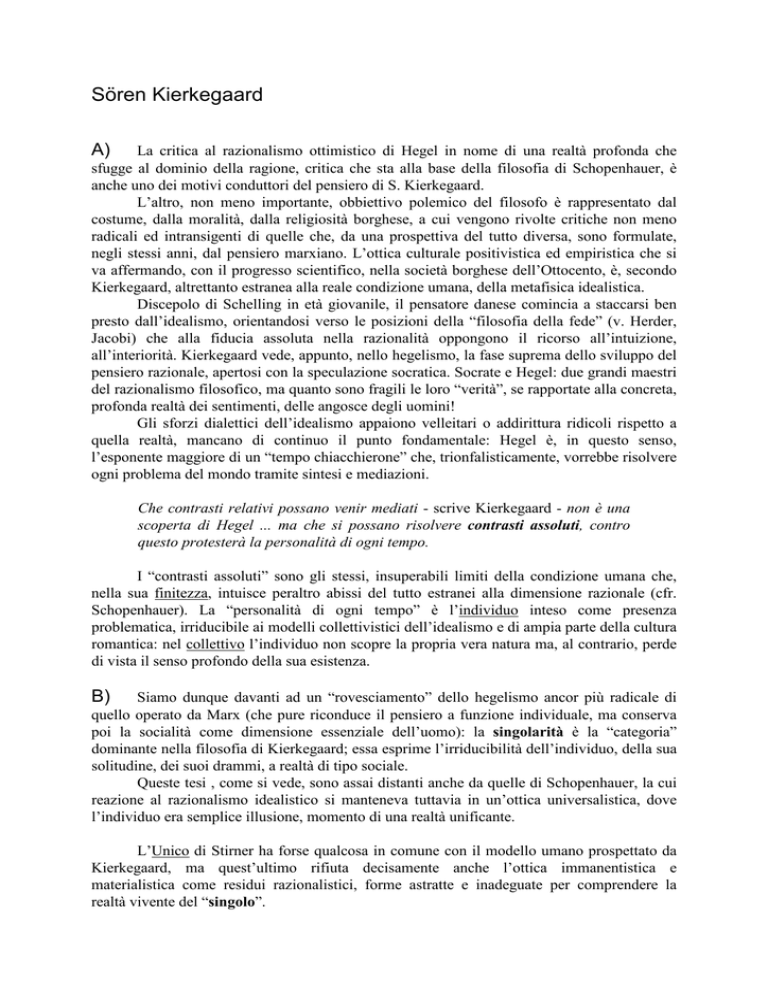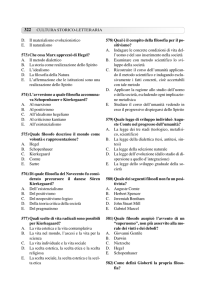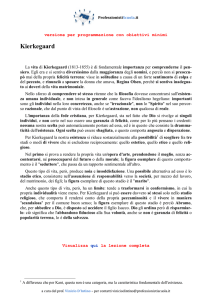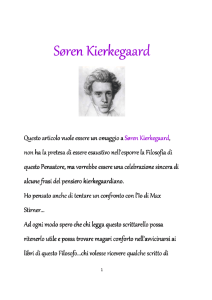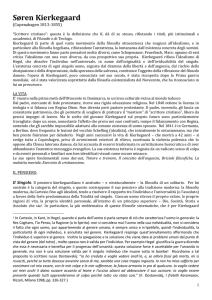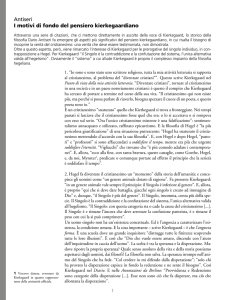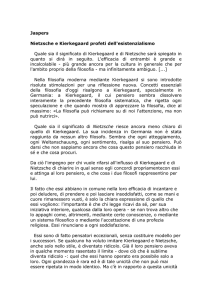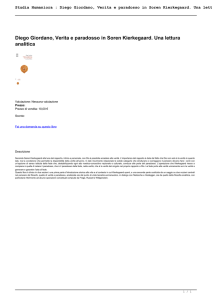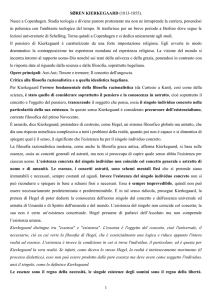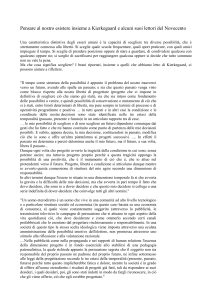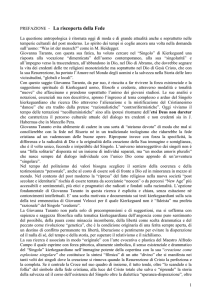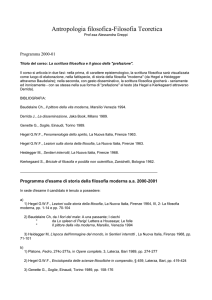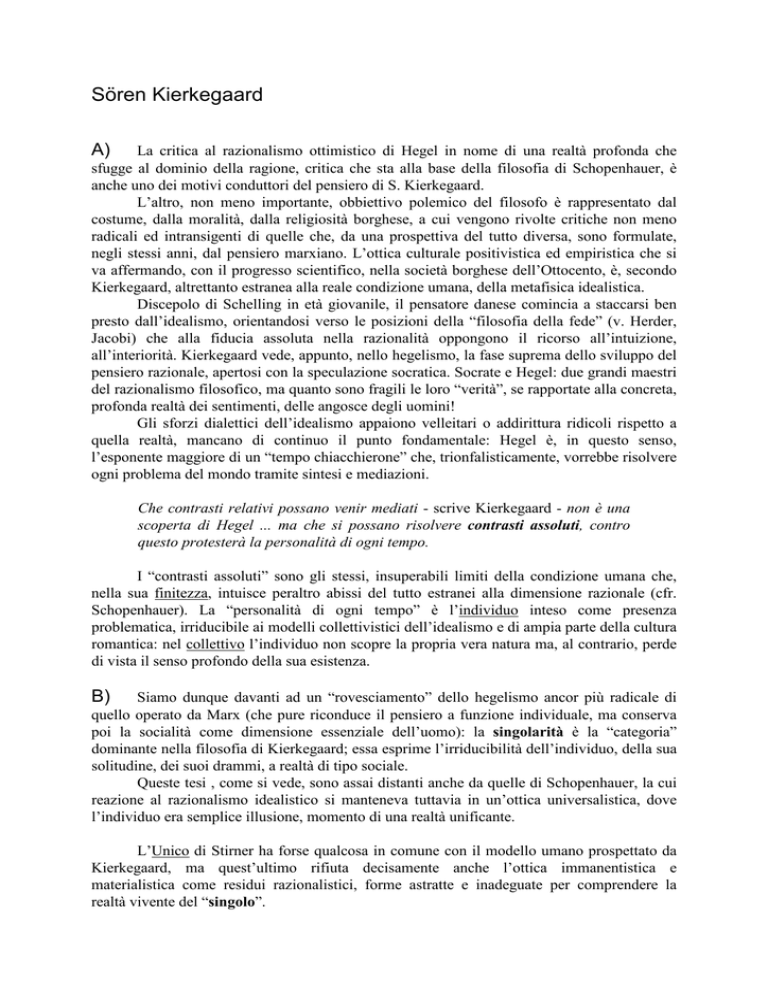
Sören Kierkegaard
A)
La critica al razionalismo ottimistico di Hegel in nome di una realtà profonda che
sfugge al dominio della ragione, critica che sta alla base della filosofia di Schopenhauer, è
anche uno dei motivi conduttori del pensiero di S. Kierkegaard.
L’altro, non meno importante, obbiettivo polemico del filosofo è rappresentato dal
costume, dalla moralità, dalla religiosità borghese, a cui vengono rivolte critiche non meno
radicali ed intransigenti di quelle che, da una prospettiva del tutto diversa, sono formulate,
negli stessi anni, dal pensiero marxiano. L’ottica culturale positivistica ed empiristica che si
va affermando, con il progresso scientifico, nella società borghese dell’Ottocento, è, secondo
Kierkegaard, altrettanto estranea alla reale condizione umana, della metafisica idealistica.
Discepolo di Schelling in età giovanile, il pensatore danese comincia a staccarsi ben
presto dall’idealismo, orientandosi verso le posizioni della “filosofia della fede” (v. Herder,
Jacobi) che alla fiducia assoluta nella razionalità oppongono il ricorso all’intuizione,
all’interiorità. Kierkegaard vede, appunto, nello hegelismo, la fase suprema dello sviluppo del
pensiero razionale, apertosi con la speculazione socratica. Socrate e Hegel: due grandi maestri
del razionalismo filosofico, ma quanto sono fragili le loro “verità”, se rapportate alla concreta,
profonda realtà dei sentimenti, delle angosce degli uomini!
Gli sforzi dialettici dell’idealismo appaiono velleitari o addirittura ridicoli rispetto a
quella realtà, mancano di continuo il punto fondamentale: Hegel è, in questo senso,
l’esponente maggiore di un “tempo chiacchierone” che, trionfalisticamente, vorrebbe risolvere
ogni problema del mondo tramite sintesi e mediazioni.
Che contrasti relativi possano venir mediati - scrive Kierkegaard - non è una
scoperta di Hegel ... ma che si possano risolvere contrasti assoluti, contro
questo protesterà la personalità di ogni tempo.
I “contrasti assoluti” sono gli stessi, insuperabili limiti della condizione umana che,
nella sua finitezza, intuisce peraltro abissi del tutto estranei alla dimensione razionale (cfr.
Schopenhauer). La “personalità di ogni tempo” è l’individuo inteso come presenza
problematica, irriducibile ai modelli collettivistici dell’idealismo e di ampia parte della cultura
romantica: nel collettivo l’individuo non scopre la propria vera natura ma, al contrario, perde
di vista il senso profondo della sua esistenza.
B)
Siamo dunque davanti ad un “rovesciamento” dello hegelismo ancor più radicale di
quello operato da Marx (che pure riconduce il pensiero a funzione individuale, ma conserva
poi la socialità come dimensione essenziale dell’uomo): la singolarità è la “categoria”
dominante nella filosofia di Kierkegaard; essa esprime l’irriducibilità dell’individuo, della sua
solitudine, dei suoi drammi, a realtà di tipo sociale.
Queste tesi , come si vede, sono assai distanti anche da quelle di Schopenhauer, la cui
reazione al razionalismo idealistico si manteneva tuttavia in un’ottica universalistica, dove
l’individuo era semplice illusione, momento di una realtà unificante.
L’Unico di Stirner ha forse qualcosa in comune con il modello umano prospettato da
Kierkegaard, ma quest’ultimo rifiuta decisamente anche l’ottica immanentistica e
materialistica come residui razionalistici, forme astratte e inadeguate per comprendere la
realtà vivente del “singolo”.
D’altra parte, se per certi versi quella realtà è solitudine, assenza di garanzie e di punti
di riferimento, è proprio in questa condizione che l’uomo scopre una sua profonda dignità,
scopre cioè la sua libertà, la sua irriducibilità a schemi prefabbricati: viene interpretata in
questa luce, p.es., la particolare condizione di Adamo rispetto agli altri esseri viventi, di cui
parla la Genesi.
Questo motivo era già presente, anche se con sviluppi diversi, nella cultura
rinascimentale (v. Pico della Mirandola, Ficino) ed era stato ripreso da esponenti
dell’Illuminismo come Lessing, ma è soprattutto nella filosofia di Pascal che possiamo
cogliere una diretta anticipazione di queste tematiche.
Compito dell’uomo è, secondo Kierkegaard, accettare fino in fondo la propria
condizione, fino a farne il proprio punto d’orgoglio:
Io sono solo un pover’uomo esistente - egli scrive - ma se qualcuno in possesso
di una formula magica si offrisse di cambiare la mia condizione ... grazie
tante, preferisco restare quello che sono, un pover’uomo esistente.
Per questo, quando il filosofo si trova a pensare all’epitaffio che vorrebbe scritto sulla
propria tomba, non trova parole più adatte che: “Quel Singolo”.
C) L’esistenza, dunque, come indeterminazione assoluta rispetto all’essenza: la vita
umana è governata non dalla Necessità, ma dalla Possibilità, dall’insuperabilità della propria
contingenza (cfr. la Geworfenheit di Heidegger). Ogni scelta, proprio perché libera, è un atto
di esclusione rispetto ad altre possibilità, un aut-aut che invalida ogni mediazione dialettica
(del tipo et-et) fra le diverse vie che stanno di fronte all’uomo. Anche Kierkegaard, come
Hegel, parla di una sfera estetica, una sfera etica, una sfera religiosa: ma qui non si tratta di
momenti che trapassano dialetticamente l’uno nell’altro, “conservando” lo stadio precedente:
essi sono invece divisi da un “salto” netto (la scelta, appunto, di uno di essi) e sono del tutto
inconciliabili tra loro. Al fondo della propria libertà di scegliersi l’uomo scopre l’angoscia,
cioè la mancanza di fondamenti e giustificazioni alla propria esistenza ed a tutte le proprie
decisioni: scopre il proprio essere sospeso sul nulla.
Siamo così di fronte ad una “filosofia” che rifiuta ogni base razionale, ad un tentativo
di descrivere la condizione umana che, fin dall’inizio, è consapevole del carattere provvisorio,
limitato, di ogni formulazione, progetto, esperienza. Un pensiero, quello di Kierkegaard,
multiforme e a tratti persino contraddittorio, che sembra talvolta tentativo di percorrere strade
incompatibili tra loro: nelle sue opere compaiono spesso pseudonimi (quasi che l’autore rifiuti
di riconoscersi in esse fino in fondo) ovvero personaggi fittizi, che sembrano incaricati di
compiere scelte e di restarvi fedeli, quasi per permettere all’autore di fare un “esperimento”,
mantenendosi però sempre al di fuori di modelli di vita con cui non può identificarsi del
tutto1.
E’ forse una disgrazia della mia esistenza - troviamo scritto nel suo Diario che io mi interesso a troppe cose e non mi decido mai per nessuna: i miei
interessi non sono subordinati ad uno solo, ma stanno tutti uno di fianco
all’altro.
1
Qualcuno ha voluto accostare l’opera di Kierkegaard a quella letteraria di F. Kafka, dove i
protagonisti sembrano svolgere una funzione analoga.
2
La crisi delle certezze è anche crisi della coerenza del soggetto e del suo senso di
identità: al suo fondo l’uomo coglie il nulla, la minaccia suprema non solo alla propria
esistenza, ma soprattutto al senso di essa (motivo, questo, che sarà centrale anche nel pensiero
di Nietzsche, ma, come vedremo, con sbocchi diametralmente opposti).
Si apre, per l’uomo, una tragicità di tipo diverso da quella espressa dalla cultura dei
secoli precedenti: di fronte alla scomparsa del senso, anche il ruolo dell’eroe diviene
impraticabile2.
D)
La prima possibilità di scelta di cui si occupa Kierkegaard, è quella con cui all’uomo si
apre la vita estetica: ma, in effetti, l’esteta “sceglie di non scegliere”, perché vive
nell’incoerenza e nella discontinuità: la sua esistenza è formata di attimi che restano fine a sé
stessi, attimi in cui egli cerca di raggiungere un ideale di bellezza e di felicità, ma nessun
conseguimento può soddisfarlo, così che tutto si riduce per lui ad un inseguimento senza fine
di nuovi miraggi.
In realtà l’esteta sta fuggendo da sé stesso, dalla tentazione (cioè dalla possibilità) di
dare alla propria vita una continuità, di compiere una scelta più responsabile e coerente. Ma,
come vedremo, è proprio vivendo a fondo questa crisi, questa precarietà del decidere, che
l’individuo può, secondo Kierkegaard, giungere a formulare una scelta in qualche modo
assoluta e definitiva.
La disperazione è il destino di chi vive secondo questo modello, e la consapevolezza
di ciò può rappresentare il passaggio ad un tipo di esistenza diverso: tale passaggio non
avviene, comunque, attraverso uno sviluppo graduale (“dialettico”), ma richiede un salto
attraverso il quale niente o quasi si conserva dello stadio precedente.
L’uomo può approdare così alla vita etica, nella quale non cerca più di fuggire da sé
stesso, ma si fa carico della propria condizione, della propria finitezza, dandosi una coerenza
ed una continuità, costruendosi una famiglia: questo comporta, anzitutto, l’accettazione di un
ruolo sociale, con tutti i doveri ed i compiti nei confronti degli altri che ne derivano.
Ma ciò non significa, per Kierkegaard, ridurre l’individuo alla realtà collettiva
(famiglia, stato), giacché in primo piano resta sempre la scelta: la dimensione sociale non
rappresenta quindi l’attuarsi di una essenza necessaria (di tipo hegeliano o marxiano), ma è
ancora funzione del libero progetto di sé da parte del singolo3.
Ancor meno, poi, egli intende difendere i valori della società borghese (conformismo,
etica del profitto) che definiscono la figura dell’homo oeconomicus, di colui che vive integrato
acriticamente nel collettivo (pur conservando tutti i suoi egoismi), smarrendo anche la
consapevolezza della propria fondamentale problematicità: questo tipo di esistenza è, anzi,
infima fra tutte, inferiore anche a quella dello “stadio estetico”, e rappresenta la forma estrema
della disperazione, nella quale l’uomo “ignora perfino di essere disperato”.
2
Vedi in proposito il confronto proposto dal critico letterario L. Trilling fra i personaggi di
Shakespeare e quelli, ad es., di Kafka: i primi, pur colpiti da un destino tragico, conservano una loro
solidità, una sicurezza della propria identità; nel secondo caso “qualcosa di terribile è accaduto al
condannato molto tempo prima dell’esecuzione della sentenza”.
3
La libertà umana si attua, qui, proprio come accettazione di una fattità (cfr. Sartre): se l’individuo
non avesse questa base , dice Kierkegaard, non si “sceglierebbe” ma si “creerebbe” dal niente.
3
Da tutto ciò comincia a diventar chiaro che, per Kierkegaard, non è tanto importante
che cosa si sceglie, quanto come si sceglie: come la sessualità del libertino non comporta
necessariamente una “scelta estetica”, così il matrimonio e la vita sociale non sono di per sé
scelte “etiche”. Appare cioè che a rendere effettiva la scelta è la consapevolezza della
condizione di fondo che la rende possibile: approfondire il significato di questa condizione
può allora divenire il compito supremo dell’individuo.
In un certo senso tutte le alternative che l’uomo ha difronte sono “equivalenti”, stanno
sullo stesso piano; in un altro senso c’è solo una scelta autentica, e questa consiste
nell’affrontare senza più riserve o rinvii, la propria assoluta contingenza, la propria angoscia4.
Anche la vita etica è, da questo punto di vista, un arrestarsi alla superficie, un non voler
affrontare l’abisso della propria esistenza: l’angoscia (Angst, Angest) è invece la coscienza del
nulla che si apre al di sotto delle sicurezze consolatorie della vita quotidiana. Attraverso di
essa l’uomo affronta la propria “malattia mortale”, la disperazione (Verzweiflung), ma è
proprio a questo punto che si può aprire una suprema via di salvezza: la vita religiosa.
E)
Se tra la sfera estetica e quella etica restano, pur nella discontinuità, rapporti e punti in
comune, lo stadio religioso si realizza tramite un salto assoluto, che taglia ogni ponte dietro di
sé. Kierkegaard scrive Timore e tremore solo pochi mesi dopo l’uscita di Aut-Aut: non si tratta
di un ripensamento o di un’evoluzione di certe posizioni; l’esperienza religiosa è una
rivelazione improvvisa che, costantemente, può aprirsi all’uomo, una possibilità estranea ma
sempre incombente rispetto alla vita quotidiana. Se questa via si mostra, la propria angoscia e
la propria disperazione sono vissute come peccato, cioè come estrema lontananza da Dio, che
solo la fede può in qualche modo colmare.
La fede non può essere accettata in base ad argomenti razionali: essa è scandalo e
paradosso per la ragione (v. emblematicità della figura di Abramo); nessuna conoscenza
speculativa può aiutare l’uomo a capire sé stesso e il suo rapporto col mistero divino: quando
la fede cerca di fondarsi su argomenti di tipo teologico, o cerca di dimostrare i suoi contenuti,
essa viene meno alla propria essenza, e si espone inevitabilmente alla sconfitta.
Altrettanto estranea all’essenza della fede è poi la religiosità borghese, collettiva,
consolatoria e fondata sulle convenzioni: quando l’uomo incontra Dio, egli è solo, nella sua
singolarità, al di là di ogni retaggio culturale e di ogni tradizione. Nel mondo moderno, dove i
benpensanti cercano di accordare il loro utilitarismo pratico al comportamento “religioso”, il
Vangelo rimane un libro del tutto frainteso, un libro sconosciuto5.
Il maggior delitto contro il cristianesimo - scrive Kierkegaard nel suo Diario non sono i piaceri bestiali o la corruzione ... ma quella cordialità e bonarietà,
dove l’ortodossia diventa mediocrità zuccherata ... piatta e cordiale
chiacchiera di famiglia.
4
Cfr. Pascal: il “divertissement” come rinvio, rifiuto della propria problematicità. V.anche Heidegger:
“essere-per-la-morte” come forma di vita “autentica” del Dasein, contrapposta all’inautenticità del
“man” impersonale. Sartre parla di “mala fede” e di esprit de sérieux come forme di fuga dall’angoscia,
cioè dalla libertà che sta al fondo dell’uomo.
5
Si veda come anche Feuerbach sostenesse l’incompatibilità fra sfera pratica e fede religiosa, ma
dal punto di vista opposto, negando cioè validità alla seconda.
4
La fede appare, così, come il rischio supremo 6 : essa non dà le stesse “garanzie” a cui
aspirava il sapere epistemico o che crede di possedere il senso comune; accettandola l’uomo
taglia i ponti con ogni eredità culturale, con ogni sapienza ed etica collettiva, taglia i ponti
persino con l’eredità storica.
O meglio: per chi vive nella fede, tutta la storia umana (e con essa anche la tradizione
biblica) viene re-interpretata alla luce della propria presente immediatezza: è nell’attimo
(Augenblick) che l’uomo coglie la concretezza del suo rapporto con la trascendenza divina, e
dunque è nell’attimo che egli può comprendere veramente il senso dell’intera storia del
mondo: la fede è, secondo Kierkegaard, il vero organo della storia.
F)
Con il pensiero di Kierkegaard viene configurandosi nettamente un atteggiamento
filosofico che, paradossalmente, rinnega ogni filosofia: questo pensiero è cioè una delle
massime espressioni della consapevolezza, che si affaccia nella cultura del XIX secolo, della
crisi irreversibile delle certezze razionali e delle grandi costruzioni metafisiche.
Lo stesso linguaggio che si propone di esprimere questo scacco, è costretto a
rinnovarsi, a “rifondarsi”, ad arricchirsi, anche, di sfumature ambigue, di un senso di
provvisorietà che corrisponde all’esperienza di una situazione di “sfondamento”. Così, in
Kierkegaard, anche termini come “angoscia” e “disperazione” si possono colorire di
significati positivi: la disperazione è una soglia, qualcosa che può portare oltre, e il vero male,
allora, consiste nel non affrontarla. I valori correnti sembrano spesso rovesciarsi, prospettando
situazioni paradossali, ma dietro le quali si può cogliere il tentativo di descrivere un vissuto
umano drammaticamente urgente e problematico: tutta la cultura contemporanea mostrerà
aperture in questa direzione.
Se in Kierkegaard la fede, l’abbandono a Dio è l’unica via che rimane, dopo il
tramonto delle “verità” filosofiche e le grandi costruzioni universali e collettive, altri pensatori
proporranno una completa riformulazione delle categorie ontologiche e del ruolo dell’uomo
stesso in quanto soggetto.
Per Nietzsche, per esempio, la crisi dei valori e delle “verità” tradizionali, porta ad un
superamento dell’antropologia corrente, in cui viene messo in discussione anche tutto ciò che
l’uomo ha finora pensato di sé (compreso, dunque, il senso dell’“individualità”): si delinea
così un compito di rifondazione radicale del rapporto uomo / realtà, senza che si possano
ancora vedere chiaramente tutti i possibili sbocchi di questo progetto.
Come dirà Heidegger, prospettando un superamento dell’intera impostazione della
metafisica occidentale verso una più autentica ed originaria dimensione del pensiero:
“l’aspetto più notevole, nella nostra epoca preoccupante, è il fatto che noi, ancora, non
pensiamo”7.
6
Cfr. Pascal: la fede come scommessa sull’esistenza di Dio.
7
Che cosa significa pensare, 1954. In un altro passo di questo saggio troviamo scritto: “... Questo
stato di cose, per cui non soltanto ogni dialettica fallisce, ma non resta neanche più lo spazio per tale
fallimento, è proprio ciò che più urta, ciò che sconvolge l’abituale modo di rappresentare e le sue
acrobazie ingegnosamente vuote”.
5