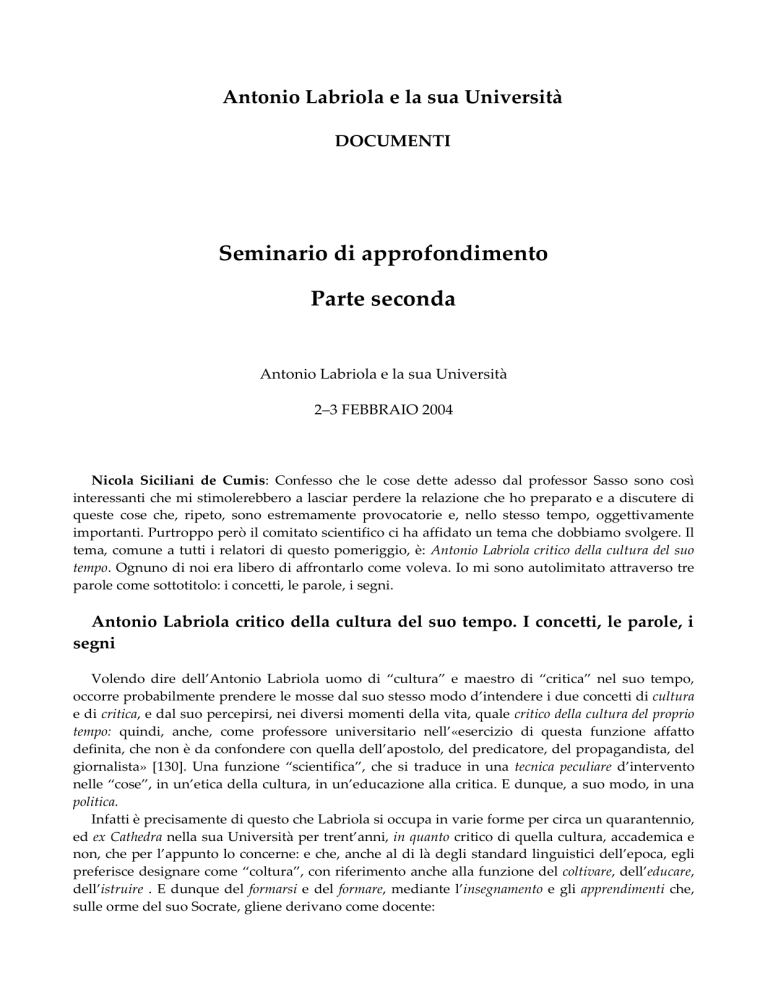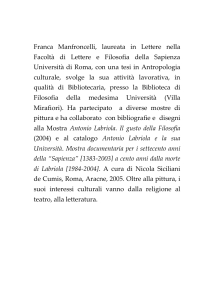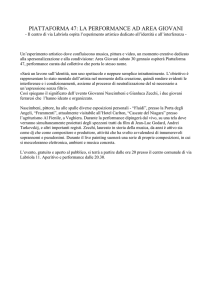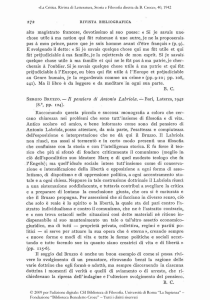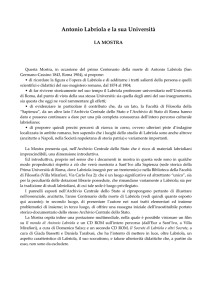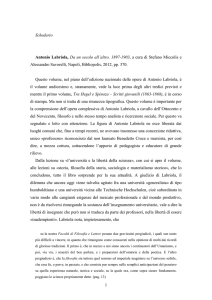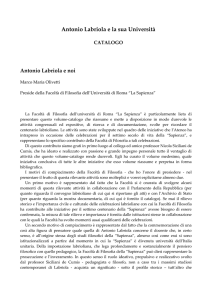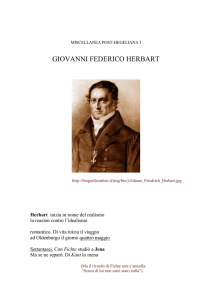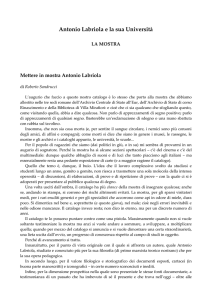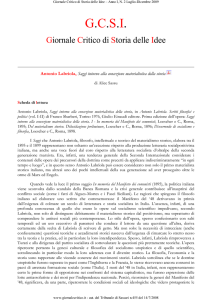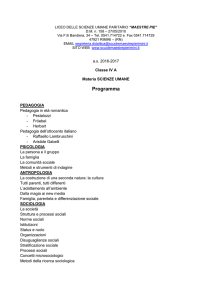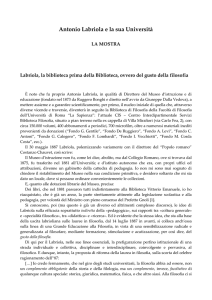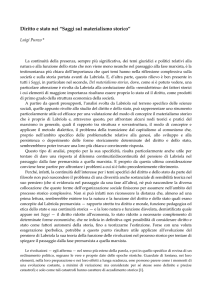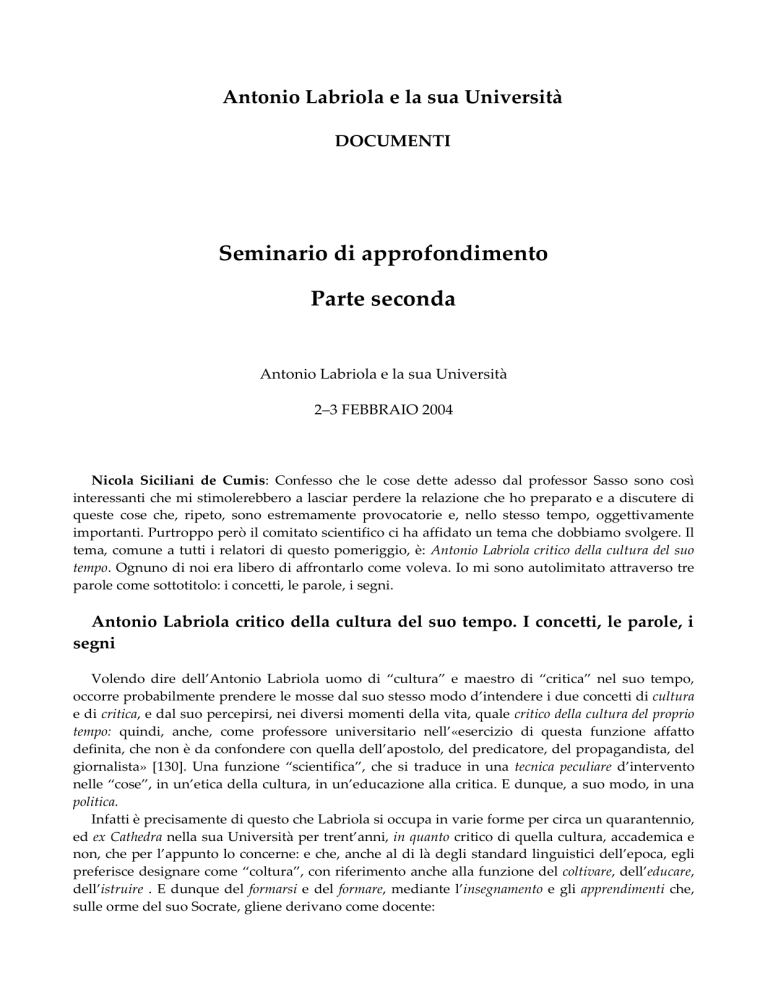
Antonio Labriola e la sua Università
DOCUMENTI
Seminario di approfondimento
Parte seconda
Antonio Labriola e la sua Università
2–3 FEBBRAIO 2004
Nicola Siciliani de Cumis: Confesso che le cose dette adesso dal professor Sasso sono così
interessanti che mi stimolerebbero a lasciar perdere la relazione che ho preparato e a discutere di
queste cose che, ripeto, sono estremamente provocatorie e, nello stesso tempo, oggettivamente
importanti. Purtroppo però il comitato scientifico ci ha affidato un tema che dobbiamo svolgere. Il
tema, comune a tutti i relatori di questo pomeriggio, è: Antonio Labriola critico della cultura del suo
tempo. Ognuno di noi era libero di affrontarlo come voleva. Io mi sono autolimitato attraverso tre
parole come sottotitolo: i concetti, le parole, i segni.
Antonio Labriola critico della cultura del suo tempo. I concetti, le parole, i
segni
Volendo dire dell’Antonio Labriola uomo di “cultura” e maestro di “critica” nel suo tempo,
occorre probabilmente prendere le mosse dal suo stesso modo d’intendere i due concetti di cultura
e di critica, e dal suo percepirsi, nei diversi momenti della vita, quale critico della cultura del proprio
tempo: quindi, anche, come professore universitario nell’«esercizio di questa funzione affatto
definita, che non è da confondere con quella dell’apostolo, del predicatore, del propagandista, del
giornalista» [130]. Una funzione “scientifica”, che si traduce in una tecnica peculiare d’intervento
nelle “cose”, in un’etica della cultura, in un’educazione alla critica. E dunque, a suo modo, in una
politica.
Infatti è precisamente di questo che Labriola si occupa in varie forme per circa un quarantennio,
ed ex Cathedra nella sua Università per trent’anni, in quanto critico di quella cultura, accademica e
non, che per l’appunto lo concerne: e che, anche al di là degli standard linguistici dell’epoca, egli
preferisce designare come “coltura”, con riferimento anche alla funzione del coltivare, dell’educare,
dell’istruire . E dunque del formarsi e del formare, mediante l’insegnamento e gli apprendimenti che,
sulle orme del suo Socrate, gliene derivano come docente:
Chi sta sulla cattedra universitaria, non deve occuparsi di cronaca quotidiana, non deve esporre la sua
opinione su cose particolari, non deve arringare né agitare, ma insegnare, cioè dimostrare, spiegare,
interpretare le cose. Egli deve chiarire i concetti, le parole, i segni, sceverare le regole fondamentali,
formulare le dottrine, presentare le modalità dello sviluppo, condurre ad unità i singoli processi, per quanto
più questo gli può riuscire possibile.
E, prendendo le mosse dai «giornali dell’ultima quindicina» (sostiene Labriola), porsi quelle
domande che servono ad intendere le realtà e le contraddizioni del proprio tempo (queste guerre
tra popoli, queste lotte sociali in corso, queste rivoluzioni a venire), per arrivare a risolvere «i fatti
politici attuali nei momenti e nei moventi, di remota preparazione quelli e di intima impulsione
questi». E per riuscire quindi ad intenderli criticamente (cioè morfologicamente e formativamente).
Ma che cosa significa critica secondo Labriola? Che vogliono dire per lui coltura e cultura del suo
tempo? C’è la possibilità, nell’insieme dell’opera labrioliana da un capo all’altro del suo prodursi
nel tempo, di rintracciare i termini di una risposta in qualche modo unitaria a tali interrogativi? E,
anche al di là degli scatti d’umore del professor «Rabbiola» e delle caratteristiche “esecuzioni
capitali” del «piccolo Robespierre del Caffè Aragno», come bisogna intendere più in generale, in
Labriola, la nettezza, la drasticità e crudezza di talune sue opinioni ed espressioni su alcuni uomini
di cultura del proprio tempo?
Se è vero infatti, secondo il Labriola della maturità, che «le idee non cascano dal cielo» e che la
storia delle idee «non consiste nel circolo vizioso delle idee che spiegano se stesse», è anche vero
che, occupandoci di Labriola, conviene cercare nell’intera sua esperienza la loro fonte. Ed è
altrettanto vero che le idee, quelle che son frutto del positivo lavoro della critica, non si trovano né
gratis sotto i cavoli né con lo sconto ai mercati generali, e tanto meno con quelle stesse facilitazioni
culturali e semplificazioni concettuali che, al tempo di Labriola, vengono secondo lui praticando
nella «Scienza», in filosofia, i neokantiani e gli idealisti, gli spiritualisti e i positivisti acritici. Cioè i
positivisti niente affatto “positivi”, di diverse nazionalità e generazioni e attività, con cui egli
variamente polemizza.
Esemplificando, rimane infatti per noi il problema di quale rilievo teoretico ed etico–politico
attribuire alle stesse fulminanti definizioni labrioliane del «pontificato scientifico», «scolastico» e
«ritardatario», del «degeneratore reazionario del geniale Saint–Simon» e dei suoi epigoni; ovvero
di quell’altro «grande eunuco» e «gran pontefice» del positivismo, «quintessenza di borghesismo
anemicamente anarchico», «a volte un kantiano inconsapevole e a volte un Hegel in caricatura»,
che sembra assommare in sé tanto i difetti di un volgare empirismo mascherato di scientificità,
quanto gli eccessi di una particolare teologia camuffata di razionalità.
Egualmente, sul piano della subitaneità di certe frequenti reazioni verbali ed epistolari, occorre
andare al di là dell’immediatezza delle circostanze e della schiuma variopinta, eccessiva,
dell’insulto: e cercare invece di comprendere, più in generale, il senso complessivo della frequenza,
schiettezza e durezza con cui, da parte di Labriola, avviene lo svillaneggiamento di questi filosofi
«scemi», «scemi di mente» (figli e magari nipoti di altri filosofi «idioti» e «poveri scemi»), e di quel
letterato «vanesio», e di quest’altro narciso che fa «la storia intima delle sue letture, fino alla
fotografia della penna della quale si serve».
Se per Labriola, infatti, risulta immediatamente incontenibile il biasimo per quel certo filosofo
«vilissimo […] inconcludente ciarlatano […] neo–commendatore e […] lustrascarpe di ministri», è
altrettanto irrefrenabile il giudizio variamente maturato sull’«ultrasiciliano» pensatore, «un po’
infatuato di sé, un po’ presuntuoso», che viene negando «la comprensione filosofica della natura e
della storia». Sicché nello stesso ordine di pensieri, ed anche al di là delle ragioni polemiche del
momento, rimane da intendere il rifiuto in blocco di tutte queste filosofie «neokantiane,
neokritiche, neopositivistiche, empiriocritiche, immanenti, contingenziali, neotomistiche,
buddistiche, realidealistiche, fessistiche, ciarlatane – da averne piene le tasche e tutte le altre
borse».
Non meraviglia quindi, in un siffatto quadro di repulse sommarie (che sono però da datare e
contestualizzare puntualmente nel loro esplicitarsi), la definizione, una volta, di «ciucciarello» per
il filosofo neokantiano responsabile delle sue «fesserie» antropologiche, della taccia di «bestia» per
il pedagogista di grido e di «buono, ma pusillanime» per un altro pedagogo nell’esercizio della sua
funzione. Né stupisce la liquidazione senza appello di quelle filosofie di autori conclamati, che si
spacciano per “nuove”, ma che non sono niente altro «coglionerie» filosofiche, niente di più che
«filosofie di privato uso ed invenzione». E la dice lunga il «pasticcio» che quest’altro noto scrittore
impersona con la sua «faccia tosta […] infinita» di «imbroglione», di «plagiario», cioè di «un
mixtum compositum di megalomania, di camorra letteraria e di vanità di mala femmina
sputtaneggiata».
Certo, si tratta di situazioni antagonistiche occasionali, che in qualche modo è lo stesso Labriola
a stimolare e ad enfatizzare in quel preciso momento. Repulsioni umorali, viscerali, che sono per
così dire costitutive della sua psicologia, della sua temperatura intellettuale e morale; e che cercano
quindi una spiegazione, oltre che in precise questioni di merito tra testi, contesti e pretesti
polemici, nello stesso contro il “ritorno a Kant” di Eduardo Zeller) e, contemporaneamente, nella
critica alla scolastica hegeliana (l’opposizione ai «vortici» dell’idealismo assoluto di stretta
osservanza). Prosegue poi il suo discorso, ampliando ed approfondendo i propri autobiografismo
metodologico labrioliano, nella sua inconfondibile verve ironica ed autoironica (pedagogica ed
autopedagogica). Idiosincrasie umane, che sembrano introdurre per così dire geneticamente sia
agli aspetti teoretici, tecnico–conoscitivi, sia a quelli etico–politici ed educativi della dottrina, di cui
la «pedagogica» è parte.
Il che avviene fin dal primo momento in cui la dimensione scientifica si affaccia
consapevolmente in Labriola, come ricerca del criterio di verità filosofiche, di valori culturali e
spinte etico–politico–pedagogiche fondanti. E, per la pars destruens, come critica delle
semplificazioni spiritualistiche, degli onniscienti razionalismi, degli empirismi volgari, dei
positivismi trionfanti; per la pars construens, come ricerca del “proprio e nuovo” nell’ambito del
«principio dello Hegellismo» e nell’ottica dell’evidente «curvatura herbartiana», quindi nel quadro
del «materialismo storico»; e dunque, dall’inizio alla fine, come impegno storico e politico ed
etico–pedagogico a costruire una cultura della critica, individuale e sociale, effettivamente “altra”.
E, oltre che all’università, nella scuola, in famiglia, nella cultura media diffusa ed altrove. A
cominciare da se stesso, dalle proprie categorie mentali.
È così che Labriola procede anzitutto, fin da giovanissimo, nella critica all’intellettualismo
astratto (già dai primi anni Sessanta dell’Ottocento, scrivendo quadri di riferimento culturale, oltre
che nell’insegnamento nella critica militante e, via via, nei saggi monografici su Spinoza e su
Socrate, sulla “libertà morale”, su “morale e religione”, sull’“insegnamento della storia”, sul
“concetto della libertà”; e con articoli giornalistici, recensioni accademiche, collaborazioni di
diverso tipo, sempre e comunque finalizzate all’incontro di cultura, etica, educazione, scuola,
società, politica.
E dunque, nel corso di tutta la carriera universitaria, nell’affermazione di una deontologia
professionale, comprendente da un lato l’avversione alle unilateralità «di scuola o di setta» e ai
«due pregiudizi egualmente perniciosi alla cultura: il volgare tradizionalismo e lo specialismo
esagerato»; e quindi, dall’altro lato, l’antipatia verso quel tipo di intellettuale cartaceo, libresco,
«scrio scrio», specialista specialista, al punto da perdere d’occhio il senso della cultura generale e
della vita; e, se pedagogista, il valore dell’educazione indiretta, piuttosto che di quella soltanto
formale e diretta.
Ciò che invece positivamente interessa al Labriola professore universitario è la prefigurazione
di una personalità di docente padrone delle sue funzioni didattiche e scientifiche, competentissimo
nella propria disciplina ed aperto a dimensioni interdisciplinari, dedito alla trasmissione e alla
produzione di un qualche nuovo sapere, puntuale nell’esercizio del suo ufficio, diligente nella
preparazione delle lezioni e nello svolgimento dei corsi, attento al piano degli studi, assiduo nella
cura degli studenti, responsabile delle proprie proposte e scelte in consiglio di facoltà, nelle attività
di ricerca e nelle altre incombenze del ruolo (ricerca, esami, formulazione di giudizi,
aggiornamento degli insegnanti, ispezioni didattiche, presenza attiva nella società civile).
Di qui per Labriola, ad un certo punto, la preferenza (per esplicito polemica nei confronti
dell’università e, come dice, della «scienza burocratica»), del far lezione di diritti e doveri agli
operai; e la propensione a dialogare, piuttosto che con colleghi professori, con stiratrici e sartine; e
ad avere a che fare, ai vari livelli, con insegnanti elementari, giornalisti, tipografi, agitatori sociali e
sindacali, militanti di partito, ministri, burocrati, preti, editori, organizzatori culturali,
professionisti, cittadini qualsiasi. E, procedendo oltre, la scelta teorica di trattare, nelle proprie
lezioni di filosofia della storia sul socialismo, dei «poveri», dei «fanciulli», dei «vecchi», degli
«inabili», degli «ammalati»… (Certamente, Labriola non è un Don Luigi Guanella, ma è a mio
parere notevole il fatto che la sua filosofia e pedagogia si alimentino anche di siffatte istanze sociali
estreme, comprendenti anche lo handicap nelle varie forme…).
È così pertanto che il Labriola più maturo, quello marxista, viene affermando e confermando
variamente la propria idea di critica della cultura del proprio tempo, come opposizione alla «fallacia
delle opinioni», al “vuoto” di scienza, al «verbalismo» («fraseologismo», «formalismo»,
«ideologismo»), e a tutto ciò che, in un modo o nell’altro, rappresenta per lui quel mal vezzo
italiano (ma non solo italiano) per cui «il culto e l’impero delle parole» finisce per corrodere la
mente, ottundere le capacità critiche e sostituirsi al «senso vivo e reale delle cose» a tutto vantaggio
di una qualche «falsa coscienza». Ed è ciò a cui Labriola, da un capo all’altro della sua opera è
specialmente attento; e a cui non fa che opporre la «critica storica in senso filologico» ed in quanto
«prodotto naturale della coltura e della vita»; la critica, come attività del «correggere, rettificare e
esaminare le opinioni altrui» e come «ricerca storica» in opposizione a «qualsiasi» idea di «filosofia
della storia» a mo’ di «dommatica del nostro secolo», una volta assunto che non può aversi alcun
progresso scientifico dove manca la prima e irrecusabile condizione di ogni metodo scientifico: la
chiarezza del problema, e la ferma delimitazione dei concetti, che sono da elaborare ed applicare.
Ed è per questa ragione che, fin dal principio, si ha a che fare con un Labriola recensore della
cultura del proprio tempo, nato e cresciuto, per così dire, al cospetto di istanze pedagogiche tra
loro contraddittorie ed opposte: quelle che gli erano derivate da un lato, positivamente,
dall’insegnamento di Bertrando Spaventa, che a suo parere «possiede schietto senso scientifico ed
ha scritto molte cose notevoli»; e quelle altre, antitetiche, che Labriola aveva respinto degli
insegnamenti di tutt’altro segno, provenienti dagli altri suoi professori d'università: di quella
«gente», cioè (ma non quella soltanto), – dice Labriola – «che non ha alcuna cittadinanza nel
mondo della scienza».
È un Labriola, questo, che avendo cominciato per tempo ad esercitare da hegeliano le armi della
critica contro il neo–kantismo di Zeller, sente per così dire di essersi reso immune da «quella
philosophia pigrorum, di cui il degno Kant parla in qualche luogo». Un Labriola che delinea subito
con chiarezza, il proprio quadro teorico, obiettando criticamente da un lato contro il “puramente
empirico” e lo psicologismo semplicemente “descrittivo”, da un altro lato contro le formalizzazioni
“assolute” del “sapere” e le ipostatizzazioni “teologiche” di un “conoscibile ora attualmente tutto
conosciuto”.
Un Labriola mentalmente hegeliano che – come ho detto – incomincia con l’obiettare, e con
eguale forza polemica, contro il “soggettivismo” di Zeller e contro una certa scolastica hegeliana:
La Teorica della Conoscenza dello Zeller, è una disciplina puramente empirica, una descrittiva
psicologica; in conseguenza della quale, e della Logica formale, si otterranno esatte ricerche, ma non un
sistema filosofico.
[…] A me pare che l’impotenza sia nella Scuola, e non nel principio. Anzi la Scuola è stata l’esagerazione
del principio. Hegel intese per sapere assoluto, che la conoscenza è in sé tutto il conoscibile; ma il conoscibile certo
non è ora attualmente tutto conosciuto.
Anche perché il conoscente, l’uomo con le sue passioni (senza le quali, secondo Labriola, non si
dà «storia»), è una macchina molto complessa, che shakespearianiamente porta in se stesso «la
sfinge che l’interroga», dando a se medesimo «la risposta». Le passioni, che sono da trattare come
veri e propri oggetti di culto; da coltivare religiosamente, «come dice l’Apostolo, di fede a fede »; e
dunque da mettere «alla pruova», tenendo «a mente che la vita si vive e non si pensa».
Con buona pace dello stesso Spaventa, dal quale il ventiquattrenne Labriola, consumando il
proprio scontento esistenziale nell’amore per Rosalia von Sprenger, dichiara ad un certo punto di
essersi allontanato:
Veramente quello che ha inaridito sempre il mio cuore sono le mie relazioni, e niente me ne fa più fede
quanto l’allontanamento da Spaventa. Quest’uomo stomachevole ha sciupato un tempo tanto del mio amore
e della mia fiducia, senza darmi in cambio che noia e mal’umore. Ora che veggo lui uomo fra gli altri, e più
meschino di molti altri, non so se debba piangere o ridere della mia sciocchezza! Tanto è vero che l’uomo non
è che un lento prodotto del suo lavoro, e che il suo destino è di raccogliere i tardi frutti dei suoi disinganni
[…]. Se il mondo m’ha negato ricetto, se tutti m’hanno maltrattato, io non risponderò certo coi pianti del
romantico, né con le minacce del liberale da commedia – questa era la mia maniera di prima – ma risponderò
coi fatti. Che tutte queste parole oltre ad essere una manifestazione matura del mio animo, si riferiscono
anche a dei piccoli incidenti, lo intenderai bene. Ma sai anche che la somma delle piccole esperienze acquista
nell’anima un valore infinito, innanzi al quale i fatti singoli perdono interamente ogni valore.
«Dagli elementi della formazione, alla cosa formata» – verrebbe da ripetere col Labriola della
maturità. Ed è su questi presupposti anche sentimentali, passionali, che viene infatti a formarsi un
Labriola critico del suo mondo “razionale e reale”. Un Labriola che, intervenendo “geneticamente”
nel proprio back–ground ideologico ed etico–politico–pedagogico, saprà fare scaturire dai propri
repentini furori gli orientamenti scientifici, le istanze ideali e morali e le prospettive sociali e
politiche, che originalmente gli appartengono.
Un Labriola pedagogo del “sé”, che vuol farsi al tempo stesso pedagogo dell’“altro da sé”; e che
usa la propria esperienza del “dover essere”, per mettere oggettivamente in discussione quel che
di criticabile gli sembra di scorgere sia in se stesso che negli altri, come individui. Un Labriola
“hegeliano” ed “herbartiano sociale”, e dunque un Labriola, che quanto più osserva e relativizza la
prima persona, tanto più prende le distanze anche dalla seconda e dalla terza persona. Per
raggiungere, così facendo, il “noi”, il “voi”, gli “essi”, quali ipotetici soggetti di educazione.
Aveva infatti scritto al giovane Benedetto Croce, al benedetto uomo («letterato», individualista,
«edonista»), che sarà la sua croce (nella prospettiva, anche, di «quello che ora occorrerebbe all’Italia
per migliorare la sua cultura»):
Voi soffrite la più grave malattia, che è quella di doversi occupare di sé stesso. Gli organi son tutti fatti
per travagliarsi in altro, e se son costretti a reagire sopra di sé stessi (io scrivo sé sempre con l’accento), si
guastano.
Fate un bel viaggio per intuire l’altro che è fuori di voi, e poi voi stesso: studiate il vostro cuoco, che
sebbene sia tanto stupido, è pure il vostro simile, e merita tutte le attenzioni, e tutti i riguardi della vostra
filosofia: amministrando i vostri beni lavorateci un po’ attorno, perché la fortuna diventi in qualche maniera
un merito: e se non potete fare altro compatite gli storpi, i ciechi, i matti, ed i birbanti, pensando che voi siete
in qualche maniera come loro, o quasi.
Perché il busillis sta qui: di avere una religione senza Dio; il che se confina con l’assurdo, niente toglie che
sia vero.
Su questo registro etico–politico–educativo, nonostante i “salti” della teoria, da un tempo
all’altro della vita di Labriola (dallo hegelismo allo herbartismo al marxismo, dal liberalismo alla
democrazia radicale al socialismo), non si può dire ci sia in lui alcuna soluzione di continuità nella
forma dell’acquisizione culturale e nei modi della contrapposizione storica al portato ideologico,
acritico, del proprio tempo. Ciò che in Labriola si mantiene ben ferma, invece, è la sua opposizione
di sempre ai «pregiudizi» d’ogni sorta. A cominciare da quelli suoi proprî, a suo tempo esorcizzati
tra gli hegeliani di Napoli, facendo polemicamente i conti con i «pregiudizi speculativi» (gli
«speculativen Vorurtheilen») di Augusto Vera, che derivano insieme da mancanza di «scienza» e
da carenza di «buona fede», sicché «la critica non può farci nulla». E difatti:
quando poi vediamo che qualcuno s’immagina che si possano prendere i fatti del sapere storico, alla cui
ricerca critica e elaborazione scientifica tante discipline si affaticano, e con un paio di parole magiche gettarli
nel vortice dell’idealismo assoluto, e che si possa inoltre passar sopra orgogliosamente a tutte le questioni
della linguistica e della mitologia, della storia del diritto e della statistica, dell’etica storica e comparata, noi
pensiamo che un tal procedere confina con la temerità; ovvero dobbiamo astenerci da ogni diritto di
pronunziare un giudizio sulla coscienziosità dell’autore.
Quanto agli sviluppi di questa posizione “di principio”, da Labriola in seguito sempre
confermata, essi finiscono col coincidere con le stesse formulazioni e riformulazioni labrioliane dei
concetti di “critica” e di “cultura”, nelle diverse dimensioni a cui gli è possibile accedere: in
filosofia, in pedagogia, in politica. Comunque in forza del criterio ermeneutico di sempre, dall’anti
– Zeller e dall’anti – Vera in avanti. E che senza dubbio viene riproponendosi nei Saggi sul
materialismo storico in altra forma, ma pur sempre nella consapevolezza (Labriola vi insiste) che le
idee non cascano dal cielo.
E spiega:
Tendenza (formale e critica) al monismo, da una parte, virtuosità a tenersi equilibratamente in un campo
di specializzata ricerca, dall’altra parte: – ecco il risultato. Per poco che s’esca da questa linea, o si ricade nel
semplice empirismo (la non–filosofia), o si trascende alla iper–filosofia, ossia alla pretesa di rappresentarsi in
atto l’Universo, come chi ne possedesse la intuizione intellettuale.
Di qui, secondo Labriola, la necessità di quel tipo di operosità critica, che se incomincia col
significare osservazione, disamina, analisi e notazione dei difetti di una determinata posizione
mentale o azione pratica, finisce anche col voler dire iniziativa pedagogica positivamente
finalizzata alla risoluzione di un problema etico–politico. E che, rispetto alla cultura del proprio
tempo, si esprime ora come biasimo, censura, correzione, rimprovero, discussione, negazione,
opposizione, polemica, ora come capacità di informazione, notazione, recensione, rassegna,
trattazione, giudizio, integrazione, cooperazione, formazione, approfondimento, interpretazione. E
si tratta, in ogni caso, di un’attività intellettuale criticamente qualificata, selettiva, alta, e tuttavia
composita, ibrida, impura. Un’attività culturale, che non è mai fine a se stessa, ma sempre e
comunque diretta a produrre e a far produrre altra attività dello stesso tipo; e che, per ciò fare,
prova ad intervenire pedagogicamente nelle realtà umane le più diverse.
E per esempio, nella vita di tutti i giorni, come stroncatura di questo o di quell’intellettuale,
«stranissimo ma assai simpatico goliardo», «minchione» oppure «minchionatore», «coglione» o
«coglionatore»; additando all’attenzione i «turpemente corrotti», gli «artisti impulcinelliti», la
«ciarlataneria cretina», i «paolotti»; ovvero demolendo quell’altro saggista «somarello,
prosuntuosello, intrigantello, farabuttello, le cui opinioni non contano nemmeno per riderci». O
ancora censurando le azioni di quei giornalisti «mascalzoni» e «marmaglia», «di solito tanto
ignoranti» e con «la sensibilità della malizia»; ovvero bollando senza peli sulla lingua le azioni di
quei «socialisti» e «internazionalisti» nostrani, che si dimostrano «asini», «rigattieri della
letteratura socialista», «cretini», «volgari», «confusionisti ed amorfisti».
Un’attività formativa, morfologica, questa di Labriola, che sorgendo nella sua quotidianità
all’incrocio di teoria e pratica, viene a costituirsi come conoscenza e come etica e politica; e, nella
propria ambivalente peculiarità, a rispecchiarsi nell’opera pedagogica e quindi a riflettersi nella
storia degli uomini. Cioè nella vita concreta, individuale e collettiva di essi e nella loro capacità di
storicizzazione del “sè”. Quindi (hegelianamente) in una autobiografia che è (herbartianamente)
un’educazione.
Proprio come, ancora all’inizio della carriera, gli era successo lavorando al Socrate. Dove non a
caso, assieme all’idea–guida di una critica della cultura, era comparso il concetto, intrinsecamente
pedagogico, di una cultura della critica. Un concetto che chiamava in causa le nozioni di civiltà e
progresso, di individuale e sociale, di civismo ed arte, di «tradizione letteraria come mezzo di
coltura» e di «paideia» («lettura, recitazione, canto, ginnastica»). Un’idea di genesi e di formazione
critica in rapporto alle cose: e, dunque, l’idea di un’autocritica delle cose come momento
imprescindibile del loro ipotetico rovesciamento.
E aveva tirato in ballo, Labriola, le «vedute» del singolo ed il loro radicamento interpersonale,
collettivo, nei «bisogni e nella coltura del tempo»; e, quanto a Socrate, messo in relazione il
«meramente scientifico» ed il «concretamente pratico», le «condizioni della coltura ateniese» e «il
risultato cui pervenne Socrate con le sue ricerche», la religiosità di Socrate ed il concetto di utilità e
di eudaimonia «nella storia della coltura greca», l’«antitesi così pronunziata» che rappresentò
Socrate nel suo tempo e l’assoluta novità dell’oggetto e del risultato della ricerca socratica che,
nelle sue stratificazioni storiche ed elementarità quotidiane, procedette ben oltre il suo tempo.
E questo, nonostante i limiti del “socratismo”, i limiti della stessa filosofia e dei suoi insegnamenti,
di cui il Labriola degli ultimi anni continua ad essere criticamente ed autocriticamente cosapevole.
Quando scrive a Croce:
Dopo 26 anni che insegno filosofia mi son persuaso che la filosofia non s’insegna a nessuno. Marx ed
Engels non ebbero che un solo torto, e fu quello di volere insegnare la filosofia alle moltitudini (dei Kautsky,
Bernstein, Lafargue, Turati!), alle quali basta la logichetta formale. Tu, Sorel ed altri avete fatto bene a
scoprire i volgarismi dei marxisti, ma non per questo avete trovato una nuova teoria della conoscenza. Anche
per questo rispetto la storia è catastrofica. La sommazione empirica delle osservazioni parziali non dà mai la
nuova Weltanschauung – il criticismo non è tutta la filosofia. La filosofia non può esistere che come factum
già bello e compiuto.
Che però, secondo Labriola, non esaurisce affatto il compito del filosofo e dell’educatore in
quanto critico della cultura del proprio tempo. Perché al di là della filosofia e delle sue solo
temporanee compiutezze, occorre fare i conti con le urgenze della realtà e con il portato della
storia, con il dominio delle cose e le loro oggettive pesantezze e interne necessità. E con la vita e le
sue estemporaneità ed imprevedibilità, le sue passioni e contraddizioni.
Gennaro Sasso: Ringrazio il professor Siciliani de Cumis per questo ritratto molto vivace, molto
partecipato, del suo autore. Mi rimane una curiosità: quella di sapere se c’è stato un personaggio,
un protagonista della vita culturale e politica del tempo di Labriola che abbia resistito per tutta la
sua vita a questo terribile giudice.
Le celebrazioni, che hanno avuto inizio questa mattina e che stanno proseguendo in questo
pomeriggio, avranno un seguito. Il 13 maggio, nella sede della Società Nazionale di Napoli
saranno presentati i volumi del carteggio labrioliano curati da Stefano Miccolis, e interverranno, in
tale occasione, Claudio Cesa, Giuseppe Cacciatore e Stefano Poggi; infine, l’8, il 9 e il 10 di ottobre a
Cassino ci sarà il convegno di studi conclusivo di questo anno labrioliano.
Vorrei chiedere se ci sono, come spero, interventi che potrebbero arricchire questo pomeriggio,
reso più breve del previsto dall’assenza del professor Cotroneo.
Marzia D’Alessandro: Avendo io fatto una tesi di laurea su Antonio Labriola e la libertà della
scienza – per la quale ho analizzato principalmente i saggi sul materialismo storico – ed essendo il
tema di oggi “Antonio Labriola critico della cultura del suo tempo”, vorrei fare alcune osservazioni
riguardanti proprio il materialismo storico. Ricordo, in particolare, che Labriola parla
esplicitamente di “comunismo critico” (anche con l’intenzione di distinguere in modo netto il
materialismo storico dalle altre filosofie socialiste o socialisteggianti) e che, a suo avviso, dal
momento che il materialismo storico è critica, deve essere continuato criticamente. Probabilmente,
proprio il fatto di non aver seguito questa indicazione ha portato alla crisi del marxismo.
Vorrei inoltre richiamare la vostra attenzione sul fatto che Labriola usa il termine “critica”
anche nel senso di autocritica che è nelle cose. Ebbene, che rapporto c’è tra comunismo critico e
l'autocritica che è nelle cose? Esiste, da questo punto di vista, una contraddizione, un problema che
Labriola non è riuscito a risolvere.
Gennaro Sasso: È una domanda così limpida e di tale impegno che non dovrei essere io a
rispondere. Potrei dire che è molto facile affermare che le filosofie vanno proseguite criticamente.
Bisogna vedere questo cosa significa. Espressioni di tal genere richiedono, evidentemente, il
riferimento al filosofare concreto, rimandano ad un allargamento o ad un restringimento di
prospettive, a seconda dei casi. Di conseguenza, è lo studioso di Labriola che, in virtù delle sue
competenze, potrebbe rispondere meglio a questa domanda.
Non c’è dubbio, tuttavia, che il marxismo di Labriola si presenti con caratteri fortemente
antidogmatici. È altrettanto vero, però, che quando le filosofie si presentano con caratteri
fortemente antidogmatici talvolta si è di fronte ad atteggiamenti velleitari, proprio perché
l'antidogmatismo si pratica, non si enunzia. Quindi, non basta dire che il marxismo è
antidogmatico in questo o in quello, perché poi lo sia sul serio. Personalmente, ritengo che il
problema fondamentale del marxismo sia in Marx, e che interpreti autentici del marxismo sono
quelli che leggono Marx nel quadro delle contraddizioni delle ideologie borghesi. Certamente
Labriola, per molti aspetti, vive questa situazione.
È probabile che chi decida di studiare il confronto, drammatico e sofferto, di Labriola con la
crisi del marxismo, forse potrebbe arrivare a comprendere il limite interno del marxismo di
Labriola.
Queste considerazioni mi sorgono sulla base della bella e vivace relazione dell’amico Siciliani
de Cumis. C’è, insomma, in Labriola una tendenza all’attacco nei confronti del mondo, che lascia, in
qualche caso, anche disorientati.
Si consideri, ad esempio, il carteggio con Croce. Leggendo le tante lettere di Labriola emerge la
sua veemenza (che nasce da una sofferenza) nei confronti di questo personaggio, di Benedetto
Croce – che allora era appena un ragazzo; un ragazzo che, tra l’altro, usciva da una grave tragedia
familiare. Nel terremoto di Casamicciola egli aveva infatti perso la madre, la sorella, oltre ad essere
rimasto sotto la macerie per diverse ore. Talvolta, sperava addirittura di morire nel sonno. Non era
quindi un egoista, ma un personaggio che viveva una situazione di grande crisi personale. Il
rapporto tra Croce e Labriola ha qualche cosa di sorprendente. In certi momenti, Labriola, che non
voleva che ci si occupasse di se stessi, solo di se stesso si occupa e delle sue sofferenze, sfogando su
questo povero ragazzo un grande malumore, una grande insoddisfazione. In tutto ciò c’è anche
una grandezza, ma c’è, parimenti, qualcosa che in me ha sempre suscitato una certa impressione di
squilibrio, di inadeguatezza.
In ogni caso, la questione del dogmatismo, dell’apertura, della criticità è una questione
filosofica. Volevo aggiungere, riprendendo quello che molto brevemente, sommariamente e
malamente, ho detto nelle poche parole di introduzione, che effettivamente succede sempre che
quando le circostanze storiche violente si abbattono sulle dottrine, queste, a un certo punto,
cadono in una sorta di letargo. La cosa più terribile che accade in questi casi è la nascita
dell’ignoranza. È successo all’idealismo intorno alla metà del secolo ventesimo, sta capitando a
tanti aspetti della nostra cultura contemporanea. È successo anche al marxismo. Bisognerebbe,
dunque, ricominciare a pensare i punti fondamentali di questa dottrina. Si tratta, infatti, di una
prospettiva che ha dominato tutto il secolo ventesimo e una parte del diciannovesimo. Io consiglio
sempre, quando si studia il marxismo, di tener presente che esso è, in primo luogo, Marx.
Nicola Siciliani de Cumis: Volevo dare anch’io un piccolo contributo di risposta a Marzia
D’Alessandro, riprendendo la distinzione che faceva il professor Sasso all’inizio della sua
introduzione quando citava da un lato Croce, mettendoci vicino la parola “metodo”, dall’altro
Gentile, mettendoci vicino la parola “filosofia della storia”. Questi due giovani intellettuali, che si
confrontano in qualche misura, anche se in modi personali assai diversi, con Labriola, possono
rappresentare due casi limite del discorso critico di Labriola all’interno della crisi del marxismo.
Labriola continua a essere un autore che si autosquilibria in qualche modo, un pensatore al limite,
pur dentro, tuttavia, una linea metodologicamente rigorosa. Questo comporta un prezzo da
pagare. Croce dirà a Gentile, nell’epistolario, che in Labriola la confusione gli viene crescendo
sempre di più in testa. Paradossalmente, quanto più Labriola critica e autocritica se stesso, si mette
al limite, tanto più dà questa impressione anche di follia teoretica, di incapacità di controllare il
rigore. Mentre è proprio in nome di quel rigore che Labriola si mette in gioco continuamente.
I saggi sul materialismo storico non si possono leggere tutti d’un pezzo. È vero che bisogna
rileggere Marx, ma è vero che le stesse letture marxiane e marxiste, si diceva prima, di Labriola,
vanno datate. Infatti, il primo saggio ha uno stile, ha un tono, ha una maniera, che non sono uguali
a quelli del secondo e del terzo. Non vi dico cosa succede in presenza del pur soltanto accennato,
frammentato, quarto saggio, in presenza di altri temi e di altri problemi. Con questo voglio dire
che quando si parla di marxismo e di critica va storicizzato tutto. Si tratta anche di correre il rischio
di essere fraintesi, di non essere capiti, di essere accusati di infranta filologia oppure di confusione.
Tuttavia, il problema è riuscire a ricostruire al massimo i termini in cui, di volta in volta,
avvengono le discussioni. Questa è una considerazione di metodo più che di merito, rispetto al
discorso che è stato fatto.
Giuseppe Boncori: Ho ascoltato con molto interesse le relazioni di questa sera, in particolare la
relazione del collega Siciliani. Nonostante io non sia uno specialista di Labriola, ho captato dei
segmenti. Questi ultimi giorni sono stati molto suggestivi e provo a richiamarli brevemente,
nell’interpretazione che si sta dando di Labriola, come persona che sottolinea l’interdisciplinarità,
che sottolinea aspetti diversi di educazione e pedagogia. Soprattutto ho sentito ricorrente la
dimensione critica, propria e tipica di Labriola.
Per quello che io ho potuto approfondire in questi anni rispetto alla dimensione critica, da un
punto di vista interdisciplinare, potremmo dire più applicativo, essa è stata vista spesso nella
letteratura internazionale come distinzione, come confronto critico, come paragone con criterio. Su
questo sono stati approntati, in tutto il mondo dall’inizio del novecento fino ai nostri giorni, una
serie di strumenti, una serie di metodi sia sul piano filosofico sia, soprattutto, sul piano
psicopedagogico e pedagogico: un investimento evidentemente enorme.
Unendo le suggestioni educativo–pedagogiche, emerse soprattutto dall’intervento di Siciliani,
alle considerazioni del professor Sasso, che faceva riferimento a un momento particolare in cui
viviamo, un periodo difficile dal punto di vista della cultura, della scienza, della ricerca, chiedo: la
critica di Labriola, applicata al campo pedagogico, quali criteri di giudizio avrebbe da proporci
oggi? Nella posizione di Labriola, considerata nei suoi vari periodi, e in particolare nel Labriola
pedagogista e critico, c’è qualche spunto pedagogico innovativo che può essere preso in
considerazione in modo utile, produttivo, in una società in crisi dal punto di vista culturale,
scientifico e anche pedagogico?
Nicola Siciliani de Cumis: È una domanda che meriterebbe un convegno a parte. Mi sono
posto questo problema nel momento in cui ho contribuito a costruire questo dépliant e lo ho
sintetizzato nell’esergo , in epigrafe. Quindi, faccio rispondere direttamente Labriola: «Ma non è
forse la università, nella parte sua essenziale, una istituzione continuativa, che deve sopravvivere a
molte generazioni di studenti?». Ed è la critica lo strumento principale che lo consente.
Tuttavia, Labriola è ancora più preciso nel sostenere che la forma critica può essere estesa e può
essere modificata, è una parola plastica che significa un mondo di cose. «Ciò che è tecnico non si
elegge, ma si sceglie; e, per poterlo scegliere, bisogna aspettare che si formi e si maturi. In cotesta
ragione tecnica consiste la specialità della nostra carriera, e la garanzia che le compete; in cotesta
stessa ragione tecnica, e non in altro, ha fondamento l’autorità nostra». In questo senso, l’unica
cosa che posso dire, è che la critica diventi tecnica, non so dire altro. E dico questo facendo uno
sforzo di metastoricizzazione dell’autore, di estrapolazione, di inserimento di Labriola nel nostro
contesto. Questa è un’operazione legittima, ma mi mette un po’ a disagio, perché il problema è
soprattutto di mettere a distanza Labriola, di storicizzarlo, di leggerlo nei suoi testi reali e nei suoi
contesti e nei suoi pretesti polemici.
Luigi Punzo: Posso aggiungere una osservazione brevissima per contestualizzare il pensiero di
Labriola. A questo proposito andrebbe ricordato che Labriola, a livello di politica culturale
dell’educazione, sosteneva l’imprescindibilità della priorità della scuola pubblica. Questa
posizione aveva il risvolto, forse datato, di scagliarsi contro il clericalismo, ma può avere un
risvolto più ampio ed essere utile anche per una riflessione – anche se bisogna sempre rifuggire
dalle attualizzazioni del pensiero di un autore – proprio in rapporto a una concezione laico–
pluralista dell’educazione.
Nicola Siciliani de Cumis: Sono d’accordo, questa è la posizione prevalente di Labriola.
Tuttavia, Labriola è un personaggio assai complesso, nel senso che in ogni posizione che sembra
quella, se si va a scavare, c’è sempre una dimensione dialettica, una dimensione altra, un’altra
faccia del problema.
In questo caso, è vera la posizione di principio di cui parlava il Punzo, basta leggere gli scritti
politici principali di Labriola. Tuttavia, si consideri il saggio Morale e religione, il punto della sua
lettura di alcuni testi herbartiani ed hegeliani che stanno alla base di quel saggio, o anche certe
posizioni politiche di Labriola verso la religione, per esempio il suo atteggiamento minoritario e
sconfitto nei confronti delle facoltà teologiche. Ebbene, Labriola, liberale, si mette contro la sua
parte politica per difendere il mantenimento delle facoltà teologiche. E questo perché egli mette la
critica in cima ad ogni cosa. Labriola, infatti, sa benissimo che le facoltà teologiche garantiscono la
lettura dei testi, l’ermeneutica biblica, garantiscono la storia delle religioni, garantiscono cioè che i
pareri incolti si alimentino della loro cultura ma in termini critici. Per questo motivo le difende.
Alcune lettere di Labriola alla fidanzata prima, moglie poi – che Miccolis ha messo in
circolazione in maniera meritoria alcuni anni fa e che adesso sta riproponendo – lasciano emergere
una inquietudine determinata dal tipo di essere umano che egli ha davanti. Infatti, la moglie,
fidanzata–moglie, è una donna di fede, è una donna che fa parte di certi gruppi evangelici e
Labriola, per starle vicino, si convince di scrivere una vita di Gesù, si convince di parlare della
religione in termini strani, non labrioliani si direbbe.
Dunque, la dimensione pedagogica della critica è quella che ha l’ultima parola per Labriola. Egli
possiede i contenuti e le grandi posizioni di principio; è un uomo che ha una cultura non
spiritualistica, una formazione idealistica, herbartiana e quindi è molto lontano da certi esiti di
fede. Tuttavia parla di fede, ne parla alla sua maniera. C’è sempre, in Labriola, una dimensione
contraddittoria, che lo rende, tuttavia anche più ricco, in qualche modo inesauribile.
Carmela Lo Giudice Sergi : Sono perfettamente d’accordo col professor Siciliani sul fatto che si
deve contestualizzare l’idea, il pensiero di qualsiasi filosofo, di qualsiasi pensatore, in particolare
quella di Labriola che ha una evoluzione abbastanza atipica. La mia domanda è la seguente: come
elabora Labriola la dialettica tra in sé e l’altro da sé, un rapporto – direi – alquanto scabroso?
Nicola Siciliani de Cumis: Dipende dalla situazione, dipende da chi ha davanti, da chi è l’altro da
sé. Vi ho appena letto la lettera a Benedetto Croce nella quale emergeva una vera e propria teoria
dell’altro da sé.
Esistono, tuttavia, anche altre facce di Labriola. Si pensi, ad esempio, all’aneddoto sul papuano
riferito da Benedetto Croce. «“Come fareste ad educare moralmente un papuano?” domandò uno
di noi scolari, tanti anni fa al prof. Labriola, in una delle sue lezioni di pedagogia, obiettando
contro l’efficacia della pedagogia. “Provvisoriamente (rispose con vichiana ed hegeliana asprezza
lo herbartiano professore), provvisoriamente lo farei schiavo; è questa sarebbe la pedagogia del
caso, salvo a vedere se pei suoi nipoti e pronipoti si potrà cominciare ad adoperare qualcosa della
pedagogia nostra”». Si tratta di un aneddoto famoso, anche perché ha suscitato una critica feroce
di Antonio Gramsci, il quale, partendo da questo aneddoto, ha mosso a Labriola delle accuse
terribili. Pertanto, non si può risolvere il problema con una battuta.
Torno, dunque, al “dipende”, in quanto Labriola è molto sensibile alla “situazione”. Proprio per
il suo pedagogismo naturale, fisiologico, egli ha una sua linea etico–politico–filosofica, valutando
però, di volta in volta, che cosa può dire e fare nella data condizione.
Irene Kajon: Ho ascoltato le relazioni e ringrazio tutte le persone che hanno parlato perché ho
appreso molte cose. Labriola non è tra gli autori che io conosco in modo approfondito, quindi
quello che dico è soltanto il risultato delle cose che ho imparato qui e di altre cose che ho letto.
Quando ho ascoltato Punzo che leggeva la relazione del professor Giarrizzo ho avuto
l'impressione che Labriola si attenesse, nella sua interpretazione dei fatti storici, a un impianto
fortemente hegeliano. Il riferimento, per esempio, alle dimensioni attive e alle dimensioni passive
mi ha fatto pensare alla filosofia della storia di Hegel, laddove si parla di passaggio da una civiltà
ad un’altra come momento egemone nel percorso storico. Quando si parlava, ancora, del ritardo
dell’Italia nel creare una socialdemocrazia che fosse all’altezza dei tempi veniva subito alla mente
uno schema che riguarda la presenza di certi elementi che sono all’avanguardia rispetto ad altri
che invece devono tenere il passo per raggiungere una determinata data storica. Dunque, siamo in
presenza di una filosofia della storia che delinea un percorso di progresso, un percorso evolutivo.
Il marxismo di Labriola rimane fortemente impregnato della filosofia della storia hegeliana e credo
che questo modo di interpretare i fatti storici, attraverso appunto un orientamento hegeliano, forse
lascia anche da parte Marx.
Come affermava il professor Sasso, prima di prendere in considerazione quello che hanno detto
i marxisti, si tratta di rileggere Marx. Credo che in Marx ci siano dei testi che non si attengono a
questo tipo di interpretazione della storia. Marx, a differenza di quello che poteva essere
l’orientamento hegeliano, aveva presente anche salti e discontinuità della storia. Dunque, ho avuto
l’impressione di un Labriola hegeliano e di un marxismo di Labriola visto attraverso Hegel.
Quando poi ho ascoltato il professor Siciliani la mia impressione è cambiata, perché l’immagine
che è venuta fuori dalla sua relazione è quella di un Labriola fortemente attento ai fatti, che lega la
vita e la teoria, che è molto attento a interpretare i singoli dettagli della realtà. Ancora una volta mi
sono trovata di fronte a ciò di cui si parlava prima, cioè ad una formazione marxista che insegna a
fare attenzione ai fatti, al metodo, e dunque anche al nesso tra struttura e sovrastruttura, cioè al
rapporto tra i fatti economico–sociali e le espressioni culturali. Di qui anche la forte polemica nei
confronti della cultura, perché Labriola aveva ben presente il nesso tra la cultura e quelle che erano
le posizioni di tipo politico, le espressioni politiche a cui poteva condurre un certo orientamento
culturale. Quindi, la mia impressione è che effettivamente ci troviamo in presenza di un marxismo
che assume diversi aspetti: c’è il metodo marxista, c’è invece un forte ancoraggio ancora alla
filosofia della storia d’impronta marxista. È giusta questa mia impressione? C’è effettivamente un
divario tra questi due aspetti? Rimane in Labriola? Oppure c’è la possibilità di costruire
un’immagine unitaria tra un Labriola empirista, che ancora mantiene gli insegnamenti che
derivano da una formazione di tipo empirista e un Labriola che si attiene a un marxismo
interpretato attraverso Hegel?
Luigi Punzo: Non posso rispondere per Giarrizzo. Posso solo dire che Giarrizzo prende in
considerazione proprio Da un secolo all’altro, il saggio di Labriola che, a molti degli esegeti, ha fatto
pensare a un ritorno di Labriola a Hegel, a un recupero da parte di Labriola delle posizioni
hegeliane. Pur essendo un saggio incompiuto, si parla di un ritorno a Hegel e, quindi, le
suggestioni che la Kajon riporta sono più che legittime. Vorrei porre una domanda – che è un
interrogativo che si poneva già Sasso nelle sue osservazioni: il marxismo è una filosofia della
storia? Il marxismo di Labriola è una filosofia della storia? Forse dovremmo partire da qui per
cercare di dipanare alcune delle questioni che vengono poste. Affermo questo ricordando che
Labriola sosteneva anche che le idee non cascano dal cielo.
Gennaro Sasso: Io non sono la persona più giusta per dire se il marxismo sia o non sia una
filosofia della storia, se sia un metodo o, infine, se in Labriola prevalga la filosofia della storia o il
metodo; anche perché il pensiero di Labriola – soprattutto del “secondo Labriola” – è molto
complesso, variegato e può dare luogo a suggestioni diverse. È opportuno, pertanto, cercare di
capire equilibratamente le sue posizioni e le difficoltà oggettive dentro le quali egli si muoveva.
Vorrei fare, invece, delle osservazioni a proposito di questo famoso aneddoto crociano del
papuano, dal quale, a mio avviso, emergono abbastanza chiaramente due questioni. In primo
luogo, l’idea labrioliana della lentezza del processo educativo: sono necessarie più generazioni
affinché… Una forte coercizione pedagogica ha insomma bisogno di molte generazioni per dare i
suoi frutti. Il “farlo schiavo” rappresenta probabilmente il gusto per il paradosso di Labriola. La
seconda questione – sicuramente più interessante – riguarda il forte elemento eurocentrico che
costituisce il fondamento dell’aneddoto e che chiama in causa lo hegelismo e la curvatura di
filosofia della storia presente negli scritti di Marx e di Labriola.
La componente eurocentrica, d’altra parte, sta a significare che tutte le culture, a un certo punto,
devono passare attraverso la cruna della cultura più alta, che conduce innanzi la storia. Esisterebbe,
in altri termini, un processo di unificazione dei processi culturali nel loro segno più alto. L’idea –
oggi predominante nell’atteggiamento antropologico – di culture diverse che si equilibrino e che si
corrispondano sul piano della parità, pur nella loro differenza, non apparteneva a Labriola.
Si tratta, evidentemente, di un punto molto delicato e molto importante. Il rispetto delle altre
culture è cosa diversa dall’idea che sul piano assiologico tutte le culture si corrispondano. Siamo di
fronte – lo ripeto – ad una questione molto delicata, sulla quale bisognerebbe discutere con
fermezza e con freddezza, lasciando da parte l’emotività e le facili accuse di razzismo.
Nicola Siciliani de Cumis: Anche io vorrei dire una cosa alla collega Kajon, perché credo che si
aspetti una risposta. Dovrebbe essere Giarrizzo a rispondere alla prima parte. Domani, quando
Volpicelli parlerà di Herbart e i suoi epigoni, emergeranno una serie di temi in chiave herbartiana
e sarà interessante.
Però vorrei dire anche un’altra cosa: che il segreto di Labriola, secondo me, è nel tema del
morfologico, che la dice lunga anche sulla questione del papuano, sulla questione dei popoli attivi
e dei popoli passivi. La mia ipotesi è questa: che l’episodio del papuano sia l’iceberg; e che
l’iceberg sia la stessa concezione della storia secondo Labriola, il suo generale modo di vedere, la
sua idea della vita e degli uomini. Il suo necessitarismo, il suo “velo” di fatalismo obiettivo.
Maria Serena Veggetti: Io parlo con un po’ di timore, perché, occupandomi di neuroscienze (le
scienze del soggetto), sono certamente limitata dallo specialismo e sarà molto difficile per me
individuare il collegamento tra la filosofia della storia di Labriola e la storia della scienza con la
riflessione sull’evolversi delle discipline scientifiche. Tuttavia, mi sembra che si impongano alcune
considerazioni: soprattutto a proposito dello sviluppo delle scienze dell’educazione a cavallo tra i
due secoli, ‘800 e ‘900.
In questo periodo assistiamo a un farsi carico da parte della scienza del tema dell’educazione.
Significativo, a questo riguardo, l’esempio di Maria Montessori, una delle più prestigiose
pedagogiste, la quale è medico e lavora nell’Università di Roma, in quell’Istituto che oggi è
diventato il Dipartimento di Scienze psichiatriche.
La Montessori, benché pratichi la medicina in quello che non è ancora l’Istituto di Psicologia,
ma che poi lo diventerà, con Labriola a ciò contrario, mette a punto un concetto di educabilità,
radicato su fondamenti biologici, come quelli da lei definiti di “età sensitive”. Da un contesto
scientifico naturale emerge la proposta e l’esigenza di educare chi potrebbe sembrare quasi un
“animale” (perché tale era considerata la persona che nasceva incapace, disadattata, con anomalie
o disturbi del comportamento). Maria Montessori ne sostiene l’educabilità, quasi
contrapponendosi alle concezioni filosofiche prevalenti. Dunque, la proposta educativa radicata su
nuove scoperte scientifiche sembra porsi in discrasia con la filosofia dell’educazione o con la
pedagogia filosofica del tempo.
Una seconda considerazione si riferisce alle concezioni generali espresse da Labriola a proposito
dei popoli che sono presenti sulla scena dell’epoca. Il professor Sasso ha giustamente osservato che
il pensiero di Labriola è eurocentrico, un atteggiamento che si spiega alla luce del suo hegelismo e
dunque alla luce della concezione della storia che ne deriva. Se si pensa, in particolar modo,
all’idea di paesi definiti come popoli attivi e popoli passivi, come soggetti storici e al fatto che la
Russia è considerata passiva, vien fatto di osservare che proprio quella Russia sarà soggetto di una
rivoluzione socialista, anche se ciò avverrà in modo inefficace nei tempi lunghi.
Tra l’altro, proprio sul suolo e nello sfondo culturale russo, viene attuato un tentativo di
rifondazione delle scienze dell’educazione che investe sia l’elaborazione teorica sia la
progettazione pratica di contesti educativi. Questa rifondazione avviene in una prospettiva
marxiana e non marxista. Studiosi come Pavel Blonskij o Lev Vygotskij, adoperano la dialettica per
creare un’antropologia marxiana, una scienza del soggetto umano della storia e non del vivente
(come in una prospettiva evoluzionistica darwiniana, extraeuropea, quale emergeva dalla proposta
comportamentistica). Questi autori, in rischioso dissidio con l’ideologia ufficiale, che aveva
identificato nella fisiologia pavloviana la teoria materialistica della conoscenza, teorizzano la
coscienza come cellula genetica che sta a fondamento dell'educazione.
La co–scienza è, secondo queste prospettive, essere e sapere condiviso: i presupposti
psicopedagogici sono presupposti ontologici, si potrebbe affermare. È ciò che oggi si definisce
“zona di sviluppo prossimale”: non si sviluppa l’Io senza l’altro, che diviene l’educatore. In
termini filosofici il soggetto dell’educazione è collettivo, la cultura, lo stato, è ciò che sta inizialmente
fuori, è esterno al discente, sono le strutture che stanno fuori, che fanno da impalcatura portante allo
sviluppo psicologico individuale a generare l’educazione, anche in senso negativo,
interdisciplinare perché delegata all’insieme anche casuale di scienze che regolamentano e
assicurano il cosiddetto vivere civile.
Proprio la consapevolezza di questo intreccio complesso che è lo sviluppo umano è ciò che,
quasi tragicamente, sembra mancare nella riflessione filosofica dell’epoca e che è invece presente
nelle elaborazioni psicologiche della Russia in epoca rivoluzionaria.
Nicola Siciliani de Cumis: Per Labriola il problema della interdisciplinarità è presentissimo,
basta rileggere L’Università e la libertà della scienza, per averne conferma immediata. Tuttavia, egli è
molto prudente prima di concedersi alle esigenze di un incontro con altre discipline e lo fa sempre
dall’interno di un processo faticoso, lento, storico, “morfologico”.
Dell’intervento di Maria Serena Veggetti mi colpisce il fatto di aver spostato il discorso sul dopo
Labriola, sul mondo dei dopo–Plekhanov, per intenderci. Plekhanov, un autore che Labriola
maltratta. Labriola risente di tutto il peso culturale che si porta dietro, molto raffinato, molto
complesso e variegato nelle sue componenti culturali. Il che non gli consente di accettare un
meccanicismo, quello che lui ritiene sia una posizione tipo. In particolare verso la Russia, dicevo
prima con una battuta, Labriola è severissimo. Egli vede la Russia come il prototipo dei paesi
passivi dove ancora tutta una serie di stadi necessari non sono stati attraversati, per cui anche i
suoi intellettuali lasciano il tempo che trovano. Verso Tolstoj ha delle parole durissime. Ecco la
prova dell’eurocentrismo di Labriola. La boria delle nazioni, di vichiana memoria, ce l’ha pure nei
confronti di tutti quegli intellettuali che non rientrano nel suo schema, nel suo quadro. Così, nei
confronti di Tolstoj, e siamo proprio in presenza di una pedagogista del tipo di quella che tu citavi,
la Formiggini Santamaria a cui lui fa una prefazione, alla fine viene fuori un giudizio pesantissimo.
So benissimo che Tolstoj è molto più complesso degli schemi che gli si affidano. Tuttavia, per
capire Labriola è molto importante quel discorso e, se prendiamo gli scritti politici, il tema del
papuano ritorna più volte, in forme diverse, in forme anche camuffate. Però c’è, perché è la
mentalità sostanzialmente hegeliana di Labriola, che obbliga a stare al passo della storia, a fare
della storia al massimo l’ostetrico, ad aiutare cioè i processi che già sono avviati; ma se i processi
non hanno già le loro radici e i loro inizi essi non sono degni di essere presi in considerazione.
Dario Ippolito: Io mi occupo di storia moderna e, quindi, parlo di Labriola come semplice
lettore. Vorrei tornare sul rapporto tra filosofia della storia e metodo che mi pare corrispondere
all’altra diade dogmatismo e critica, che è stata citata prima. Colgo l’invito del professor Siciliani a
distinguere fra i testi di Labriola, in questa prospettiva. Mi pare che siano molto diversi, per
esempio, il primo dei saggi e il secondo. In memoria del manifesto è un testo che ha più l’aria più di
un discorso politico. Il professore sottolineava il discorso sul tono e sullo stile. Si tratta, infatti, di
un discorso molto enfatico, molto perentorio, ridondante, che punta a convincere e a costruire una
prospettiva politica, una robusta dottrina per il movimento operaio. In questo testo, dunque,
prevale l’aspetto del dogmatismo.
Il secondo saggio, invece, è più articolato, è un discorso aperto in cui Labriola afferma che il
materialismo storico va praticato, non va teorizzato, dopo averlo appunto teorizzato il quel saggio
importante, nel quale perviene forse a delle conclusioni molto vicine a quelle dell’Ideologia tedesca
(che non conosceva, perché era un manoscritto ancora inedito). Tuttavia, anche nel secondo saggio,
nonostante esso sia sicuramente raffinato, articolato e tenda a proporre il materialismo storico
come metodo di interpretazione della storia, compare l’espressione “filosofia della storia”. E Croce,
quando interverrà, sarà costretto in fondo – per sottacere le distanze con Labriola – a passare sotto
silenzio questo elemento, perché egli tende a vedere il materialismo storico non come una filosofia
della storia.
Anche a proposito del problema dell’aggettivo morfologico mi sembra che compaia in Labriola
l’espressione «previsione morfologica» e non cronologica. Secondo me ciò avvalora l’idea che
Labriola pensasse ad una previsione scientifica, naturalmente non collocabile nel tempo, ma a una
previsione basata sull’esperienza storica. Quindi, questi due aspetti del pensiero di Labriola, che
sicuramente sollevano un problema, sono secondo me una spia dell’atteggiamento intellettuale
complessivo. Se Labriola sia più in sintonia con una prospettiva o con l’altra, emerge dal modo in
cui nel terzo saggio si pone a confronto con il Capitale (e questa rappresenta sicuramente la parte
più debole della riflessione di Labriola su Marx, assolutamente inconsistente). Qui si vede come,
dopo l’intervento di Croce, che era già intervenuto con una famosa nota a piè di pagina in cui
aveva espresso un’idea che poi svilupperà e che sicuramente sarà uno dei contributi maggiori della
riflessione italiana allo studio del Capitale, Labriola non avrà argomenti, però difenderà
ugualmente il Capitale. Utilizzerà un escamotage retorico, molto debole: affermerà che le
contraddizioni del primo e del terzo libro non sono dell’opera ma della realtà; l’opera riflette la
realtà.
Difendere una posizione anche senza avere nessun argomento mi sembra tipico di un
atteggiamento dogmatico. Mi pare che, nell’intervento del professor Sasso, si tendesse a suggerire
proprio che un limite nello sviluppo del marxismo di Labriola fosse questo nocciolo di
dogmatismo.
In fondo ciò emerge dal fatto che, nel momento in cui Sorel e Croce cominceranno a sviluppare
una critica molto radicale, Labriola entrerà in crisi. Infatti, dopo il terzo saggio egli avrà molte
difficoltà a portare avanti la propria riflessione. Probabilmente, quindi, complessivamente domina
questo atteggiamento di adesione fideistica alla dottrina di Marx, piuttosto che il proseguimento
critico, che pure aveva auspicato e programmato nel secondo saggio.
Gennaro Sasso: Io credo che questo non sia un atteggiamento dogmatico. Piuttosto, in questo
caso bisogna cogliere la tonalità della polemica di Labriola con Croce in particolare per quanto
riguarda il problema del Capitale. Si deve insistere su un altro aspetto: il ricorso anche a una certa,
lei dice, retorica dipende dal fatto che Labriola è effettivamente in grande sofferenza nei confronti
di se stesso, quindi il suo è tutt’altro che un atteggiamento dogmatico. Quello che si esprime nella
parola non corrisponde effettivamente a quello che Labriola sentiva. E questo, per una ragione che
io credo sia effettivamente fondamentale. Anche per merito o per demerito, se vogliamo dire così,
di Labriola il marxismo italiano è stato essenzialmente un marxismo filosofico. Ma il marxismo
non è semplicemente filosofia, il marxismo è economia politica, per dirla volgarmente. Il Capitale è
una critica dell’economia politica, una grande e complessa opera che richiede competenze che non
sono assolutamente quelle del filosofo, il quale, se legge il Capitale, può trovare molte suggestioni,
ma poi di fronte a nodi e passaggi della dottrina economica si trova in difficoltà. Senza alcun
dubbio Labriola non ha avuto né la pazienza, né l’attitudine a farsi questa dottrina economica che
lo mettesse in condizioni di capire “dal di dentro” il Capitale, di persuadersi delle dottrine del
Capitale in modo criticamente soddisfacente per se stesso. Qui sta il punto della questione: il modo
in cui Labriola vive la crisi del marxismo è un modo psicologicamente molto sofferto e spiega
molti dei suoi scatti polemici e anche il maltrattamento a cui sottopone tanti personaggi, a
cominciare dal suo stesso giovane amico, Benedetto Croce. Per questo richiamavo prima
l’attenzione su questo punto, che a me pare sia effettivamente importante, non soltanto per
Labriola, ma anche per il pensiero successivo, Gramsci compreso, a mio modo di vedere.
In Italia mi sembra ci sia una certa distinzione tra coloro che studiano Marx economista,
diciamo così volgarmente, e quelli che lo studiano come filosofo, o come storico–filosofo, o come
scienziato sociale, che è cosa diversa. Insomma la tecnica, la filologia economica di Marx richiede
una competenza particolare che, a mio modo di vedere, per quello che io ho capito, Labriola
probabilmente non possiede. Forse, egli era affaticato, sentiva nascere dentro di sé la malattia che
poi lo avrebbe condotto alla morte molto presto, ed è probabile che questo lo rendesse
particolarmente inquieto e insofferente. Di un personaggio che scrive come scriveva Labriola, che
si esprime come si esprimeva Labriola, non possiamo non cogliere un aspetto psicologico
predominante per capire il temperamento dell’uomo. Forse è la paura di non aver più saldamente
il terreno sotto i piedi che lo rende così polemico.
Nicola Siciliani de Cumis: Sono essenzialmente d’accordo con il professor Sasso. Tuttavia,
vorrei aggiungere qualche precisazione, a cominciare dal tormento, non solo psicologico ma anche
culturale, filosofico, che accompagna la costruzione dei saggi. Credo che l’unica cosa da fare per
averne la misura è rileggere il carteggio con Croce. Lo scontento di Labriola, certo, si riversa anche
su Croce; ma prima di tutto si tratta di uno scontento verso se stesso, di una difficoltà, una fatica a
costruire i propri pensieri che è evidente; anche perché la fatica non è solo un fatto culturale, è un
fatto di rapporto con la realtà. In altre parole, diversamente da Croce che tende a sistemare una
volta per tutte il suo rapporto con la logica, con l’utile, con gli altri, per Labriola le varie
dimensioni sono sempre in circolo, sono mescolate, pasticciate, perché il vero punto per lui è il
problema della realtà storica e politica, le contraddizioni del mondo.
Ecco perché insisto sulla differenza tra i vari saggi, la differenza di tono, la differenza di
temperatura e di rapporto con la realtà che chiariscono da un lato la questione della previsione
morfologica dall’altro anche le oscillazioni e tensioni interne. In questo senso, se il marxismo entra
in crisi, questo non è un fatto deciso a tavolino da alcuni intellettuali. Ci sono evidentemente
alcune ragioni storiche e politiche che esigono in qualche modo la crisi di certi schemi mentali. Gli
intellettuali fanno i conti con questo discorso, per cui non dobbiamo dare troppe responsabilità né
ai professori universitari, né ai liberi pensatori, come fossero loro a decidere a casa, nel loro studio,
che cosa deve succedere nel mondo. Il problema è che nel mondo succedono lo stesso tutta una
serie di cose e si stabilisce infatti una specie di andirivieni tra le modalità di ricezione di quello che
succede nel mondo e le obiettive novità storiche che succedono nel mondo; ne risulta un rapporto
critico che è consegnato nei testi, ma i testi sono testi e in qualche misura, se sono intelligenti, sono
anche contraddittori, sbilanciati, squilibrati, aperti sulle varie dimensioni della realtà.
Stefano Miccolis: A me sembra che vada sottolineata, per quanto possibile, l’affermazione fatta
dal professor Sasso: che la posizione di Labriola è eurocentrica. Diversamente da quella di Marx e
Engels, questo è il punto. È eurocentrica come è eurocentrica la cultura dell’800. Questo è un dato
fondamentale per capire anche la sua posizione nei riguardi della politica estera. Perché, non se ne
è fatto cenno, ma Labriola si è occupato parecchio di politica estera, già quando aveva idee
moderate – ne scrive almeno in forma privata. Pubblicamente già alla fine del 1890 egli assume
una posizione precisa nei riguardi del problema delle colonie. Non si capirebbe altrimenti la
possibilità che egli vede di un esperimento di socialismo pratico. Aggiunge che ci sono terre che
non hanno diritti acquisiti. Questo è un punto di vista specificamente eurocentrico, non c’è alcun
dubbio.
Il suo punto di vista è identico anche nel 1896, quando scoppia la questione, diremmo oggi,
d’Oriente, la questione balcanica. Labriola vuole che si arrivi alla dissoluzione dell’Impero
Ottomano, alla libertà di Creta. Prende così una posizione molto netta. Il socialismo italiano si
spacca, ma lui non ha dubbi: proprio perché i turchi sono turchi micidiali e la Grecia è invece la
culla, una delle radici fondamentali della cultura europea. E così la sua presa di posizione nei
confronti della questione polacca, ad esempio, che diventa scottante nel 1896: al Congresso
dell’Internazionale Socialista di Londra si cerca di affrontarla. Labriola è per l’indipendenza
nazionale della Polonia, ancora una volta – qui giocano sia le sue radici ideali risorgimentali, ma
anche quella visione per cui ci sono popoli attivi, popoli passivi. I popoli attivi, quelli che
conducono la storia, devono adoperarsi per recuperare la dimensione attiva, anche le popolazioni
più vitali (lui usa questo termine). La sua posizione, come peraltro quella di Marx, pone al centro
la visione della storia dell’Europa post–industriale: per cui il riscatto e l’emancipazione del
proletariato sono possibili soltanto all'interno del massimo sviluppo al quale deve giungere la
borghesia. Labriola, su questo, la pensa in maniera costante, fino all’ultimo.
Direi poi che, fermo restando i problemi, che indubbiamente ci sono, di carattere teorico, non c’è
dubbio – qualcuno lo ha già detto – che dal secondo saggio in poi c’è una maggiore vivacità
interna. Il dramma, la malattia giunge nel ‘96 e precipiterà nei primi anni del ‘900. Così pure non
va dimenticato che è terminato quel rapporto intenso che Labriola ha avuto con Engels fino al ‘95.
Egli, dopo il ‘95, è anche più libero, più autonomo, più consapevole.
Nel secondo e nel terzo saggio, insieme alla sofferenza, che è stata giustamente sottolineata, ci
sono degli squarci di lucidità intellettuale che vanno apprezzati. Labriola intuisce, fin dal 1896, che
la politica mondiale, il mercato mondiale si sta spostando dall’Atlantico al Pacifico e sostiene che ci
sarà una lunga pausa per il socialismo. Labriola lo afferma fin dal 1896 e lo ripete negli anni
successivi, assumendo un atteggiamento realistico nei confronti della politica sia interna che estera.
Negli ultimi anni Labriola esprime delle posizioni politiche interne che oggi definiremmo
riformistiche e invita i socialisti ad accettare quello che è realisticamente possibile.
Inoltre, questa giornata mi pare abbia messo in luce diverse questioni, ma forse ne ha sottaciuta
un’altra: cioè l’atteggiamento di Labriola nei confronti del problema del rapporto fra Stato e
Chiesa. Va detto che questo è stato uno degli elementi fondamentali della sua riflessione, fino
all’ultimo. Egli era convinto, non diversamente da Silvio Spaventa, con il quale spesso si trovava
molto d’accordo, che il contrasto fra Stato e Chiesa fosse addirittura un elemento positivo per la
modernizzazione dell’Italia e quindi ha sempre avuto questo tipo di atteggiamento non ideologico,
non materialistico. Lo ripete anche nei suoi saggi. Non è che egli si opponga alla religione o alla
chiesa in quanto istituzione religiosa. Piuttosto, ritiene che sia addirittura dovere, diritto, della
borghesia italiana – aggiunge anche nel terzo saggio – di assumere un atteggiamento fermo nei
riguardi della possibile clericalizzazione. Perché è in questo che egli vede la possibilità della
modernizzazione dell’Italia. Quello che avrebbe voluto, è che lo Stato assumesse una funzione
attiva per la diffusione di quelli che egli chiamava i nuclei della estensione della cultura e per
l’elevazione del popolo al livello della classe dirigente.
Quindi, non deve sorprendere l’aneddoto così brusco raccontato da Croce. Mi sorprende invece,
come diceva prima la professoressa Veggetti, che Labriola sia stato contrario all'Istituto di
Psicologia. Labriola, infatti, si è battuto personalmente, anche magari per amicizia con Patrizi,
perché Sante De Sanctis avesse la libera docenza in Psicologia sperimentale presso la facoltà di
Lettere e Filosofia. Egli era convinto che questo fosse positivo dal punto di vista culturale.
Gennaro Sasso: Ringrazio molto il professor Miccolis, che è un esperto di studi su Labriola.
Chiedo se ci sono ancora interventi. Grazie della vostra presenza, dei relatori, naturalmente, di
coloro che sono intervenuti. L’appuntamento è per domani mattina alle nove.
Nicola Siciliani de Cumis: Ieri a più riprese, a cominciare dalla mattina in Campidoglio con la
lezione del professor Tessitore, sono affiorati alcuni problemi. Il primo problema, quello della
“continuità”, ovvero della “sussultorietà” della formazione di Antonio Labriola: una questione che
ha una storia, da Croce a Garin, ad altri interpreti. Per esempio Mastroianni. Ma si aggiunge
un’altra domanda sulla fortuna, sulla attualità o meno di Labriola oggi. Continuità e discontinuità
della fortuna di Labriola; della fortuna o meno del tema della formazione, anche in rapporto alla
formazione. Che cosa vuol dire? Non vuol dire certamente che Labriola cambia a seconda della
domanda di pubblico, vuol dire piuttosto che Labriola è un pensatore legato strettamente ai
movimenti, legato alla ricerca scientifica, non alle carriere universitarie, alle riflessioni di questo o
di quell’altro intellettuale, è legato ai partiti, è legato al modo di vedere i movimenti della società.
Ora, siccome c’è oggi una temperie evidentemente diversa dal punto di vista storico e sociale,
questo fatto interferisce anche sulla recezione di Labriola. Basti riflettere sulle conseguenze della
implosione dell’URSS. Il discorso su Labriola si è interrotto, è anche esso imploso.
C’è tuttavia un lavoro perdurante, continuativo, sotterraneo, che oggi, in occasione del
centenario della morte di Labriola si autopromuove. Il libro di Ignazio Volpicelli su Herbart e i
suoi epigoni rientra in questo quadro; e Giacomo Cives, Bruno Bellerate, Giuseppe Spadafora ed io
stiamo qui a testimoniarlo. A maggior ragione oggi che viene a riproporsi il tema della continuità e
della discontinuità nella formazione di Labriola, perché Herbart e gli herbartiani sono parte
esenziale del problema. Quale, in altri termini, il ruolo dello herbartismo di Labriola nel quadro
del suo hegelismo? C’è un nesso tra la “curvatura herbartiana degli anni Settanta–Ottanta e la
successiva scelta del materialismo storico? Questa domanda a parte, a me sembra che Volpicelli
abbia costruito un importante dossier critico. C’erano poche cose sistematiche, filologicamente
accurate sugli herbartiani d’Italia (a partire da un antico scrittarello di Alessandro Casati); ebbene,
è certo un merito di Volpicelli avere documentato e scavato in profondità, avere intravisto strade
nuove e invitato a percorrerne di diverse.
Quanto a me, gli sono particolarmente grato perché per una strada tutta sua, da quello studioso
indipendente e maturo che è, Volpicelli ha realizzato quel progetto che io avevo solo intravisto
tanti anni fa, quando nelle biblioteche di Heidelberg e di Francoforte, cominciai a raccogliere i testi
degli herbartiani ora egregiamente indagati dal collega, nel ricordo anche della lezione di Augusto
Guerra cui Herbart e i suoi epigoni non sarebbe certo dispiaciuto.
Ma pregherei Bellerate di volere intervenire, lui studioso di Herbart avrà certo cose interessanti
da dire…
Bruno Bellererate: Sono già state dette molte cose di varia importanza, con tagli diversi e con
puntualizzazioni particolari, nella presentazione del libro di Ignazio Volpicelli.
Io esporrò qualche considerazione generale e, specialmente, sotto il profilo, informativo. È già
stato detto che il libro di Volpicelli è opera di un esperto, di uno che da anni sta studiando Herbart,
ne traduce opere, e adesso più direttamente si è dedicato anche allo herbartismo, cioè alla scuola,
che si è formata al suo seguito e si è radicata, sia pure con caratterizzazioni diverse, in vari paesi.
Però, se voi vedete questo libro, il cui titolo è Herbart e i suoi epigoni, poi lo sfogliate e guardate
l’indice, vi renderete conto che non parla degli herbartiani, per esempio, degli Stati Uniti, dove
pure hanno svolto un rilevante ruolo, ma non perché li ignori (infatti Ignazio Volpicelli ha scritto
un saggio proprio su gli herbartiani degli Stati Uniti), ma perché qui si è dedicato agli herbartiani
solo in seconda battuta, subordinatamente, dopo essersi impegnato in un’analisi accurata degli
scritti di Herbart stesso. E questo nonostante che, in partenza, giustifichi il rinnovato interesse per
questo ambito di ricerca.
Quindi questo libro è il risultato di un’indagine, di una puntigliosa indagine fatta da un esperto,
che aveva le mani in pasta, che sapeva dove trovare le fonti, esplorate con attenzione; e il testo è
una palese testimonianza di questo, non soltanto per la preziosa bibliografia finale, magari
neppure del tutto utilizzata nel testo, perché va ben al di là di quello che ne è il contenuto, ma
soprattutto per le innumerevoli citazioni, precise, poste in nota al testo stesso. Esse forse
appesantiscono un po’ la lettura, specialmente per i non addetti ai lavori, ma testimoniano
appunto l’accuratezza della ricerca, indubbiamente lunga, che l'autore ha condotto su questa
materia.
Ribadisco perciò, dal momento che è già stato detto, che questo è un libro, che riempie una
grave lacuna, in Italia, dove si è scritto abbastanza su Herbart nei primi decenni del secolo scorso,
poi c’è stato un vuoto, finché il sottoscritto, stimolato, da un suo docente (a me non piace usare il
termine “maestro”), che aveva studiato Herbart prima di me, vi si è dedicato anzitutto con la
pubblicazione di un volumetto, molto citato, perché più reperibile, ma assai meno valido di altri
libri usciti dopo, sebbene poco citati.
Mi sono così impegnato, per vari anni, nello studio di Herbart, perché una volta che uno viene
in contatto con un autore e vi si consacra con dedizione, ne rimane poi, per dire così, fagocitato,
viene del tutto coinvolto; e allora, finchè non arriva a certi obiettivi, continua a lavorare su di lui,
anche per parecchio tempo. A un certo punto però si ha voglia di dire basta, com’è successo a me.
Ma invece no, perché qualche amico, come il qui presente Volpicelli, ogni tanto mi dice: “Perché
non mi fai un articoletto?” e, troppo spesso, non si sa dire di no. Forse, bisognerebbe dire no
qualche volta in più: è importante saper dire di no.
Questo pregevole saggio riempie, dunque, un vuoto rilevante da noi, soprattutto per quel che
riguarda lo herbartismo, oltreché per la disamina di scritti particolari di Herbart (non tutti!),
perché, come ho detto, su di lui c’erano già stati degli studi, che ne avevano delineato globalmente
un profilo, analizzato il pensiero nel suo insieme e, magari, individuato il peso che questa filosofia,
anche se combattuta, anche se oggetto di aspre polemiche in certi momenti storici (non ultimo
quello degli anni 60, anche in Italia), da parte di professori tedeschi e non. Ricordo soltanto, a titolo
d’esempio, il professor K.G. Fischer, che ha scritto un articolo su «Scuola e città» contro Herbart,
come portabandiera del conservatorismo, senza tentare di comprendere le ragioni dei suoi
comportamenti. E questo perché, come diceva prima Nicola Siciliani De Cumis, quegli anni erano
anni animati da una verve ideologica, assai pesante, per cui chi rientrava nell’ambito della propria
ideologia, era come un amico, uno da giustificare, era uno d’appoggiare ecc.; chi invece non
rientrava in essa, doveva essere bersaglio di critiche, più o meno valide (a volte anche valide,
perché nessuno è perfetto, tutti abbiamo dei limiti e quindi c’è sempre la possibilità di criticare
chiunque), ma spesso e volentieri le critiche non erano molto fondate.
Così è capitato pure a Herbart, non unico e non ultimo. Prima, sempre Nicola, diceva che anche
Makarenko ha avuto una sorte analoga e, come questi, altri autori, perché ci sono i momenti di
esaltazione, direi, supportati da situazioni o condizioni storiche consone, che mitizzano un autore,
magari in modo sbagliatissimo, come è successo a Makarenko appunto (a Herbart un po’ meno).
Makarenko è veramente un emblema, da questo punto di vista: i comunisti ne hanno fatto un
idolo, per un certo periodo, ma un idolo non era, non c’entrava quasi niente con quanto dicevano e
poi c’è stata la caduta, c’è stato un oblio generalizzato. Oggi l’unico, che, in Italia, in vari modi si
occupa di Makarenko è Nicola: glie ne do atto.
In ogni caso, io sono contentissimo che Nicola continui in questa ricerca che non è facile, anche
se oggi è agevolata dal crollo del muro di Berlino, per cui archivi prima inaccessibili, ora lo sono.
Insomma abbiamo qui un rappresentante di indirizzi e di orientamenti che purtroppo non hanno
goduto di sufficienti spazi negli studi pedagogici o che hanno subito un crollo con l’andare del
tempo e con le situazioni culturali che si sono oggi imposte.
Ho detto che il libro di Volpicelli riempie una grossa lacuna soprattutto nei confronti dello
herbartismo, ma debbo aggiungere che il libro è una miniera: è una miniera non solo sotto il
profilo bibliografico, ma perché richiama figure di autori, di pensatori nostrani, dimenticate anche
dagli italiani, e dà molto spazio agli epigoni herbartiani; e fra gli italiani naturalmente occupa un
posto centrale Labriola (che è stato l’occasione per questo incontro). Labriola, che, come già
accennato, è passato attraverso un momento herbartiano nella sua vita.
Ecco, questo è un altro spunto di cui mi sento di dover approfittare: il fatto che uno cambi
orientamento, che cambi idee, che passi da una filosofia ad un’altra. Questo non è, secondo me, un
sintomo di debolezza, un sintomo di non so che o di volubilità o di cose di questo genere. Esso è
un sintomo di coraggio: ci vuole coraggio per cambiare bandiera, diciamo così. Ma, al di là del
coraggio, tale decisione si colloca anche nella linea di quella che oggi è stata molto decantata,
divulgata, sbandierata: la cosiddetta educazione permanente, che in tanto è permanente ed è
educazione, in quanto non può non comportare dei cambiamenti, dei mutamenti, più o meno
consistenti, più o meno significativi, secondo le situazioni, le circostanze o le esigenze culturali,
sociali o di altro genere.
Anche Labriola perciò è entrato in questo processo: e tutti, secondo me, dovrebbero entrare in
questo prospettiva, se non vogliono diventare mummie, se non si estraniano, se non si rendono
così passivi di fronte alle situazioni, di fronte ai mutamenti politici, sociali, culturali o di altro tipo,
da non essere in grado di adattarvisi e quindi, se opportuno, di cambiare anche concezione rispetto
a quella che avevano prima. Oggi, direi che l’educazione permanente, frutto di riflessioni teoriche
soprattutto, è un flatus vocis più che un fatto ricorrente, diffuso e concreto e, spesso, i cambiamenti
di posizione sono dettati da opportunismo e da convenienza di vario tipo.
Tuttavia questa digressione mi induce a un richiamo che voglio fare, dal punto di vista della
metodologia della ricerca, della ricerca storica. Secondo me, è importante che, studiando un autore,
o un movimento, o un’epoca, si tenga conto accuratamente di tutte le variazioni avvenute, grazie
all’evoluzione storica, a nuovi incontri o apporti, alla successione e all’ordine degli scritti e così via.
E questo è importante, perché ciò che è stato detto e sostenuto a un certo momento della propria
vita (e io lo potrei dire di me stesso e sono perfettamente consapevole sia di quello che ho detto e
scritto in certi tempi, sia di quello che sto dicendo e dico ora), essendo appunto ognuno di noi, di
diritto se non di fatto, soggetto ad una evoluzione, dal punto di vista educativo, pedagogico,
rappresenta un passo, nel tempo, di una crescita umana; e la crescita umana, come ogni altra,
comporta naturalmente l’abbandono di certe elementi per l’acquisizione di altri. Di fatto,
nell’uomo, anche la crescita biologica comporta questo: adesso io non ricordo quante migliaia,
milioni di cellule noi perdiamo giorno per giorno, che vengono sostituite da altre. Questa è la vita,
questo è ciò che effettivamente dà sugo, dà senso, al divenire reale di un qualsiasi essere vivente.
Chiudo la parentesi e non mi dilungo oltre, per quanto tale riflessione sia importante.
Allora dicevo, quello di Ignazio Volpicelli è un libro estremamente meritorio, a mio avviso:
estremamente meritorio, perché appunto è andato, per primo, dopo molti anni, a scavare in
miniere che erano state abbandonate, ha riportato alla superficie informazioni, dati, che sono non
solo utili, ma, talora indispensabili per chi affronta storicamente lo studio di Herbart e del suo
pensiero.
Tuttavia, forse Ignazio me lo consentirà, quello che è mancato un pochettino è stato lo sviluppo
nella trattazione di talune tematiche tipicamente herbartiane e alcune, direi, più dei suoi epigoni
che non di Herbart stesso, come quella dei “gradi formali” o la loro interpretazione del suo
pensiero, non senza polemiche (nei cui confronti tuttavia Ignazio non si è pronunciato e non so che
cosa pensi).
Comunque alcune di queste tesi degli herbartiani e di Herbart stesso, secondo me, hanno un
ruolo significativo nella contestualità culturale del tempo e anche di oggi, per quello che riguarda
la nostra scuola, per esempio. Infatti molte delle strategie scolastiche, indicate da Herbart e dagli
herbartiani, a mio avviso, dovrebbero trovarvi posto e qualcuna lo ha trovato, per ragioni diverse
(come le “unità didattiche”) e non certo per discepolato di Herbart. Altre indicazioni di questo
genere, le potete trovare molto ben chiarite, specificate, nel libro di Ignazio, che però non ne
approfitta per sviluppare considerazioni critiche sulla nostra scuola. In compenso, per così dire,
l’Autore si mostra un po’ troppo esigente nei confronti dei lettori, che, per esempio, nella
stragrande maggioranza, non conoscono il tedesco.
Il valore del libro (ci torno!) è più che rilevante anche perché, come detto, riporta alla luce
figure, momenti e osservazioni, che erano passate, direi, sotto traccia nella stessa storia della
filosofia e della pedagogia, come Bonatelli, che è già stato nominato, Tocco, Nova e poi l’origine
dello herbartismo in Italia, che lui è andato a ricercare, trovando persino delle assonanze tra
Romagnosi e Herbart, sebbene non risulti che Romagnosi lo abbia letto.
Purtroppo la pedagogia, all’interno di questo discorso, per necessità di cose, è rimasta un po’ da
parte, mentre hanno avuto più spazio tematiche di tipo filosofico. D’altronde, lo stesso sottotitolo
del saggio dice: “Genesi e sviluppo di una filosofia dell’educazione”. Non va comunque
dimenticato che, se ha avuto più spazio il discorso filosofico e persino psicologico, ciò è certamente
dovuto anche al fatto che Herbart, da un lato, si è sempre ritenuto filosofo e, dall’altro, è stato un
po’ all’origine della psicologia. Tantissimi lo sanno, per quanto pochissime volte venga citato nelle
storie della psicologia. In realtà, ha avuto idee molto interessanti in merito e Ignazio lo sa
benissimo e se volete lo potete constatare.
La pedagogia invece ha trovato più spazio negli herbartiani anche italiani, all’interno del
pensiero di uno Spaventa o Labriola e di altri autori, tra cui lo stesso Luigi Volpicelli, per non dire
di Credano, che hanno cercato di utilizzare la concezione herbartiana per quello che ne era
l’apporto nell’ambito pedagogico.
Concludendo, a mio avviso, questo libro segna una pietra miliare nella storia del pensiero
pedagogico in genere, ma soprattutto per quello che riguarda Herbart e lo herbartismo; e farei un
augurio a Ignazio, se me lo consente: dopo tutti gli studi che ha fatto su Herbart e adesso anche su
lo herbartismo, di riuscire a pubblicare, al più presto, un saggio che sarebbe, forse, o quasi o
proprio definitivo su Herbart e lo herbartismo stessi, non solo in Italia ma nel mondo.
Grazie per la vostra pazienza.
Nicola Siciliani de Cumis: Ringrazio Bruno Bellerate, ma farei alcune sottolineature, anche se
telegraficamente. Volpicelli si assume la responsabilità di svolgere monograficamente alcune
dimensioni del problema. Ma va al di là di ciò. Egli redige, infatti, una bibliografia che rompe gli
schemi. Faccio un esempio. Si è citato Herbart negli Stati Uniti d’America, ma accade pure che
facendo una ricognizione di tutti i luoghi che emergono dalla bibliografia, si potrebbe scrivere un
vero e proprio saggio su Herbart e i suoi epigoni nel mondo. Io, per esempio, ho trovato degli
spunti molto efficaci, anche se non svolti, per i paesi slavi, per la Russia. Ma anche per l’Estremo
Oriente ci sono tutta una serie di indicazioni, per cui, riprenderei volentieri le indicazioni di
Bellerate oggi (e quelle di Serena Veggetti, ieri) per rivisitare le varie questioni herbartiane e
labrioliane alla luce anche della loro circolazione di tempo in tempo e nelle diverse culture.
Problemi come il rapporto tra filosofia e psicologia, hegelismo e neokantismo, determinismo e
indeterminismo, libertà e necessità, ecc. non potranno che trovare ulteriori, preziosi, elementi di
riflessione.
Darei quindi la parola al professor Spadafora.
Giuseppe Spadafora: Anzitutto, ringrazio Nicola Siciliani de Cumis per avermi invitato a
questa presentazione, anche perché non sono uno specialista di Herbart. Conosco invece molto
bene l’amico Ignazio Volpicelli e in particolare i suoi sforzi di filologo e di studioso di filosofia, che
ha intrapreso da tempo una analisi radicale del pensiero herbartiano e dello herbartismo, unendo –
come emerge chiaramente da questo suo ultimo lavoro – la sua capacità di filologo e di traduttore
esperto con la sua riflessione filosofica e pedagogica.
Il volume di Volpicelli è estremamente complesso, soprattutto perché, a differenza di molti testi
che si occupano delle influenze di un autore, egli è riuscito ad operare un confronto “in presa
diretta” tra le interpretazioni herbartiane e alcuni spunti specifici di Herbart. L’influenza di un
autore è spesso qualcosa di molto diverso dall’autenticità del suo pensiero. Sono emblematici, a tal
proposito, i casi di Dewey e di Gentile: il deweysmo è cosa diversa dal pensiero di Dewey, così
come l’interpretazione di Gentile e della sua “riforma” è cosa molto diversa dall’autenticità del
pensiero gentiliano.
Quando ho letto il titolo del volume di Volpicelli (Herbart e i suoi epigoni) pensavo che il testo si
occupasse, fin dall’inizio, degli epigoni di Herbart. Sennonché, come ha rilevato giustamente
Nicola Siciliani de Cumis, ci si trova di fronte ad almeno due libri. I primi quattro capitoli
costituiscono un’analisi molto attenta e acuta, filologicamente ineccepibile, dell’influenza di
Herbart nel nostro paese. A questo proposito, pensando in particolare a Spaventa e a Labriola, mi
chiedo se questi autori siano da considerarsi degli “epigoni” o, piuttosto, se essi non siano stati
influenzati in modo decisivo dallo herbartismo.
Gli ultimi due capitoli, invece, non solo contengono in nuce la possibilità di analizzare
l’influenza di Herbart nel mondo – è significativa a tal proposito la nota uno del sesto capitolo –
ma trattano nello specifico degli epigoni di Herbart, che in parte fanno proprio il pensiero del
maestro in modo quasi totale, in parte lo trasformano. Emblematico, a quest’ultimo riguardo, il
caso dell’Associazione per la pedagogia scientifica che sotto la presidenza di Ziller, per la prima
volta, unisce in un’unica associazione i pedagogisti e gli educatori con l’obiettivo di costruire una
nuova pedagogia, una pedagogia scientifica.
In altri termini, il volume di Volpicelli affronta due aspetti centrali dello herbartismo: il suo
ruolo fondamentale nell’ambito della cultura italiana e la sua diffusione nel mondo. In particolare,
per quanto riguarda l’influenza di Herbart, meriterebbe sicuramente di essere approfondito il
rapporto con Dewey.
Vorrei ora fare alcune riflessioni sulla fortuna herbartiana in Italia e sulla lettura che si può dare
dell’influenza di Herbart. Sarebbe interessante indagare il rapporto tra Gentile e Herbart perché,
secondo me, è una chiave di lettura per capire meglio il rapporto sia con Spaventa sia con lo stesso
Labriola. Gentile, infatti, ne Il concetto scientifico della pedagogia risolve la pedagogia nella filosofia
non certo riferendosi ai positivisti, alla filosofia spaventiana o al nesso Kant–Hegel – da cui trae le
radici della sua concezione attualistica – ma all’interpretazione di Credaro del pensiero
herbartiano. In questo scritto, che rimane probabilmente il testo più lucido sull’identità della
pedagogia, Gentile disegna due possibilità di fondazione della pedagogia riprendendole da
Herbart. La prima è quella dell’inevitabile risoluzione della pedagogia; vale a dire che la
pedagogia, come riflessione sull’educazione, si deve risolvere in qualcos’altro (nella filosofia, nella
politica, nella psicologia, nella sociologia). La seconda è quella dell’inevitabile antinomia della
pedagogia, vale a dire che la pedagogia è condannata ad essere antinomica. Questa posizione
nasce proprio dalla lettura gentiliana di un’interpretazione di Herbart.
Ancora in relazione al continuo rimando tra pensiero autentico e interpretazioni suffragate dai
testi, è fondamentale il rapporto tra Herbart e Spaventa. Spaventa, infatti, analizzando la
contraddittorietà del “dato” nello Herbart di Esperienza e Metafisica del 1888 e mettendo in rilievo il
pluralismo degli enti e la difficoltà di passare dal principio alle conseguenze, di fatto riceve da
Herbart un enorme patrimonio. Tuttavia, il debito fondamentale di Spaventa nei confronti di
Herbart è il passaggio – egli parla di “escogitazione” rispetto al modo in cui Herbart affronta il
problema dell’anima – dall’anima ente all’anima atto. Questa soluzione, fondamentale, ha offerto
alla linea Spaventa–Gentile la forza di costruire, di concretizzare l’atto di pensiero, di riformare il
trascendentale concretizzandolo. Il che trova, almeno in parte, le sue origini nell’influenza dello
herbartismo su Spaventa. In altre parole, l’influenza herbartiana su Spaventa – che forse non è
epigono di Herbart, ma deve ad Herbart la sua scelta – probabilmente è legata a questa
interpretazione che dà una visione di enti pluralistici nella realtà legati alla concretezza.
Dunque, Herbart, o meglio Herbart interpretato più che studiato nella sua autenticità, ha avuto
per Spaventa un ruolo fondamentale, come probabilmente lo ha avuto per lo stesso Gentile.
Gentile, tuttavia, non dichiara un rapporto diretto con Herbart... In effetti, quando studiavo
Gentile, mi ponevo proprio il problema del suo rapporto con Spaventa, chiedendomi come fosse
sorta in Gentile l’idea della concretezza dell’atto. Probabilmente, è sorta perché Spaventa ha
analizzato il problema alla radice. Per quel che riguarda Gentile, invece, quella idea sorge perché
egli, al pari di Dewey, si occupa direttamente dell’educazione. Quindi, la concretezza dell’atto, la
concretezza della situazione – che secondo me non è concreta, ma rimane chiusa nel luogo astratto
– nel caso di Gentile è dettata da questo sforzo di studio sul problema educativo. Nel caso di
Spaventa, invece, essa ha una filiazione diretta da Herbart. Il lavoro di Ignazio Volpicelli, grazie al
confronto “in presa diretta” con l’autenticità del pensiero herbartiano, chiarisce bene queste
questioni.
Su Labriola ho poco da dire perché mi sembrerebbe poco opportuno vista la presenza di Nicola
Siciliani de Cumis. Tuttavia, pongo un ulteriore problema. Nell’analisi dell’influenza herbartiana
su Labriola i testi maggiormente significativi sono Della libertà morale del ‘73 e Del’insegnamento
della storia del ‘76. Si consideri, ad esempio, il rapporto tra determinismo e libertà, che è un
rapporto centrale, un rapporto su cui, di fatto, si costruiscono i due paradigmi della sussultorietà e
della continuità della scelta labrioliana. Questa terza via, questa piena compatibilità tra una visione
essenzialmente deterministica e le aspirazioni a una forma di libertà tese a salvaguardare la
responsabilità etica dell’azione umana, sicuramente ha in Herbart un punto di riferimento
fondamentale.
Tuttavia, non riesco a capire – questa è la mia curiosità di lettore, non di specialista – quanta
interpretazione ci sia rispetto all’autenticità del pensiero herbartiano. Nel caso di Labriola credo
che il rapporto non sia stato chiarito fino in fondo. Sarebbe estremamente interessante e
affascinante intraprendere un lavoro sullo herbartismo in America. A mio parere, infatti, lo
herbartismo ha dato molto al pragmatismo americano soprattutto per ciò che riguarda la questione
del dato, la questione della particolarizzazione dell’ente nella situazione specifica. L’occasione per
un approfondimento potrebbe essere il convegno mondiale su Dewey che sto organizzando per
l’anno prossimo. Nel volume di Volpicelli appare in nuce proprio questo enorme lavoro
sull’influenza di Herbart nel mondo e, in particolare, nel mondo della pedagogia.
Probabilmente la fortuna enorme di Herbart, specialmente nella versione zilleriana, è legata al
fatto che egli affronta direttamente il problema didattico e il legame tra l’esito dell’educazione
(un’educazione che si basa sui valori religiosi) e la gradualità del discorso didattico (qui c’è il
problema filosofico della autorappresentazione, dell’autoconservazione della massa appercepiente,
della massa percepita). Emerge in Herbart l’attenzione per una didattica legata sia alle materie –
oggi potremmo dire ai curricula – sia alla formazione; c’è una stretta connessione tra la gradualità
del discorso didattico e il modello di formazione che ne consegue. Anche Gentile fa un’operazione
simile relativamente all’insegnamento della filosofia. Pertanto, sarebbe interessante analizzare
anche il rapporto tra Herbart e Gentile.
In questo senso, il volume di Volpicelli fornisce delle suggestioni importanti per studiare a
fondo un autore che, a mio avviso, deve essere rilanciato. Inoltre, credo che sia un libro che fa
molto bene alla pedagogia contemporanea, proprio perché attraverso autori come Herbart e come
Dewey (che va completamente riletto) la pedagogia e le scienze psicologiche debbono uscire da
questo stato di minorità a cui spesso la cultura ufficiale le condanna. In altre parole, solo grazie ad
autori che hanno un progetto chiaro che lega una teoria pedagogica alla costruzione di una scuola
reale e alla formazione di un soggetto possiamo ritrovare il senso stesso della cultura pedagogica.
Nicola Siciliani De Cumis: Il libro di Volpicelli, soprattutto per ciò che attiene a Labriola, aiuta
a capire le posizioni labrioliane dal punto di vista della psicologia empirica che, a date condizioni e
dentro certi limiti, è anche sperimentale, comparata, storica e sociale. Voglio dire, però, che il
problema meriterebbe, a mio avviso, un ulteriore supplemento di indagine sul piano del contesto.
Con Ignazio abbiamo spesso riflettuto sul fatto che andrebbe affrontato il tema del significato di
Herbart sul piano della storia delle idee, della cultura a seconda del mutamento delle prospettive.
Direi che l’intervento di Spadafora, proiettato anche verso alcuni “altri oggi” – l’oggi di Gentile,
ma anche l’oggi nostro – ce lo conferma da un altro punto di vista. Ma darei la parola a Giacomo
Cives.
Giacomo Cives: Ignazio Volpicelli, lo herbartismo e Antonio Labriola
L’esigenza del rilancio anche della storia delle teorie pedagogiche
Sta accadendo alla storia delle idee pedagogiche, cioè alla storia della teoria pedagogica con
particolare attenzione alla sua componente di filosofia dell’educazione, quello che suscitò circa la
dimensione filosofica allora mortificata della pedagogia, come ricordato tante volte, la reazione,
per la verità con scarsi frutti, testimoniata dal dibattito curato da Giovanni Maria Bertin su «Scuola
e Città» [131], cui più modestamente seguì a ripresa dei suoi temi il libretto di chi scrive La filosofia
dell’educazione in Italia oggi [132]. In risposta alla caduta dell’egemonia attualistica che aveva ridotta
la pedagogia a semplice appendice della filosofia, si era di fatto cancellato lo specifico della
pedagogia dissolvendolo nel pluralismo reattivo delle scienze umane. Di fronte a ciò si
rivendicava, pur nella varietà delle scienze dell’educazione e senza più predominio, l’importanza
insostituibile della pedagogia teorica.
Allo stesso modo in risposta alla storia della pedagogia ridotta a semplice capitolo aggiunto alle
ricostruzioni della storia della filosofia senza attenzione per la sua specificità (basti pensare alla
prassi per lungo tempo dei manuali di storia di filosofia e pedagogia degli istituti magistrali), si è a
ragione difesa e rilanciata la pluralità delle dimensioni più democratiche della ricerca storico–
educativa, intesa come storia della scuola, della didattica, della letteratura per l’infanzia, della
storia sociale dell’educazione, con particolare (e benemerita) attenzione per il recupero della
pesante realtà socio–educativa in gran parte esclusa fin qui delle condizioni più mutilate dei
marginali, dei poveri, dei menomati, degli sfortunati, degli esposti e così via. Ma ciò non può
significare, come purtroppo comunemente si intende, che la storia delle idee educative non abbia
più ragion d’essere. Ieri dominante e esclusiva, ora non può essere assente. La gamma delle sfere
di ricerca della storia della pedagogia è bene allora che sia allargata, ma insieme che comprenda
anche, pur se ridimensionata e non enfatizzata, quella della storia delle teorie pedagogiche.
Intendiamoci, incalza un modo nuovo di intendere la pedagogia, orientata in senso più o meno
sperimentalistico e tecnologico, che punta ai suoi aspetti pratici e applicativi e che molto spesso
dimentica, trascura la sua dimensione sia teorica che storica tout court (e quindi non solo come
storia delle sue “dottrine”).
Di recente a Salerno l’amico Giuseppe Acone in occasione dell’assegnazione del premio
Valitutti osservava confidenzialmente a proposito di una monografia che trattava di un
pedagogista della prima metà del Novecento, avendo cura di cercare di ricostruire di lui come
d’uso, in modo documentato, formazione, ambiente, pensiero, opera, “lezione”, nonché la critica
che lo ha riguardato, che si trattava di un libro “come si scrivevano una volta”, e ahinoi non si
scrivono più. I libri di pedagogia attuali sono infatti tutti sbilanciati sul come insegnare, e non si
occupano più del perché e della storia del perché e del come, sempre fondamentale per capire il
presente, si è insegnato e educato nel passato.
Recentemente è arrivato il catalogo di un editore di scritti sull’educazione: ebbene i testi indicati
erano tutti di didattica e tecnica dell’insegnamento, sulla valutazione, su come organizzare la
classe, sulla programmazione e così via. Nemmeno un titolo riguardava la teoria e la storia della
pedagogia.
Viene in mente quanto osservava qualche anno fa un editore abruzzese: se pubblico un testo di
didattica, a meno che sia pessimo, so di poterlo vendere rapidamente, se metto in catalogo un libro
di pedagogia generale o di storia della pedagogia, lo smaltirò, se pure ci riuscirò, con estrema
lentezza. L’editoria non è dunque incentivata a pubblicare testi di tale tipo. E naturalmente non è
neanche incentivata la ricerca relativa.
A ciò si aggiunga la tendenza in rispondenza alle richieste specifiche dei corsi di laurea
triennale, di testi succinti e divulgativi. Si moltiplica così la produzione di brevi e sintetici manuali
che incentivano uno studio di seconda mano, che allontana dai classici e dalla ricerca più
approfondita. I testi di pedagogia teorica e di storia della pedagogia richiedono passaggi articolati,
sviluppi e documentazioni adeguati, e tendono naturalmente ad essere emarginati da questa
nuova letteratura.
Il bel libro di Ignazio Volpicelli sullo herbartismo
Benvenuto allora un libro come quello di Ignazio Volpicelli [133], squisitamente di storia delle
teorie educativa, ma anche delle scuole, degli indirizzi, dei movimenti che nella loro elaborazione
nell’università e nella scuola concreta si sono sviluppati. È un testo di grande approfondimento,
documentazione, puntualizzazione sullo sviluppo dello herbartismo nel mondo di lingua tedesca e
in Italia, dove ha assunto particolare rilievo nell’elaborazione di Labriola, qui particolarmente
trattato, e di Credaro. Questi due rilevanti personaggi com’è noto si sono succeduti
nell’insegnamento della pedagogia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “La
Sapienza” di Roma. Un insegnamento che svolto all’insegna di Herbart nel legame con la scuola e
nella valorizzazione della formazione e del perfezionamento degli insegnanti chi scrive ha tentato
di ricostruire nella relazione dedicata a La scuola di pedagogia dell’Università di Roma nel 1994
[134].
In Herbart e i suoi epigoni sono moltissime le letture e citazioni precise di libri, saggi e articoli
specie tedeschi di e su Herbart e suoi scolari, con riferimento di efficace documentazione. Ne
risulta ricostruito un pensiero e un movimento oggi dimenticati, ma che segnarono una grande
crescita della pedagogia, in Europa e (pur se qui non trattata) negli Stati Uniti. Ignazio Volpicelli
anche nelle sue opere precedenti ha dedicato con buon successo molta attenzione alla frontiera
storica pedagogia–filosofia con studi su Schleiermacher, Schopenhauer, Gentile.
La rassegna critica di Dewey delle più note teorie pedagogiche
Sull’importanza dell’apporto di Herbart alla pedagogia moderna è interessante il giudizio, pur
critico, di Dewey che ne riconosce l’apporto di rigore e di novità. In Democrazia e educazione giunge
alla sua definizione positiva di educazione come duttile «ricostruzione o riorganizzazione
dell’esperienza, che accresca il significato dell’esperienza e che aumenti la capacità a dirigere il
corso dell’esperienza seguente. L’incremento del significato corrisponde all’aumentata percezione
del nesso e della continuità delle attività nelle quali siamo impegnati» [135]. Dunque duttilità,
mediazione, continuità tra particolare e generale, fine e processo, individualità e socialità,
utilizzazione del passato e costruzione prospettica del futuro, interazione tra attività spontanee e
ambiente che le trasforma e che si trasforma, nel riadattamento continuo che è proprio della
democrazia.
Per giungere a questa proposta, che conclude il VI capitolo del libro, Dewey nello stesso
capitolo e in quello precedente ricorda con chiarezza e sintesi felice altre concezioni educative,
mostrandone l’inadeguatezza.
No allora all’educazione come preparazione, per i bambini a diventare adulti, per gli adulti
magari per un’“altra vita”. Così si mortifica lo slancio, la partecipazione e lo stimolo della gioia, e
si cancella il valore del presente come esperienza ricca e fervida, sia pure aperta nella continuità
della crescenza alla dimensione del futuro.
No poi all’educazione come svolgimento, quale approccio in rigida successione ai materiali col
loro valore simbolico, alla scala ascendente delle istituzioni, sostenuto da Froebel a Hegel, in
direzione del compimento dell’Assoluto. Ma così non vi è riconoscimento per l’originale e
imprevedibile apporto degli uomini comuni, in modo che «la conformità, non la trasformazione, è
l’essenza dell’educazione» [136]. Se non è affatto da disprezzare il valore educativo delle
istituzioni, intenderle nella rigidità totalizzante conforme all’esclusiva Ragione Assoluta cancella lo
spazio e i diritti delle personalità concrete.
No ancora, continua Dewey, all’educazione come allenamento delle facoltà, come “disciplina
formale”. Un esercizio ripetuto con un materiale già definito e con prestabilita gradualità
allenerebbe alcune facoltà della mente. Modello di questa impostazione Locke, privilegiando allo
scopo la matematica. Altre discipline, si può notare, sono state sostenute come fruttuosa
“ginnastica mentale”: si pensi ad esempio al latino. Ma alla base vi era una psicologia datata e
superata, quella delle facoltà separate, e una concezione “dualistica” errata, con un esercizio
staccato e indifferente al suo oggetto. L’azione della mente è ben più complessa e implica pluralità
di aspetti. Non è sorda al campo in cui si applica: implica pulsioni, interessi, motivazioni. Non vi
possono essere allora materie formative privilegiate (ecco una importante notazione democratica
contro una ingiustificata gerarchia di discipline e di scuole). Contano in tal modo “iniziativa”,
“inventività” e “riadattabilità” [137] e una forte interazione delle attività tra loro senza esclusione e
dell’intera personalità con il contesto sociale.
Ma eccoci agli herbartiani e a Herbart.
Con la critica dell’educazione come ricapitolazione e retrospezione, Dewey distingue un aspetto
biologico, col principio poi dal positivismo dell’ontogenesi che ripete la filogenesi, da uno
culturale, per cui la formazione dovrebbe ripercorrere via via lo sviluppo culturale dell’umanità,
dai miti e dalle leggende dell’età pastorale al sapere tecnico dell’età contemporanea. Quest’ultima
impostazione è generalmente accettata e diffusa, traducendola nel privilegiare lo studio del
passato rispetto a quello dell’attualità, mentre, attenzione, nella sua forma integrale «la teoria,
eccetto per un’esigua scuola in Germania (per lo più seguaci di Herbart), ha avuto poco corso»
[138].
Sostenendo il parallelismo tra sviluppo culturale dell’umanità e dell’individuo, già Herbart
aveva proposto di partire dallo studio dell’Odissea. Ma qui Dewey sembra riferirsi, pur senza
nominarlo, a Ziller scolaro di Herbart e fondatore del Seminario di Lipsia, che aveva dedicato la
sua attenzione al curricolo delle varie classi e alle identificazione delle materie su cui concentrare
l’insegnamento, ai fini della crescita spirituale. Ricorda Ignazio Volpicelli nel suo Herbart e i suoi
epigoni che Ziller con accentuata intonazione confessionale aveva tracciato per i primi 8 anni di
scuola un piano didattico centrato nel I anno sulle fiabe (materia di accentuata controversia tra le
varie correnti herbartiane), nel II sulle vicende di Robinson, dal III al VII su vari momenti e aspetti
della storia sacra, nell’VIII nello studio della religione come ricapitolazione delle massime e dei
principî.
Ma la semplice retrospezione, osserva Dewey, sia sul piano biologico che su quello culturale
non tien conto del fatto che nell’uomo non vi sono solo ripetizioni ma anche mutamenti.
L’ereditarietà biologica sul piano educativo è solo il bagaglio originario degli individui, ma nulla è
detto per l’uso futuro. Così per il parlare a un certo punto giungono a maturazione ed efficienza gli
organi vocali, con i vari sensi, però è l’ambiente sociale con le sue interazioni che trasmette quella
determinata lingua usata in quella comunità. Quanto al piano culturale la conoscenza del passato e
della sua eredità è importante, ma se utilizzata dal presente “in moto” impegnato a dirigere i
propri movimenti e il suo futuro. Dice Dewey: «Il passato è una gran risorsa per l’immaginazione,
aggiunge una nuova dimensione alla vita, a condizione di esser visto come il passato del presente,
e non come un mondo diverso e distaccato» [139].
Anche qui dunque niente dualismo passato–presente. Dewey privilegia l’autenticità esistenziale
del presente, dimensione di gioia e di creatività, costruttrice in modo imprevedibile del futuro e
capace così anche di valorizzare le indicazioni del passato. Ma senza lasciarsene ingabbiare e senza
consentire una “eterodirezione” (anziché autocostruzione legata allo sviluppo aperto
dell’esperienza) legata a una rigida e prestabilita (e quindi imposta) successione dei contenuti di
sapere.
Limiti e meriti di Herbart secondo Dewey
Queste considerazioni si collegano direttamente a quelle della critica di Dewey alla concezione
dell’educazione come formazione, che è poi proprio quella della pedagogia di Herbart, «il miglior
rappresentante storico di questo tipo di teoria» [140]. Qui niente facoltà innate, ma potenzialità che
reagiscono agli stimoli esterni graduati e uniformi, che diventano rappresentazioni, le quali
persistono e si agglomerano anche sotto la soglia della coscienza in masse appercepienti. Dunque
«adattamenti, associazioni e complicazioni» [141], da cui le percezioni, il pensiero, la memoria, gli
stessi sentimenti e così via.
È dunque molto importante la presentazione del materiale e il suo ordine, e il ruolo decisivo qui
giocato dall’insegnante. Ma qui, nota Dewey, vi è una eccessiva esaltazione del suo ruolo, divenuto
determinante per tutto il processo, come vi è un eccessiva esaltazione del metodo da lui adoprato,
trascurando il nuovo, l’imprevedibile. Dov’è allora l’allievo, si chiede Dewey, la sua energia di
partenza, la sua attività creativa, la sua costruzione prescolastica? È sopravalutato il metodo, si
insiste troppo sull’antico, sul passato, e si trascura «l’essenziale, l’energia vitale che cerca
l’occasione di esercitarsi liberamente» [142] e la libera esperienza stimolata dall’esperienza sociale.
Se è permessa l’automenzione, vari anni fa tenendo conto del giudizio di Dewey, ma anche
dall’impressione ricavata dalla diretta lettura di testi di Herbart come Pedagogia generale e Disegno
di lezioni di pedagogia osservavamo in linea con queste valutazioni che nel pedagogista tedesco
«l’accento batte sul costruire, l’organizzare. E il costruttore, l’organizzatore […] è soprattutto il
maestro, la cui viva voce indottrina, o almeno istruisce e pertanto educa (istruzione educativa):
viva vox docet» [143]. Dunque la scuola è concepita «come azione fondamentalmente
dell'insegnante», da cui l’importanza della sua preparazione.
È chiaro che la nuova temperie culturale degli anni di Dewey, e particolarmente in America,
ispirati a un duttile naturalismo, a un elastico volontarismo, a un aperto sperimentalismo, a una
forte disponibilità creativa e a un vitale slancio democratico, all’insegna delle nuove dinamiche
correnti del pragmatismo, dello strumentalismo, del progressivismo educativo, non potesse che
porsi oltre la rigidità tutto sommato pedagogistica di Herbart, anche se desiderosa di partire dal
basso, di farsi in qualche modo rigorosa, di porsi oltre il tradizionale moralismo esortativo.
Se la critica di Dewey al pensiero educativo del filosofo dei reali non poteva che essere piuttosto
radicale, è netto anche il riconoscimento dei suoi meriti. Scrive Dewey [144]: «Il gran servizio reso
da Herbart è stato di aver strappato il lavoro dell’insegnante alla routine e al caso. Egli lo ha portato
nella sfera del metodo cosciente; è diventato un problema cosciente con uno scopo e un
procedimento determinati invece di essere un miscuglio di ispirazione casuale e di
assoggettamento alla tradizione». Herbart andò oltre le «generalizzazioni vaghe e più o meno
mistiche sugli ideali ultimi» e i simboli spirituali. Superò l’idea di “facoltà” bell’e pronte da
allenare col semplice esercizio con qualunque materiale. Ebbe e promosse grande attenzione per
gli oggetti concreti, per il contenuto dell’insegnamento e per «le questioni relative ai materiali di
studio». Attribuì giustamente grande importanza al metodo (anche se come si è detto irrigidendolo
e sopravalutandone il ruolo).
E ancora è merito di Herbart di aver portato avanti il tentativo di costruire una pedagogia
scientifica, con riferimento ad una psicologia, sia pure non ancora sperimentale, con l’utilizzazione
anche di strumenti di calcolo. Herbart ebbe il senso della complessità, pluralità, molteplicità dei
reali, opponendosi al monismo riduttivo della Filosofia dello Spirito idealistica. Capì il valore
dell’insegnante, da preparare in appositi istituti teorici e pratici. Promosse e sostenne il
riconoscimento dell’autonomia della pedagogia, disciplina distinta di dignità universitaria per
quanto particolarmente connessa all’etica e alla psicologia.
Qui la modernità di Herbart, la sua spinta laica innovativa.
Studiosi e allievi di Herbart di lingua tedesca
Si comprende allora l’ampia risonanza che la pedagogia di Herbart ebbe nel mondo della
cultura e della scuola non solo d’Europa, proponendo dibattiti, applicazioni, convegni, iniziative,
seminari, ispirando anche un esteso movimento con proprie sedi, varietà di posizioni e di interessi
approfonditi.
Si comprende così l’interesse del denso libro di Ignazio Volpicelli Herbart e i suoi epigoni che
come abbiamo già detto è dedicato a queste varie posizioni e correnti di ispirazione herbartiana.
Ne ricorderemo la trama generale e alcuni autori e momenti di particolare interesse, per dare una
qualche idea dell’importanza del volume. Per far questo li collocheremo in quattro momenti o
aspetti fondamentali, enucleabili dalla in effetti intrecciata trattazione di Ignazio Volpicelli. Queste
quattro analisi a nostro avviso sembrano riguardare: 1) il giudizio su Herbart di pensatori di
lingua tedesca; 2) i primi studi e la prima diffusione di Herbart in Italia; 3) lo svilupparsi del
movimento herbartiano e la sua dialettica; 4) lo herbartismo già ricordato presso l’Università “La
Sapienza” di Roma di Labriola e Credaro, nonché dello herbartiano Nicola Fornelli, docente
nell’Università di Napoli, come scrive Volpicelli «collega, amico e collaboratore di Credaro» [145].
La presentazione della teoria di Herbart non è svolta in modo diretto, ma attraverso l’analisi che ne
è stata fatta dagli studiosi che se ne sono occupati. Per quanto riguarda gli studiosi di lingua
tedesca (Bernhard Riemann, Rudolf Hermann Lotze, con iniziali interessi teologici e poi filologo,
Johann Eduard Erdmann, hegeliano ma critico verso gli esiti di panteismo, Immanuel Hermann
Fichte, «figlio del più celebre Johann Gottlieb Fiche» [146]), hanno in genere apprezzato il suo
realismo, la sua difesa dell’individuo contro il dissolvimento nell’assoluto, il suo marcato
avvicinamento alle scienze naturali, pur avanzando in vari casi incertezza sul mancato
riconoscimento di un livello superiore dell’Io, della coscienza, dell’atto, oltre il determinismo delle
rappresentazioni. Una riserva che verrà formulata, possiamo anticipare, anche dai filosofi italiani
che si sono occupati di Herbart, di ispirazione spiritualista o idealistica, Francesco Bonatelli,
Bertrando Spaventa, Felice Tocco.
Altri giudizi ricordati su Herbart sono quello avverso del gesuita Anton Günther che respinge
la sua “metafisica senza Dio”, quello molto favorevole dello herbartiano František Cupr che esalta
in lui l’estensione del “metodo delle scienze naturali” alla psicologia e alla conoscenza, mettendo
in grave crisi l’orientamento hegeliano, quello particolare ma molto interessante di Eduard
Hanslick che sulla traccia del formalismo di Herbart ha sostenuto nel campo dell’estetica musicale
il valore dell’“udibilità pura” contro le esasperazioni dell’estetica sentimentalistica, romantica e
wagneriana. E poi è ricordata ancora la critica di Friedrich Adolf Trendelenburg, con consonanze
poi con Tocco, che, pur molto interessato e benevolo verso Herbart, vedeva la sua inadeguatezza
per la spiegazione del concetto dell’essere, posta a livello solo formale.
Opportunamente poi Volpicelli si occupa in maniera più dettagliata e più organica di Franz
Seraphin Exner, docente all’Università di Praga, che ha fatto conoscere e ha sostenuto in Boemia e
in Austria il pensiero di Herbart, specie per l’aspetto psicologico, pedagogico e didattico, e ha
elaborato col filologo Herbart Bonitz un piano di riforma del Ginnasio in Austria, ispirando scrive
Volpicelli, «per un lungo lasso di tempo la fisionomia e il carattere dell’istruzione media nei
territori dell’impero austroungarico» [147]. Compreso il Lombardo–Veneto ove, in analogia con
quelli austriaci, presero a circolare manuali di ispirazione herbartiana di pedagogia e anche di
psicologia. La diffusione del pensiero di Herbart veniva così incoraggiata non solo a livello
accademico, ma anche scolastico. Aggiungiamo che manuali e libri di testo furono con la specifica
preparazione dei docenti uno strumento fondamentale per l’affermazione dello herbartismo.
Dai pur rapsodici riferimenti di Ignazio Volpicelli al dibattito su Herbart nel mondo austro–
tedesco risulta dunque come la sua lezione sia stata accolta in generale favorevolmente per la sua
radicale opposizione alla dialettica troppo astratta della filosofia idealistica, il suo avvicinamento
tra le scienze morali e naturali, per il suo intento di rendere più organizzato e meno disordinato e
casuale l’insegnamento, per la sua spinta complessiva, naturalmente non senza resistenze, verso la
modernizzazione e laicizzazione del sistema di istruzione.
Studi su Herbart e sua diffusione in Italia
Ed eccoci agli studi su Herbart in Italia, prima dell’autorevole e maturo suo approfondimento
alla “Sapienza” di Roma. Volpicelli ricorda come sia stato Benedetto Croce a ricordare come fu
Giacomo Lignana, tornato dalla Germania ove cominciava ad affermarsi la reazione contro Hegel,
subito dopo il 1860 a iniziare la divulgazione di Herbart in Italia.
Giandomenico Romagnosi presenta singolari coincidenze col pensiero di Herbart, come
pluralità di sostanze sconosciute dal cui commercio con l’“anima” deriva l’esperienza, e centralità
dell’“istruzione educante”, anche se non se ne può provare una diretta derivazione.
Esplicito invece il riferimento a Herbart di Alessandro Nova che su di lui svolge corsi
all’Università di Pavia. Nova, spiritualista cristiano, presenta numerose concordanze col pensiero
herbartiano ed è mosso in prima istanza, anche lui, dall’opposizione all’idealismo assoluto di
Hegel.
Con forti consonanze con Lotze, dopo un periodo di studi a Vienna, Francesco Bonatelli,
spiritualista cristiano docente all’Università di Padova, si occupa con equilibrio e finezza di
Herbart, apprezzando la utilizzazione del modello delle scienze naturali a livello materiale, ma
criticando la mancanza di distinzione tra l’attualità psichica e il livello superiore della coscienza. Il
solo processo, dice Bonatelli, delle rappresentazioni è limitato ed è riduttivo se non si coglie il
pensiero superiore che le anima.
All’analisi di Herbart sviluppata dallo hegeliano Bertrando Spaventa il sostenitore della
“circolazione europea” del pensiero passato dall’Italia alla Germania e da questa tornato in Italia,
Volpicelli si dedica in modo esteso, proseguendo le analisi già svolte da Nicola Siciliani De Cumis.
Spaventa è severo verso il dogmatismo del naturalismo più schematico e apprezza la convinzione
che è anche di Herbart del legame tra filosofia e metafisica, di Herbart che ben avverte le
“contraddizioni” dei dati dell’esperienza. Da qui la tesi della pluralità dei reali legati da complessi
rapporti determinati, superando il riduttismo dei semplici dati isolati. Ma il limite è nella
presunzione di voler spiegar tutto con le semplici leggi meccaniche dell’unità inconscia, senza dar
spazio a un anima costruttiva e dinamica, scrive Volpicelli, «concepita cioè nella sua più intima
essenza come potenza originariamente produttiva, attiva, destinata insomma a svolgersi non per
‘combinazione estrinseca’ ma per interna e propria energia» [148]. In sostanza, sostiene Spaventa
con Lotze, se all’anima è necessario il meccanismo psicologico, in più bisogna riconoscerle, ricorda
Volpicelli, «una naturale ‘spontaneità’ nel dispiegare la sua propria ‘attività’ e nell’attuarsi nelle
sue forme ingenite» [149].
Allievo a Napoli di Bertrando Spaventa e poi a Bologna di Francesco Fiorentino, Felice Tocco,
anch’egli meridionale (era nato a Catanzaro), si entusiasma alla nuova filosofia tedesca, passando
poi dallo hegelismo al neokantismo, e insegnando con grande scrupolo storia della filosofia a Pisa
e a Firenze. In uno scritto inedito di Studi su Herbart di 66 pagine manoscritte esamina con
acutezza, nota Volpicelli, come punto debole dell’impianto herbartiano il dato sensoriale di
partenza, il valore delle contraddizioni e del “metodo delle relazioni”, l’antitesi tra qualità
dell’Ente e i concetti di qualità ad essa riferiti, e come già rilevato da Trentelenburg il passaggio dal
mondo dei fenomeni a quello dei noumeni e la trasformazione dei rapporti logici in rapporti reali.
Dunque un esame penetrante e serio per quanto critico.
Nel complesso per questo punto si può rilevare che l’attenzione per Herbart, pur non molto
estesa, in Italia si ebbe tanto a Nord che a Sud anche se forse nel Mezzogiorno con maggiore
attenzione teoretica e filosofica, nel Settentrione pedagogica e applicativa.
Sviluppo del movimento herbartiano e dei suoi seminari per gli insegnanti
Interessante nel libro di Volpicelli è la ricostruzione della storia del movimento herbartiano, sul
piano non semplicemente teorico, delle articolazioni delle idee, ma anche su quello organizzativo.
La pedagogia di Herbart si determina in applicazione didattica e ha bisogno di una formazione
specifica degli insegnanti. Come nel caso del montessorismo, le concezioni pedagogiche richiedono
corsi di formazione teorico–pratica per gli educatori e quindi una organizzazione che li promuova,
li animi e li gestisca, garantendo una sostanziale fedeltà alla concezione ispiratrice. Ecco allora
sorgere nel 1868 a Lipsia una associazione o lega di pedagogisti e educatori (primari e secondari,
questa una componente molto importante) ispirati alla pedagogia di Herbart e alla sua
applicazione, con un forte impegno di innovazione dell’istruzione con convegni e pubblicazioni.
Presidente è Ziller, poi Theodor Vogt dal 1882, Wilhelm Rein nel 1906. L’azione dell’associazione
ha risonanza internazionale e nel 1882 risultano iscritti alla lega ben 800 studiosi e uomini di
scuola, provenienti da vari paesi.
Contrasti di proposte e di vedute motivano il costituirsi di diverse correnti. Così si distinguerà
l’orientamento dei “vecchi herbartiani” di cui è autorevole esponente Karl Volkmar Stoy, attento a
conservare l’ortodossia herbartiana, da quello dei “neoherbartiani”, ispirato a Ziller, impegnato a
integrare e semplificare il pensiero di Herbart. Due poli di riferimento diversificati si determinano
così con Stoy a Jena, e con Ziller a Lipsia, pur se esistono indubbie analogie e convergenze nelle
due scuole, specie nel mediare teoria e pratica all’insegna della promozione del “tatto
pedagogico”. Mentre la scuola di Jena batte specialmente sulla formazione della personalità
dell’insegnante, quella di Lipsia di Zeller si impegna in particolare a definire come abbiam visto la
concentrazione delle materie del curricolo, puntando a una rigorosa tecnologia dell’insegnamento,
e a valorizzare i 4 gradi formali dell’articolazione dell’istruzione, consistenti in chiarezza,
associazione, sistema, metodo. Si può notare che a Jena la notazione è sostanzialmente laica, in più
diretta corrispondenza con la posizione di Herbart, mentre a Lipsia predomina, come già
ricordato, la “curvatura confessionale” data da Ziller.
A proposito poi di “tecnologia dell’istruzione”, associata all’accento dominante dell’insegnante,
della scuola, dell’istruzione, notiamo a margine come il termine insieme al suo contesto sia tornato
d’attualità in America dopo lo sputnik e la paura di esser superati dallo sviluppo della scienza
applicata sovietica e dal Convegno del 1959 di Woods Hole, in funzione polemica contro la
duttilità liberale e democratica dell’educazione progressiva ispirata a Dewey. La notazione
complessiva sembrerebbe implicitamente neo–herbartiana, anche se di Herbart non si parla e ci si
riferisce a nuove teorie e dimensioni scientifiche come lo strutturalismo e il cognitivismo.
Viene da pensare che si è di fronte a una ritornante e pendolare oscillazione della cultura e
dell’educazione, dalla libertà al rigore, dalla creatività alla necessità e così via. Pur propendendo
personalmente per la prima posizione, anche se comprendendo che un certo loro grado di
integrazione è con qualche probabilità inevitabile, si può rilevare che l’indicazione di Herbart per
l’altra posizione è molto netta ed anzi rappresentativa e emblematica.
Come abbiam detto è decisiva e caratterizzante nel movimento herbartiano la formazione degli
insegnanti promovendo il “tatto pedagogico”. Così è lo stesso Herbart ad aprire per loro un
Seminario pedagogico a Königsberg che rimarrà in vita fino al 1833 quando passerà a insegnare a
Gottinga. Altri Seminari si aprono a Jena, a Lipsia, sviluppando insieme conoscenza delle leggi
dell’individuo e dell’educazione, pratica didattica, valutazione dell’azione educativa. Così ad
esempio l’articolazione delle discipline sviluppate a Jena si basava, è indicativo, su teoria,
psicologia, filosofia dell’educazione, pratica scolastica. Anche a Lipsia grande attenzione era
dedicata tra l’altro alla psicologia e alla realizzazione della circolazione tra teoria e pratica.
Si è detto del gran numero degli iscritti alla lega herbartiana. Ma pure molto alto fu il numero
dei frequentanti ai Seminari per gli insegnanti. Ignazio Volpicelli ricorda che a quello di Jena dal
1844 al 1866 e dal 1874 al 1883 i praticanti furono circa 700, mentre nel 1911 si valutava che durante
cinquanta semestri diretti da Rein i frequentanti fossero stati circa duemila. Al Seminario di Lipsia
sino alla sua chiusura nel 1883 i praticanti risultati iscritti furono 367. Nota Volpicelli che si è
trattato comunque di un numero indubbiamente considerevole di studenti, praticanti, tirocinanti, e
non solo tedeschi o di madrelingua tedesca, che contribuirono a diffondere e propagare i principî
della pedagogia e della didattica herbartiana anche oltre oceano, a cui occorrerebbe comunque
aggiungere anche quello, ben più numeroso, di tutti coloro che frequentarono le numerose
istituzioni che, ispirate a quei principî e a quelle ipotesi, videro la luce in Germania e altrove […]”
[150] non si aprono le virgolette. Ad esempio in Svizzera, specie nel cantone dei Grigioni.
Sono evidenti dunque le vie della diffusione internazionale dello herbartismo, la cui fortuna è
durata fino ai primi decenni del Novecento.
La pedagogia di Herbart alla “Sapienza”
nell’insegnamento di Antonio Labriola
di
Roma
E siamo così all’altra componente della trattazione di Volpicelli, quella del pensiero di Labriola
e Credaro, entrambi come si è detto docenti di pedagogia all’Università “La Sapienza”, autorevoli
studiosi l’uno sostenitore del pensiero marxista, l’altro protagonista della politica scolastica nell’età
giolittiana. A Labriola sono dedicate anzi ben 60 pagine e si può ben dire che assuma un ruolo
centrale in Herbart e i suoi epigoni.
Riportiamo un puntuale profilo su di lui di Richard Falkenberg del 1906, trascritto da Volpicelli:
«Formatosi a Napoli sotto l’influenza della fiorente e senza dubbio assai benemerita scuola
hegeliana, nutritosi anche attraverso gli studi della filosofia classica, in parte anche della teologia,
illustrò l’indirizzo socratico – e questo era allora qualcosa di completamente nuovo – non secondo
la tradizione filosofica, ma attraverso le condizioni sociali ed economiche di Atene, chiamando in
causa le lotte di classe. Attraverso la linguistica e attraverso Steinthal e Lazarus pervenne alla
filosofia di Herbart. In occasione della domanda per la docenza in storia della filosofia (Napoli
1871) e in una critica a Vera» del 1871 «mostrò in tutti i punti il suo completo divorzio dalla scuola
hegeliana». Continua Falkenberg: «Come professore all’Università di Roma assunse un
atteggiamento critico rispetto alla scuola herbartiana occupandosi propriamente di Volkmann e di
Lindner. Quindi, dal 1878, si dedicò a studi economici e sociologici, divenne socialista e (1887) per
cento aspetti marxista» [151]. Anche se verso gli herbartiani si potrebbe dire che ebbe un
atteggiamento di critica e di adesione insieme.
In realtà il marxismo di Labriola, teorico e pratico, non è stato affatto marginale, ma ha
costituito un punto problematico fondamentale e non solo in Italia. Opponendosi ai riduzionismi
ideologici e sistematici, Labriola diceva per il suo pensiero che «la nostra dottrina non pretende di
essere la visione intellettuale di un gran piano o disegno, ma è soltanto un metodo di ricerca o di
concezione. Non a caso Marx parlava della sua scoperta come un filo conduttore» [152].
Labriola è dunque passato dall’idealismo allo herbartismo al marxismo, ricavando dal
“realismo” salvato dallo schematismo dell’ideologismo delle tre correnti, ha osservato Lombardi,
l’approdo a «un integrale umanesimo o realismo critico» [153]. Volpicelli in Herbart e i suoi epigoni
ha battuto sulla forte continuità tra herbartismo e marxismo in Labriola. Ma in un’altra occasione
ha ricordato che tale continuità si estende anche alla stessa fase idealistica, poiché «indubbiamente
la tesi della organicità e continuità della riflessione labrioliana contro ogni ipotesi interpretativa di
tipo discontinuo o sussultorio è una tesi ormai assodata e consolidata in ambito critico». Pure se lo
studio di una abbondante documentazione ancora inedita potrà meglio far capire i legami e i
passaggi tra i vari periodi [154].
Non è vero, osserva Volpicelli, che Labriola si sia accostato a Herbart come sostenuto da
qualche autorevole studioso, non per la metafisica ma per le sue lezioni di pedagogia e per
l’insegnamento della storia. Egli ha invece guardato a Hegel, oltre che per alcuni temi metafisici,
anche per la psicologia, per il problema della libertà e per la morale, del resto direttamente
connessa alla pedagogia.
Della fitta trattazione su Herbart ricordiamo solo alcuni punti emblematici. Fa presente nel suo
volume Volpicelli che la conoscenza secondo Labriola ha la sua fonte originaria nel realismo e non
nell’Io. L’Io è problematico e il cammino effettivo va dagli accadimenti psichici alla mente.
L’anima va intesa allora non come entità metafisica, ma come attività delle rappresentazioni e
della volontà e come vita reale. L’anima così non è sede di facoltà, che costituiscono del resto mere
astrazioni logiche. Non ridursi allora al livello delle semplici metafore linguistiche e definizioni
nominali erroneamente intese in senso ontologico, ma guardare alla molteplicità delle forze in
contrasto nel nostro animo. Allora non introspezione mitologica riferita a una psicologia costruita
sulla base di “pregiudizi” e “false generalizzazioni” [155], ma attenta considerazione dei fenomeni
come problema. Non mitologia dell’aggregazione delle facoltà, e si può aggiungere dell’apriorismo
delle categorie e dell’entificazioni immobile dell’Io, ma “teoria dinamica dell’evoluzione del
microcosmo interiore”.
Ecco, è qui introdotta una dimensione costruttiva e creativa della dinamica delle appercezioni
connesse agli stimoli della realtà di ispirazione herbartiana, che porta allo sviluppo di una scienza
empirica dell’anima, che fa piazza pulita delle costruzioni fantastiche e gratuite della precedente
metafisica. Una dimensione che avrà grande rilievo nella considerazione del tema della libertà, cui
Labriola si è particolarmente dedicato.
Il concetto della libertà secondo Labriola e coincidenze di quello della “libertà pesante” di Franco
Lombardi
La libertà, dice Labriola, non va intesa come semplice potenza di fare. È implicito il volere come
possibilità e qualità morale. La libertà del volere non è però incondizionata, non è
autodeterminazione assoluta, ma è inserita in una serie di cause. Diceva Labriola: «Il motivo c’è
sempre».
Ma la libertà non è neanche assoluto meccanicismo e determinismo naturalistico. La decisione è
la somma di particolari stati, e per capirla bisogna considerare la storia della formazione
dell’uomo, la complessità delle sue intime motivazioni.
La libertà sul piano psicologico si lega alla dinamica delle rappresentazioni, delle appercezioni,
dei motivi. Nell’abbassamento e nell’elevazione della soglia di appercezione interna vi è una
maggiore o minore grado di libertà. Afferma Labriola: ciascuno è libero per quel tanto che può.
Meno condizionato è l’uomo dalla forte struttura della propria individualità, dal saldo carattere,
inteso come forma della volontà. Qui una importante osservazione: il carattere, variamente
graduato, non è un dato originario ma il risultato di un processo di formazione. Secondo: il
carattere come costante fedeltà a certe massime non è ancora buono o cattivo. Il carattere può
anche essere indirizzato al male. Non basta allora la stabile rispondenza ad esse, ma per procedere
dal livello psicologico a quello morale bisogna approfondire la caratteristica di quelle massime, la
loro origine e la loro natura. Tra psicologia e morale il processo è continuo. Lungi dall’accettazione
di apriorismi e imperativi categorici tutto il processo, sostenuto dalla “istruzione educativa”, si
sviluppa dal basso, dall’esperienza: dal contatto dei reali ai reciproci atti di difesa, dalle
rappresentazioni alla loro affermazione e alle masse appercepienti.
In tutto questo, si può notare, si evidenzia una vera e propria inversione rivoluzionaria rispetto
alla concezione aprioristica, trascendente o trascendentale dello spiritualismo e dell’idealismo
dominanti, costituendo un vero e proprio momento di passaggio dalla filosofia tradizionale e
classica a quella moderna, pur non senza, ancora, bardature e rigidità.
Osserviamo a margine, essendo già stati alla “Sapienza” di Roma Ignazio Volpicelli e chi scrive
allievi di Franco Lombardi, e quest’ultimo per vari anni anche suo collaboratore, come ci dessimo
di gomito a considerare la problematica e stimolante concezione di Labriola, nel richiamo ad
Herbart, della libertà gravata (ma non cancellata) dalle molteplici esperienze di ciascuno, pulsioni,
aspirazioni, frustrazioni, successi: l’idea insomma di una libertà storica e evolutiva. L’idea che era
subito venuta a entrambi alla mente era: guarda come a questo concetto di Labriola sia vicino e
corrisponda quello proposto negli anni ‘50 da Lombardi, della “libertà pesante”. Vale a dire: «una
libertà come crisi – cioè secondo il significato etimologico del termine, come decisione insieme e
come sentenza – diversa dal concetto della libertà che, pur attraverso i contrasti e le posizioni
diverse, ci viene presentato per solito».
Concetto alla cui base è quello “teologico” del pensiero, di una razionalità che la volontà non
può che seguire “o farsi irrazionale”, o con l’idealismo identificato con la volontà e autogarantito
sulla base di un semplice dialettismo di concetti privo del peso e del riscontro della realtà. E
Lombardi proseguiva: «[…] Questa libertà o crisi non è cosa, come si dice, spirituale, bensì si
radica nell’effettivo essere dell’individuo come spirito–corpo o tutt’unito».
«Possiamo dire questo concetto della libertà il concetto della libertà pesante, intendendo che in
essa inside non soltanto il peso della carne, delle preoccupazioni dell’individuo, della miseria e del
bisogno, bensì anche inside il peso delle generazioni e della specie […]. E benché siamo stati e
siamo sempre liberi, siamo la libertà così e così caratterizzata dell’individuo che noi storicamente
siamo» [156].
La convergenza dei concetti della libertà di Labriola e Lombardi è forte. V’è un’integrazione
reciproca, con risultati di stimolante concretezza.
Molto interessante è anche il riferimento di Ignazio Volpicelli all’adesione di Labriola al
raccordo proposto da Herbart, contro il rigorismo morale di Kant, con Schiller di etica e estetica. Il
giudizio etico è giudicato ben diverso dalla conoscenza teoretica e ben più vicino a quello estetico.
L’intervento educativo aiuta a realizzare principî reali di volere. Decisiva è poi l’educazione del
sentimento, mediatore tra morale e volere. Al di là del rigorismo del dovere, si tratta di realizzare
una libertà morale, nell’armonia del volere.
E qui il ruolo della mediazione pedagogica è importante, insostituibile. Collegando
materialismo storico e pedagogia dei reali, Marx a Herbart, Labriola chiarisce con un’affermazione
famosa che «l’uomo bisogna educarlo». E Volpicelli ricorda un’altra affermazione di Labriola, pure
ben nota, secondo cui «le idee non cascano dal cielo, né noi riceviamo il ben di dio in sogno».
L’educazione assume dunque un grande rilievo nella proposta umanistica di Labriola, non
astratta, aprioristica e retorica, ma storica, sociale e costruttiva, e disancorata da quel tipo di
“pensiero teologico” di cui abbiam visto parlare Lombardi, legata invece alla effettiva esperienza.
È dunque una riflessione di grande rilievo quella di Herbart, inserita in un ampio discorso
culturale e impegnato. La singolare vivacità di studioso sui generis di Labriola, il cui pensiero è
stato osservato risulta legato più agli appunti, base dei suoi illuminati e ispirati discorsi, che ai
volumi scritti con una distintiva insofferenza, di Labriola geniale testimone di una rapida e
profonda trasformazione di indirizzi di cultura, di cui è stato attivo protagonista, ha giustamente
motivato la particolare attenzione a lui dedicata da I. Volpicelli e qui di conseguenza da noi,
illustrandola e commentandola. Una riflessione che non essendo esclusivamente pedagogica e
quindi incline a scivolare nel pedagogismo, con l’inserimento dell’“istruzione educativa”, che è
ben di più come diceva Labriola, del semplice addestramento e ammaestramento, in un ampio
contesto di teorie e di sapere, le ha dato il maggior rilievo. Il non essere specificamente Labriola,
nonostante la titolarità dell’insegnamento universitario, un pedagogista etichettato, ha dato ai
problemi dell’educazione, come spesso accade in questi casi, più importanza e più sostanza.
Lo herbartismo di Luigi Credaro e il suo impegno per la
formazione degli insegnanti
Meno pagine Ignazio Volpicelli dedica a Luigi Credaro, a lui succeduto alla “Sapienza”
neokantiano, allievo a Lipsia di Ludwig Strümpell, «uno degli ultimi scolari diretti di Herbart»
[157], e di Wilhelm Wundt, il fondatore della pedagogia scientifica. Egli fu anche ministro della
pubblica istruzione dal 1911 al 1914, e uno dei più importanti punti di riferimento del giolittismo,
il quale com’è noto si appoggiò sul piano filosofico alla filosofia neokantiana e su quello
pedagogico proprio alla pedagogia di Herbart [158].
Volpicelli ricorda rapidamente che Credaro, in pedagogia herbartiano, fu autore di un libro di
successo di esposizione della pedagogia del teorico dei reali e delle rappresentazioni, La Pedagogia
di Herbart, scritto vari anni prima ma pubblicato nel 1900 con la Dante Alighieri. Il libro in realtà
ebbe un grande rilievo nella diffusione dello herbartismo in Italia, e non fa male Marco Antonio
D’Arcangeli, oggi in Italia il maggiore e più impegnato studioso di Credaro, ad esporne
dettagliatamente il contenuto, osservando che il volume «costituisce […] l’opera più conosciuta,
nota e significativa di Credaro. La sua pubblicazione, avvenuta nel 1900, segnò un vero e proprio
spartiacque nella vicenda biografica ed intellettuale dello studioso valtellinese, oltre che una svolta
di non trascurabile rilievo per il dibattito pedagogico del nostro paese. Fra l’altro non ci pare
superfluo notare come in essa convergano e si fondano le due direttrici fondamentali dell’opera di
Credaro: quella storiografica e la pedagogica» [159].
D’Arcangeli aggiunge che «in sostanza, secondo il nostro punto di vista, La Pedagogia di G. F.
Herbart costituì il manifesto, anche», della sua azione scolastica riformatrice democratica del primo
Novecento, «e possiamo pure affermare che lo herbartismo tese a proporsi, proprie nelle iniziative
organizzative e legislative di Credaro, come la traduzione nel mondo scolastico del più generale
progetto politico giolittiano» [160].
Opportunamente D’Arcangeli ricorda anche prese di posizione di Credaro tra le varie scuole
herbartiane, prediligendo alle posizioni di destra, formalistiche e religiose, di Ziller quelle di Rein,
che pur non essendo «un creatore nel vero senso della parola» [161], trasse dal realismo di Herbart
molte applicazioni utili e si distinse per l’elasticità delle interpretazioni.
Ignazio Volpicelli batte comunque sull’impegno di Credaro per il rinnovamento della
formazione degli insegnanti. Considerato che il sapere non basta per insegnare, che la logica
scientifica è distinto da quella dell’insegnamento, e che per insegnare occorre sapere insegnare,
Credaro si adopera, perché tutti gli insegnanti abbiano sull’esempio tedesco una formazione di
pedagogia, elevata ormai a vera scienza, e una pratica didattica. Sostiene così che gli insegnanti
debbano compiere un’esperienza di tirocinio in apposite istituzioni a carattere di “clinica
pedagogica” (ecco un concetto che sarà probabilmente molto piaciuto al compianto Riccardo
Massa). Sostiene che nelle Scuole di Magistero universitarie per l’insegnamento nelle scuole
secondarie, varate nel 1891 e poi riordinate nel 1907, vengano istituite “sezioni di pedagogia
pratica” per conoscere le «diverse esigenze metodiche e pratiche relative» e per svolgere «esercizi
pratici nell’istruire», così da promuovere l’“arte di insegnare” e quello che gli herbartiani tedeschi
chiamavano, come già ricordato, il “tatto pedagogico”.
Ma le Scuole di Magistero non ebbero adeguato slancio e sviluppo [162], e furono sciolte nel
1923 dalla riforma Gentile. Questa riforma liquidò pure i “corsi di perfezionamento per i licenziati
delle scuole normali” presso le Università, le cosiddette “scuole pedagogiche” istituite nel 1906 con
forte sollecitazione di Credaro, che pure miravano a congiungere «formazione di pedagogia
scientifica» e «tirocinio pratico per la promozione dell’istruzione educativa».
Così la proposta di Credaro dell’inizio del secolo del “ritorno ad Herbart” per ravvivare la
scuola soprattutto attraverso una rinnovata formazione degli insegnanti caratterizzata dalla
promozione di una pedagogia autonoma e laica, salva così dall’evanescenza idealistica che dalla
scientificismo formalistico positivista, avrà nel 1923 la sua definitiva sconfitta, con l’assorbimento
della pedagogia nella filosofia e la soppressione dello stesso tirocinio nello scuola dei maestri, il
rinnovato istituto magistrale, con rammarico dello stesso pedagogista attualistico (ma sui generis)
Giuseppe Lombardo Radice [163].
L’egemonia di Giovanni Gentile e il valore storico dello
herbartismo
Sconfitti risultano anche garbati auspici formulati fin dal 1887 dello herbartiano Fornelli con la
cui menzione si chiude il nutrito discorso su Herbart e i suoi epigoni di Ignazio Volpicelli, di
accogliere la proposta civile di Herbart dell’“istruzione educativa” come via “laica e civile” per
«formare un abito della mente ed un criterio pratico del mondo in servizio della libertà» [164].
Era una proposta quella di Fornelli, come del resto di Credaro, di ricavare da Herbart senza
fanatismi uno stimolo al rinnovamento didattico e alla trasformazione della professione docente,
attraverso «un confronto spassionato, libero, aperto intorno ai problemi ed aspetti concreti di
generale interesse» [165]. E Fornelli scriveva ancora nel 1912 di vedere in Herbart un’ancora di
salvezza, un termine medio, una via maestra su cui possano stare tutti senza sacrificare le proprie
posizioni.
Ma la proposta, per quanto formulata benevolmente, non riuscirà ad andare avanti.
Gradualmente l’egemonia culturale neo–hegeliana si affermerà in modo sempre più definitivo e
con la fine dell’età giolittiana lo herbartismo verrà definitivamente spazzato via.
Il merito del bel libro di Volpicelli, con un’attenzione forse più filosofica che pedagogica e
didattica, il che però non è male con una posizione che aveva fondamento nella sua svolta teoretica
realistica e antihegeliana, fitto di posizioni e intricati riferimenti, è nell’aver ricostruito
storicamente gli sviluppi dello herbartismo nei paesi di lingua tedesca e italiana, riservando,
com’era giusto, uno spazio di particolare rilievo all’affascinante figura di Labriola.
Un tema, lo herbartismo, in questi anni poco ricordato, ma che pure ha costituito un movimento
di enorme importanza con forte confluenza di sedi universitari, scuole, studiosi, professori e
maestri di diversi paesi, per proporre la scientificità della pedagogia, e della psicologia, la dignità
della stessa pedagogia, una formazione degli insegnanti che congiungesse il cosa insegnare al
come insegnarlo, con una specifica attrezzatura teorico–pratica.
Il cammino da fare sarà ancora parecchio, ma il segno di una svolta forte in senso laico,
consapevole, non moralistico e, come abbiamo notato, retorico è ormai dato. Bisognerà procedere
ancora parecchio in direzione di una scientificità sperimentale e insieme di una concezione duttile
e dinamica, di una autentica fede nelle potenzialità creative e costruttive dell’infanzia, di una
valorizzazione di un libero rapporto incentivante con l’ambiente e con la società, per non
dimenticare da ultimo, ma non è un aspetto secondario, bensì è decisivo e caratterizzante, il
carattere autenticamente democratico dell’educare.
[130] Le espressioni e le citazioni di Labriola da me adoperate provvisoriamente in questa sede
rinviano, da un lato, alla mia relazione sul Criterio del “morfologico” secondo Labriola, in preparazione
per il Convegno dell’ottobre prossimo a Cassino (è lì, appunto, che ritornerei sull’argomento
“critico” labrioliano, precisando fonti e concetti). Da un altro lato, gli appunti di cui oggi mi servo
sono in funzione un’altro studio sulla lingua di Labriola, cui attendo da tempo, e che mi darà agio,
spero, di svolgere i vari temi qui solo accennati. Quanto ai testi utilizzati nel mio intervento
d’adesso, essi sono stati soprattutto i seguenti: i tre volumi delle Opere di Antonio Labriola, a cura
di L. Dal Pane, I, Scritti e appunti su Zeller e su Spinoza (1862–1868), Milano, Feltrinelli, 1959; II, La
dottrina di Socrate secondo Senofonte Platone ed Aristotele (1871), Milano, Feltrinelli, 1961; III, Ricerche
sul problema della libertà e altri scritti di filosofia e di pedagogia (1870–1883), Milano, Feltrinelli, 1962]; i
tre volumi dei Carteggi labrioliani, a cura di S. Miccolis, I, 1861–1880, Napoli, Bibliopolis, 2000; II,
1881–1889, Napoli, Bibliopolis, 2002; III, 1890–1895, Napoli, Bibliopolis, 2003; A. Labriola, Id.,
Scritti politici 1996–1904, a cura di V. Gerratana, Bari, Laterza, 1970; Id., Saggi sul materialismo
storico, a cura di V. Gerratana e A. Guerra, Roma, Editori Riuniti, 1977; Id., Scritti pedagogici, a cura
di N. Siciliani de Cumis, Torino, UTET, 1981; Id., Epistolario 1896–1904, Introduzione di E. Garin, a
cura di V. Gerratana e A. A. Santucci, Roma, Editori Riuniti, 1983. Nella ricerca si è anche tenuto
conto, in particolare, di L. Dal Pane, Antonio Labriola. La vita e il pensiero, Roma, ed. Roma, 1934–35;
di N. Siciliani de Cumis, Studi su Labriola, Urbino, Argalìa, 1976; e Id., Laboratorio Labriola. Ricerca,
didattica, formazione, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1994.
[131] Manca il titolo del dibattito, in «Scuola e città», 1–2, gennaio–febbraio, 1976.
[132] G. Cives, La filosofia dell'educazione in Italia oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1978.
[133] I. Volpicelli, Herbart e i suoi epigoni. Genesi e sviluppo di una filosofia dell’educazione, Torino,
UTET Libreria, 2003.
[134] cfr. in Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Facoltà di Lettere e Filosofia, Le
grandi scuole della Facoltà, Roma, 1994, pp. 188–218.
[135] J. Dewey, Democrazia e educazione, trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1949, p. 103.
[136] Ivi, p. 80.
[137] Ivi, p. 92.
[138] Ivi, p. 97.
[139] Ivi, p. 102.
[140] Ivi, p. 93.
[141] Ivi, p. 94.
[142] Ivi, p. 96.
[143] G. Cives, La vita didattica della scuola, in La Pedagogia, diretta da L. Volpicelli, vol. IX,
Milano, F. Vallardi, 1970, p. 88.
[144] J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., p. 95.
[145] I. Volpicelli, Herbart e i suoi epigoni, cit., p. 219.
[146] Ivi, p. 11.
[147] Ivi, p. 18.
[148] Ivi, p. 68.
[149] Ivi, p. 73.
[150] Ivi, p. 206.
[151] Ivi, p. 94.
[152] Cit. in Franco Lombardi, La filosofia italiana negli ultimi cento anni, Asti, Arethusa, s.a. ma
1958, p. 52.
[153] Ivi, p. 51.
[154] I. Volpicelli, Antonio Labriola cento anni dopo (1904–2004), in «Bollettino C.I.R.S.E.», XXIV,
41, 2004, p. 16.
[155] Id., Herbart e i suoi epigoni, cit., p. 112.
[156] F. Lombardi, Nascita del mondo moderno, Asti, Arethusa, 1953, pp. 210–211. Per una
recensione di chi scrive sul volume cfr. in «Archivio di Filosofia», 1954, fasc. II, pp. 166–168.
Sull’argomento si può vedere anche F. Lombardi, Il concetto della libertà, Asti, Arethusa, 1955,
specie pp. 173–179.
[157] I. Volpicelli, Herbart e i suoi epigoni, cit., p. 212.
[158] Cfr. Patrizia Guarnieri, La «Rivista Filosofica» (1899–1908). Conoscenza e valori del
neokantismo italiano, Firenze, La Nuova Italia, 1981 e Id., Filosofia e scuola nell’età giolittiana, Torino,
Loescher, 1980.
[159] Marco Antonio D’Arcangeli, L’impegno necessario. Filosofia, politica, educazione in Luigi
Credaro (1860–1914), Roma, manca la casa editrice 2004, p. 285.
[160] Ivi, p. 289.
[161] Ivi, p. 320.
[162] Cfr. per le critiche relative a queste nel 1908 le critiche di Gaetano Salvemini e Alfredo
Galletti in G. Salvemini, Scritti sulla scuola, Torino, Feltrinelli, 1966, pp. 586–595.
[163] Su di lui e sui suoi complessi e problematici rapporti con Gentile cfr. G. Cives, Giuseppe
Lombardo Radice. Didattica e pedagogia della collaborazione, Roma, La Nuova Italia, 1970.
[164] I. Volpicelli, Herbart e i suoi epigoni, cit., p. 220.
[165] Ivi, p. 221.