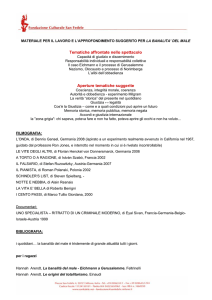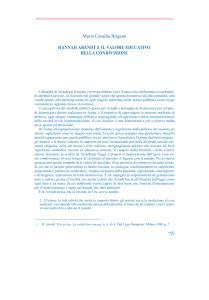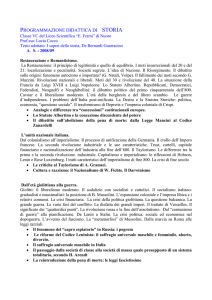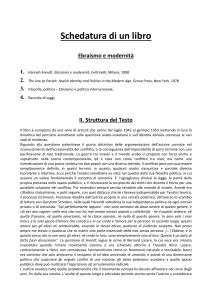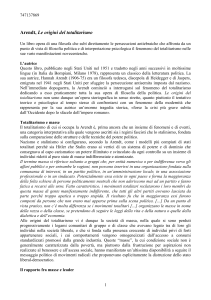Le lacrime di Penelope e il vento del pensiero
Saggio sulla Vita della Mente di Hannah Arendt
di Aldo Meccariello
Premessa
Quando Hannah Arendt comincia a scrivere le Gifford Lectures che doveva tenere all’Università di
Aberdeen in Scozia, nella primavera del 1973 e in quella successiva, ha già in mente un’opera che doveva
esaminare le nostre attività spirituali («pensare», «volere» e «giudicare») e lo fa a partire dalla meraviglia,
oggetto e origine della filosofia. L’uso del termine meraviglia attraversa come un Leitfaden molti scritti
arendtiani, perché il punto di partenza del pensare non è il dubbio o il sospetto, ma lo stupore generato dal
trovarsi di fronte al mondo, di fronte alle persone con cui ci relazioniamo, di fronte alla nostra stessa
esistenza. Il mondo, gli altri, la nostra esistenza sono sempre una fonte di curiosità e non cessano di stupirci.
Le Gifford Lectures, che erano state affidate in passato a pensatori come William James, Henri Bergson,
Karl Barth, Etienne Gilson e Gabriel Marcel, offrirono l’occasione ad Hannah Arendt di allestire The Life of
the Mind, l’opera sua ultima e incompiuta, pubblicata solo nel 1978, tre anni dopo la morte dell’autrice
avvenuta a New York nel dicembre del 1975. Si tratta di un’opera di grande spessore teoretico che attraversa
quel mare in gran tempesta che è la tradizione filosofica occidentale per, alfine, superarla.
In un passo dell’opera, l’autrice confessa di non avere dubbi e di sentirsi «apertamente schierata tra coloro
che da qualche tempo a questa parte hanno tentato di smantellare la metafisica (con la filosofia e tutte le sue
categorie) così come le abbiamo conosciute dal loro esordio in Grecia sino ai giorni nostri». i L’intento
arendtiano in questo lavoro di demolizione, di palese matrice heideggeriana, muove da vari presupposti:
primo fra tutti, il filo spezzato della tradizione e poi la perdita del passato di cui possiamo intravedere solo
frammenti: «un passato in frammenti, che ha perduto la certezza del suo criterio di valutazione». ii
C'è uno scritto in cui Hannah Arendt prende il pescatore di perle come figura di un certo pensare. Lo
chiama pensare poeticamente, per una concretezza materica che si distanzia dalle rarefazioni filosofiche.
L’autrice lo riferisce a Walter Benjamin in uno splendido saggio, L’omino gobbo e il pescatore di perleiii.
Chi ha a cuore la tecnica di smantellamento e vuole provarsi a cercare nuove vie al pensiero, faccia come il
pescatore di perle in fondo al mare, recuperi, le cose più preziose, «i coralli» e «le perle», che
«probabilmente possono ancora essere salvati solo come frammenti».iv
1
Un pensiero che voglia sottrarsi alla sua dissoluzione deve prendere congedo dalla tradizione metafisica e
volgersi o alla forma benjaminiana del frammento o di ‘frammenti di pensiero’, o provare a riconciliarsi con
il mondo, a trasformarsi in un pensiero secondo : pensare è sempre pensare in seguito ad una cosa o ad un
evento.
Il pensare, ogni pensare è sempre «propriamente un ri-pensare».v Il pensare è la ricerca del significato, è
un’attività della nostra mente che esige un rallentamento della fatticità, una sorta di sosta di cui si ha bisogno
quando si prendono decisioni oppure quando si operano delle scelte.
Ma cos’è propriamente il pensare? Che cosa ci fa pensare? Dove siamo quando pensiamo? Sono domande
che sembrano provenire dal sensus communis, dai ritmi della nostra esperienza vivente e tuttavia sono
domande radicali che, però, l’abitudine rimuove di continuo e con determinazione.
L’urgenza di queste domande concerne il destino medesimo del pensare, «l’idoneità del pensiero ad
apparire, perché si tratta, appunto, di sapere se il pensiero e le altre attività invisibili e silenziose della mente
siano destinate ad apparire o se di fatto esse non possono trovare mai dimora adeguata nel mondo»vi. Perché
l’attività del pensare non si rinserri nella pura sfera della contemplazione, come è successo sin dai tempi di
Platone, occorre che tale attività si riconcilii presto con il mondo e con il concreto agire degli uomini.
The Life of the Mind è un’opera affascinante e insieme eterodossa rispetto ai canoni della tradizione,
quindi esposta ai molteplici sensi di lettura e di interpretazione. L’opera è «una specie di Parte Seconda della
Human Condition»vii come l’autrice confessa in una lettera alla cara amica Mary McCarty, e perciò la
prosecuzione di un intenso lavoro teorico che si interrompe solo con la morte. Rispetto a The Human
Condition, Hannah Arendt estende l’indagine dall’Analitica della vita activa all’Analitica della cosiddetta
vita contemplativa o vita della mente per scrutare non tanto la tensione irrisolta tra queste due modalità di
essere al mondo che affiorano in maniera divaricata sin dal Medioevo, né tanto meno per focalizzare
‘astrattamente’ l’attività del pensare, quanto per soppesare tale attività al lavoro: si tratta, infatti, di
descrivere che cosa succede quando l’uomo pensa, quando cioè esercita la sua più alta facoltà specificamente
umana.viii Se l’agire, che è il motivo dominante della Human Condition, è pura attività che si mostra
nell’esecuzione in pubblico, parimenti anche il pensare o meglio l’esperienza del pensare, che è il motivo
dominante della Life of the Mind, è pura attività che si manifesta in pubblico, che è resa visibile attraverso la
parola. Il filo conduttore che lega le due opere è l’idea della pluralità, ovvero il punto di vista privilegiato
dell’autrice che le permette di esercitare il suo sguardo fenomenologico sulla condizione umana nelle sue
diverse sfere della vita activa e della vita della mente: lavorare, operare ed agire da un lato, pensare, volere
e giudicare dall’altro cioè esperienze e facoltà proprie degli uomini in quanto esseri unici.
Nell’uomo, l’alterità che egli condivide con tutte le altre cose e la distinzione, che condivide con gli esseri
viventi, diventano unicità, e la pluralità umana è la paradossale pluralità di essere uniciix. Ma è la natalità,
questa potente categoria arendtiana, ad impedire la divaricazione tra pensiero e mondo, tra pensiero e corpo,
e a troncare qualsiasi assoluta avventura della mente. Proprio la nascita, infatti, in The Life of the Mind
neutralizza l’opposizione tra vita activa e vita contemplativa, materializzandosi nel primato dell’apparire. La
2
nascita intensifica l’essere umano, lo rafforza, offrendogli possibilità di azione e di pensiero. Senza nascita e
quindi senza corporeità non c’è vita della mente che tenga.
Pensare, volere e giudicare sono per Hannah Arendt le tre attività spirituali fondamentali dell’uomo (che
sembrano richiamare la tripartizione kantiana di Ragion pura, Ragion pratica e Giudizio, e in forma più
remota, lo schema agostiniano del De Trinitate di intelligere, velle e memoria con la significativa
sostituzione della memoria con il giudizio): «non si possono dedurre l’una dall’altra e sebbene posseggano
certe caratteristiche comuni non si possono ridurre a un comune denominatore»x perché sono autonome e
incondizionate. «Certamente, gli oggetti del mio pensare, del mio volere o giudicare, i contenuti delle attività
della mente, sono dati nel mondo o vengono alla mia vita in questo mondo, ma essi in quanto tali, non
condizionano le attività della mente in quanto attività».xi
In altri termini, le facoltà della mente non sono separate dall’ambito fenomenico e, su questo punto,
l’autrice imposta un discorso, se non nuovo, originale, sull’idea di una relazione costitutiva tra il mondo e le
facoltà soggettive dell’uomo; allo stesso tempo, «nessuna delle condizioni della vita o del mondo
corrisponde ad esse direttamente»xii perché tali facoltà possono trascendere ‘spiritualmente’ tutte queste
condizioni.
Già nell’Introduzione, l’autrice vincola il senso della sua ricerca a due esperienze fondamentali ma
abbastanza diverse: la prima è lo stimolo che le viene assistendo al processo Eichmann svoltosi a
Gerusalemme nel 1961 e il discusso resoconto che ne segue pubblicato nel 1963, in prima edizione, dal titolo
La banalità del male: «Restai colpita dalla evidente superficialità del colpevole, superficialità che rendeva
impossibile ricondurre l’incontestabile malvagità dei suoi atti a un livello più profondo di cause e di
motivazioni… e l’unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento
passato, come in quello tenuto durante il processo e lungo tutto l’interrogatorio della polizia prima del
processo, era qualcosa di interamente negativo: non stupidità, ma mancanza di pensiero».xiii
È abbastanza chiaro da questo passaggio che la prima motivazione ad occuparsi delle attività della mente
era stata una motivazione etica e la conseguente capacità di distinguere il bene dal male, di giudicare
concretamente delle azioni. Il male, nella sua versione banale, può venire secondo l’Arendt ricondotto alla
incapacità di riflettere sulle azioni, su ciò che si fa. Nel criminale nazista Eichmann non c’è nessuna
profondità demoniaca, ma solo assenza di giudizio e accettazione passiva delle regole dettate da un’autorità
superiore. Fu proprio questa assenza di pensiero a destare l’interesse della Arendt nell’intraprendere questa
ricerca e a sollevare un grande quesito squisitamente morale: può l’esercizio del pensare in quanto tale
allontanare gli uomini dal fare il male o addirittura predisporli contro di esso? E ancora: è possibile
connettere la nostra facoltà di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato con la nostra facoltà di
pensiero? Interrogativi che fanno comunque da sfondo all’intero percorso dell’opera.
La seconda esperienza che suscita l’interesse dell’autrice riguarda più in generale il completamento
dell’indagine sulla condizione umana, questa volta sul versante della vita contemplativa, considerata
3
tradizionalmente una pura condizione di quiete, consacrata, a differenza della vita attiva, alla ‘visione di
Dio’.
L’Arendt giudica manchevole e approssimativa la risposta della tradizione alla faccenda del pensare che
è stata incastonata nei facili dualismi tra ‘il modo di vita attivo che si svolge sempre in pubblico’ e ‘il modo
di vita contemplativo che si svolge nel deserto’. In specie, nella tradizione cristiana questa tendenza si
accentua, favorendo l’identificazione del pensiero con la pura meditazione, sospingendo nell’angolo il
pensiero, asservito, ormai, alla teologia. Le cose non cambiano nell’età moderna, con Descartes, quando «il
pensiero divenne essenzialmente l’ancella della scienza, della conoscenza organizzata».xiv
Commentando questi passaggi dell’Introduzione si può facilmente desumere come l’intento arendtiano
sia non solo quello di scandagliare a fondo l’attività del pensare, riscattandola dai lacci della tradizione
platonico-cristiana, ma anche quello di ‘decostruire’ le linee principali del pensiero metafisico, mostrandone
i veri e propri errori, o ‘fallacie’, in connessione con le esperienze peculiari che le hanno rese possibili..
Ma c’è qualcosa di più in quest’opera, che rimane celato o almeno non sempre immediatamente visibile:
la sfida sulla critica alla metafisica che Hannah Arendt ingaggia col suo maestro e amante Martin
Heideggerxv, una sfida che acquista invece visibilità nella sezione della Vita della mente dedicata alla volontà
– la facoltà che, sconosciuta al mondo antico, è ‘l’organo del futuro’, perché chiama in causa la libertà
umana e la sua finitezza.
Questo saggio non vuole essere certo un’interpretazione complessiva dell’opera arendtiana, ma vuole
prendere in esame, in particolare, la prima sezione dedicata al Pensare, mostrando come il pensiero prenda
nell’analisi arendtiana una dimensione, per così dire, orizzontale, in opposizione alla dimensione verticale
del pensiero astratto di marca platonica: per noi questa concezione del pensare è la vera e tacita sfida che
Hannh Arendt lancia ad Heidegger sulla critica alla tradizione metafisica. Quel che è certo, infatti, è che per
il suo antico maestro la faccenda del pensare non è un bene che può toccare in sorte alla città.xvi
Vedere, vedersi
Se c’è un Leit-motiv che compare e ricompare agli snodi cruciali del tragitto arendtiano, condensandosi
soprattutto nei primi paragrafi della Vita della Mente, questo è il tema dell’apparire, che ha non poche
consonanze con l’ultimo Merleau-Ponty del Visibile e l’Invisibile, come nota acutamente Alessandro Dal
Lago nell’introduzione all’edizione italiana del libroxvii, e come la stessa autrice ammette in maniera esplicita
in alcune stringenti argomentazioni. Anzi, l’incipit del capitolo primo, paragrafo primo, dedicato alla natura
fenomenica del mondo, riecheggia in maniera impressionante la prosa merleau-pontyana: «Il mondo in cui
gli uomini nascono contiene molte cose, naturali ed artificiali, vive e morte, caduche ed eterne, che hanno
4
tutte in comune il fatto di apparire, e sono quindi destinate a essere viste, udite, toccate, gustate ed odorate,
ad essere percepite da creature senzienti munite degli appropriati organi di senso». xviii
Al pari di Merleau-Ponty, Hannah Arendt individua uno snodo cruciale per riconsiderare il rapporto tra il
mondo e le capacità spirituali dell’uomo nel fenomeno dell’apparenza, concepito come un dato di fatto della
vita quotidiana a cui nessuno può sottrarsi, tanto meno i filosofi o gli scienziati. Siccome tutto ciò che vive
viene percepito da altri, Essere e Apparire coincidono, cioè ogni essere presuppone degli spettatori. Vedere,
vedersi, essere visti sono modalità che dischiudono una nuova comprensione del reale, veri e propri snodi di
questo primato dell’apparire: «Apparire significa sempre parere agli altri, e questo parere varia secondo il
punto di vista e la prospettiva degli spettatori. In altre parole, ogni cosa che appare, in virtù del suo apparire,
acquisisce una sorta di travestimento che può in verità – benché non necessariamente – dissimularla o
deformarla. Il parere corrisponde al fatto che ogni apparenza, ad onta della propria identità, è percepita da
una pluralità di spettatori.»xix
Ciò che garantisce agli uomini la realtà del mondo è l’apparenza del mondo stesso. Il che significa che il
mondo è il luogo e la dimora dell’apparire. L’Arendt rivendica, sulle orme di Merleau-Ponty, la natura
fenomenica del mondo che si intreccia con una sorta di filosofia dell’apparenza, e allo stesso tempo delinea
l’opzione strategica della sua ricerca, che concerne «l’idoneità del pensiero ad apparire, poichè si tratta
appunto di sapere se il pensiero e le altre attività invisibili e silenziose della mente siano destinate a apparire
o se di fatto esse non possano trovare mai dimora adeguata nel mondo».xx
L’analisi dell’apparire porta Hannah Arendt a riformulare la critica al pensiero metafisico che aveva
sempre concepito la dimensione fenomenica come una dimensione accidentale e transeunte in nome della
certezza e della verità di un essere immutabile e a dare seguito a quel lavoro di smantellamento della
metafisica di cui dà un primo resoconto nelle pagine conclusive della sezione dedicate al Pensare.
In altri termini la tesi dell’apparenza, radicalmente antimetafisica, demolisce il dualismo dell’essere e
dell’apparire e rivela l’inconsistenza della teoria dei «due mondi» come l’inganno, sia pure affascinante,
della metafisica: «Ciò che è giunto alla fine è la distinzione di fondo tra il sensibile e il sovrasensible,
insieme con la nozione risalente almeno a Parmenide, che tutto ciò che non è dato ai sensi - Dio, l’Essere, I
principi Primi e le Cause (archai), le Idee - sia più reale, vero e significativo di ciò che appare, trovandosi
non solo al di là della percezione sensoriale, ma al di sopra del mondo dei sensi.»xxi
Con il crollo della teoria platonica dei due mondi, crolla l’edificio metafisico e ogni illusione di verità
ultima e definitiva. La Arendt invoca persino l’autorità del sofista Gorgia per denunciare la fallacia logica di
tutte le teorie che riposano sulla dicotomia di Essere e Apparire, che tanta afflizione ha portato al pensiero.
Ma che cos’è propriamente l’apparenza? Lo sfondo teorico che si apre da questo interrogativo si presenta
ricco di intuizioni originali: anzitutto, una volta che è stata affermata la natura fenomenica del mondo e
constatato il fatto «che noi siamo del mondo e non semplicemente in esso: anche noi siamo apparenze,
proprio in virtù del nostro arrivare e partire, apparire e scomparire»xxii, possiamo cominciare a precisare
5
alcune caratteristiche dell’apparire che l’Arendt trae in parte dall’insegnamento di Husserl e di MerleauPonty e in parte dalle ricerche del biologo svizzero Adolf Portmann.xxiii
Nel terzo paragrafo del capitolo I della prima parte dedicata al Pensare, significativamente titolato Il
rovesciamento della gerarchia metafisica: il valore della superficie, la Arendt chiarisce, infatti, il suo punto
di vista, polemizzando anche con l’atteggiamento dello scienziato che ha sempre tentato di portare alla luce il
fondamento delle apparenze, che ha finito per contagiare la scienza, colpita da una sorta di malattia infantile.
In tal senso la critica non deve solo rivolgersi alle pretese di totalità del pensare metafisico e quindi al
pensiero stesso nella sua interezza, ma anche alla scienza e al suo operare. Tale critica investe anche l’ipotesi
funzionalistica, in cui le apparenze sono interpretate come funzioni di un processo vitale sottostante, e quindi
funzionali all’autoconservazione e alla conservazione della specie, mentre l’intento dell’Arendt è riutilizzare
i contributi di Portmann sulle forme della vita dell’animale per rivendicare la modalità dell’apparire come
unica possibile: «Anteriormente a tutte le funzioni dirette alla conservazione dell’individuo e della specie
…si trova il semplice fatto di apparire come autoesibizione che dà senso a tutte queste funzioni»xxiv. Come il
piumaggio degli uccelli, «che a prima vista ci sembra possedere il valore di un caldo rivestimento protettivo,
ed esse soltanto, compongono un manto colorato il cui pregio intrinseco risiede solamente nella sua
apparenza visibile »xxv. Più precisamente, la riflessione di Portmann legittima il valore dell’apparenza come
la caratteristica morfologica delle specie viventi per cui «Non ciò che una cosa è, ma come essa “appare”
costituisce il problema della ricerca»xxvi. Quindi, ogni creatura vivente è portata ad apparire, a mostrarsi, ad
autoesibirsi come una sua disposizione innata.
Tuttavia l’Arendt non sembra dare credito assoluto alle ricerche di Portmann, soprattutto quando
quest’ultimo tende a distinguere le apparenze autentiche, cioè le forme esterne di qualsiasi essere vivente,
dalle apparenze inautentiche, cioè le forme interne come le radici di una pianta o gli organi interni di un
animale. Perché se l’esterno, ciò che appare, ha solo la funzione di proteggere l’interno, l’apparato
funzionale del processo vitale, allora ci assomiglieremmo tutti, e perderemmo la nostra specificità
individuale nella misura in cui gli organi interni della corporeità dovessero venire alla luce. Pertanto
l’interpretazione arendtiana, che gioca sul doppio significato del verbo tedesco esibirsi, Selbstdarstellung (=
far vedere la mia presenza, ma anche esibire il proprio sé), è che questo “impulso all’autoesibizione”
costitutivo di ogni essere si integri con una sorta di attività spontanea, nel senso che ogni cosa che vive e che
conseguentemente tende ad apparire è sempre predisposta ad essere vista e destinata ad apparire agli altri.
Quando facciamo la nostra apparizione come attori sulla scena del mondo, siamo per così dire posseduti
da «un impulso all’autoesibizione che corrisponde in ognuno al dato di fatto del nostro apparire» xxvii, e tale
impulso a mostrarsi, comune a uomini e ad animali, consiste in una serie di movimenti alternati a fasi di stasi
che coincidono con il decorso naturale di ogni vita individuale; tali sono le esperienze fondamentali di ogni
essere vivente che non esiste mai al singolare, ma presuppone sempre gli altri che lo percepiscono - e
presuppone altresì che l’apparire abbia un inizio e una fine, un arrivo e una partenza, un apparire e uno
scomparire rispetto al mondo che sempre ci sopravvive.
6
Un primo carattere dell’apparire è dunque il suo movimento: il mondo stesso si rivela come una scena di
apparizioni e scomparse. Il movimento dell’apparire - aggiunge l’autrice con il sostegno di Merleau-Ponty si spiega anche col fatto che «nessuna cosa, nessuna faccia di una cosa, si mostra se non nascondendo
attivamente tutte le altre»xxviii. L’apparire di un essere vivente è dunque un mosso che si costituisce in un
gioco di Schein (parvenza) e di Erscheinung (apparenza).
Il secondo carattere, non meno importante del primo, riguarda così il fattore dell’autopresentazione, nel
senso che, tra gli esseri viventi, gli uomini si presentano con atti e parole indicando così il modo in cui
desiderano apparire, ciò che a loro avviso è idoneo o meno ad essere veduto. Si tratta dell’elemento della
scelta rispetto a ciò che si vuole mostrare o si vuole nascondere.
Alla luce di questi primi due caratteri possiamo rilevare che l’apparire è anzitutto autoesibizione, fare
attivamente vedere, vedersi, udire la propria presenza, e poi successivamente autopresentazione, scelta
deliberata e attiva di come apparire agli altri.xxix
Scrive l’autrice: «Siccome le apparenze si presentano sempre nelle vesti del parere, simulazione e
inganno intenzionale da parte dell’attore, errore ed illusione da parte dello spettatore figurano,
inevitabilmente, tra le loro intrinseche potenzialità. L’autopresentazione si distingue dall’autoesibizione
grazie alla scelta attiva e consapevole dell’immagine mostrata: l’esibirsi non ha altra scelta che mostrare tutte
le proprietà in possesso di un essere vivente. L’autopresentazione non sarebbe invece possibile senza un
certo grado di consapevolezza di sé, capacità connaturata al carattere riflessivo delle attività spirituali che
trascende, chiaramente, la semplice coscienza che con ogni probabilità l’uomo ha in comune con gli animali
superiori.»xxx
Il concetto di autopresentazione permette all’Arendt di chiarire ulteriormente il primato dell’apparire,
questa volta in relazione all’attività del pensare, e lo strumento di cui si serve è la distinzione tra anima (soul)
e mente (mind), che non coincidono affatto.xxxi Se è vero che la vita dell’anima, cioè la vita psichica, si
esprime attraverso emozioni, sentimenti, affetti e passioni che non sono idonee ad apparire più di quanto lo
siano gli organi corporei che permettono la conservazione della vita, esse, tuttavia, rappresentano delle
apparenze inautentiche: «A differenza dei pensieri e delle idee, sentimenti, passioni ed emozioni non
possono divenire parte integrante del mondo delle apparenze più di quanto avvenga ai nostro organi
interni».xxxii
C’è quindi uno iato tra apparenze e vita interiore, perché i pensieri e le idee hanno sempre bisogno di
essere calate nel discorso e quindi sono sempre dotate di un significato, destinate come sono ad essere udite e
comprese da altri, mentre le emozioni, le passioni si nutrono di un fondo di oscurità che è il loro elemento
naturale, e mai possiamo controllarle. Come già in alcune pagine di Vita Activa, Hannah Arendt muove una
critica radicale e profonda alla vita interiore, e in più in generale alla vita intima la cui caratteristica è quella
di non essere destinata ad apparirexxxiii. Il punto centrale di questa discussione, è che il pensiero e le attività
mentali in genere non possono in alcun modo essere considerate un interno dell’io, perché la regione del
7
pensiero non è l’interiorità, e la riflessione si trova già sempre fuori, proiettata verso la sfera dell’apparenza.
Il pensiero fa sempre riferimento alla pluralità costitutiva della realtà umana.
La mente, infatti, è altro dall’anima, perché è pura attività che può essere avviata o interrotta. L’anima,
da cui provengono «le nostre passioni, i nostri sentimenti e le nostre emozioni, è un vortice più o meno
caotico di eventi che noi non mettiamo in atto, patiamo (pathein) e che in circostanze di forte intensità
possono travolgerci come avviene con il dolore o con il piacere; l’invisibilità dell’anima assomiglia a quella
degli organi interni del corpo, di cui avvertiamo il funzionamento o la disfunzione senza essere in grado di
controllarli»xxxiv. Tuttavia è anche vero che ogni emozione, ogni manifestazione di collera o di coraggio è
sempre un’esperienza somatica, che ‘trabocca nel corpo’. L’anima pertanto, come aveva già sostenuto
Aristotele nel De Anima, non sembra funzionare senza ricevere affezioni dal corpo con cui è in diretto
contatto.
Viceversa, il pensiero e le attività mentali in genere non possono in alcun modo essere considerate un
interno dell’io, né sono in diretto rapporto con il corpo anche se, come vedremo più avanti, esse «si
ritraggono dal mondo delle apparenze, ma tale ritiro non si dirige verso un interno dell’io o dell’anima». xxxv
L’apparenza, dunque, non è né può essere considerata alla stregua di una manifestazione esterna della
dimensione interiore costituita dall’anima; essa piuttosto appartiene ad un ordine di realtà differente.
Ora, sviluppando la questione dell’apparenza, Hannah Arendt tocca un tema di grande interesse, che è
quello della percezione o della fede percettiva: poiché «tutto ciò che appare è destinato a un essere
percipiente, a un soggetto potenziale tanto connaturato a ogni oggettività quanto un oggetto potenziale è
connaturato alla soggettività di ogni atto intenzionale»xxxvi, la natura dell’apparire coinvolge
‘intenzionalmente’ sempre e comunque un soggetto e un oggetto in un movimento di percepire e di essere
percepiti. Come ha notato Laura Boella, è palese ormai un chiaro atteggiamento fenomenologico
dell’Arendt, che si impegna tra l’altro in un confronto sia con Husserl sia con Merleau-Ponty, in contrasto
con l’atteggiamento filosofico tradizionale. La ‘fede percettiva’ non è altro che l’esistenza, vale a dire la
certezza che l’oggetto pensato o percepito possiede un’esistenza autonoma dall’atto del percepire, perché
dipende interamente dalla presenza di una pluralità di prospettive che percepiscono da molteplici punti di
vista lo stesso oggetto. Solo così, osserva Hannah Arendt citando Merleau-Ponty, è possibile afferrare
l’oggettività del realexxxvii. La percezione non è la coscienza di sé o qualcosa di soggettivo, perché si
costituisce in un tessuto di prospettive, in un gioco di pluralità che solo è in grado di conferire la necessaria
realtà alla sfera delle apparenze: «In un mondo di apparenze la realtà è caratterizzata in primo luogo dallo
‘star ferma e permanere’ la stessa, tanto a lungo da diventare un oggetto per la conoscenza e il
riconoscimento di un soggetto».xxxviii
Non è possibile in tale contesto approfondire questi problemi, che richiederebbero una ricerca particolare
per la ricca trama fenomenologica che li sottende, ma ciò che è importante sottolineare è che per Hannah
Arendt la coscienza non è sufficiente a garantire la realtà, e tanto basta per una presa di distanza dalle teorie
8
solipsistiche di matrice cartesiana; la percezione non è mai qualcosa di immediato, perché la realtà di ciò che
percepisco è «garantita da un lato dal suo contesto mondano, che comprende altri uomini che percepiscono
come me e, dall’altro, dall’azione combinata dei cinque sensi»xxxix. Quindi la realtà percepita, le cose, hanno
lati misteriosi e umbratili non appena cambia il punto di vista di colui che percepisce. Ciò che garantisce la
realtà in un mondo di apparenze è, appunto, la comunanza dei sensi dell’uomo che, pur diversi fra loro,
fanno riferimento ad uno stesso oggetto e al contesto che allo stesso tempo riunisce e separa gli individui; vi
è poi il sensus communis, una specie di sesto senso ‘misterioso e senza luogo’ che fornisce quella sensazione
di realtà che corrisponde alla proprietà mondana delle cose di essere- reali. «Questo sesto senso - chiarisce
l’autrice - non coincide con il pensiero, perché l’essere-reale delle cose, di ciascuna cosa, è sempre fuori
della sua portata. Il pensiero viene sempre dopo la realtà, né la realtà si può dedurre dal pensiero. Ma il
pensare, che sottopone al dubbio tutto ciò di cui si impadronisce, non possiede una simile relazione naturale
e scontata con la realtà».xl
Qui Hannah Arendt riconosce il ruolo centrale, strategico che il concetto di apparenza gioca nella
filosofia kantiana, non sul versante della tradizione teologica o di un presupposto metafisico (secondo cui
Dio è qualcosa, causa di ciò che è, ma non appare, è pensato ma non appare pur essendo causa delle
apparenze)xli, bensì sul versante della quotidianità, cioè dell’insieme dell’esperienze concrete degli uomini,
perché se le apparenze devono avere esse stesse fondamenti che non sono apparenze e devono pertanto
«fondarsi su un oggetto trascendente» che le determini come semplici rappresentazioni, ciò sembra derivare
per analogia dai fenomeni di questo mondo, mondo che include sia le apparenze autentiche sia quelle
inautentichexlii, per cui il fondamento delle apparenze risiede nelle apparenze medesime. Del resto, osserva
l’Arendt, questo lo dice Kant medesimo, anche se a volte egli non prende sempre atto delle conseguenze
delle sue argomentazioni, perché la distinzione tra la cosa in sé, cioè l’oggetto trascendente, e il fenomeno,
cioè la mera rappresentazione, si risolve non tanto nell’ambito di una gerarchia metafisica, quanto piuttosto
si fonda sulla nostra esperienza concreta. A conferma di ciò suona un celebre passo kantiano:
«Se una conoscenza deve avere una realtà oggettiva, cioè riferirsi a un oggetto e avere in esso significato
e senso, l’oggetto in maniera qualunque deve potere essere dato. Senza di che, i concetti sono vuoti, e se uno
con essi pensa, in fatto tuttavia con questo pensiero non conosce nulla, ma giuoca semplicemente con
rappresentazioni».xliii
Come a dire che è l’esperienza fonte e possibilità di ogni nostra conoscenza, senza di cui anche i concetti,
tutti i concetti, indistintamente non avrebbero valore alcuno.xliv
Ma lo snodo di questo confronto serrato con Kantxlv, anche a sostegno della nostra tesi, è sviluppato
nell’Introduzione alla Vita della mente e nel § 8 della prima parte, e riguarda la distinzione tra Vernunft
(ragione) e Verstand (intelletto), allo scopo di assegnare al pensiero una propria autonomia ma che sia
soprattutto legittimato a trascendere «i limiti dell’attività cognitiva e dell’intelletto» e giustificato in questa
sua pretesa. Si deve «allora presumere che il pensiero e la ragione non si occupino di ciò di cui si occupa
l’intelletto»xlvi. Polemizzando con Heidegger, Hannah Arendt afferma, infatti, in modo lapidario che il
9
bisogno di ragione non è ispirato dalla ricerca di verità ma dalla ricerca di significato. E verità e significato
non sono la stessa cosa.xlvii
Ma procediamo con ordine. Preliminarmente l’autrice chiarisce, a suo avviso, alcune caratteristiche della
scienza moderna che persegue sempre una verità irrefutabile, a partire dall’evidenza dei sensi. Tuttavia, se è
vero che la tecnologia e l’esperimento costituiscono il modo di procedere dello scienziato, per far vedere
come le cose funzionano, è anche vero che il ritorno al senso comune e all’esperienza si impone di per sé.
«Sotto questo aspetto - scrive l’Arendt - la scienza non costituisce se non un prolungamento
straordinariamente raffinato di senso comune»xlviii. Essa persegue sempre verità e certezze che si impongono
come autoevidenti. Se ricorriamo, infatti, alla celebre la distinzione leibniziana tra verità di ragione e verità
di fatto, scopriamo che ambedue le verità sono funzionali al modo di operare della scienza moderna: le
prime, cioè le verità matematiche, dipendono dalla natura della mente e sono di per sé certe e universali,
mentre le seconde, pur essendo “contingenti” secondo la definizione di Leibniz, dipendono dai nostri sensi e
non per questo sono meno coercitive delle prima. «La fonte della verità matematica è il cervello umano, e la
capacità cerebrale non è meno naturale, né meno attrezzata per orientarci attraverso un mondo che appare,
dei cinque sensi, aggiungendo ad essi il senso comune e quel suo prolungamento che Kant chiamava
intelletto».xlix
Altra cosa è il pensiero, altra cosa sono le sue procedure, intanto perché «l’attività di pensare, al contrario,
non lascia nulla di così tangibile dietro di sé»l e poi perché il pensiero, collocandosi sempre al di là della
verità scientifica, non può restare legato ai criteri di evidenza propri del mondo delle apparenze. Nella
distinzione kantiana tra Vernunft (ragione) e Verstand (intelletto), cioè tra la ragione intesa come la facoltà
del pensiero speculativo, capace di inoltrarsi in territori a lei sconosciuti, e l’intelletto che è la nostra capacità
di conoscere che scaturisce dall’esperienza sensibile, Hannah Arendt intravede una diversa lettura della
Critica della ragion pura, ma più in generale tenta di emancipare il criticismo kantiano da un impianto di
tipo epistemologico, per restituire al pensiero una sfera di autonomia e di produzione di senso. Si tratta di un
tentativo di riabilitare la ragione, cogliendo nella sua natura delle potenzialità teoriche che non hanno nulla a
che vedere né con il senso comune né con qualsiasi modello di verità, ma attingono a questioni di significato;
vale a dire che la Dialettica trascendentale, intesa kantianamente come logica della parvenza perché disvela
le impietose illusioni della ragion pura, può essere letta come una logica del significato perché dà alla
ragione un campo d’azione che prima le era precluso, e una dignità che Kant già comunque le riconosce. È
impossibile, infatti, scrive l’Arendt, citando Kant, che la ragione, «questa suprema corte di tutti i diritti e
pretese della speculazione, sia essa stessa l’origine di inganni e illusioni».li
Hannah Arendt giunge ad affermare che lo stesso Kant non approfondì mai questa particolare
implicazione del suo pensiero, e benché abbia tracciato la linea di demarcazione tra pensare e conoscere, tra
ragione e intelletto, queste due facoltà sono intimamente legate, «malgrado la differenza estrema di toni e di
propositi»lii che i filosofi hanno sempre finito di adottare per il criterio della verità. Il che equivale a ribadire
che i concetti della ragione ci servono a concepire [begreifen, comprendere], mentre i concetti dell’intelletto
ci servono a comprendere le percezioni.liii In termini arendtiani, la distinzione kantiana tra ragione e intelletto
10
è che la prima desidera comprendere il significato di ciò che l’intelletto ha già compreso pensando gli oggetti
dell’intuizione sensibile, cioè assolvendo il suo compito di unificare il molteplice sensibile.
A differenza della ragione, l’intelletto puro, in quanto fonte dei giudizi sintetici a priori che delineano
l’orizzonte di oggettività al cui interno qualcosa si può presentare come oggetto, si configura pertanto come
la fonte di ogni oggetto e come il fondamento della stessa verità.
La lettura arendtiana del criticismo kantiano si muove dentro l’ottica di una critica radicale alla
metafisica, che ha sempre tentato erroneamente di interpretare il significato sulla falsariga della verità e di
omologare il pensiero ai risultati della conoscenza. L’errore dei filosofi è sempre stato l’ossessione della
verità.
Tuttavia, la rielaborazione arendtiana della distinzione tra pensare e conoscere trova poco sostegno nel
testo kantiano, benché l’autrice si sforzi di rilevare che ciò «comporta conseguenze molto più estese di quelle
da lui stesso riconosciute, forse anche del tutto differenti»liv. Se da un lato il ricorso alla distinzione kantiana
tra pensare e conoscere non ha altro scopo per l’Arendt se non quello di marcare la correlazione tra la sfera
fenomenica e la vita della mente che pertiene alla ricerca del significato, dall’altro, non c’è dubbio che la
lettura arendtiana di Kant risulti non priva di fascino nel ribadire una trama più ampia del pensiero rispetto al
conoscere, e rappresenti al contempo un contributo prezioso ad una revisione del kantismo, in direzione non
tanto di un’epistemologia quanto «di una teoria dell’uomo».lv
Una prima conclusione di questo complesso ragionamento arendtiano, è che il riattraversamento del testo
kantiano conduce l’autrice a due risultati importanti: uno riguarda le attività della mente che procedono
sempre dalla realtà; l’altro è che esse conservano una propria autonomia e libertà da ogni condizionamento.
Le lacrime di Penelope
Le due importanti acquisizioni del discorso arendtiano intorno alle ‘attività della mente in un mondo di
apparenze’ si fanno sentire in alcuni passaggi nodali del secondo capitolo della prima parte dell’opera
dedicato, appunto, alle attività della mente le cui caratteristiche principali sono l’invisibilità e il ritrarsi.
Proviamo ad entrare nel merito di questi due importanti attributi della vita della mente.
Intanto, non è azzardato sostenere che visibile e invisibile in Hannah Arendt hanno una palese matrice
merleau-pontyana o per lo meno, come ha osservato Laura Boella, stanno in un rapporto molto simile a
quello prospettato da Merleau-Pontylvi. Per l’uomo che pensa, il suo apparato percettivo rimane sì regolato
sull’apparenza, ma la sua primaria attività, cioè il fatto che pensa, rimane celata allo sguardo, quindi rimane
invisibile. L’attività mentale, in altri termini, è un’attività pura, silenziosa, che non possiede alcuna
manifestazione esteriore, ad eccezione della distrazione, che vuol dire noncuranza del mondo circostante; l’io
11
che pensa tende, quando pensa, a ritirarsi deliberatamente dal mondo e a trascendere sempre la mera datità di
qualsiasi cosa che abbia suscitato la sua attenzione. Sembrerebbe, ad una prima lettura, che «l’ovunque del
pensiero è effettivamente una regione del non luogo», ma su questo punto torneremo più in avanti; per il
momento ci limitiamo ad osservare che l’invisibilità è la pura trascendenza del dato, o la pura sottrazione di
ciò che è presente ai sensi. E così si spiega anche il ritrarsi o il distacco dal mondo, che non è affatto una
perdita per l’io che pensa, e che non è mai solo ma sempre in compagnia con sé stesso. Affiora qui uno dei
grandi temi dell’opera che è quello della dualità, il due-in-uno dentro lo scenario della pluralità come il tratto
costitutivo della condizione umana. A questo stato, in cui tengo compagnia a me stesso, Hannah Arendt dà il
nome di solitudine per distinguerlo dalla desolazione, dove si è altrettanto soli ma abbandonati non solo dagli
altri, ma anche dalla compagnia di se stessi.lvii
La facoltà della mente è di rendere presente ciò che è assente: ogni pensiero nasce da un ricordo, dall’aver
presenti alla mente i medesimi oggetti che una volta sono stati oggetto della percezione sensibile. Ppreleva
il file docer il pensiero, allora, sebbene non per la filosofia in senso tecnico, il ritrarsi dal mondo delle
apparenze rappresenta la sola precondizione essenziale. Perché noi si pensi a qualcuno, questi deve essere
lontano dalla nostra presenza; finché si è con lui, non si pensa né a lui né su di lui; il pensiero implica
sempre il ricordo: ogni pensare è propriamente un ri-pensare. Può certo accadere che si cominci a pensare su
qualcuno o qualcosa ancora presenti, nel qual caso ci siamo allontanati clandestinamente da ciò che ci
circonda, ci stiamo comportando come se fossimo già assenti.lviii
Quella del pensare è un’esperienza paradossale, perché da un lato è sempre ancorata al mondo, e quindi,
alla condizione della pluralità, dall’altro, invece, presuppone l’assenza del mondo, degli altri, del prossimo,
perché il pensare esige la sosta, l’interruzione da ogni fare, la sospensione di ogni attività. In questo doppio
movimento di relazione e di sospensione rispetto al mondo risiede la cifra arendtiana del pensiero, che ha
come compito quello di sorreggere le faccende umane - perché «non c’è nulla nella vita ordinaria dell’uomo
che non possa divenire cibo per il pensiero, assoggettandosi, cioè, alla duplice trasformazione che predispone
un oggetto del senso a diventare un conveniente oggetto di pensiero».lix
Occorre, però, capire meglio questo doppio movimento, ovvero la funzionalità del pensiero. Per questo
Hannah Arendt, con il sostegno del suo amato Kant, si rifà al concetto di ri-presentazione, che si attua per
mezzo dell’immaginazione: «La rappresentazione (nel senso di ri-presentazione) che rende possibile ciò che
di fatto è assente, costituisce la dote incomparabile della mente e poiché la nostra intera terminologia relativa
alla mente si basa su metafore tratte dall’esperienza della visione, tale dote ha nome immaginazione, definita
da Kant ‘la facoltà d’intuizione anche senza la presenza dell’oggetto’».lx
L’immaginazione ha il compito di preparare gli oggetti per il pensiero, di smaterializzare gli oggetti
visibili su cui la mente lavora, per trasformarli in immagini invisibili. Non è difficile cogliere come l’Arendt
si serva di un apparato categoriale tradizionale per dare una nuova spinta propulsiva al pensiero,
emancipandolo dalle concezioni metafisiche e postmetafisiche che da Platone ad Heidegger si sono
sedimentate lungo la tradizione ed hanno eretto una barriera tra il pensare e il senso comune. L’idea che il
12
pensare sia attività di tutti e non più patrimonio di pochi privilegiati, è già una netta presa di distanza dalla
tradizione del pensiero metafisico.
L’oggetto del pensiero è differente dall’immagine, come l’immagine differisce dall’oggetto visibile del
senso di cui è semplice rappresentazione. È a causa di questa duplice trasformazione che il pensiero «di fatto
va anche oltre», ben oltre la sfera di ogni possibile immaginazione, «quando la ragione proclama l’infinità
del numero che nessuna visione nel pensiero di cose corporee ha mai afferrato» o «ci insegna che anche i
corpi più piccoli sono divisibili all’infinito». L’immaginazione, pertanto, che trasforma un oggetto visibile in
un’immagine invisibile, idonea a essere immagazzinata nella mente, costituisce la condizione sine qua non
per fornire alla mente convenienti oggetti di pensiero; ma tali oggetti di pensiero, a loro volta, vengono alla
luce solo quando la mente ricorda in modo attivo e deliberato, raccoglie e tra-sceglie dal deposito della
memoria tutto ciò che desti il suo interesse in maniera sufficiente a causare concentrazione. In queste
operazioni la mente apprende come affrontare e trattare le cose che sono assenti, e si prepara insieme ad
«andare oltre», verso la comprensione di cose che sono per sempre assenti, di cui non può esservi ricordo
perché non sono mai state presenti all’esperienza sensibile.lxi
La caratteristica della mente è questo suo «andare oltre», questo suo trascendere la natura: nell’atto di
pensare io non sono dove sono in realtà, né tanto meno ho nozione della mia corporeità: la regione in cui
sono è immateriale, invisibile, situata ben al di là del mondo fenomenico, «una sorta di terra di nessuno, la
terra dell’invisibile, di cui non saprei nulla se non mi fosse data questa facoltà di ricordare e di
immaginare»lxii. Con immagini poetiche molto suggestive, Hannah Arendt paragona il processo del pensiero
che interrompe la sua attività nell’ordinario mondo della vita, al desiderio di Orfeo che si volta
immediatamente a vedere Euridice e questa scompare: così ogni invisibile svanisce di nuovo.
L’interpretazione arendtiana di Kant presuppone, quindi, che il pensiero debba liberarsi dai lacci della verità
scientifica né può restare legato ai criteri di evidenza della sfera fenomenica, ma deve piuttosto trascendere
tale sfera, scoprendo il significato che le apparenze rivelano alla mente dell’uomo.
Il Pensare è dunque un’esperienza di tutti e di ciascuno, una sorta di maieutica socratica che tende non
solo a riesaminare e mettere in discussione ogni dato dell’esperienza, ma a soddisfare il nostro bisogno di
dare un senso a quello che pensiamo e a quello che facciamo. Anzi, il pensiero è tutt’uno con la vita perché
una vita senza pensiero non è completamente viva.lxiii
A questo punto, la ricerca dell’autrice prende una direzione laterale almeno rispetto ai canoni della
tradizione che mai, ad eccezione di Platone ne Il Sofista, aveva osato esplorare il luogo di chi pensa: se il
pensiero, infatti, è un’attività che si allontana da ciò che è presente e vicino, allora dove siamo quando
pensiamo? Ovvero, dove si trova il luogo del pensiero? Sono domande che lo stesso Platone aveva lasciato
senza risposte, mentre l’Arendt, proprio alla luce della particolare natura del pensiero in quanto attività
smaterializzante, ritiene che una ricognizione spaziale del pensare sia fuorviante: «L’ovunque del pensiero è
effettivamente una regione del non luogo.»lxiv
13
Ciò vorrebbe dire che la domanda era sbagliata, perché non siamo solo nello spazio, ma anche nel tempo:
perché se il pensare, come diceva Agostino, è raccogliere e anticipare dalla memoria ciò che non è più
presente, o progettare ciò che non è ancora, allora il “vero luogo” del pensiero è nel tempo, e questo luogo
non può essere che il presente. Ma facciamo un passo indietro per meglio dipanare i fili dell’argomentazione
arendtiana. Come è possibile, infatti, l’incontro tra l’invisibile e il visibile, tra il pensiero e il mondo in cui si
esercita l’attività dell’io che pensa? È un interrogativo cruciale per l’indagine che permette all’Arendt di
chiamare in causa per la prima volta e in maniera sistematica il linguaggio e quella particolare connessione
tra pensiero e linguaggio, perché «non l’anima ma la mente richiede la parola».lxv
Il linguaggio è il solo medium mediante il quale le attività della mente possono manifestarsi non solo al
mondo esterno, ma anche allo stesso io della mente, e nessun linguaggio possiede un vocabolario già pronto
per i bisogni dell’attività della mente. L’attenzione arendtiana sul linguaggio trova il proprio sbocco
nell’analisi della metafora che meglio si presta a definire la natura e l’attività del pensiero: «Al pensiero
senza immagini, astratto, la metafora fornisce un’intuizione tratta dal mondo delle apparenze la cui funzione
è di “provare la realtà dei nostri concetti”, annullando dunque, per così dire, quel ritrarsi dal mondo delle
apparenze che è la pre-condizione delle attività spirituali. […] La metafora effettua il metapherein – transportare – […] il passaggio da uno stato esistenziale, quello del pensare, a un altro, quello di apparenza tra le
apparenze».lxvi
Proprio nell’appello del suo metapherein, del trans-portare, del portare oltre le nostre esperienze
sensibili, la metafora consente di ricomporre la scissione operata dalla metafisica tradizionale tra i “due
mondi” dell’essere e dell’apparire: offrendo al pensiero un riavvicinamento, ma anche una
complementarietà, tra mondo dell’apparenza e l’ineffabile, essa corrobora la vita della mente, la svincola dai
lacci della fattualità pur consentendole di essere “stretta al mondo”.
Nel suo essere non un artificio semiologico, ma un modello di orientamento nel mondo dell’esperienza e
nel modo di fare esperienza del mondo, la metafora può consentire all’individuo di reintegrare, nella sua vita
di relazione, l’unità tra interiore ed esteriore, tra sfera privata e sfera pubblica del vivere. La metafora è,
dunque, il filo con cui la mente si tiene stretta al mondo, è letteralmente trasposizione dell’invisibile nel
visibile, punto di congiunzione tra le attività interiori e invisibili della mente e il mondo delle apparenze: «la
metafora fu sicuramente il dono più grande che il linguaggio potesse offrire al pensiero e quindi alla
filosofia, ma in sé e per sé prima che filosofica la metafora è originariamente poetica.»lxvii
Questa citazione meriterebbe ben altro approfondimento per tutte le implicazioni e i rapporti tra
linguaggio poetico e linguaggio filosofico e per la funzione che Hannah Arendt, anche sulla scia del suo
maestro Heidegger, sembra assegnare alla poesia, cioè quella di tracciare una via per il pensiero, perché il
pensiero necessita di poesia.
C’è un episodio illuminante a tal proposito, che l’autrice trae dall’Odissea omerica. Odisseo, travestito da
mendicante, ritorna ad Itaca e incontra Penelope: dicendo molte menzogne le racconta di aver conosciuto suo
marito a Creta, al che Penelope reagisce lasciando scorrere copiose le lacrime, così come si scioglie la neve
14
sulle cime dei monti e riempie i fiumi. In questi termini si esprime Omero: «così si scioglievano le sue belle
guance nel piangere, piangendo Penelope lo sposo che le era seduto accanto». Qui, commenta l’Arendt,
abbiamo soltanto enti visibili: «le guance di Penelope non sono meno visibili della neve che si scioglie»;
però l’invisibile che è reso palese da queste immagini metaforiche è l’insieme dei pensieri che travagliano
Penelope e che costituiscono il significato delle lacrime. Quindi le lacrime sono una sorta di pensiero
congelato che il pensare deve scongelare
lxviii
. La potenza di queste immagini e di queste associazioni (se le
lacrime sono il dolore e la neve che si scioglie è l’annuncio di una nuova primavera, allora un pensiero di
tristezza può trasformarsi in un pensiero di gioia) eleva la metafora al rango di un pensiero congelato: non
più o non solo un ornamento stilistico o una sostituzione lessicale motivata dalla somiglianza, ma la metafora
è soprattutto una forza generativa e rigenerativa della vita della mente, è ciò che dà frescura al pensiero
restituendogli senso e movimentolxix. In altri termini, la metafora non consiste semplicemente in un’analogia
per mezzo della quale un determinato termine viene trasferito a un oggetto diverso da quello a cui si riferisce,
sebbene a esso somigliante: «Ogni metafora porta allo scoperto “una percezione intuitiva della somiglianza
in cose dissimili” e , secondo Aristotele, rappresenta proprio per questa ragione “un segno del genio” , “di
gran lunga la cosa più grande”».lxx
Tramite la metafora, la vita della mente dà conto pienamente di se stessa, riesce a rendersi manifesta nella
sfera delle apparenze colmando il vuoto lasciato dal suo sottrarsi al mondo, si presta ad essere una specie di
campo di tensione tra il visibile e l’invisibile: «Non vi sono due mondi proprio perché la metafora li unisce.
La teoria dei due mondi è un’illusione metafisica».lxxi
La metafora, come linfa della vita della mente oltre che espressione e riconnessione di realtà e pensiero, si
presenta come “metafora viva”, parafrasando ancora Ricoeur, nel suo essere forma di azione comunicativa
creativa e immaginativa Essa è infatti potere di riscrivere il reale, dischiudendo un diverso modo di
simbolizzarlo e dunque anche di interpretarlo.
L’analisi della Arendt conduce a ritenere che proprio attraverso le metafore il pensiero può pensare la
realtà e riappropriarsi della sua origine prima nel mondo: in questo senso non è solo “ponte”, ma struttura di
concepibilità creativa e ricreativa del mondo. E perché l’attività di pensiero sia tale, è necessario che essa
non si riduca solo ad aver presente a se stessa ciò che è presente ai sensi.
Proviamo a fare una prima ricapitolazione delle cose dette fin qui.
Per Hannah Arendt il pensiero, contrariamente alle attività cognitive che lo hanno sempre usato come un
semplice strumento, è soprattutto un’attività che ha bisogno del discorso per acquistare la propria operatività,
e soprattutto è sempre un pensiero secondo che trae la propria linfa vitale dall’esperienza, apparenza tra le
apparenze. Ma il pensare è qualcosa di più: “è fuori dall’ordine”, è resistenza all’ordine, è sovversione della
logica ordinaria tipica della tradizione metafisica.
15
Il pensiero è “fuori dell’ordine” non solo perché «arresta tutte le altre attività così indispensabili alle
faccende del vivere e del sopravvivere, ma perché capovolge tutti i rapporti ordinari: ciò che è vicino e
appare direttamente ai sensi è adesso distante, ciò che è lontano è effettivamente presente.»lxxii
Pensare è essere coinvolti, pur rimanendo all’esterno, è figurativamente una specie di intercapedine tra la
presenza e l’assenza, tra il visibile e l’invisibile: pensare è appunto questo, un punto sapienziale che
approfondisce e illumina la vita di ciascun essere umano.
Se il pensiero è fuori dell’ordine, è proprio perché la ricerca di significato non dà luogo a risultati finali
che sopravviveranno all’attività stessa, che continueranno ad avere senso dopo che l’attività è giunta alla
fine. In altre parole, benché manifesto all’io che pensa, il piacere del pensare di cui parla Aristotele è
ineffabile per definizione. La sola metafora che resta, la sola che sia possibile concepire per la vita della
mente, è la sensazione della vitalità. Privo del soffio vitale il corpo umano è un cadavere; priva del pensiero
la mente dell’uomo è morta.lxxiii
Se c’è una metafora che ben si adatta al pensare, questa è la metafora socratica del vento: «I venti in sé
sono invisibili, tuttavia ciò che essi fanno è manifesto e in certo modo noi avvertiamo il loro
avvicinarsi.»lxxiv. E così è per il pensiero e il suo movimento.
Ma di questo parleremo nel prossimo paragrafo.
Il pensiero come vento
Il pensare, l’esercizio del pensare è sempre stato un ineliminabile bisogno dell’uomo e «che tale bisogno
sia coevo all’apparizione dell’uomo sulla terra»lxxv è un dato di fatto.
La premessa arendtiana chiarisce un punto molto importante che non si può sottacere: mai può venire in
discussione, nonostante la rottura di una determinata modalità di pensare, la più generale capacità umana di
pensare e la possibilità di continuare a fare filosofia. Perché di questo si tratta: la fine del pensiero metafisico
può mettere in luce altre vie, altre potenzialità del pensare, e per la tesi che vogliamo dimostrare Hannah
Arendt si spinge a legittimare una dimensione, per così dire orizzontale del pensare in opposizione alla
dimensione verticale del pensiero astratto di marca platonica e heideggeriana.
Il pensare orizzontale è il pensare narrativo che, a dispetto della ricerca della verità, predilige la ricerca
del significato, di ciò che pulsa nell’esperienza vivente. Un pensare che non abbia legami con la vita non è
un pensare: «il significato di ciò che di fatto accade, e appare accadendo, si rivela dopo che è scomparso: il
ricordo, con il quale si rende presente alla mente ciò che di fatto è assente e passato, svela il significato
16
nella forma del racconto. Colui che compie il disvelamento non è coinvolto in ciò che appare: è cieco, ben al
riparo del visibile, proprio per essere in grado di “vedere” l’invisibile».lxxvi
Spostamento e movimento sono gli attributi di un pensare che declina verso la narrazione: spostamento
tra ciò che è lontano e ciò che è vicino, movimento fra ciò che è consegnato al ricordo e ciò che ci è
immediatamente accanto. Il pensare narrativo è, dunque, un pensare che si sgancia dall’oggettività e riporta
in auge l’antico motivo greco del thauma, dello stupore generato dallo spettacolo della vita e dalle cose del
mondo.
Lo stupore è il principio primo del pensare come ben sapevano Platone ed Aristotele che lo posero
all’origine della filosofia e della metafisica. Lo stupore è ciò che ci fa pensare.
Ma un conto è se il quesito “Che cosa ci fa pensare?” è posto dai cosiddetti filosofi di professione, «una
specie così difficile da frequentare» perché mai sanno sganciarsi dai loro contenuti dottrinali come
dimostrano secoli di storia della filosofia sin dai Greci, altro conto se è posto dal senso comune che abita in
ciascuno di noi e che induce ad interrogarci su un’attività che nella vita ordinaria è fuori dell’ordine. L’unico
filosofo che è riuscito a scuotere il senso comune in sé e a spogliarsi dei suoi interessi professionali di
pensatore è Socrate, il grande personaggio della cultura greca del quinto secolo che più di ogni altro ha
influenzato l’intera opera dell’autrice.lxxvii
Ancora una volta, è una metafora che soccorre l’insegnamento di Socrate quando questi esercita l’attività
del pensiero coi suoi amici e discepoli. La metafora è quella del vento perché il pensiero è come il vento,
solleva, spazza via, disgrega, smuove, scuote certezze, fissità, valori , tradizioni, unità di misura del bene e
del male. Socrate ha avuto il merito, nel paragonarsi di volta in volta ad un tafano, ad una levatrice, ad una
torpedine, di alimentare il potenziale metaforico del pensiero, tracciandone sempre nuovi e potenziali
percorsi destabilizzanti.
Ogni volta che si leva il vento del pensiero, nulla può essere più come prima: «È nella natura di
.quest’elemento invisibile, disfare, disgelare, per così dire, ciò che il linguaggio, il medium del pensiero, ha
congelato in parole del pensiero (concetti, proposizioni, definizioni, dottrine).»lxxviii
Come la tela di Penelope, il pensiero disfa di notte ciò che si tesse di giorno, con la conseguenza che esso
rivela un insolito effetto distruttivo. Socrate ne è consapevole a tal punto che punzecchia e pungola i suoi
concittadini perché si accorgano di non avere in mano se non dei dubbi, delle perplessità. Imparare ad
esercitare il pensiero è il nucleo dell’insegnamento di Socrate, ma con Socrate e oltre Socrate, pensare è
sempre un’attività pericolosa e destabilizzante “per tutti i credi” perché «ogni volta che ci troviamo di fronte
a qualche difficoltà nella vita siamo costretti a decidere ripartendo da zero».lxxix
Il pensare produce, pertanto, un effetto paralizzante per l’uomo: ripartire da zero non è semplice, in
quanto egli si ritrova incerto e dubbioso davanti a ciò che invece sembrava convincente prima di pensare. Lo
sforzo per ricominciare è pari a quello del pescatore di perle che decide di esplorare i fondali marini (della
metafisica) per riportare benjaminianamente alla luce ‘coralli’, cioè frammenti di pensiero.
17
Il Socrate arendtiano è da sempre impegnato in questa ricerca, lavora con concetti abituali, ‘quotidiani’
come la giustizia, il coraggio, la felicità. Però, non appena si impossessa di queste nozioni all’apparenza
tanto familiari, esse diventano immediatamente problematiche, incerte nel loro significato. Si apre così il
problema su cui tanto insiste l’autrice, del rapporto fra i concetti come forme di pensiero congelato e il
pensare vero come atto del loro scongelamento in vista della scoperta del loro vero significato. Si afferma
quasi un’antinomia: da un lato il pensiero ci scuote dal sonno e quindi ci tiene costantemente svegli e fa
tutt’uno con la vita, dall’altro, però, esso non produce immediati risultati tangibili: l’unico risultato
verificabile e certo risiede nel processo stesso del pensare. È l’atto del pensare in quanto tale che va preso in
considerazione.
Hannah Arendt, addentrandosi nella natura del pensare scopre così una drammatica aporia che la porta
inevitabilmente a cercare delle soluzioni possibili. In altre parole, se il pensiero è solo ricerca, brezza salutare
che scuote, e per di più una ricerca che può anche degenerare, non certo meno rischiosa di quanto sia il nonpensare, cosa può produrre in ordine al problema del bene e del male e più in generale in ordine ad una vita
che sia etica? Affiora qui prepotentemente la questione del male che proviene dalla mancanza di pensiero,
ma che esula ora dal nostro discorso.
Certo, se nel pensiero occidentale fosse esistita una tradizione socratica, annota con una punta di leggera
ironia l’autrice, se, nelle parole di Whitehead, la storia della filosofia, fosse una raccolta di note a pie’ di
pagina, non a Platone, ma a Socrate, per il pensare, e anche per la filosofia sarebbe stata tutt’altra storia.lxxx
Ma tant’è: per districarsi dall’aporia, bisogna ancora interrogare Socrate.
La Arendt esamina due affermazioni socratiche contenute nel Gorgia platonico. La prima è: «Patire un
torto è meglio che commetterlo», la seconda dice: «Personalmente, sarebbe meglio suonare una lira scordata,
dirigere un coro stonato e dissonante, e anche che molti uomini non fossero d’accordo con me, piuttosto che
io, essendo uno, fossi così in disarmonia e in contraddizione con me stesso»lxxxi. In queste due affermazioni,
soprattutto nella seconda, si sottintende il tema di una costitutiva dualità dell’essere umano - il due-in-uno che è uno dei grandi motivi della Life of Mind, ma direi, dell’intera opera arendtiana.
Di questo due-in-uno vive il pensiero, tanto che Platone ha potuto definire quest’ultimo come il dialogo
senza voce fra me e me stesso; nel dialogo fra me e me stesso io sono costretto a fare i conti con le mie
azioni e le mie scelte e devo giustificarle di fronte a un mio altro io, senza perciò possibilità di mentire. E sta
qui la soluzione del problema del rapporto tra pensiero e vita eticalxxxii. Se il pensiero può qualcosa contro il
male, se riveste una qualche valenza etica, ciò non dovrà attribuirsi agli eventuali oggetti che si darà o
produrrà, ma piuttosto dovrà annettersi all’attività di pensare in quanto tale: «Se nel pensare esiste realmente
qualcosa che possa impedire agli uomini di fare del male, deve trattarsi d’una proprietà inerente all’attività
stessa, indipendentemente dai suoi oggetti.»lxxxiii
La dualità del due in uno è, come dire, un factum della pluralità interna, una modalità di conoscenza che
si attualizza in ogni processo del pensiero, una prevenzione per discernere ed evitare il male. Ciò conferma
come l’idea arendtiana di pluralità coniughi e congiunga le sfere della vita activa e della vita contemplativa,
18
il vero punto di contatto diretto tra la dimensione di ciò che facciamo e ciò che facciamo quando pensiamo,
tra lo spazio aperto in cui parliamo e agiamo in mezzo agli altri, e quello dove siamo soli con noi stessi.
Ma, ancora una volta, non è l’attività di pensiero a costituire l’unità, a unificare il due-in-uno; al contrario,
il due-in-uno diviene Uno non appena il mondo esterno si imponga di forza al pensatore e tronchi
bruscamente il processo di pensiero. Allora, quando è richiamato per nome nel mondo delle apparenze, là
dove è sempre Uno, è come se nel pensatore, scisso in due dal processo di pensiero, la differenza si
richiudesse di colpo. In termini esistenziali, pensare costituisce un’occupazione solitaria, ma non è
l’occupazione dell’isolato. La solitudine è quella situazione umana in cui tengo compagnia a me stesso. La
desolazione dell’isolamento si produce quando sono solo senza essere capace di scindermi nel due-in-uno,
senza essere capace di tenermi compagnia, allorché, come soleva dire Jaspers, “vengo meno a me stesso”
(ich bleibe mir aus) o, per dirla in altro modo, quando sono uno e senza compagnia: «Nulla forse indica con
più forza che l’uomo esiste essenzialmente al plurale dal fatto che nel corso della sua attività di pensiero la
solitudine attualizza la semplice coscienza di sé, che probabilmente egli ha in comune con gli animali
superiori come una dualità.»lxxxiv
In questa dualità dunque risiede l’essenza del pensare, il cui criterio di validità non sarà né l’intuizione
data nell’evidenza sensibile, né la deduzione del ragionamento logico, ma l’accordo, l’essere coerenti con se
stessi. La differenza tra me e me stesso, d’altra parte, presuppone che il pensiero - «come attualizzazione
della differenza che si dà nella coscienza» - sia in ascolto dell’altro che è in me.
Gli esseri umani vivono nella pluralità e ne dipendono anche per la vita della mente, che si dà solo alla
condizione della pluralità. La natura intrinsecamente dialogica del pensiero mostra come nella solitudine
dell’io che pensa valga pur sempre la pluralità, che è la legge della terralxxxv. Anche il problema della vita
etica trova così la sua ragion d’essere nella dualità perché chi non conosce il dialogo tra me e me non entrerà
mai in contraddizione con se stesso e mai potrà vigilare le sue azioni e le sue scelte. Pertanto ciascuno di noi
deve vigilare ed esercitarsi nella ricerca del significato, perché ogni giorno bisogna fare i conti con l’agire.
Questa impresa, tuttavia, non sarà affidata al pensare, ma al giudicare, ossia a quella particolare attitudine a
discernere il bene dal male, il bello dal brutto, che è considerata da Hannah Arendt la più politica delle nostre
facoltà spirituali, quella che consente di dare forma e spessore all’unità tra la vita della mente e la vita attiva,
fornendo un effetto visibile all’invisibile vento del pensiero.lxxxvi
Non è azzardato sostenere che la pratica socratica del pensare apra canali di comunicazione tra la sfera del
pensare e la sfera dell’agire nel senso di una unitarietà dell’esperienza umana, e comprovi al contempo anche
una forte unitarietà e coesione del pensiero arendtiano.
Egli
19
La complessa disamina arendtiana dedicata al Pensare si conclude con un ulteriore interrogativo: Dove
siamo quando pensiamo? che abbiamo già richiamato in alcuni passaggi precedenti. Si tratta di esplorare la
spazialità del pensare, ma paradossalmente occorre misurarsi col tempo, perché quando pensiamo non siamo
solo nello spazio, ma anche nel tempo, ricordando ad esempio il passato e progettando il futuro. Pertanto,
non può non essere il presente il luogo dell’io che pena.
Come ha notato Alessandro Dal Lago, nell’introduzione italiana alla Vita della mente, «questa domanda
impone, una volta di più, che il soggetto si confronti con il problema del tempo». lxxxvii Il tempo è il grande
tema della filosofia arendtiana, è il pensiero dominante di tutti i suoi libri sin dalla Dissertatio su Agostino
pubblicata nel 1929, e risente fortemente delle influenze heideggeriane.
Il punto teoretico rilevante che Hannah Arendt mette a fuoco, con lucidità teorica e con grande
padronanza filologica, a partire dai testi di Agostino, è come porre rimedio a superare la tensione irrisolta in
cui la nostra esistenza è già da sempre gettata tra la dimensione della fugacità e la dimensione dell’eterno, o
in altri termini la possibilità di conciliare la temporalità dell’esistenza con la stabilità del mondo. È un’aporia
drammatica che mette capo ad un’unica certezza: l’impossibilità di dominare il tempo. La vita umana sulla
terra, rapportata al mondo, è drammaticamente intrisa di fugacità, di contingenza e di imprevedibilità. Un
motivo in più per congedarsi dalla filosofia, che ha sempre evitato di confrontarsi con questo dato
drammatico della condizione umana. Un simile legame tra il pensiero e la sua costituzione temporale, trova
una folgorante sintesi in una parabola kafkiana dal titolo “Egli”, che Hannah Arendt trae dagli scritti del suo
scrittore più amato:
«Egli ha due avversari; il primo lo incalza alle spalle, dall’origine, il secondo gli taglia la strada davanti.
Egli combatte con entrambi. Veramente il primo lo soccorre nella lotta col secondo perché vuole spingerlo in
avanti, e altrettanto lo soccorre il secondo nella lotta col primo perché lo spinge indietro. Questo però
soltanto in teoria, poiché non ci sono soltanto i due avversari ma anche lui stesso: e chi può dire di conoscere
le sue intenzioni? Certo sarebbe il suo sogno uscire una volta, in un momento non osservato – è vero che per
questo ci vuole una notte buia come non è stata mai – dalla linea di combattimento, e per la sua esperienza
nella lotta essere nominato arbitro dei suoi avversari, che combattono fra loro.»lxxxviii
Questa parabola descrive la percezione temporale dell’io che pensa, che lacera il continuum temporale;
ciò non si deve al tempo stesso, ma alla continuità delle nostre occupazioni della vita quotidiana e dei nostri
affari nel mondo. La parabola kafkiana sovverte innanzitutto una concezione lineare e continuistica del
tempo: abituati come siamo a considerare il presente come il tempo limite che indica il trascorrere del futuro,
che ci viene incontro, come qualcosa che è davanti a noi, il passato, inteso come il tempo che si allontana
sempre di più, è qualcosa che è situato dietro di noi. Il presente allora è il più evanescente dei tempi, il
semplice passaggio dal passato al futuro e viceversa. L’Egli kafkiano, invece, interrompe il continuum
temporale e concentra i propri sforzi su di sé, sull’esperienza che sta vivendo del suo essere presente, perché,
in quanto pensa, Egli sente il bisogno di soffermarsi per riflettere: si mette di traverso fra il suo passato e il
20
suo futuro che lo incalzano da entrambe le direzioni e, con il suo frapporsi, produce una frattura che difende
dal duplice attacco, aprendo una lacuna che costituisce il campo di battaglia.
Il presente è questa lacuna, ma è anche un vero e proprio punto di resistenza e di scontro, per così dire,
con le dimensioni della temporalità: qui troviamo il nostro luogo temporale quando pensiamo, cioè quando
siamo sufficientemente discosti dal passato e dal futuro per ricercarne il significato, e per prevenirne le
azioni destabilizzanti, perché ciò che «l’io che pensa avverte come ‘suo’ duplice avversario è il tempo stesso,
col mutamento ininterrotto che esso implica, il moto senza posa che trasforma ogni Essere in Divenire invece
di lasciarlo essere, e in questo modo distrugge incessantemente la presenza del suo presente»lxxxix. L’io che
pensa è un io straniero, perché si sposta in una sfera diversa, che non è quella degli uomini che vivono e
agiscono nella prospettiva del divenire - che è la prospettiva del fluire del tempo e del suo strutturarsi su una
linea retta. Per questo motivo il tempo è il maggior nemico dell’io che pensa: l’Egli kafkiano è un eroe
resistente, una specie di guerriero che lotta contro il tempo per difendere e far durare il proprio presente.
Questo presente senza mutamento, che i pensatori medievali denominavano nunc stans e che fungeva da
metafora dell’eternità divina, per Hannah Arendt rimane invece un campo di battaglia perenne, perché non ci
si può mai sottrarre alla lotta contro il passato e il futuro e tanto meno uscire, come anche Kafka riteneva
possibile, dalla linea di combattimento per osservare dall’esterno lo scontro, o giudicarlo senza più esserne
coinvolto. Tale, purtroppo, è stato il sogno impietoso di tutta la metafisica occidentale, da Parmenide a
Hegel: essi hanno preteso di accedere ad una regione senza tempo e di produrre uno spettatore in grado di
contemplarla. Per usare un’altra metafora, il presente è «la quiete dell’occhio del ciclone che, anche se
completamente diverso dal ciclone, fa tuttavia parte di esso»xc. In sintesi, l’Arendt, per rettificare il suo punto
di vista anche rispetto all’Egli kafkiano, presenta questa figura in cui l’azione delle due forze, il passato e il
futuro che formano i lati del parallelogramma, determina una terza forza, la diagonale che interseca la
direzione del pensiero, «la cui origine sarebbe allora il punto nel quale le forze s’incontrano e sul quale
agiscono».xci Dal punto di vista del presente che sta in mezzo, le due forze del passato e del futuro, benché
abbiano un’origine indeterminata, hanno però un termine ultimo, a differenza della diagonale (del pensiero)
che ha un’ origine conosciuta, e una direzione determinata (dal passato e dal futuro), ma indeterminata
rispetto al suo termine.
Per Hannah Arendt, la diagonale è la metafora che si presta assai bene all’attività del pensare, e insieme
una correzione di rotta dell’Egli kafkiano che, se avesse scoperto questa diagonale, non avrebbe avuto
bisogno di uscire dalla linea di combattimento.
21
Dove siamo quando pensiamo
Infinito
direzione del pensiero
Infinito
futuro
Presente
Infinito
Passato
Ci sia consentito di affermare, anche alla luce delle considerazioni fin qui svolte, che se la temporalità del
pensiero è caratterizzata dal primato del presente, «il più transitorio dei tempi nel mondo delle apparenze»,
allora è anche vero che l’esperienza dell’io che pensa è un’esperienza che dura in mezzo alla transitorietà
mutevole del mondo e delle vicende degli uomini, e ancora di più una risposta efficace alla precarietà, che è
la cifra più propria della condizione umana. Non è un caso che dal pensiero si originano le grandi opere che
resistono alla distruzione del tempo.xcii
22
i
H. Arendt, The Life of the Mind, ed. by M. Mc Carthy, New York, Harcourt, Brace & Jovanovich, 1978, 2
voll.; La vita della mente, a cura di A. Dal Lago, tr. it. di G. Zanetti, Bologna, Il Mulino, 1987, p.306.
ii
Ibidem, p.307.
iii
H. Arendt, Il futuro alle spalle, a cura di L. Ritter Santini, tr. it. di V. Bazzicalupo e S. Muscas, Il Mulino,
Bologna 2000, pp.43-103. In particolare sul pensare poeticamente, l’autrice scrive: “Questo pensiero, nutrito dell'oggi,
lavora con i ‘frammenti di pensiero’ che può strappare al passato e raccogliere intorno a sé. Come il pescatore di perle
che arriva sul fondo del mare non per scavarlo e riportarlo alla luce, ma per rompere staccando nella profondità le cose
preziose e rare, perle e coralli, e per riportarne frammenti alla superficie del giorno, esso si immerge nelle profondità del
passato non per richiamarlo in vita così come era e per aiutare il rinnovamento di epoche già consumate. Quello che
guida questo pensiero è la convinzione che il mondo vivente ceda alla rovina dei tempi, ma che il processo di
decomposizione sia insieme anche un processo di cristallizzazione; che nella ‘protezione del mare’ - nello stesso
elemento non storico cui deve cedere tutto quanto si è compiuto nella storia - nascono nuove forme e formazioni
cristalline che, rese invulnerabili contro gli elementi, sussistono e aspettano solo il pescatore di perle che le riporti alla
luce: come ‘frammenti di pensiero’, come frammenti o anche come eterni ‘fenomeni originari’” (p.99).
iv
H. Arendt, La vita della mente, cit., p.307.
v
Ibidem, p.161.
vi
Ibidem, p.103
vii
H. Arendt - M. McCarty, Tra amiche. La corrispondenza di H. Arendt e M. McCarty(1949-1975), a cura di C.
Brightman, tr.it.di A. Pakravan Papi, Sellerio Editore, 1999, Palermo, p.383.
viii
M. McCarty, Prefazione all’edizione americana in La vita della mente, Op.cit., p.65.
ix
H. Arendt, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1958; introd. di A. Dal Lago, tr. it. di
S. Finzi, Vita Activa, Milano, Bompiani, 1994, p.128.
x
H. Arendt, La vita della mente, cit., p.151.
xi
Ibidem, p.153.
xii
Ibidem, p.152.
xiii
Ibidem, p.84. Cfr. una lettera di M. McCarty ad Hannh Arendt del 9 Giugno del 1971, in Tra amiche, cit.,
p.518. La McCarty faceva notare all’Arendt che non vedeva veramente chiara la distinzione tra ‘la mancanza di
riflessione’ e ‘la stupidità’. Essere profondamente stupidi, come nel caso di Eichmann, non vuol dire avere un basso
quoziente di intelligenza.
xiv
Ibidem, p.87.
xv
Il rapporto tra Arendt ed Heidegger è complesso e contraddittorio poichè si evolve, tra alti e bassi, lungo il
corso degli anni. Cfr. Simona Forti, Vita della mente e tempo della polis, Franco Angeli, Milano 1996, nota 25, p.55. Se
a partire dal saggio che stiamo esaminando “Che cos’è la filosofia dell’esistenza” (1946), l’autrice celebra la filosofia
di Jaspers, tacciando di ambiguità quella heideggeriana, otto anni dopo è la volta del saggio L’interesse per la politica
nel recente pensiero filosofico europeo (1954), in «aut, aut», sett.- dic.1990, n.239-240, pp.31-46, nel quale il pensiero
heideggeriano è rivalutato per la messa a fuoco dell’aspetto plurale e mondano dell’esistenza. Ma l’omaggio vero e
proprio che l’Arendt tributa all’antico maestro è il saggio del 1969, M. Heidegger ist Achtzig Jahre Alt, «Merkur»5
XXIII, n.10, pp.893-302, ora in «MicroMega», n.2, 1988, pp.165-179, col titolo Martin Heidegger a Ottant’Anni. La
filosofia heideggeriana è presentata come la vera testimonianza dell’attività del pensare. Infine, in luoghi decisivi della
Vita della Mente, cit., pp.497-522, la Arendt sembra appropriarsi dell’eredità heideggeriana. Cfr.,inoltre, il prezioso
volume di F. Fistetti, Hannah Arendt e Martin Heidegger,.Alle origini della filosofia occidentale, Roma, Editori Riuniti,
1998 e il fondamentale libro di R. Schurmann, Dai principi all’anarchia. Essere e agire in Heidegger, Bologna, Il
Mulino, 1995.
xvi
F. Fistetti, Hannah Arendt e Martin Heidegger..Alle origini della filosofia occidentale, cit.,pp.52-53. E’
difficile escludere - fa notare l’autore - che l’Arendt non stesse pensando in questi passaggi ad Heidegger e ai suoi
rapporti con il nazionalsocialismo.
xvii
A. Dal Lago, La difficile vittoria sul tempo. Pensiero e azione in Hannah Arendt, Introduzione all’edizione
italiana de La vita della mente, cit., p.14.
xviii
H. Arendt, La vita della mente, cit.., p.99.
xix
Ibidem., p.102.
xx
Ibidem, p.103.
xxi
Ibidem, p.91.
xxii
Ibidem, p.103.
xxiii
I testi di A. Portmann cui Hannah Arendt fa riferimento sono: Die Tier als soziales Wesen, Zürich, 1953, e Die
Tiergestalt Studien uber die Bedeutung der tierischen Erscheinung, Basel, 1960, in Id., La vita della mente, cit., p.108,
note 11 e 12.
xxiv
Ivi.
xxv
Ivi.
23
xxvi
Ibidem, p.109.
Ibidem, p.102.
xxviii
Ibidem, p.106.
xxix
Cfr. L. Boella, Hannah Arendt “fenomenologia”. Smantellamento della metafisica e critica dell’ontologia, in
“Aut Aut”, n. 239-240, 1990, pp.83-110. L’apparenza, secondo la Boella, si costituisce, non come rappresentazione,
oggetto e costruzione del pensiero, bensì nei movimenti della percezione (p.103), Sul tema dell’apparenza nell’opera
dell’Arendt ha scritto pagine intense E. Tassin, La question de l’apparence, in M. Abensour (a cura di), Ontologie et
Politique. Actes du Colloqui Hannah Arendt , Editions Tierce, Paris 1989, pp.63-84..
xxx
H. Arendt, La vita della mente, cit.,p.118.
xxxi
Cfr. le interessanti annotazioni del traduttore all’edizione italiana alla Vita della mente che non .nasconde le
difficoltà per la resa nella lingua italiana del termine mind che può essere tradotto sia con mente (seguendo l’uso
corrente) sia con spirito (seguendo un certo uso filosofico di tono, però, storicistico e idealistico). Comunque - nota
Zanetti - Hannah Arendt intende con mind sia il complesso delle attività mentali (elaborazione dei dati percettivi,
pensare, immaginare ecc.) sia il complesso delle funzioni superiori della mente (meditare, teorizzare, rammemorare). In
ultimo, in termini arendtiani mind copre sia il mentale che lo spirituale (p.60).
xxxii
Ibidem, p.112.
xxxiii
Cfr. un saggio intenso su queste tematiche di Laura Boella, Cuori indistruttibili. L’idea di umanità in Hannah
Arendt, in “La società degli individui”, n.13, Anno V, 2002/1, Franco Angeli, pp.19-37.
xxxiv
H.Arendt, La vita della mente, cit., pp.154-155.
xxxv
Ibidem, pp.113.
xxxvi
Ibidem, p.129.
xxxvii
Ivi. Cfr., inoltre M. Merleau-Ponty, Segni, a cura di A. Bonomi, tr. it. di G. Alfieri, Net, Milano 2003, p.44 e
p.220. Per gli studi più approfonditi sul rapporto tra H. Arendt e M. Merleau-Ponty, anche in merito alla foi perceptive,
si rinvia a A. Enegrén, Hannah Arendt, lectrice de Merleau-Ponty, in “Esprit”, 1982, 6, pp.154-155. Nell’opera
arendtiana, come affermano anche gli autorevoli pareri di A. Dal Lago e di L. Boella, sono tracciate le linee di quella
che potrebbe essere definita “un’ontologia dell’apparenza” di chiara derivazione merleau-pontyana.
xxxviii
H. Arendt, La vita della mente, cit.,128.
xxxix
Ibidem, p.133-134.
xl
Ibidem, p.136.
xli
Ibidem, p.122-123.
xlii
Cfr. Ivi.
xliii
I. Kant, Critica della ragion pura, tr.it. di G. Gentile e G. Lombardo Radice, riv. da V. Mathieu, sesta
edizione, Bari, Laterza, 1977, p.175. Il passo è tratto dall’Analitica dei principi, libro II, sezione II, Del principio
supremo di tutti i giudizi sintetici.
xliv
H. Arendt, La vita della mente, cit., pp.123-124.
xlv
Hannah Arendt non ha mai scritto un libro su Kant. E tuttavia un rapporto intenso e speciale ha legato
l’Arendt, lungo il corso di tutta la sua vita, al filosofo di Kőnigsberg. Nelle opere giovanili e della maturità, nelle
conferenze, nei carteggi (con Martin Heidegger, con Karl Jaspers, con Mary McCarty) il nome di Kant ritorna sempre
come un’ombra che veglia e segue passo per passo lo sviluppo e l’evoluzione del suo pensiero.
xlvi
Ibidem, p.97. Cfr. F. Fistetti, I Filosofi e la polis, La scoperta del principio di ragion sufficiente, Pensa
Multimedia, Lecce 2004, pp.54-56. L’autore vede in questa rielaborazione arendtiana della dicotomia verstand/vernunft
il dissidio fin troppo esplicito dell’autrice con Heidegger perché non vi è dubbio “che ad essere preso di mira è il
progetto heideggeriano di re(in)saturazione della questione dell’Essere in una con la tecnica della Destruktion ad esso
finalizzato. Fin da Essere e Tempo il Fragen di Heidegger assume la verità - l’aletheia - come ‘compito del pensiero’ e
come suo esercizio interminabile ed inesauribile”.
xlvii
Ivi.
xlviii
Ibidem, p.137.
xlix
Ibidem, p.144.
l
Ibidem, p.147.
li
Ibidem, p.149.
lii
Ibidem, p.96.
liii
Ibidem, p.141.
liv
Ibidem, p.147. Si veda in questa pagina per esteso la nota 83, in cui l’Arendt scrive “che la sola interpretazione
di Kant a me nota che si potrebbe citare a sostegno della mia lettura…è l’analisi della Critica della ragion pura
compiuta da Erich Weil, Penser et Connaitre, La Foi et la Chose-en-soi, in Problemès Kantiens, Paris 1970”. L’Arendt
attribuisce a Weil non solo la capacità di restare più fedele al modo in cui Kant leggeva se stesso, ma soprattutto una
lettura antropologica dell’intera filosofia kantiana.
xxvii
24
lv
Cfr. E. Tavani, «Senso comune» estetico e spazio politico. Le Lectures di Hannah Arendt su Kant, in La
Ragione possibile, Rivista di Filosofia e teoria sociale, anno 3, n.1 inverno 1992-primavera 1993, Edizioni Bagatto
Libri, Roma, pp.231-256. “Se il pensare- scrive la Tavani - oltre il suo utilizzo come ‘sapere’ e come ‘fare’ (VM, p.93)
si concreta, come troviamo ribadito nelle Lezioni, proprio nell’attività del giudicare, ciò che più conta nella visione
arendtiana è che tale ‘bisogno’ - per Kant anche ‘scandalo’ della ragione non sia distinto dal bisogno dell’uomo di
raccontare la storia di un evento di cui è stato testimone, o di scrivere una poesia nel rimembrarlo” (p.242)..
L. Boella, Hannah Arendt “fenomenologia”, cit., pp.103-104.
H. Arendt, La vita della mente, cit., p.157. Cfr. Id., Tra amiche, cit., pp.426-30. In una lettera dell’8 Agosto
1969, Hannah Arendt espone alla sua amica M. McCarthy un interessante resoconto intorno ai temi della Vita della
mente su cui sta lavorando e in specie, sul dialogo silenzioso che prosegue tra me e me.
lviii
Ibidem, p.161.
lix
Ivi.
lx
Ibidem, pp.158-159.
lxi
Ivi.
lxii
Ibidem, p.169.
lxiii
Ibidem, pp.286-287.
lxiv
Ibidem, p.295..
lxv
Ibidem, p.183.
lxvi
Ibidem, pp.188-189. Rifacendosi a Kant, l’Arendt aveva affermato che anche
per l’ordinaria esperienza sensibile è necessario frequentare enti invisibili come si può desumere dal capitolo sullo
Schematismo nella Critica della Ragion Pura, così anche la peculiarità del linguaggio filosofico come linguaggio
metaforico è un’intuizione kantiana. Cfr.l’edizione italiana dell’opera, H. Arendt, Teoria del giudizio politico. Lezioni
sulla filosofia politica di Kant, tr.it. di P.P. Portinaro, Il Melangolo, Genova 1990, p.122.
lxvii
Ibidem, p.192.
lxviii
Ibidem, p.194.
lvi
lvii
lxix
Cfr. P. Ricoeur, La metafora viva, tr. it., Jaca Book, Milano, 1976. E’ interessante un confronto tra Arendt e
Ricoeur. Per il grande filosofo francese, la “scintilla di senso” costituiva della metafora viva, cioè l’enunciato
metaforico, vero e proprio “poema in miniatura”, non è più da considerarsi un ornamento stilistico, un nome improprio,
una sostituzione lessicale motivata dalla somiglianza, ma è una “predicazione bizzarra”, un’ “attribuzione
impertinente”: non è un fenomeno di parola, una “denominazione deviante”, ma un evento testuale e discorsivo che,
carico di una potenzialità di ri-figurare la realtà e insieme capace di scoprire dimensioni ontologiche nascoste
dell’esperienza umana e di trasformare la nostra visione del mondo, produce, attraverso lo slancio dell’immaginazione,
una nuova pertinenza concettuale, nella quale un senso nuovo viene creato proiettando una nuova comprensione del
mondo. La “verità metaforica”, sospendendo la “referenza” ordinaria per attivare quella secondaria, “divisa” e
“spezzata”, contribuisce, come dice Ricoeur, a una ri-descrizione del reale e, più generalmente, del nostro essere-almondo, in virtù della corrispondenza fra un vedere-come sul piano del linguaggio e un essere-come sul piano
ontologico: essa è la verità di un mondo ridescritto e riconfigurato che ha di mira “l’essere non più secondo le modalità
dell’esser-dato, bensì secondo quelle del poter essere”.
lxx
H. Arendt, La vita della mente, cit., p.188.
Ibidem, p.197.
lxxii
Ibidem, p.169.
lxxiii
Ibidem, p.212.
lxxiv
Ibidem, p.268.
lxxv
Ibidem, p.217.
lxxvi
Ibidem, pp.222-223.
lxxvii
Kant e Socrate vengono giudicati dalla Arendt, con le parole di Lessing,
come i due massimi esponenti di un pensiero critico in grado di far «tremare le fondamenta delle più diffuse verità
ovunque lascino cadere i loro occhi». Si veda H. Arendt, Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di
Kant, cit., p.61. Cfr. anche H. Arendt, Karl Marx e la tradizione del pensiero politico occidentale, in “MicroMega” n.
5, Roma 1995, p.86.
E’ interessante un confronto con altre opere arendtiane che si soffermano
sulla figura di Socrate come The Life of The Mind (La Vita della Mente, cit., pp.259-278, e Thinking and Moral
Considerations (Pensiero e riflessioni morali), in “Social Research”, 1971, 38, n.3, pp.417-446, tr.it. in H. Arendt, La
disobbedienza civile e altri saggi, a cura di T. Serra, Giuffrè, Roma 1985, pp.113-153, ora in H. Arendt, Come
raccontare il mondo, Edizioni Studium, Roma 1995, pp.143-182. In specie per le pagine su Socrate, il par. 2, pp.157171. Si vedano, infine, Alcune questioni di filosofia morale in Id., Responsabilità e Giudizio, a cura di J. Kohn, tr.it. di
lxxi
25
D. Tarizzo, Torino, Einaudi, 2004, pp.41-126. Potremmo dire che il Socrate delle opere edite è più esigente e insieme
più sfuggente; infatti, da un lato pungola i suoi concittadini senza dare loro né definizioni né valori per la futura
condotta nella città, e dall’altra egli sembra ritrarsi come il vento che scuote, spazza via le precedenti certezze,
lasciando nei concittadini nient’altro che dubbi. Cfr., inoltre, F. Fistetti, H. Arendt e M.Heidegger, Op. cit., in specie il
secondo capitolo, Heidegger e Socrate, pp.35-85. Occorrerebbe, infine, uno studio a parte sulle molteplici
rappresentazioni del Socrate arendtiano, tenndo conto anche degli scritti inediti.
lxxviii
H. Arendt, La vita della mente, cit.,p.269.
lxxix
Ibidem, p.271
lxxx
Cfr. Ibidem, pp.267-268.
lxxxi
Platone, Gorgia, 473d, 482c 483c, in Id., Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano, Rusconi, 1992.
lxxxii
Cfr. J. Kristeva, Le génie féminin, Hannah Arendt, Gallimard, Paris 1999, in specie le pp.293-317.
lxxxiii
H. Arendt, La vita della mente, cit., p.274.
lxxxiv
Ibidem, p.280.
lxxxv
Della categoria della pluralità è contaminata tutta l’opera arendtiana. In Vita Activa, Op.cit., troviamo le
formulazioni più sistematiche.
lxxxvi
Come è noto Hannah Arendt non portò mai a termine la terza parte della Vita della mente, dedicata appunto al
giudicare, la terza facoltà spirituale per la morte improvvisa che la colse nel dicembre del 1975. Ed è vano chiedersi in
quali termini questa facoltà sarebbe stata spiegata o descritta. Si vedamo comunque le pagine del Post-scriptum pp.308312 che chiude la sezione dedicata al Pensare e l’Appendice, Giudicare pp.547-567 che chiude The Life of The Mind.
Ci limitiamo a dire, a proposito del nesso, tra pensiero e giudizio, che se il primo è comprensione che dà significato alle
esperienze, il secondo si origina sempre da esperienze particolari e si struttura sempre in riferimento alle esperienze a e
ai punti di vista diversi. Assume, agli occhi dell’Arendt, una particolare importanza, per comprendere questo nesso, la
terza Critica kantiana. E un ciclo di lezioni sulla filosofia politica di Kant, vedi Id., Teoria del giudizio politico. Lezioni
sulla filosofia politica di Kant, Op.cit.
lxxxvii
A. Dal Lago, La difficile vittoria sul tempo, Introduzione alla Vita della mente, cit., p.51.
lxxxviii
Ibidem, 297. L’apologo Egli si trova in F. Kafka, Confessioni e Diari, Milano, Mondadori, 1972, pp. 811-812.
Cfr. una prima versione arendtiana dell’apologo kafkiano in Id., Premessa. La lacuna tra passato e futuro, in Tra
passato e futuro, tr.it. di T. Gargiulo, Milano, Garzanti, 1999, pp.25-39. Nella Premessa del 1958, il riferimento a Kafka
si colloca in un contesto diverso, quello legato alla resistenza francese, finita la guerra, e espresso da una frase del poeta
René Char: “La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento” (p.25). Inoltre, in un saggio ancora precedente del
1944, dal titolo Kafka: il costruttore di modelli, ora, in Id., Il futuro alle spalle, cit., pp.23-41, l’Arendt, richiamandosi a
Benjamin e alle sue Tesi di Filosofia della Storia, ritiene irrilevante e dannoso il credo dell’uomo nel progresso. E’ un
puro pregiudizio pensare che il progresso sia necessario.
lxxxix
H. Arendt, La vita della mente, cit., p.301.
xc
Ibidem, p.304.
xci
Ibidem, p.303. Cfr. il saggio interpretativo di R. Beiner, ora in H. Arendt, Teoria del giudizio politico, cit.,
p.197, dedicato ad Hannah Arendt sull’importanza dell’attimo che racchiude il senso del tempo, anzi l’attimo è tutto il
tempo. Beiner si spinge a istituire relazioni tra la concezione arendtiana dell’attimo e quella di Nietzsche. Non è tuttavia
casuale che l’Arendt citi l’autore di Così parlò Zarathustra subito dopo la parabola di Kafka..
xcii
Che le grandi opere siano frutto del pensiero, Hannah Arendt lo aveva già scritto in Vita Activa., Op.cit.,
p.120..Che le grandi opere aprano la possibilità di comprensione del mondo dei mortali è un’idea di cui la Arendt è
largamente debitrice di Heidegger. Cfr. M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Id., Sentieri Interrotti, La Nuova
Italia, Firenze 1984.
26