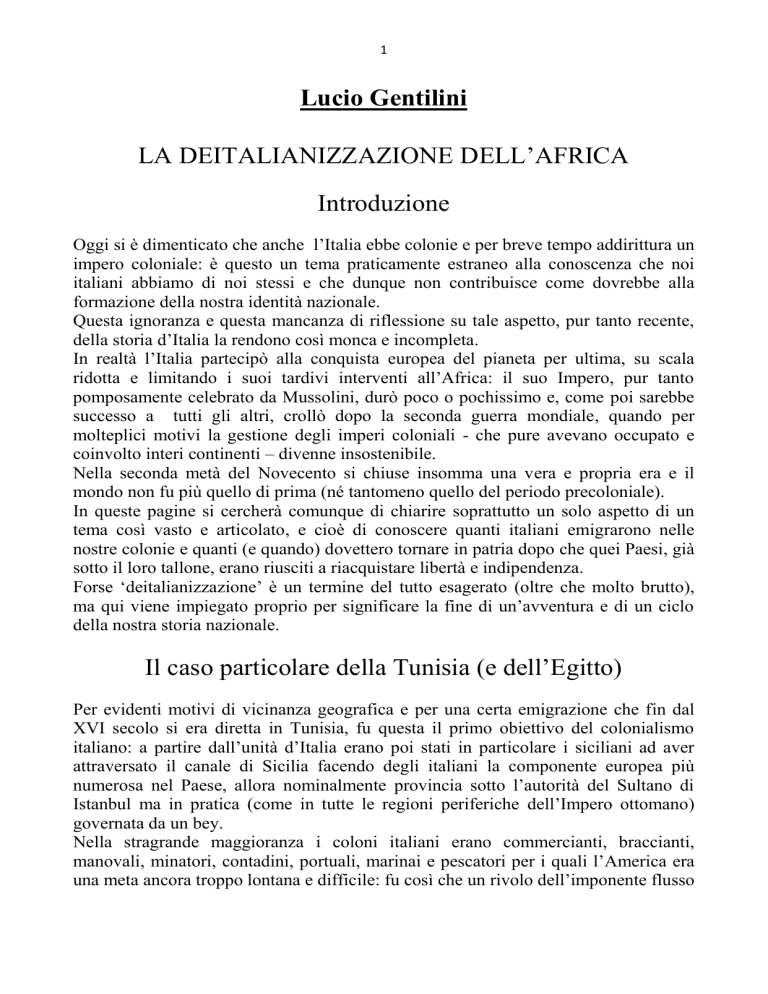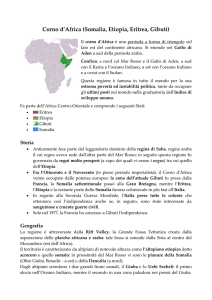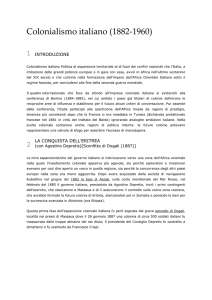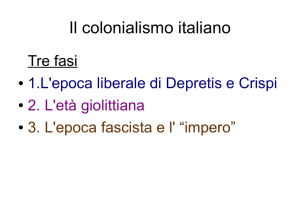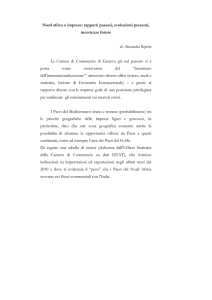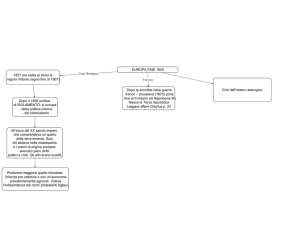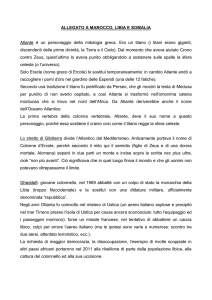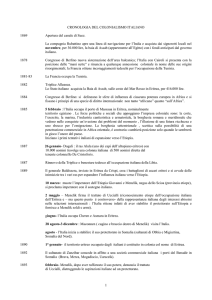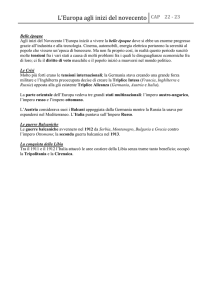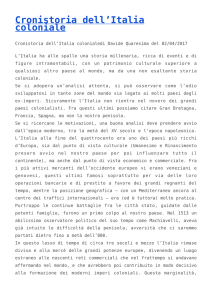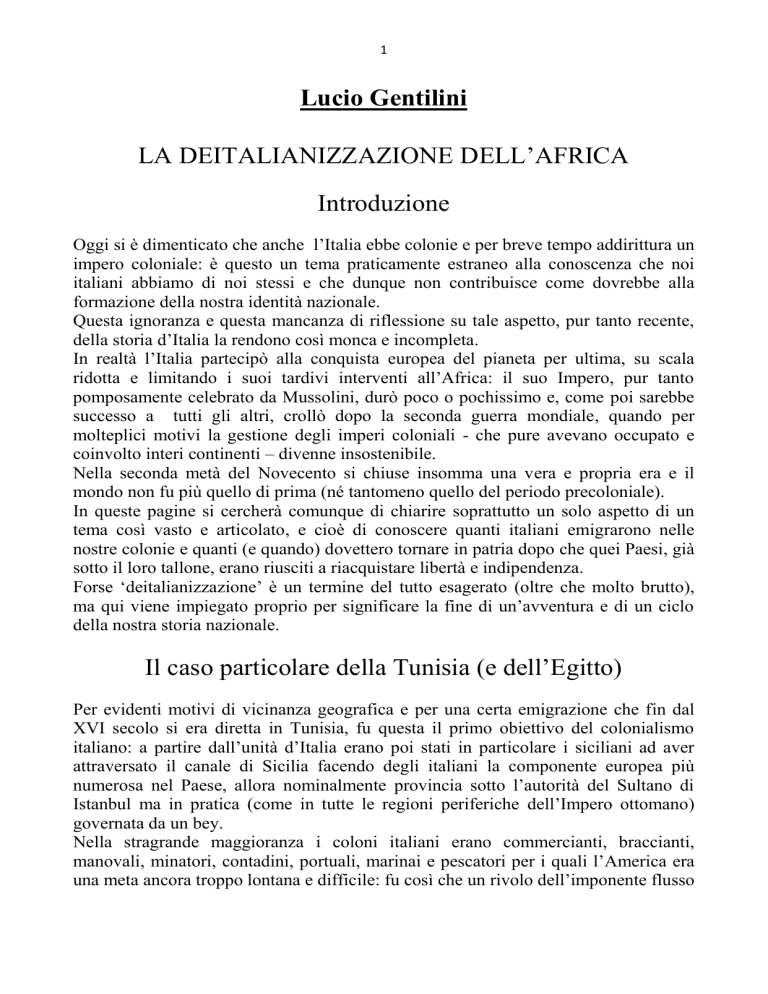
1
Lucio Gentilini
LA DEITALIANIZZAZIONE DELL’AFRICA
Introduzione
Oggi si è dimenticato che anche l’Italia ebbe colonie e per breve tempo addirittura un
impero coloniale: è questo un tema praticamente estraneo alla conoscenza che noi
italiani abbiamo di noi stessi e che dunque non contribuisce come dovrebbe alla
formazione della nostra identità nazionale.
Questa ignoranza e questa mancanza di riflessione su tale aspetto, pur tanto recente,
della storia d’Italia la rendono così monca e incompleta.
In realtà l’Italia partecipò alla conquista europea del pianeta per ultima, su scala
ridotta e limitando i suoi tardivi interventi all’Africa: il suo Impero, pur tanto
pomposamente celebrato da Mussolini, durò poco o pochissimo e, come poi sarebbe
successo a tutti gli altri, crollò dopo la seconda guerra mondiale, quando per
molteplici motivi la gestione degli imperi coloniali - che pure avevano occupato e
coinvolto interi continenti – divenne insostenibile.
Nella seconda metà del Novecento si chiuse insomma una vera e propria era e il
mondo non fu più quello di prima (né tantomeno quello del periodo precoloniale).
In queste pagine si cercherà comunque di chiarire soprattutto un solo aspetto di un
tema così vasto e articolato, e cioè di conoscere quanti italiani emigrarono nelle
nostre colonie e quanti (e quando) dovettero tornare in patria dopo che quei Paesi, già
sotto il loro tallone, erano riusciti a riacquistare libertà e indipendenza.
Forse ‘deitalianizzazione’ è un termine del tutto esagerato (oltre che molto brutto),
ma qui viene impiegato proprio per significare la fine di un’avventura e di un ciclo
della nostra storia nazionale.
Il caso particolare della Tunisia (e dell’Egitto)
Per evidenti motivi di vicinanza geografica e per una certa emigrazione che fin dal
XVI secolo si era diretta in Tunisia, fu questa il primo obiettivo del colonialismo
italiano: a partire dall’unità d’Italia erano poi stati in particolare i siciliani ad aver
attraversato il canale di Sicilia facendo degli italiani la componente europea più
numerosa nel Paese, allora nominalmente provincia sotto l’autorità del Sultano di
Istanbul ma in pratica (come in tutte le regioni periferiche dell’Impero ottomano)
governata da un bey.
Nella stragrande maggioranza i coloni italiani erano commercianti, braccianti,
manovali, minatori, contadini, portuali, marinai e pescatori per i quali l’America era
una meta ancora troppo lontana e difficile: fu così che un rivolo dell’imponente flusso
2
migratorio italiano – tristissima conseguenza dell’Unità - si riversò nella vicina e
molto più accessibile Tunisia.
Per proteggere e salvaguardare i diritti di questi italiani colà residenti (e alcune
concessioni per servizi e stabilimenti) già prima del 1861 erano stati firmati alcuni
trattati fra i vari stati della Penisola e la Tunisia finchè l’8 settembre 1868 il giovane
Regno d’Italia aveva siglato col bey uno dei numerosi ‘regimi delle capitolazioni’ allora molto in uso fra l’Impero turco e le Potenze europee - che accordavano diritti e
privilegi di vario genere ai cittadini di queste ultime che si erano stabiliti nel territorio
ottomano.
Nella fattispecie, quello stipulato con l’Italia aveva una durata di 28 anni e stabiliva
che gli ‘italiani di Tunisia’ mantenevano la loro nazionalità d’origine e che in materia
civile, commerciale e giudiziaria per loro si applicava la legislazione italiana
amministrata da un console italiano: questo regime garantiva insomma agli italiani
residenti in Tunisia (e ai loro stabilimenti) i benefici dell’immunità e dell’extraterritorialità.
Tutto era avvenuto pacificamente e in modo condiviso e gli italiani di Tunisia
sottostavano dunque alla leggi del proprio stato come se fossero ancora nel proprio
Paese.
La cittadina di La Goletta, a dieci chilometri a nord di Tunisi, fu la più schietta
manifestazione del successo degli italiani: grazie al loro duro lavoro ed al loro spirito
di iniziativa nel giro di pochi decenni gli emigrati si riscattarono dal precedente stato
di indigenza e il quartiere della ‘Piccola Sicilia’ li fece diventare addirittura
maggioritari nella cittadina.
I nuovi venuti vissero tranquillamente insieme alla popolazione autoctona ed anzi
furono inevitabili e frequenti le interazioni culturali (abbigliamento, tradizioni e
addirittura solennità religiose) mentre alcuni matrimoni misti amalgamarono
ulteriormente le due comunità.
I
Gli italiani si erano radicati in Tunisia pacificamente e vi esercitavano varie attività
economiche, ma più si erano affermati sul territorio africano più era cresciuta la
volontà della madrepatria di trasformare questa importante presenza in dominio vero
e proprio e di fare dunque della Tunisia una colonia o almeno un protettorato.
Nell’ambito delle crescenti mire colonialiste europee (anche se la famosa ‘corsa
all’Africa’ si sarebbe scatenata solo dopo la Conferenza di Berlino del 1884-85) fu
questo il principale obiettivo di politica estera del secondo governo di Benedetto
Cairoli, ma venne portato avanti in modo confuso e contraddittorio.
Cairoli infatti (come del resto in seguito Agostino Depretis) non volle procedere
all’occupazione del Paese: troppo vivi erano in lui gli ideali del Risorgimento perché
si convertisse ad una politica militarista, senza contare che l’Italia doveva affrontare
il grave deficit del bilancio statale postunitario ed era fortemente indebitata con molti
Paesi europei fra cui la Francia che, già padrona dell’Algeria, covava le sue stesse
mire sul confinante Paese africano.
3
Per bloccare la Francia in Tunisia il governo italiano puntava sull’opposizione
dell’Inghilterra ad un ulteriore allargamento della sfera di influenza francese
nell’Africa settentrionale ed al controllo del Canale di Sicilia da parte di una sola
potenza: non era forse stata questa la ragione principale del favore britannico
all’unificazione stessa dell’Italia?
Le esitazioni e questo calcolo errato del governo italiano costarono cari: ottenuto il
via libera di Bismarck (che dopo che nel 1870 aveva strappato l’Alsazia-Lorena alla
Francia la spingeva in Africa per dissuaderla dalla ‘revanche’), il 3 maggio 1881 un
primo contingente francese sbarcò a Biserta, seguito dal grosso delle forze appena
otto giorni dopo.
Le scuse addotte per questa invasione erano le solite: interessi delle concessioni (ben
più importanti di quelle ottenute dagli italiani) minacciati, scontri al confine con
l’Algeria francese, supposte vessazioni subite dai francesi residenti, ecc., ma la loro
inconsistenza apparve evidente (se pur ce ne fosse stato bisogno) già il 12 maggio
1881 quando il bey fu costretto a stipulare il Trattato del Bardo che, ben lungi dal
limitarsi a proteggere gli interessi francesi, incaricava addirittura ‘gli agenti
diplomatici e consolari della Francia nei paesi stranieri […] della protezione degli
interessi tunisini’ (sic).
L’intera politica estera tunisina era passata insomma nelle mani della Francia, ma ciò
non fu ancora ritenuto sufficiente e il 5 giugno 1883 le Convenzioni della Marsa
costrinsero il bey a ‘procedere alle riforme amministrative, giudiziarie e finanziarie
che il governo francese giudicherà utili’: in conclusione: formalmente la Tunisia
continuava ad essere governata dal bey (e dunque a far nominalmente ancora parte
dell’Impero ottomano) ma di fatto era divenuta improvvisamente un protettorato della
Francia che ne occupò alcune basi strategiche (ovviamente soprattutto sulla costa).
Anche se Ahmed Kassab (‘Histoire de la Tunisie’) insiste sulla resistenza che pure
iniziò subito (soprattutto ad opera delle tribù del centro-sud) e che cercò inutilmente
aiuto dalle autorità turche di Tripoli, in verità questa fu poco efficace e poco diffusa e
comunque non ostacolò più di tanto i piani francesi di occupazione e di sfruttamento.
II
Per l’Italia fu questo lo ‘schiaffo di Tunisi’ che spinse Cairoli alle dimissioni (29
maggio 1881) e all’uscita definitiva dalla vita politica.
Già tre anni prima l’Italia era tornata senza aver ottenuto nulla da quel mercato di
spartizioni e di accaparramenti che era stato il Congresso di Berlino (1878): Cairoli
allora aveva sostenuto di esserne uscito con le ‘mani nette’, ma in realtà erano vuote e
ora l’Italia si rese conto che avrebbe dovuto presto porre rimedio al suo evidente
isolamento internazionale.
Per i francesi il vero problema era comunque che in Tunisia la popolazione italiana
superava di gran lunga quella francese: nel 1881 i francesi erano infatti appena 700
mentre gli Italiani 25mila, tanto che ci fu chi concluse che ‘La Tunisia è una colonia
italiana amministrata da funzionari francesi’.
4
La sorpresa, il risentimento e la frustrazione degli italo-tunisini (cioè gli italiani
residenti in Tunisia) furono fonte di preoccupazione per i francesi che parlarono
apertamente di un ‘peril italien’ e che si adoperarono per placare gli animi con una
graduale (ma anche forzata) politica di assimilazione e di garanzia: gli italiani
poterono così fondare una camera di commercio (1884), la Banca Siciliana, il
quotidiano ‘L’Unione’ ed altri enti culturali ed assistenziali (teatri, cinema, scuole,
ospedale) per italiani, ma persero il diritto di rimanere sotto la giurisdizione
particolare del loro console.
Gli accordi firmati a Parigi il 28 settembre 1896 permisero poi agli italiani di
mantenere la propria nazionalità (da padre in figlio) senza nessuna scadenza, di
conservare l’autonomia delle proprie scuole e associazioni culturali e di poter
esercitare liberamente le proprie attività, mentre per ovviare allo squilibrio fra le due
comunità (e alle sue possibili conseguenze) - ma soprattutto al fine di garantirsi
l’effettivo controllo sul Paese -, oltre a trasferire personale dalla madrepatria e ad
incoraggiare l’emigrazione di suoi cittadini, la Francia volle anche sfruttare (per così
dire) gli elementi già a disposizione sul terreno e così sin dall’inizio del protettorato,
ma con maggior determinazione a partire dal primo dopoguerra, portò avanti una
politica di naturalizzazione degli italiani.
Quest’ultima iniziativa conobbe qualche successo e la distanza fra le due comunità
comprensibilmente si ridusse, nondimeno il numero degli italiani in Tunisia aumentò
considerevolmente soprattutto quando la Francia vi intraprese i numerosi lavori
pubblici e ammodernamenti tipici di tutti i regimi coloniali: dei 173.281 europei
censiti nel 1926 (dopo 45 anni di protettorato) ben 89.216 (più della metà) erano
ancora italiani, 71.020 francesi e 8.396 maltesi, ma in quello del 1936 (94mila
italiani, 108mila francesi e 7.200 altri europei) il rapporto si invertì, anche se il dato è
poco significativo perché classifica come francesi gli italiani (e altri europei)
naturalizzati francesi.
Inoltre, più passava il tempo meno determinante era l’emigrazione in confronto alle
nascite di europei in Tunisia.
III
Dato il suo acceso nazionalismo e la sua esaltazione e valorizzazione della patria, il
regime fascista si impegnò a fondo anche in Tunisia per galvanizzare e rafforzare la
presenza e l’identità degli italiani colà residenti finanziando la costruzione di scuole e
di ospedali e istituendo apposite banche ed organizzazioni assistenziali: molti italotunisini aderirono convintamente al fascismo e non è difficile comprendere le loro
motivazioni.
Essi vivevano infatti una condizione doppiamente frustrante: costituivano un’esigua
minoranza (per quanto largamente concentrata) in un Paese straniero ma
contemporaneamente erano soggetti ad un’altra Potenza europea che, per quanto
tentasse di amalgamarli, rimaneva pur sempre straniera.
Vivevano in una sorta di limbo, né veramente appartenenti e figli della terra su cui
risiedevano né spalleggiati da una madrepatria che l’avesse comunque sottomessa: la
5
propaganda fascista non poteva dunque non attrarli e rincuorarli e soprattutto offriva
loro la garanzia che non erano stati dimenticati e che in caso di necessità sarebbero
stati difesi (come del resto stava già avvenendo in tempo di pace).
Fu comunque la guerra a far precipitare la strana condizione in cui si trovavano.
IV
L’irresponsabile (a dir poco) dichiarazione di guerra dell’Italia alla Francia (10
giugno 1940) in un primo momento rese ovviamente critica e instabile la posizione
della comunità italiana in Tunisia che però si ristabilizzò quando la Tunisia (come
tutte le colonie francesi) venne lasciata alla Repubblica di Vichy, alleata e
collaborazionista dell’Asse, ma precipitò e diventò invece del tutto irreparabile
quando Mussolini, aperto il fronte africano, diede inizio alla ‘campagna del
Nordafrica’ (conosciuta anche come ‘guerra nel deserto’).
Il 13 settembre 1940 l’esercito italiano di stanza in Libia invase l’Egitto ma dovette
presto fermarsi e nel dicembre le forze britanniche passarono al contrattacco, lo
sbaragliarono e occuparono l’intera Cirenaica: Mussolini fu costretto a chiedere aiuto
a Hitler che nel marzo 1941 si risolse a inviare in Nordafrica un corpo di spedizione
tedesco (l’Afrika Korps).
Continuò così quella lunga campagna fatta di avanzate e di arretramenti, di vittorie e
di sconfitte, finchè nel gennaio 1943 gli inglesi riuscirono ad avere definitivamente la
meglio e a occupare l’intera Libia: la disfatta fu resa ancora più grave (se possibile)
dall’arrivo degli americani che intanto l’8 novembre 1942 erano sbarcati in forze
sulle coste marocchine e algerine (‘operazione Torch’).
Le truppe dell’Asse vennero insomma strette in una tenaglia e non poterono che
rifugiarsi in Tunisia (12 novembre 1942) da dove, raggiunte da rinforzi, tentarono
vanamente di fermare l’avanzata alleata da est e da ovest finchè, completamente
esauste e sconfitte, il 13 maggio 1943 dovettero finalmente arrendersi.
Comprensibilmente un certo numero di italo-tunisini aveva inneggiato alla ‘Tunisia
nostra’, si era unito ai propri compatrioti e aveva combattuto contro gli Alleati ma fu
proprio la vittoria di questi ultimi a segnare l’inizio della scomparsa della comunità
italiana in Tunisia: travolta l’Italia, indifendibile e sgangherata corresponsabile della
guerra, gli italo-tunisini risultarono infatti doppiamente sconfitti, sia come italiani che
come cittadini soggetti alla Francia, e ritenuti doppiamente colpevoli, sia come
fascisti (o ritenuti tali) che come traditori.
Risulta comunque davvero difficile condannarli senza tener conto della situazione
impossibile in cui erano venuti a trovarsi e sembra più giusto e opportuno vedere in
essi uno dei tanti tristi casi di comunità stritolate da una storia troppo più grande di
loro, senza vie d’uscita e costrette a pagare il conto delle colpe di altri.
In ogni caso, mentre in Tunisia tutte le scuole e i giornali italiani vennero chiusi
d’autorità, fra i 1.200 e i 3.000 italo-tunisini furono espulsi senza troppi distinguo:
oltre agli agitatori fascisti dovettero infatti andarsene anche gli intellettuali in genere,
gran parte di coloro che possedevano un titolo di studio elevato e persino, in qualche
caso, dei noti antifascisti (!).
6
Oltre ai nemici dichiarati fu insomma evidente che i francesi volevano allontanare
dalla loro colonia anche tutti quegli italiani di un certo spessore intellettuale, per un
motivo o per un altro ritenuti meno malleabili e dunque indesiderabili.
Il risultato fu che, dopo che da tempo la proporzione fra le due comunità aveva
comunque cominciato ad invertirsi, nel censimento del 1946 gli italiani erano 84.935
e i francesi 143.977.
V
La comunità italiana in Egitto fu un’altra vittima innocente della seconda guerra
mondiale in Nordafrica.
Con oltre 55mila membri, concentrati soprattutto al Cairo e ad Alessandria, al
momento dell’invasione del 1940 gli italo-egiziani (soprattutto mercanti ed artigiani
ma col tempo, spinti dal bisogno, a questi si erano aggiunti sempre più lavoratori
manuali generici) costituivano la seconda comunità straniera del Paese (appena dopo
quella greca), regolata e protetta da un proprio ‘regime delle capitolazioni’,
amministrata da un suo console e garantita nella sua identità anche grazie a proprie
scuole frequentate da circa 1.500 studenti.
Mentre l’esercito italiano marciava all’interno del Paese, Mussolini proclamò
solennemente il pieno rispetto per la sovranità e l’integrità dell’Egitto, pretendendo
che si comprendesse (e si accettasse) che la guerra fascista era diretta solo contro gli
inglesi dominatori del canale di Suez: forse si aspettava di essere preso sul serio
mentre in realtà l’invasione del 1940 distrusse in un attimo i buoni e proficui rapporti
cogli egiziani che duravano da sempre, dato che gli italiani erano emigrati in Egitto
pacificamente (non certo come colonialisti!) e fino ad allora avevano convissuto
tranquillamente cogli indigeni.
Per tutta risposta il governo egiziano subito predispose infatti un piano di difesa degli
interessi britannici e uno contro gli italiani residenti in Egitto che comprese
l’internamento degli uomini dai 15 ai 65 anni e delle donne ritenute pericolose, il
licenziamento dai posti di lavoro, il divieto di esercitare attività economiche, di
effettuare transazioni commerciali e il sequestro dei loro beni mobili e immobili.
Gli italiani internati furono complessivamente circa 8mila e alcuni di questi (pochi)
perirono durante l’immeritata ma inevitabile prigionia: alla fine della guerra ci furono
poi comprensibili e numerose espulsioni anche se il numero degli italo-egiziani
diminuì in modo veramente drastico solo fra il 1950 e il 1960 in seguito all’avvento
al potere di Nasser (1954).
Insomma: già vittime innocenti della insensata guerra fascista, gli incolpevoli italoegiziani furono dunque spazzati via a causa dell’effettiva indipendenza e della
liberazione dell’Egitto (dall’influenza inglese!), i cui abitanti erano finalmente tornati
ad essere padroni in casa propria e non volevano più degli europei sul loro suolo.
Ciò era inevitabile e forse giusto dato che le famose (o famigerate) capitolazioni
erano pur sempre state atti di prepotenza e che gli europei erano pur sempre stati gli
odiati colonialisti pieni di disprezzo per gli africani, ma non risulta che gli italiani in
Egitto si fossero macchiati di colpe particolari.
7
In realtà ancora una volta essi furono vittime di eventi di cui non avevano alcuna
responsabilità: dovettero cedere tutto quello che avevano, persero tutti i frutti del
lavoro loro e dei loro predecessori, abbandonarono la terra in cui erano nati e
sparirono per sempre nell’anonimo mondo dei vinti.
VI
Anche il vero motivo della deitalianizzazione della Tunisia fu la politica adottata nel
Paese dopo che il 20 marzo 1956 ebbe finalmente ottenuto l’indipendenza (contro i
francesi!).
Quando nel 1956 la Tunisia e il Marocco si liberarono degli occupanti francesi questi
ultimi dovettero infatti andarsene in massa sia perché le redini del governo e
dell’amministrazione passarono nelle mani degli indigeni (e per tutti i funzionari
francesi non ci fu dunque più posto), sia per le misure adottate dai nuovi governanti
riassumibili in una politica di progressiva e ineluttabile (diciamo così)
‘tunisificazione’.
Nuove leggi, come quella del marzo 1958 che impose la sostituzione degli autisti
stranieri con autisti tunisini nelle zone cosiddette ‘d’emergenza’ (cioè lungo i confini
con l’Algeria che stava combattendo la sua dura guerra di liberazione) o come quella
che nello stesso anno impose ai datori di lavoro di assumere soltanto apprendisti
tunisini, mirarono a escludere gli stranieri dal mercato del lavoro.
I primi ad essere colpiti furono dunque i lavoratori dipendenti, ma presto anche
coloro che avevano investito i propri capitali in attività commerciali vennero travolti
dalla politica di decolonizzazione, come i tassisti ai quali nel giro di pochi giorni fu
tolta la licenza o come i commercianti cui la licenza venne concessa solo in via
provvisoria dato che le attività commerciali d’ora in avanti potevano essere esercitate
soltanto da tunisini.
Era evidente che il governo di Habib Bourguiba (l’eroe della lotta di liberazione)
intendeva disfarsi degli stranieri per i quali in Tunisia non c’era semplicemente più
futuro: l’epoca del colonialismo si stava definitivamente chiudendo (e certamente non
solo in Tunisia!) e anche agli italiani non restò che andarsene.
La pietra tombale sulla presenza di una comunità italiana in Tunisia venne posta nel
1964 con la nazionalizzazione delle terre appartenenti agli stranieri e col
sequestro puro e semplice dei loro beni.
Gli italo-tunisini pagarono per colpe non proprie: si erano trasferiti in Tunisia
pacificamente e col consenso degli indigeni, avevano costruito e lavorato contando
solo sulle proprie forze, avevano investito i loro sudati guadagni nelle loro attività
che con fatica e sacrificio avevano impiantato un po’ in tutti i settori, ma ora per loro
non c’era più posto, non avevano più diritti ed erano diventati degli elementi estranei
di cui i tunisini volevano liberarsi.
Essi non poterono che andarsene abbandonando i frutti dell’opera di intere
generazioni.
Lasciati completamente a se stessi gli italo-tunisini poterono scegliere solo se
emigrare in Italia o in Francia.
8
Gli italiani di La Goletta avevano documenti francesi e non ebbero altra strada che
andare a costruirsi una nuova vita in Francia, ma anche molti altri italiani li seguirono
perchè la sentivano più vicina essendo vissuti sempre sotto la sua amministrazione
mentre l’Italia per loro in pratica era sempre stata un paese straniero.
Naturalmente altri decisero comunque di ‘tornare’ in Italia e insomma la comunità
italiana di Tunisia si divise e si sparpagliò fra i due Paesi.
A parte i funzionari statali (francesi) che vennero assorbiti nella burocrazia statale
tutti questi ‘rimpatriati’ (ammesso e non concesso che sia legittimo chiamarli così
dato che erano nati e vissuti in terra d’Africa) - così come ad esempio il milione di
‘pieds-noirs’ provenienti dall’Algeria (vedi il mio saggio sull’Algeria) - dovettero
arrangiarsi e rifarsi una vita con le sole proprie forze, ignorati e dimenticati da tutti,
vittime sconosciute sparite senza lasciar traccia (a parte ciò che è rimasto ancora in
piedi di quel che avevano costruito nella terra che li cacciò).
Al momento dell’indipendenza tunisina gli italiani erano 66.500, nel censimento del
1959 51.702, nel 1962 33.000, nel 1969 meno di 10.000 e nel 2005 solo 3.000 (di
cui appena 900 discendenti dall’originaria emigrazione ottocentesca), concentrati
principalmente nell’area metropolitana di Tunisi (e soprattutto a La Goletta).
Intendiamoci: in queste pagine nessuno si sogna nemmeno di difendere il
colonialismo: le misure prese dalle ex-colonie per disfarsi dei loro ex-padroni sono
assolutamente comprensibili e condivisibili ma questo inevitabile - e giusto! sviluppo della storia ha avuto anche le sue vittime innocenti e gli italo-tunisini sono
sicuramente fra queste.
Strano il destino di questa gente che visse in un Paese colonizzato senza appartenere
al mondo dei colonizzatori ma che finì ugualmente per subire in modo pesantissimo
le conseguenze della decolonizzazione: come si è già detto, furono persone
stritolate da una storia troppo più grande di loro e che non ebbero possibilità di
scampo.
Allora furono ignorate e oggi nessuno le ricorda più.
Eritrea colonia primigenia
Dopo lo ‘schiaffo di Tunisi’ la politica estera italiana cambiò decisamente rotta:
l’Italia si alleò con la Germania e l’Austria-Ungheria dando vita alla Triplice
Alleanza (20 maggio 1882) e in campo coloniale si indirizzò verso l’Eritrea (e la
Somalia).
Dopo che la (solita) compagnia Rubattino aveva acquistato i territori di Assab (sulla
costa occidentale del Mar Rosso nella regione della Dancalia meridionale, in Eritrea),
il 10 marzo 1882 lo Stato italiano li acquistò a sua volta e il 5 luglio 1882 Assab
divenne ufficialmente la prima colonia italiana.
Fu questo comunque solo il primo passo: il secondo fu l’occupazione di Massaua (5
febbraio 1885) sulla costa della Dancalia settentrionale, e il terzo due ulteriori
spedizioni (12 e 24 febbraio) colle quali truppe italiane presero il controllo di tutta la
9
costa compresa fra Massaua e Assab, incoraggiate dall’Inghilterra e senza che i suoi
deboli possessori egiziani potessero seriamente opporsi.
La penetrazione italiana continuò e finì per impensierire l’impero etiope che stava
perdendo l’accesso al mare: l’inevitabile scontro aperto culminò nella battaglia di
Dogali (26 gennaio 1887) in cui gli italiani furono nettamente sconfitti (430 morti di
cui 23 ufficiali), ma l’Italia continuò imperterrita nella sua invasione finchè,
accordatasi col ras etiope Menelik, il 1 gennaio 1890 potè orgogliosamente
proclamare la nascita della colonia eritrea (85mila kmq. di superficie).
La struttura di questa colonia primigenia si definì meglio in seguito al trattato
commerciale con l’Etiopia (24 giugno 1897), a quello con l’Inghilterra (7 dicembre
1898) che tracciava i confini col Sudan, e infine a quello (1900) che a sua volta
definiva i confini con l’Etiopia stessa.
I
I motivi che spingevano l’Italia (soprattutto al tempo del primo governo Crispi, 188791) erano i soliti - partecipazione alla spartizione dell’immenso bottino africano, non
restare tagliati fuori nella divisione delle sfere di influenza fra le Potenze europee,
missione umanitaria e civilizzatrice, spirito d’avventura, reazione alla crisi economica
e alla rivalità sempre più accesa con la Francia - ma, soprattutto, si voleva trovare
uno sbocco alla crescente emigrazione – tristissima conseguenza dell’Unità - che
principalmente dal Mezzogiorno spingeva masse di contadini alla disperata ricerca di
lavoro fuori dai confini nazionali.
Dirigendo il flusso migratorio in terre acquisite al dominio italiano si pensava inoltre
di risolvere con un colpo solo anche l’esigenza di accrescere la potenza italiana:
insomma: si sosteneva che in Italia c’erano troppi italiani e in Africa terre spopolate,
o comunque abbandonate e lasciate improduttive, per cui sembrò logico e naturale
popolarle di italiani e renderle fiorenti grazie al loro lavoro ottenendo così anche un
complessivo rafforzamento dell’Italia stessa.
E’ addirittura superfluo notare come nessuno allora si poneva il problema dei diritti e
del destino degli indigeni locali (prima di allora sotto il disinteressato Egitto) che al
massimo si pretendeva avrebbero tratto giovamento dall’opera civilizzatrice di una
Potenza tanto superiore e più avanzata della loro.
L’Eritrea comunque, a differenza di tante altre colonie straniere, non fu mai
dichiarata – almeno a parole - colonia di mero sfruttamento, ma di popolamento:
Crispi diede un forte impulso a questo tipo di politica imperialistica e considerò
quelle terre pezzi d’Italia destinati ad ospitare ‘quella massa d’emigranti che prende
la via dell’America’.
Fin dal 1890 venne così approvato un piano sperimentale di colonizzazione agricola
dell’Eritrea col fine esplicito di deviare il flusso migratorio di centinaia di migliaia di
italiani altrimenti diretti nelle Americhe: nacque allora il mito dell’ ‘Oltremare’ e del
‘posto al Sole’ verso cui fino alla seconda guerra mondiale i governi avrebbero
cercato di indirizzare il maggior numero possibile dei nostri emigranti e l’Eritrea, la
‘colonia primogenita’, cominciò così ad essere raggiunta da gente che partiva dalle
10
aree più povere (e popolate) del Paese, ben decisa a rimanere per generazioni nelle
nuove appendici della madrepatria.
Tuttavia questo ‘imperialismo da straccioni’ (come ebbe a definirlo Lenin) non
funzionò, e il tentativo di convogliare l’immigrazione italiana in direzione dei nuovi
possedimenti africani si risolse in un fallimento a causa del clima, della mancanza di
infrastrutture e dell’impreparazione dei coloni: se infatti nel 1893 i civili italiani in
Eritrea erano 623, una trentina di anni dopo erano saliti appena a 4mila (meno
dell’1% della popolazione autoctona).
Si trattava insomma di un rivolo insignificante se confrontato con le imponenti cifre
dell’emigrazione italiana che toccò il suo culmine nel decennio 1906-15 con svariati
milioni di partenze.
Anche in Eritrea la presenza dei colonizzatori europei produsse comunque lo
sviluppo (solito) dovuto alla costruzione ed installazione di nuove infrastrutture (allo
scoppio della seconda guerra mondiale c’erano 600 km. di ferrovie), agli
investimenti, all’ammodernamento e al conseguente aumento della produzione.
II
Con l’avvento del fascismo l’emigrazione italiana verso l’Eritrea (e la Somalia)
ricevette un impulso non indifferente e in particolare in Eritrea la comunità italiana
(3.635 residenti registrati dal censimento del 1 dicembre 1921) crebbe sensibilmente
concentrandosi soprattutto nelle città e nella capitale Asmara, soprannominata la
‘piccola Roma’ e dove gli italiani arrivarono a costituire la metà circa della
popolazione.
In Eritrea (e non solo) il fascismo intese creare tutto un nuovo e organico sistema
sociale che fondesse la colonizzazione demografica, realizzata con l’emigrazione di
masse di contadini, alle altre forme di valorizzazione economica: l’Italia avrebbe
dovuto trasferirvi infatti ‘tutta l’attrezzatura della propria civiltà’.
La colonizzazione fascista intese trasporre nelle colonie tutti gli elementi produttivi
della madrepatria e riprodurvi tutti i meccanismi della società italiana così che nelle
principali città eritree (e non solo) vennero costruiti ospedali, scuole, istituzioni
religiose, fabbriche, cinema, teatri, caffè, ecc. in modo da impiantarvi ex novo gli
stili di vita della madrepatria.
Nonostante gli sforzi compiuti dal fascismo, nel maggio 1939 la popolazione italiana
era però arrivata solo a 58mila unità (il 4% della popolazione autoctona) – altre fonti
parlano però di 76mila italiani e di 740mila autoctoni - e ciò perché in occasione della
guerra d’Etiopia (ottobre 1935 – maggio 1936) migliaia di operai erano stati fatti
affluire in Eritrea per costruire strade ed altre opere pubbliche.
Naturalmente a questi lavoratori si erano aggiunti i militari, i funzionari e gli
impiegati pubblici di vario genere ma all’avventura africana partecipò comunque
anche un certo numero di persone dotate di grande spirito di adattamento, voglia di
lavorare, capacità di iniziativa e di inventiva (piccoli imprenditori, commercianti,
esercenti di pubblici esercizi, ‘padroncini’ conduttori e proprietari di piccoli mezzi di
11
trasporto, operai qualificati, artigiani, ecc.) che riuscirono a fondare imprese
autonome e a conseguire anche discreti successi.
Tutto questo sviluppo finì però bruscamente in seguito alla disastrosa sconfitta
italiana nel settore africano della seconda guerra mondiale.
III
Lo svolgimento delle operazioni belliche della seconda guerra mondiale nell’Africa
nera verrà brevemente trattato in un prossimo capitolo (quello sull’Etiopia) quando
sarà stato chiarito l’intero sviluppo dell’impero coloniale italiano in Africa: qui
basterà ricordare che già l’11 giugno 1940 (lo stesso giorno successivo alla
dichiarazione di guerra di Mussolini alla Francia e all’Inghilterra!) Asmara subì il
primo bombardamento aereo ad opera della RAF, subito seguito da martellanti,
continue ed indiscriminate incursioni aeree sulle altre città dell’Eritrea (Assab,
Massaua e Cheren).
Mentre i bombardamenti aerei proseguirono continui ed indiscriminati anche su
obiettivi civili, le truppe britanniche procedettero all’invasione terrestre dell’Eritrea,
culminata nella battaglia di Cheren (una delle più cruente dell’intero conflitto) nella
quale le truppe italiane (in larga parte composte da indigeni) si coprirono di gloria
resistendo per ben 56 giorni finchè il 26 marzo 1941 non poterono che ritirarsi: da
quel momento le truppe britanniche non ebbero più ostacoli nella loro penetrazione
nell’ormai ex-colonia italiana, il 1 aprile Asmara si consegnò (fra gli applausi della
popolazione e il sollievo dei soldati!) e l’8 aprile Massaua fu espugnata dopo una
futile difesa, non prima però che quasi tutta la flotta – quella che avrebbe dovuto
dominare l’oceano Indiano! - si fosse autoaffondata.
L’Eritrea era persa e sconvolta dal caos e dallo sbandamento che sempre seguono le
sconfitte: il velleitarismo e l’irresponsabilità fascista che avevano voluto far entrare
l’Italia (oltretutto del tutto impreparata) in una guerra di tali dimensioni emersero in
tutta la loro dolorosa evidenza.
E’ questa una verità storica notissima ma non per questo meno grave e comunque
meritevole di essere continuamente ricordata: per i circa 80mila italo-eritrei iniziò
allora un periodo tragico e difficile che si sarebbe concluso con la loro pressochè
totale scomparsa dal suolo africano.
Il 1 aprile le truppe britanniche entrarono in Asmara e iniziarono l’occupazione
sistematica dell’intera colonia: guai ai vinti! Vendette e ritorsioni, aggressioni e
assalti, omicidi e saccheggi, scorribande e devastazioni ad opera dei nativi che
volevano vendicarsi dei tanti torti subiti e impadronirsi dei beni e delle proprietà degli
italiani sconfitti (e degli arabi) si moltiplicarono anche in vista della riappropriazione
e di una prevista redistribuzione, a guerra finita, delle proprietà terriere e immobiliari
degli italiani.
Eppure numerosi italiani rimasero al loro posto e continuarono a far funzionare le
strutture installate con tanto lavoro e tanti sacrifici riuscendo a risollevare in breve
tempo l’economia eritrea e suscitando l’ammirazione degli osservatori dell’ONU,
12
ma l’Italia era pur sempre la sconfitta e l’Amministrazione Militare Britannica si
trovò fra due fuochi: pur ricorrendo anche all’uso della forza, non sempre riuscì
difendere gli italiani e a riportare l’ordine, ma suscitò ugualmente l’ostilità e la
sorpresa dei nativi che si sentirono traditi e defraudati perché ostacolati in quel
risarcimento per l’oppressione subita che ritenevano giusto e doveroso.
IV
Oltre a ciò, le conseguenze della sconfitta furono organizzate anche in modo più
regolare e ordinato: fin dai primi di aprile iniziarono infatti ad affluire al Forte
Baldissera numerose colonne di autocarri carichi di prigionieri italiani e poco dopo
cominciarono i rastrellamenti per le strade cittadine, nei pubblici locali e gli arresti a
sorpresa di notte nelle abitazioni.
Tra il 1941 ed il 1943 per gli sconfitti furono allestiti centri di raccolta profughi da
cui i militari ed anche alcuni civili vennero presto trasferiti nei campi di
concentramento e di prigionia apprestati nelle varie colonie inglesi.
Inevitabilmente si venne presto a creare una vera e propria emergenza umanitaria.
Al governo britannico si presentò infatti l’enorme problema della gestione dei civili
sfollati, senza mezzi di sostentamento e rinchiusi nei campi di prigionia: non si
trattava tanto dei soldati, dei funzionari e degli uomini validi ormai internati e,
insomma, in qualche modo al sicuro nei campi di concentramento, perché grazie alla
politica di popolamento l’Africa Orientale era diventata una seconda patria per
migliaia di famiglie italiane le cui donne, vecchi, bambini e infermi erano ora allo
sbando e deperivano nei campi allestiti per loro nelle circostanti colonie inglesi.
Alla fine del 1941 il governo britannico informò così quello italiano che non avrebbe
potuto garantire la sicurezza e la sopravvivenza stessa degli italiani del Corno
d’Africa e che quindi era necessario aprire una trattativa per il loro rimpatrio in Italia:
il governo fascista non potè che accettare anche se paventava che questo esodo
potesse compromettere per sempre tutta la sua politica di popolamento cui non
intendeva ancora rinunciare.
V
Con il permesso delle autorità inglesi (e dietro pagamento di riscatti) furono così
organizzati convogli navali per portare in Italia donne, bambini, vecchi e infermi:
migliaia di famiglie furono smembrate (ma gli uomini erano stati comunque già
imprigionati) e le motonavi ‘Saturnia’ e ‘Vulcania’ e i transatlantici ‘Caio Duilio’ e
‘Giulio Cesare’, dipinte con i colori della Croce Rossa, divennero le famose ‘navi
bianche’ a bordo delle quali circa 28mila persone in tre viaggi diversi tra l’aprile
1942 e il settembre 1943 si imbarcarono a Berbera (nel Somaliland) e lasciarono
Etiopia, Eritrea e, in misura minore, Somalia per essere rimpatriate.
Emanuele Ertola (‘Navi Bianche. Il rimpatrio dei civili italiani dall’Africa Orientale’)
ha studiato l’evento con attenzione e descrive un’umanità sconfitta e dolente: si
imbarcarono ‘Donne smunte, lacerate accaldate, affrante dalle fatiche, scosse dalle
13
emozioni … Bimbi sparuti che le lunghe privazioni … e l’ardore del clima hanno
immiserito e stremato fino al limite’, oltre opportunisti che si presentarono sotto falso
nome e tolsero il posto a chi ne aveva diritto, mentre a bordo le malattie e le molestie
sessuali sarebbero state sempre in agguato.
Per evidenti motivi militari la navigazione del canale di Suez era interdetta e dunque
per arrivare in Italia si dovette circumnavigare l’Africa con viaggi di 11mila miglia
marine che duravano 34 giorni (più altrettanti per tornare) passando dai torridi climi
equatoriali a quelli gelidi dell’inverno antartico.
Per parte sua il regime fascista cercò in tutti i modi (al solito) di salvare la faccia:
nonostante le navi fossero sotto il controllo dei soldati britannici e si trattasse di una
emergenza umanitaria dovuta alla sconfitta, le missioni vennero invece presentate
come un’azione di salvataggio e di solidarietà nazionale.
Si proclamò che ‘L’Italia fascista andava a riprendersi i suoi figli in pericolo. Le navi
bianche rappresentavano la patria’ e al momento dell’imbarco i profughi venivano
salutati dalle note della ‘Marcia Reale’ e di ‘Giovinezza’ come se la loro partenza
fosse un successo di cui menar vanto.
Lo sforzo del governo fascista fu comunque sincero: pur impelagato in una guerra
che stava perdendo (ma anche per far sfoggio di una potenza che non aveva) attrezzò
le quattro navi in modo da rendere le traversate il più sicure e confortevoli possibile.
Al momento dell’imbarco tutti venivano sottoposti a una disinfezione generale
(docce, cambi di vestiti, taglio dei capelli e vaccinazione antidifterica per i bambini):
anche se poi in fondo queste famose navi bianche erano pur sempre degli enormi
dormitori che dovevano contenere il triplo dei passeggeri previsto e se nelle camerate
i letti a castello erano sistemati su cinque o sei piani, c’erano però la posta, una filiale
della Banca Nazionale del Lavoro e del Banco di Roma, il cinema, la radio, la
biblioteca, la sala da ballo, calzolai, la stamperia che pubblicava in formato ridotto il
‘Corriere della sera’, il ‘Popolo d’Italia’ e il ‘Giornale d’Italia’, l’ospedale con un
direttore di sanità, chirurghi, pediatri, farmacisti, gabinetti batteriologici, radiologici e
dentistici, la sala parto, il dispensario, ambulatori, un reparto per le malattie infettive,
uno per i tubercolotici, due sale operatorie e addirittura celle con le pareti imbottite
per i pazzi furiosi.
Particolare cura venne posta poi al vitto con cuochi e camerieri che preparavano e
servivano cibo buono e abbondante; tre parrucchieri per nave erano subissati di
richieste dalle donne che da mesi non ne vedevano uno, così come i due calzolai per
nave, costantemente intenti a rappezzare scarpe ridotte in condizioni pietose.
Tutto era stato previsto e si pensò perfino a organizzare i bambini (che avevano
ricevuto giocattoli) perchè aiutassero a mantenere l’ordine a bordo.
Per gente provata dalla guerra e da mille privazioni, che in un clima implacabile era
stata tradotta con grandi disagi dai campi di prigionia o dalle sue città di residenza
ormai del tutto insicure, riuscire finalmente a imbarcarsi e trovare così rifugio,
sicurezza, cibo e vestiti, rappresentò sicuramente un profondo e commuovente
sollievo: anche se a bordo i problemi non mancarono le testimonianze in questo senso
sono concordi, ma si trattò di una tregua passeggera.
14
Partirono infatti donne, bambini, vecchi, disabili e infermi che erano stati separati
dagli uomini validi rinchiusi nei campi di detenzione così che le famiglie erano state
smembrate e si sarebbero potute riunire (quando lo furono) solo dopo anni; i profughi
che sbarcarono in Italia avevano dovuto abbandonare tutto quello che avevano e che
avevano costruito col loro lavoro; tutte le loro speranze di una vita migliore erano
miseramente naufragate e le promesse che li avevano allettati e li avevano fatti partire
non erano state minimamente mantenute; arrivarono coi loro miseri stracci in un
Paese che stava perdendo la guerra e che presto sarebbe stato invaso da nord e da sud.
Eppure queste circa 28mila persone all’arrivo sulle banchine dei porti di Genova, di
Livorno e di Napoli vennero ugualmente accolte ‘da un bagno di patriottismo con alla
testa lo stesso sovrano’ (G. Esposito), grottesca celebrazione che inconsultamente
sperava di far passare per trionfo un disastro di quelle proporzioni, tipico esempio
della insulsa propaganda fascista.
Quelli delle navi bianche furono comunque solo i primi profughi ad arrivare in Italia
il cui flusso, iniziato spontaneamente nel 1940 subito dopo lo scoppio della guerra e
l’avanzata dell’esercito britannico, assunse inevitabilmente proporzioni sempre più
rilevanti.
Si era insomma solo all’inizio del dramma perché alla fine degli anni Quaranta i
profughi rimpatriati dall’Africa sarebbero stati 205.865 (54.878 dall’Etiopia,
45.142 dall’Eritrea, 12.124 dalla Somalia e 93.721 dalla Libia) e metà di questi
dovettero passare lunghi anni nei campi-profughi prima di poter essere
lentamente riassorbiti.
Per quanto concerneva l’Eritrea, dei circa 80mila italiani del 1941 nel 1944 ne era
rimasta la metà, 36.800 nel 1945, 31.800 nel 1946, 27mila nel 1947 e 20mila nel
1950, anche perché dal 1948 era ripresa l’attività terroristica ed aggressiva degli
‘sciftà’ che attaccavano gli italiani e le proprietà che erano riusciti a conservare.
VI
Il loro destino era un’ineluttabilità storica: avevano occupato con la violenza la
terra di altri e si erano comportati da padroni, nè valeva a riscattarli da questa
colpa incancellabile il fatto che un certo numero di loro aveva però lavorato e
costruito, piantato radici e portato migliorie anche sostanziali a quella che aveva
considerato la sua nuova patria.
Non potevano più restare in Eritrea (e negli altri Paesi del Corno d’Africa), era
giusto e inevitabile che dovessero infine pagare il conto per le sofferenze e i
soprusi che avevano causato alle popolazioni indigene: il colonialismo non ha
scusanti.
La politica di popolamento, ben precedente alla sua esasperazione operata dal
regime fascista, era stata irrealistica ed errata (e ingiusta!) fin dall’inizio, ma con
la sua irresponsabile e sconsiderata (per non dire altro) entrata in guerra la classe
dirigente fascista aveva mostrato di avere una visione totalmente e colpevolmente
distorta della situazione e, prigioniera della sua stessa propaganda megalomane e
irresponsabile, aveva radicalmente e drammaticamente sbagliato tutti i calcoli e tutte
15
le previsioni: non fu certo un rimedio alla sua criminale insipienza se cercò almeno di
alleviare la tragedia del rimpatrio forzato dei profughi organizzando un trasferimento
che, nei limiti del possibile, fu comunque apprezzabile e anche generoso.
VII
Dal 1 aprile 1941 l’Eritrea rimase sotto occupazione militare fino al 1947 e fu poi
protettorato britannico fino al 15 settembre 1952, quando l’ONU la dichiarò (non
senza difficoltà) federata all’Impero etiope: nel 1949 gli italiani in Eritrea erano
ancora 25mila e quelli ad Asmara 17.183 (su una popolazione di 127.579 abitanti).
In prevalenza giovani nati in Eritrea, essi si mantenevano estranei alla vita politica e
lavoravano con profitto, ma il loro numero si andò assottigliando finchè al momento
dell’indipendenza ne erano rimasti circa 11mila (quasi tutti concentrati ad Asmara):
anche il destino di questi ultimi sopravvissuti della storia era però ormai
segnato.
Dopo che nel 1962 l’Eritrea era divenuta (contro la sua volontà) una provincia etiope,
il nuovo regime comunista del DERG di Menghistu nel 1975 depose e assassinò il
Negus (protettore degli italiani) e, fra l’altro, procedette a numerose nazionalizzazioni
che colpirono - soprattutto in Eritrea – i circa 9mila proprietari italiani che erano
riusciti a conservare i loro beni (industrie, terre e case), che avevano prosperato e che
ora dovettero cominciare ad andarsene: la situazione della comunità italiana di
Asmara era infatti divenuta così seria che nello stesso 1975 il governo italiano, a
partire dal 5 febbraio, dovette istituire un ponte aereo per portarne buona parte in
salvo a Roma.
Le partenze continuarono negli anni seguenti finchè all’inizio degli anni Ottanta in
Eritrea erano rimasti circa 2mila italiani: ulteriori abbandoni furono infine causati
dalla guerra tra Etiopia ed Eritrea (e dalla guerra civile in Etiopia) negli anni
immediatamente seguenti, al termine della quale il 24 maggio 1993 l’Eritrea ottenne
l’agognata indipendenza.
Una nuova guerra con l’Etiopia per il problema dei confini spinse all’emigrazione
altri italiani ancora, finchè nel 2007 in Eritrea ne erano rimasti solamente 733, quasi
tutti ormai anziani e concentrati ad Asmara e Massaua, pallida testimonianza di
un’epoca ormai da tempo giunta alla sua logica e inevitabile conclusione.
Somalia colonia più duratura
Insieme all’Eritrea, il colonialismo italiano mosse i suoi primi passi anche in
direzione della Somalia.
A quel tempo questa terra lontana e semidesertica non esisteva certo come nazione
unita e omogenea: era infatti abitata da popolazioni somale, etiopi, dancale e oromo,
mentre dal punto di vista politico gli egiziani avevano il controllo (almeno teorico)
delle coste sul mar Rosso mentre il resto della regione era frazionato in sultanati,
emirati e altri territori retti da capi tribali.
16
L’apertura del canale di Suez (1869) e la conseguente profonda modificazione delle
rotte per l’Oriente resero le coste del Corno d’Africa importanti e appetibili per le
Potenze europee che ne sconvolsero completamente l’assetto: Inghilterra, Italia e
Francia cominciarono infatti a stabilirvi i primi punti d’appoggio tramite accordi e
contratti con i vari sultani locali e procedettero ben presto ad allargamenti,
occupazioni e spartizioni.
Dopo aver sottomesso l’Egitto, gli inglesi nel 1886 (subito dopo la conclusione del
Congresso di Berlino) stabilirono il loro protettorato su gran parte della costa sul mar
Rosso e sul corrispondente interno (la Somalia Britannica futuro Somaliland); una
piccola parte della costa sul mar Rosso che separava la Somalia dall’Eritrea fu
assegnata alla Francia (la Somalia Francese), mentre tutta la Somalia meridionale
(comprendente la punta del Corno e tutta la fascia sull’oceano Indiano) fu lasciata
all’Italia.
Come si vede, si trattava dei (soliti) accordi fra le Potenze europee che potevano
permettersi di fare quel che volevano delle terre africane (e asiatiche) e delle loro
popolazioni.
In questi veri e propri accaparramenti erano inoltre grandemente facilitati dalla
capacità degli europei di inserirsi nelle dispute locali a proprio esclusivo vantaggio: il
primo passo della penetrazione italiana in Somalia fu così il trattato commerciale col
sultano di Zanzibar (1885); alla fine del 1888 il sultano di Obbia (sulla costa centrale
dell’oceano Indiano) stipulò poi un trattato con gli italiani che rendeva il suo
sultanato un loro protettorato; l’anno seguente il sultano della Migiurtinia (sul Corno
e sulla costa settentrionale dell’oceano Indiano), suo rivale, ne firmò uno simile;
infine nel 1891 l’Italia ottenne in affitto dal sultano di Zanzibar alcuni porti del
Benadir fra cui quello di Mogadiscio.
I sultani di Obbia e di Migiurtinia erano mossi da propri obiettivi espansionistici per
il conseguimento dei quali chiesero l’aiuto italiano e (come tanti altri) pensarono di
poter sfruttare a proprio vantaggio gli interessi contrastanti delle Potenze europee nel
Corno d’Africa: davvero una vana ed ingenua speranza dato che le Potenze europee
si accordavano sempre fra loro per dividersi e spartirsi gli immensi spazi asiatici
e africani (e non certo solo quelli somali) servendosi dei capi locali se e fino a che
lo ritenevano utile.
L’Italia iniziò subito ad espandersi nei territori circostanti le sue concessioni: la
Somalia era comunque un Paese in gran parte desertico che risultava appetibile non
tanto per le sue risorse quanto per i suoi porti e per le regioni dell’interno cui questi
davano accesso.
L’Italia non aveva dunque grossi interessi alla colonizzazione del Paese, ma i gravi
incidenti di Mogadiscio (1896) e la rivolta di Muhammad Abd Allah al-Hasan, ‘the
Mad Mullah’ (il ‘Mullah pazzo’ per gli inglesi), scoppiata nel 1901 con la
proclamazione della guerra santa contro inglesi, italiani ed etiopi, convinsero il
governo italiano a inviare truppe e a occupare ulteriormente il Paese (o, meglio,
quella sua parte che gli era stata assegnata).
Nel 1903 il governo italiano istituì così una vera e propria colonia nel sud della
Somalia (un territorio che versava nel caos e nella miseria) affidandola però alla
17
(sovvenzionata) Società Commerciale Italiana del Benadir sulla base di una
convenzione della durata di cinquant’anni.
La rapace e disastrosa gestione della Società (nel 1903 nel Benadir c’erano tredici
italiani e l’anno seguente diciassette) e lo scandalo per le accuse di aver tollerato e
addirittura collaborato alla tratta degli schiavi (!) sono così descritte da Angelo Del
Boca (‘Gli italiani in Africa Orientale’): ‘Una colonia che esiste solo sulla carta. Una
Società di gestione che non amministra ma esercita una rapina. Venti italiani che si
odiano fra di loro e che sono circondati dall’odio degli autoctoni. … Sotto gli occhi
delle autorità italiane … gli schiavi vengono … liberamente acquistati, venduti,
ereditati, offerti in regalo, sfruttati, incatenati, deportati.’
Giolitti dovete così correre ai ripari: il 13 gennaio 1905 si accordò col sultano di
Zanzibar per l’assunzione diretta dei porti e della colonia del Benadir (dietro
pagamento di un’ingente somma), il 14 febbraio la Società si autoliquidò e il 5 aprile
1908 il governo italiano trasformò definitivamente l’intera Somalia meridionale in
colonia col nome di Somalia Italiana, i cui confini furono definiti nello stesso anno
da un trattato italo-etiope.
Secondo una logica non certo nuova né infrequente, anche nel caso della Somalia
Italiana la potenza coloniale era stata quasi costretta ad accrescere la sua zona
d’influenza e a metterla sotto stretto controllo: un dominio più ridotto (e forse più
desiderabile) non era infatti possibile data l’ostilità delle popolazioni indigene che
avevano presto compreso la trappola in cui erano cadute dopo che avevano cercato ed
accettato trattati con gli europei e ne avevano invece subìto l’espansione militare e la
confisca delle (poche) terre migliori.
In conclusione: se gli europei volevano restare in Somalia le sue popolazioni
andavano sottomesse in modo definitivo.
L’espansione italiana in Somalia dunque continuò e culminò il 15 luglio 1924 con
l’acquisizione del porto di Chisimaio e della regione circostante (l’Oltregiuba)
nell’estremo sud della costa sull’oceano Indiano: questi territori (90mila kmq. con
72mila abitanti) - già acquisiti dall’Inghilterra dal sultano di Zanzibar e uniti al Kenia
- fecero parte di quei (magri) compensi coloniali previsti dal Patto di Londra (in
occasione dell’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale) e costituirono la
regione più ricca della Somalia Italiana.
I
Anche in Somalia con l’avvento del fascismo si registrò una netta intensificazione
della pressione coloniale: il suo governatore De Vecchi (un ex-quadrumviro) impose
un regime duro e spietato e procedette alla vera e propria riconquista (o conquista) di
numerosi territori così che nel 1926 la colonia era stata completamente ‘pacificata’
(vergognoso eufemismo per significare il dominio ottenuto al prezzo di stragi e di
violenze di ogni tipo).
Nella spietata e brutale opera di sottomissione e di repressione gli italiani fecero
ampio ricorso a truppe africane (12mila soldati indigeni comandati da 300 ufficiali
italiani, marina e aviazione a parte), altra tristissima caratteristica dei regimi
18
coloniali che seppero sempre trovare indigeni (o comunque extra-europei)
disposti ad obbedirli e a servirli (anche con entusiasmo) con le armi in pugno
contro i propri stessi conterranei.
Così Angelo Del Boca riassume l’accaduto dell’ultima fase delle operazioni (192627): ‘De Vecchi può fare il bilancio definitivo delle perdite nei due campi in due anni
di guerriglia e controguerriglia. Sono morti 3 ufficiali italiani, 4 soldati metropolitani,
97 ascari [mercenari eritrei], 449 dubat [soldati irregolari somali], mentre i feriti sono
341. Nel campo avversario i morti sono 1.236 e i feriti 757. Dal che si deduce che
l’intero tributo di sangue è stato pagato dai somali, in una guerra fratricida, mentre i
dominatori hanno talmente perfezionato i loro metodi, con l’ausilio della marina e
dell’aviazione e assoldando senza risparmio i mercenari, da non perdere che sette
uomini in tutto.’
II
La triste ‘pacificazione’ ebbe comunque un certo successo così che nei primi anni
Trenta molti somali si arruolarono nelle truppe coloniali italiane e i nuovi governatori
italiani poterono sviluppare una politica fondata sull’assimilazione dei somali e della
loro cultura e su un certo rispetto della loro struttura tribale e sociale e della loro
religione islamica.
Secondo la logica stessa del colonialismo venne poi varato il (solito) programma di
opere pubbliche (le prime ferrovie, una migliore sistemazione della rete stradale,
dighe, porti, ecc.) che permettessero lo sfruttamento delle risorse del territorio
altrimenti inutilizzabili.
Naturalmente la politica di popolamento fu applicata anche alla Somalia: in un primo
tempo l’emigrazione italiana in Somalia era stata limitata ai soli uomini ed a
pochissime famiglie (al primo censimento del 1 dicembre 1921 risultarono 656
italiani residenti), ma ora col nuovo impulso impresso dal fascismo molte centinaia
di famiglie italiane vennero trapiantate nel Paese - soprattutto nella capitale, nelle
aree agricole del Villaggio Duca degli Abruzzi (fondato nel 1920 dal duca Luigi
Amedeo di Savoia-Aosta e detto anche ‘Villabruzzi’) e sull’Uebi Scebeli (50 km a
nord di Mogadiscio).
A Villabruzzi nella seconda metà degli anni Trenta si insediarono alcune migliaia di
coloni italiani e la cittadina divenne il centro agricolo principale della Somalia
Italiana con un’annessa industria alimentare.
Altra colonia agricola, promossa dal governatore De Vecchi e sviluppata da coloni
italiani, fu Genale (vicino alla foce del Giuba) che presto divenne un’importante
produttrice di cotone e in seguito di banane.
Migliaia di coloni italiani si trasferirono a Mogadiscio e fondarono altre aziende
agricole intorno alla capitale e, se nel 1930 c’erano in Somalia 22mila coloni italiani
(il 2% dell’intera popolazione), nel 1935 erano saliti a oltre 50mila (il 5% della
popolazione), 20mila dei quali residenti nella capitale (circa il 40% dei 50mila
abitanti della città).
19
Queste cifre non includono ovviamente nessuno dei 220mila soldati italiani di stanza
nella Somalia Italiana durante la seconda guerra italo-abissina, cioè la guerra
d’Etiopia tout court (1935-36).
III
Durante la guerra d’Etiopia (che verrà trattata nel capitolo sull’Etiopia), nell’ottobre
1935 l’attacco sul fronte meridionale partì dalla Somalia e, a guerra conclusa (maggio
1936), alla Somalia Italiana venne aggiunto l’Ogaden (in quanto popolato da somali).
Con la proclamazione dell’Impero la Somalia Italiana con Etiopia ed Eritrea entrò
infine a far parte dell’Africa Orientale Italiana (AOI).
Negli anni seguenti e prima dello scoppio della seconda guerra mondiale anche la
Somalia (come tutto l’Impero) fu ulteriormente interessata da un nuovo impulso alle
opere pubbliche (nuove strade come la ‘Strada Imperiale Mogadiscio - Addis Abeba,
nuove ferrovie, scuole, ospedali, porti, ponti, ecc.): lo sforzo fu serio tanto che nel
1940 la Somalia Italiana era diventato uno degli stati africani col più alto tenore di
vita (dei coloni ma anche dei somali) e che nell’ambito dell’AOI Mogadiscio
conobbe uno sviluppo urbano inferiore solo a quello di Asmara.
Nel marzo 1940 vivevano a Mogadiscio oltre 30mila italiani (1/3 della popolazione
totale della città) e il Villaggio ‘Duca degli Abruzzi’ contava ormai 12mila persone,
di cui quasi ¼ era italiano: esso raggiunse un notevole livello di sviluppo grazie alle
sue piantagioni di banane, di cotone e di canna da zucchero, e ad alcune piccole
industrie agricole.
IV
Tutto questo venne spazzato via dall’insensata entrata dell’Italia nella seconda guerra
mondiale e, ancor più, dalla dissennata campagna militare che venne condotta nel
Corno d’Africa.
Allo scoppio delle ostilità subito infatti le truppe italiane invasero il Somaliland
britannico: le forze britanniche nel Somaliland ammontavano a 11mila uomini e
quelle italiane a 35mila (30.000 indigeni e 5.000 italiani) così l’operazione ebbe
successo e il 19 agosto 1940 (a poco più di due settimane dall’inizio dell’offensiva!)
le truppe italiane entrarono vittoriose a Berbera e occuparono anche le aree del Kenya
confinanti con l’Oltregiuba, tanto che nell’agosto 1940 Mussolini, incredibilmente
perso nei suoi vaniloqui, arrivò dichiarare che aveva ormai riunito quasi tutti i somali
e realizzato così il loro sogno della Grande Somalia.
La realtà era però ben diversa ed anzi opposta a queste irresponsabili vanterie.
Il contrattacco inglese infatti non si fece attendere e, partito nel novembre-dicembre
1940 dal Kenya nella regione del Giuba, fu portato avanti da forze che, se
numericamente erano poco più della metà di quelle italiane, erano però motorizzate e nella guerra nel deserto la mobilità e la velocità sono tutto.
Il Corno d’Africa fu l’unico settore di guerra in cui i tedeschi non corsero in
aiuto degli italiani e così il contrattacco inglese si risolse in una ritirata continua e
20
disordinata dei reparti italiani guidati da generali indecisi, confusi e incapaci, agli
ordini del duca d’Aosta altrettanto dubbioso, contraddittorio, inconcludente e
velleitario.
Gli italiani riuscirono a resistere solo a Cheren dopo di che la campagna si risolse,
come disse il War Office inglese, in un ‘inseguimento [che] non ha pari nella storia
militare per la celerità della marcia e la vastità della distanza coperta. La Somalia
Italiana cadde come una pera matura’: le truppe indigene disertarono in massa
‘mentre i generali italiani gareggiano in velocità sulle strade imperiali’ commenta
amaro e ironico Angelo Del Boca.
Il 25 febbraio Mogadiscio venne proclamata città aperta e, occupata la Somalia,
gli inglesi proseguirono di slancio verso Addis Abeba, ampiamente riforniti di armi,
carburante, mezzi, viveri e materiali trovati e requisiti nei magazzini italiani.
La Somalia Italiana (come tutta l’AOI) era persa e interamente occupata dalle
truppe inglesi.
V
Come altrove, anche in Somalia gli italiani sconfitti conobbero il peso della perdita
della loro nuova patria: anche qui un buon numero di civili continuò comunque a
collaborare all’amministrazione inglese e a sostenere i 9.349 connazionali di
Mogadiscio e gli altri 800 nel resto del Paese, ma i 2/3 delle terre bonificate dovettero
essere abbandonati, i militari vennero internati e un certo numero di famiglie il 5
luglio 1943 trovò un passaggio sulle famose navi bianche.
La comunità italiana in Somalia nel 1945 si era così dimezzata e contava 4.600 unità
(di cui 4.152 a Mogadiscio), ulteriormente calate a 3.680 due anni dopo: mentre tutto
il materiale asportabile (binari compresi) venne smontato e portato via dagli inglesi, i
coloni di Villabruzzi furono costretti ad andarsene, il suo territorio fu lasciato
progressivamente incolto finchè ricevette il colpo di grazia in seguito alla guerra
civile del 1991: la ferrovia che la collegava alla capitale venne disattivata.
Anche se un certo numero di somali (soprattutto gli ex-combattenti) rimase amico
degli ex-coloni, nei primi anni del dopoguerra scoppiarono però moti nazionalistici
contro gli italiani che sotto il naso degli inglesi l’11 gennaio 1948 a Mogadiscio
sfociarono in violentissimi scontri, caccie, uccisioni indiscriminate di italiani, stupri e
diffusi saccheggi: il bilancio fu di 54 morti, 55 feriti (alcuni gravissimi) fra gli italiani
e di 14 morti e 43 feriti fra i somali che erano corsi in loro aiuto.
La commissione inglese Flaxman cercò di discolpare i suoi connazionali e di
attribuire la responsabilità degli incidenti a provocazioni (vere) da parte degli italiani,
ma nondimeno per descrivere l’accaduto ricorse al termine (che scrisse in corsivo)
‘pogrom’.
Alla fine dell’anno gli italiani a Mogadiscio si erano ridotti a 2.192.
21
VI
Eppure la presenza degli italiani in Somalia non venne giudicata negativamente tanto
che il 21 novembre 1949 con la risoluzione n° 289 la neonata ONU, nonostante
l’opposizione delle associazioni patriottiche e nazionaliste somale, accettò e fece
propria la proposta dell’Italia perché la preparazione della Somalia Italiana
all’indipendenza (da raggiungere in dieci anni) venisse affidata proprio a lei in un
regime di amministrazione fiduciaria.
L’ONU dunque assegnò la Somalia Italiana in amministrazione fiduciaria all’Italia
perché la portasse gradualmente all’indipendenza e gli inglesi continuarono ad
amministrarla solo fino a quando l’Italia il 1 aprile 1950 ne assunse il controllo
diretto (ratificato dall’ONU il 2 dicembre 1950 con la risoluzione n° 442).
L’Italia si assunse insomma il compito e la responsabilità di organizzare la Somalia,
già sua ex-colonia, in modo che questa fosse pronta e preparata per sapersi gestire
come Paese autonomo e indipendente: costituita l’AFIS (Amministrazione Fiduciaria
Italiana della Somalia), nei primi mesi dell’anno giunsero nel Paese 5.791 persone
più svariati mezzi ed armamenti per garantirne la sicurezza: insomma: tornarono in
Somalia anche truppe italiane (!).
La nuova occupazione della Somalia avvenne in modo pacifico e senza incidenti, i
carabinieri assunsero il controllo della polizia somala e giustizia e amministrazione
vennero affidate dagli italiani che progressivamente dovevano però cederne il
controllo ai somali: il Paese era ridotto in condizioni miserevoli perché quel po’ di
innovazione e di ammodernamento portato dagli italiani era stato saccheggiato,
requisito, distrutto e in gran parte annullato nei dieci anni di occupazione inglese.
Inevitabilmente il personale impiegato fu quello fascista (‘dopo la guerra non tornò in
Africa la nuova Italia democratica, ma ancora una volta la più schietta Italia fascista’
riconobbe Alessandro Pazzi ), quello che aveva dominato la colonia, che ora voleva
rivivere i privilegi del passato e che spesso ci riusciva: nei primi tempi l’AFIS subì
così dure critiche dall’ONU e dal governo italiano stesso, però è un fatto che il Corpo
di Sicurezza venne presto ridotto dai 5.688 soldati del 1950 ai 2.021del 1951 ed ai
692 nel 1953, che piano piano l’AFIS e la Lega dei Giovani Somali (la maggior
formazione patriottica) dopo i primi anni di dura opposizione cominciarono ad
avvicinarsi fra loro e che il processo di somalizzazione in qualche modo procedette.
Una certa cooperazione (nel 1956 facevano parte dell’AFIS 621 italiani e 4.380
somali), un percepibile progresso politico-sociale, ma solo modesti sviluppi
economici (nonostante i finanziamenti dell’ONU), fecero da cornice alle elezioni
generali del 1956, quando i somali elessero la loro prima Assemblea per la
semiautonomia, e a quelle del 1959, quando la Lega dei Giovani Somali divenne
partito di maggioranza: infine il 1 luglio 1960 la Somalia Italiana fu unita a quella
Britannica (che aveva ottenuto l’indipendenza il 26 giugno 1960) in un’unica
Repubblica.
22
VII
La missione era stata compiuta e l’Italia aveva speso cifre ingenti per la sua
esecuzione: non era certo una novità, bensì una regola, che l’Italia in Africa ci aveva
sempre rimesso, tanto che vien da chiedersi che senso abbia mai avuto la sua
insistenza nel chiedere di caricarsi sulle spalle anche questo peso mentre all’interno
aveva tanti bisogni da soddisfare e tanti problemi da risolvere (Ernesto Rossi
concluse che ‘le Somalie da assistere non abbiamo bisogno di cercarle fuori dei nostri
confini’) e la risposta non può che essere cercata nel bisogno di prestigio
internazionale, nel rimpianto per la passata presenza in Africa, nelle pressioni delle
lobbies coloniali ancora forti e influenti, negli interessi dei pochi, ricchi ma potenti,
concessionari in Somalia (che in Italia avevano per esempio il monopolio della
vendita delle banane che così costavano il doppio che nel resto d’Europa) e di tutto il
personale italiano che riceveva altissimi stipendi (che assorbirono grandi fette dei
finanziamenti) e che poteva lucrare in molti altri modi facendo sì che ‘gran parte del
denaro stanziato dall’Italia per la Somalia è in realtà rientrato in Italia’ (Angelo Del
Boca), ma questo fu anche il canto del cigno degli italiani in terra d’Africa.
Le loro partenze si erano già moltiplicate e quando nel 1970 Siad Barre, dopo alcuni
anni di agitazioni politiche, dichiarò che la Somalia era uno stato socialista e
nazionalizzò la maggior parte delle attività economiche del Paese, il flusso migratorio
degli italiani si intensificò riducendo fortemente il numero di coloro che invece
restavano.
La prosecuzione delle nazionalizzazioni e lo scoppio della guerra con l’Etiopia nel
1977 accelerarono l’inevitabile destino degli ultimi italiani in Somalia: nel 1989 ne
erano rimasti un migliaio, nel 2007 si erano ridotti a 15 e nel 2010 a 4.
VIII
Un altro capitolo della nostra storia si concluse così nell’indifferenza dell’opinione
pubblica metropolitana, altri sogni andarono in frantumi cozzando contro la realtà,
altre vite furono travolte e altre eredità svanirono e vennero dimenticate per sempre:
anche in questo caso sentimenti e giudizi nei confronti di coloro che rientrarono dalla
Somalia non possono che essere contrastanti perché essi pagarono caramente per aver
seguito e creduto nel governo del loro Paese, furono convinti assertori e artefici di
una vera e propria missione che questo aveva affidato loro e quando questa fallì
miseramente furono quelli che persero tutto mentre in Italia nessuno si curò più di
loro.
Tutto vero, ma questi italiani furono anche complici della spoliazione e dello
sfruttamento di un popolo lontano che non gli aveva fatto niente, della sua
sottomissione ottenuta con metodi vili e violenti e del disprezzo razzista tipico del
bianco verso il nero: furono quindi colpevoli.
Ebbero dunque quel che si meritarono? La risposta non può che essere
affermativa.
23
Il professor Ernesto Galli della Loggia invita giustamente a non dimenticare che
quella colonialista era comunque la mentalità del tempo e che oggi è fin troppo facile,
quindi ingiusto e sbagliato, condannare comportamenti che allora erano normali:
verissimo: diciamo allora che è semplicemente giusto che, cambiati i tempi, chi più
profittò di quelli passati più deve pagare anche se, se non proprio i soli, i primi a
volare furono comunque gli stracci, ma questa è sempre la solita storia.
Libia colonia principale
Troppo recentemente unificata e con risorse limitate, l’Italia arrivò ultima nella corsa
all’accaparramento dell’Africa e in qualche modo dovette accontentarsi (per così
dire) di quei territori che erano rimasti ‘liberi’ e ‘disponibili’ fra cui la Tripolitania e
la Cirenaica – cioè la Libia –, ancora possedimenti ottomani seppur separati
geograficamente dal resto dell’Impero: dopo lo ‘schiaffo di Tunisi’ fu così che l’Italia
indirizzò le sue mire espansionistiche anche in questa direzione.
Nonostante l’Italia ne fosse allora il principale partner commerciale e ci vivessero
circa 600 suoi cittadini, per lei la Libia era però un insieme di territori ancora
completamente sconosciuti e così dagli anni Ottanta dell’Ottocento per un trentennio
si susseguirono esplorazioni, studi e contatti coi capi delle tribù arabe che si
supponeva fossero ostili ai turchi e quindi disposti a sostenere l’eventuale conquista
da parte di una potenza europea che le avrebbe ‘liberate’.
Ancora una volta (come sempre) le trattative per questa progettata ulteriore conquista
coloniale si svolsero però fra i Paesi europei nell’ambito di (le solite) complicate
manovre spartitorie, ‘compensi’ in cambio del riconoscimento delle occupazioni
altrui, ricerca di equilibrio nel Mediterraneo e fra i domini extraeuropei delle varie
Potenze, scambi diplomatici e quant’altro le nazioni europee mettevano in campo per
garantirsi pretese ben al di fuori dei propri confini, convinte com’erano di avere
illimitati diritti su tutta l’Asia, su tutta l’Africa e su tutti coloro che ci vivevano,
giudicati barbari, primitivi e appartenenti a culture e civiltà incomparabilmente
inferiori alla loro.
I
Alla svolta del secolo l’Italia stava vivendo una situazione davvero contraddittoria
perché mentre la sua produzione aumentava considerevolmente in tutti i settori e il
sapiente Giolitti metteva finalmente mano a una politica di riforme sociali,
l’emigrazione - soprattutto dal Meridione - cresceva però a ritmi impressionanti
mentre nasceva una nuova destra (futurismo e nazionalismo) scalpitante e ansiosa di
azione: tutti gli ingredienti del colonialismo – e in particolare di quello italiano che
voleva risolvere con la conquista di nuovi territori il problema della destinazione
degli emigranti - con l’aggiunta per soprammercato di tutto il ciarpame
propagandistico a proposito della liberazione degli arabi dall’iniquo e crudele giogo
ottomano, della nobile e grandiosa missione civilizzatrice ecc. ecc., si coagularono e
24
spinsero Giolitti a decidere di invadere la Libia ancora ‘libera’ e su cui le Potenze
europee avevano da tempo riconosciuto ‘l’interesse preminente’ dell’Italia
(lasciandogliela cioè a disposizione).
Nel 1911 in Libia vivevano meno di un migliaio di italiani (quasi tutti a Tripoli e un
centinaio a Bengasi) su circa 750mila indigeni e da anni in Italia il Paese era
considerato una vera e propria ‘terra promessa’, ricchissima di risorse naturali, via
d’accesso all’Africa subsahariana e ai suoi commerci, che finalmente avrebbe fatto
uscire l’Italia dalla gabbia del Mediterraneo: una forsennata campagna di stampa (e
non solo degli entusiasti nazionalisti) non conobbe limiti nell’esagerare in modo
irresponsabile ciò che la Libia avrebbe potuto offrire ai coloni e agli imprenditori
italiani e alla sua possibilità di risolvere (o almeno di mitigare) il sempre pressante
problema dell’emigrazione.
Il meccanismo della preparazione all’invasione fu ancora una volta il solito: nei primi
anni del nuovo secolo il Banco di Roma (cattolico), protetto dal governo, aveva dato
vita ad una ‘penetrazione pacifica’ della Libia mediante l’apertura di filiali e di
aziende e tutta una serie di grossi investimenti fino a lanciarsi in una vera e propria
campagna acquisti di beni immobiliari pagando prezzi anche spropositatamente alti.
Le autorità turche si erano ovviamente allarmate e avevano cominciato ad ostacolare
questa ‘penetrazione pacifica’ fornendo così la semplice (e scontata) scusa per la
guerra: pretendendo che i legittimi interessi dell’Italia fossero minacciati dalla
prepotenza e dall’inciviltà turche ed ignorando tutte le proposte di accordo e di
conciliazione che queste avanzavano (mostrandosi disposte a fare concessioni anche
rilevanti), Giolitti ottenne l’approvazione del re e procedette senza nemmeno
consultare il Parlamento alla conquista della Libia.
Il 28 settembre 1911 (cinquantenario dell’Unità) il governo italiano per rispondere
all’ ‘appello dei suoi sudditi in pericolo’ lanciò un ultimatum a quello turco dandogli
ventiquattr’ore di tempo per decidere e, rifiutata ogni proposta offerta di dialogo e di
discussione, ordinò di invadere la Libia: in realtà gli italiani in Libia erano così ‘in
pericolo’ che al precipitare degli eventi - per la loro stessa salvaguardia - vennero
imbarcati per l’Italia sotto la protezione dei soldati turchi.
II
La guerra, iniziata il 3 ottobre 1911 col bombardamento navale di Tripoli e con lo
sbarco effettuato due giorni dopo sulle sue coste, andò ben diversamente - anzi in
modo opposto - a quanto immaginato: a Roma si era pensato infatti che si sarebbe
trattato di una guerra-lampo facile e veloce visto che si dava per scontato che gli arabi
si sarebbero sollevati contro i turchi al fianco degli italiani mentre invece avvenne
l’esatto contrario perché essi combatterono subito, duramente e convintamente,
proprio insieme ai turchi contro gli invasori venuti dal mare.
Presi in contropiede, gli italiani sostennero che gli arabi avevano ‘tradito’ (!?) e che si
comportavano ‘brigantescamente’ (!?) così che nei loro confronti la repressione fu
brutale, selvaggia e costellata di rivoltanti efferatezze: fin dall’inizio gli eccidi e le
25
atrocità indiscriminate si moltiplicarono, perpetrate al riparo degli occhi della stampa
pesantemente tenuta lontana e censurata.
Imbarazzata e desiderosa di mettere le Potenze europee di fronte al fatto compiuto, il
5 novembre l’Italia proclamò uniteralmente l’annessione della Libia (che il
Parlamento convertì in legge nei primi giorni del marzo 1912 con 431 sì, 38 no e 1
astenuto) anche se allora non aveva stabilito che teste di ponte sulla costa, non era
stata in grado di avanzare nel territorio e la stragrande parte del Paese era ancora
totalmente fuori del suo controllo: nonostante la schiacciante superiorità per numero
di soldati (che dai 34mila iniziali alla fine dell’anno sarebbero arrivati a 103mila
contro poche migliaia di turchi, i partigiani arabi e la popolazione indigena), mezzi ed
armamenti, gli italiani infatti non erano riusciti a penetrare nell’interno che in modo
del tutto trascurabile ed erano rimasti sempre inchiodati sulle coste ben al riparo dei
cannoni delle corazzate.
Ma in Italia la guerra veniva celebrata con entusiastici profluvi di pubblicazioni e di
propagande di ogni tipo presso ogni strato della società, mentre dall’altra parte del
Mediterraneo le fucilazioni e le impiccagioni pubbliche di arabi resistenti si
moltiplicavano senza che questi cessassero – tranne poche eccezioni – di sostenere i
turchi e di combattere strenuamente al loro fianco: non solo dunque la guerra durò e
costò molto più del previsto, ma non fu nemmeno possibile risolverla sul suolo libico.
III
Nel tentativo di piegare finalmente la caparbia e incredibilmente abile resistenza dei
turchi e degli arabi, per l’Italia fu infatti necessario condurre le operazioni su altri tre
fronti (!):
il primo fu nel mar Rosso dove la flotta italiana cercò di interrompere l’arrivo di
rifornimenti ai resistenti e di minacciare la Turchia anche in Arabia (dove trovò
alleati), ma anche questo espediente non fu risolutivo perché gli aiuti comunque
continuarono ad affluire in Libia via terra dalla Tunisia e dall’Egitto;
un secondo fronte fu allora aperto nel mar Egeo dove nell’aprile-maggio 1912
vennero occupate Rodi e altre dodici isole (sotto il dominio turco ma popolate
prevalentemente da greci): va notato fu solo dopo questa estensione della guerra che
la Turchia si risolse all’immediata espulsione dei 60mila italiani che risiedevano
sul suo territorio;
una terza linea di attacco minacciò infine i Dardanelli dove la flotta italiana il 18
aprile 1912 bombardò i forti esterni (e lo stretto rimase chiuso per un mese fra le
condanne della comunità internazionale) e il 18 luglio con cinque torpediniere
effettuò un ardito e riuscito raid nello stretto stesso.
Eppure nemmeno questi molteplici interventi riuscirono nell’intento di piegare la
Turchia (!!!): le trattative segrete giacevano infatti a un punto morto e in Libia gli
italiani rimanevano chiusi nelle loro sacche (sette) sulla costa perché non erano
riusciti a penetrare all’interno per più di 15 km., e solo in alcuni punti.
La guerra insomma continuava ed era chiaro che l’Italia non riusciva a vincerla
nonostante moltiplicasse gli sforzi, le violente repressioni, l’invio di truppe e le spese.
26
IV
Fu infatti un evento esterno a far vincere la guerra all’Italia: il 30 settembre 1912
Bulgaria, Grecia, Serbia e Montenegro colsero l’occasione della guerra dell’Italia
contro la Turchia per dichiarargliela a loro volta (prima guerra balcanica) allo
scopo di espellerla una buona volta dai Balcani e dall’Europa.
Fu solo quando potè farsi forte di questa complicazione internazionale che Giolitti
riuscì finalmente ad imporre alla Turchia il suo ultimatum: il 18 ottobre 1912 venne
così stipulata la pace di Losanna con la quale la Turchia concedeva l’autonomia alla
Libia e l’abbandonava al suo destino nonostante le suppliche della popolazione araba
e la resistenza dei Senussi in Cirenaica (dove l’abile ed eroico Enver bey, uno dei
Giovani Turchi e dirigente del CUP, aveva mietuto notevoli successi).
Per parte sua l’Italia si impegnava a sgombrare le isole dell’Egeo, ad amnistiare gli
arabi (!?) e a garantire loro la libertà religiosa: quest’ultimo punto era di notevole
rilevanza perché Califfo, cioè supremo capo religioso degli islamici, era il Sultano di
Istanbul che quindi otteneva in qualche modo di continuare a governare
spiritualmente anche gli arabi della Libia - e questa era un’evidente ed oggettiva
limitazione del potere italiano su di essa.
Sia come sia, in effetti l’Italia aveva superato la sua prima vera prova in campo
internazionale, seppur in una guerra che era durata ben oltre le previsioni e che
comunque non aveva affatto portato alla conquista della Libia: in patria l’entusiasmo
e la soddisfazione furono però sinceri e notevoli, come testimoniò il voto con cui la
Camera (335 contro 24) e il Senato (157 contro 2) approvarono il trattato di pace
(detto di Ouchy).
La guerra era costata ufficialmente 3.431 morti (1483 in combattimento e 1.949 di
malattia, soprattutto per il colera dilagato fin dal momento del primo sbarco) e
secondo Francesco Rapaci nel quadriennio 1911-14 aveva assorbito circa metà del
bilancio annuo dello stato (!): ingente era stato infine il consumo di equipaggiamento
bellico della cui carenza l’Italia avrebbe risentito nell’imminente prima guerra
mondiale.
Eppure la guerra non era certo finita e la Libia era ancora quasi tutta da conquistare.
V
Col trattato di Losanna la Turchia aveva accettato di riconoscere l’indipendenza della
Libia (ma non l’aveva ceduta all’Italia!) e dovette quindi cominciare a sgombrare le
sue poche migliaia di soldati ma, nonostante da tempo avesse proclamato che era una
sua colonia, l’Italia non se n’era ancora impossessata: anche se un certo numero di
capi arabi tripolitani fece atto di sottomissione all’Italia, molti però abbandonarono il
Paese per trasferirsi nei territori dell’Impero ottomano e altri, capeggiati soprattutto
da Suleimàn el-Baruni, continuarono la resistenza contro gli invasori.
In realtà Suleimàn el-Baruni sarebbe stato anche disposto ad un accordo con l’Italia
ma le trattative naufragarono presto di fronte all’intransigenza dei militari sul campo
e dello stesso Giolitti: in Tripolitania iniziò così una confusa serie di scontri, di
27
vittorie e di sconfitte che videro gli italiani, pur assolutamente prevalenti per numero
di uomini e di mezzi (gli arabi potevano contare solo su qualche migliaio di
combattenti), dover fare affidamento sulle truppe di ascari eritrei e anche locali
perché questi erano gli unici in grado di condurre la guerra nel deserto e nelle
condizioni estremamente difficili di un territorio tanto esteso e desolato come
quello libico.
Anche quando gli italiani riuscivano ad avanzare nell’interno finivano poi per
rimanere intrappolati in quella inospitale vastità e a dover fare affidamento (colle
buone o colle cattive) sulle tribù locali.
Peggio ancora andarono le cose in Cirenaica dove Enver bey cercò tutte le scuse
possibili per non andarsene e dove i Senussi, diffusi anche al di fuori del territorio
libico, non si dimostrarono per niente disposti a cedere e a piegarsi: la repressione
italiana non conobbe allora limiti.
Fucilazioni e impiccagioni pubbliche e senza processo (dal governo stesso di Roma
arrivarono proteste), imprigionamenti, deportazioni, rastrellamenti, devastazioni,
stragi, si infittirono ai danni delle disgraziate popolazioni locali che però
continuavano a resistere: la controguerriglia e le rappresaglie praticate dagli italiani (e
dai loro reparti indigeni) si incrudelì tanto che Angelo Del Boca segnala che
‘nell’estate del 1913, cominciano a manifestarsi in tutta la Cirenaica gli effetti
disastrosi di due anni di guerra, di siccità, di cattivi raccolti, di frequenti passaggi
delle locuste. E con la fame arrivano anche altri flagelli, come il colera, il vaiolo e il
tifo. … fra il 1913 e il 1914 periscono in Cirenaica due terzi della popolazione, che
passa da 300mila, nel 1911, a 120mila nel 1915.’ (Va detto però che questa
affermazione non risulta del tutto credibile ed è oltretutto smentita dalle cifre diverse
fornite in altri momenti dallo stesso Del Boca).
Rimane comunque il fatto che nel 1911 in tutta la vasta Libia erano vissute circa
750mila persone, dunque una popolazione scarsa e tecnologicamente molto arretrata,
eppure l’Italia (e le sue truppe indigene) nonostante i metodi brutali e spietati non
riusciva ad averne ragione né a venire a capo della loro ostinazione: anche coloro che
pure si sottomettevano erano però sempre pronti a rialzare la testa appena se ne
presentava l’occasione.
Il motivo di ciò era semplice: se volevano rimanere liberi sulla propria terra non
avevano altra scelta.
Per esempio, fin dal 1875 i turchi avevano concesso diritti politici e rappresentanza ai
libici mentre gli italiani (che si erano presentati come ‘liberatori’) glieli avevano
subito tolti e ai capi collaborazionisti concedevano semmai cariche che erano
semplici titoli onorifici senza vero contenuto: in Libia si erano poi gettati speculatori,
avventurieri e veri e propri razziatori avidi di bottino e di facili guadagni che subito si
erano dedicati alla spoliazione dei nativi.
A rendere ancora più assurda la vicenda, divenne sempre più evidente che la Libia,
che pur era stata presentata come la ‘terra promessa’, era in realtà largamente
desertica (il famoso ‘scatolone di sabbia’ di Nitti) e che la terra coltivabile era di
proprietà – individuale o collettiva – dei libici, mentre quella del demanio ex-turco,
su cui gli italiani volevano e potevano mettere le mani, era molto poca.
28
La Libia costava sempre di più, assorbiva forze notevoli e non rendeva niente: ciò
faceva sì che il carico terribile di sofferenze inflitto all’innocente e sfortunata
popolazione locale era ancor più insensato e vergognoso: del tutto incurante di questo
aspetto della situazione il 7 marzo 1914 il Parlamento italiano con 231 voti a favore e
47 contrari approvò tranquillamente ulteriori spese militari.
VI
Scoppiata pochi mesi dopo la prima guerra mondiale, turchi e tedeschi non si fecero
ingannare dall’iniziale neutralità dell’Italia e subito la impegnarono ulteriormente in
Libia facendovi giungere propri ufficiali e aiuti.
L’appoggio di turchi e tedeschi ridiede slancio alla resistenza araba: così come nella
vittoria dell’Italia sulla Turchia era stata essenziale la prima guerra balcanica, allo
stesso modo nel riaccendere la resistenza libica fu determinante la prima guerra
mondiale che si può dire l’Italia combattè anche in Africa, dove disponeva di 70mila
soldati e di molto armamento moderno contro una popolazione di 600mila persone in
Tripolitania e di 200mila in Cirenaica che poterono mettere in campo solo alcune
migliaia di uomini, seppur aiutati da (scarse) truppe turche e dai rifornimenti che
sbarcavano dai sottomarini tedeschi.
Dopo un periodo di stasi, sotto la guida di Ahmed esc-Sherif i libici insorsero
compatti sorprendendo gli italiani che reagirono in modo confuso e contraddittorio
ma con grandi violenze, per tacere di quelle degli ascari che infierivano sulla
popolazione civile gettando così altra benzina sul fuoco: ancora una volta gli italiani
furono comunque costretti a ritirarsi sulla costa effettuando una serie di rientri dalle
posizioni più avanzate che erano riusciti a raggiungere, raramente condotti
tempestivamente e con successo.
Ancora una volta stupisce la sproporzione fra il numero schiacciante delle truppe
italiane ed ascare (e i loro mezzi) e le poche migliaia di partigiani arabi che sapevano
però muoversi da padroni nel deserto e nei vasti spazi africani (che conoscevano a
menadito) e che riuscirono spesso a rifornirsi del materiale e dei viveri abbandonati
dagli italiani in fuga.
Il disastro italiano in Tripolitania superò quello di Adua (spina sempre presente nel
cuore dei colonialisti) e, mentre le accuse reciproche si mescolavano ai rimpalli di
responsabilità, nessuno poteva proclamarsi innocente e/o immune da errori,
tergiversazioni, calcoli sbagliati e sottovalutazione del problema.
Come se tutto ciò non bastasse, gli italiani si incattivirono sui civili ancora sotto il
loro controllo in un crescendo di odiosità e di brutalità tanto allucinanti quanto
controproducenti: rare furono le voci autocritiche e inesistenti le punizioni per i
crimini di guerra che pure qualcuno si ostinava a denunciare e che il generale Pàntano
riassunse lucidamente affermando che ‘non potendo vendicarci sopra i nemici che
ottennero, con sì scarsi mezzi, risultati tanto vistosi, sfoghiamo l’umiliazione sui
deboli, sugli inermi’.
29
Carestie, fame e malattie fecero da sfondo al martirio delle disgraziate popolazioni
tripolitane che però non cessavano la lotta, incuranti delle numerose perdite e dei
terribili sacrifici che questa imponeva.
In Cirenaica per gli italiani le cose andarono un po’ meglio perché, invece di
approfittare del ritiro degli italiani sulla costa da tutte le posizioni avanzate
dell’interno, Ahmed esc-Sherif accettò di collaborare con le sue forze al piano di
Enver bey - divenuto pascià, ministro della Guerra turco e assistito dai tedeschi - di
occupare il canale di Suez attaccando l’Inghilterra in Egitto da est (Siria), da sud
(Sudan) e da ovest (appunto dalla Cirenaica): lanciata l’offensiva nel settembre 1915,
in dicembre essa però era già fallita per l’arrivo di truppe sudafricane e la Senussia
dovette scendere a patti.
Ahmed esc-Sherif cedette il comando a Mohammed Idris (nipote del fondatore della
confraternita dei Senussi) che non potè che aprire i negoziati di pace sia con
l’Inghilterra che con l’Italia mentre il suo popolo moriva letteralmente di fame: i
turchi così lo abbandonarono al suo destino e si trasferirono in Tripolitania per
continuarvi la loro guerra ad oltranza e senza quartiere.
Le trattative fra Italia e Mohammed Idris furono però lunghe e complicate finchè il
17 aprile 1916 si conclusero con la stipula del patto di Acroma: nessuna delle due
parti rinunciava alla pretesa della sovranità sull’intera Cirenaica, ma per il momento
si stabilì che di fatto agli italiani rimaneva la fascia costiera e a Mohammed Idris
l’altopiano e l’interno, mentre comunque le ostilità erano cessate con immenso
sollievo della stremata popolazione.
VII
Mentre in Tripolitania la guerra continuava e in Cirenaica era invece sospesa, l’Italia
uscì vincitrice dal conflitto mondiale e la Turchia e la Germania, pesantemente
sconfitte, dovettero – fra l’altro – evacuare la Libia così che gli arabi rimasero
nuovamente soli nella loro disperata ed eroica resistenza: l’Italia tuttavia si rese conto
che doveva cambiare atteggiamento e politica nei loro confronti e inaugurare un’era
di collaborazione e di rispetto allo scopo di conseguire finalmente la comune
prosperità e il progresso condiviso tanto auspicati.
Era questa una pretesa davvero insostenibile perché in realtà quello che gli italiani
chiedevano ai libici era di accettare di sottomettersi a un Paese che - senza che
questi gli avessero mai fatto niente - era sbarcato sulle loro coste e nell’intento di
conquistarli e di occuparli aveva inferto loro sofferenze indicibili: come se anni e
anni di orrori non ci fossero mai stati, come se gli italiani avessero (chissà
perché) il diritto di dominare in casa altrui, come se i libici non avessero invece
quello di vivere liberi sulla loro terra, adesso in Italia si decideva
unilateralmente che essi dovevano non solo rassegnarsi al fatto compiuto ma
anzi collaborare e gioire per il nuovo corso coloniale!
Naturalmente il gioco fu presto scoperto: visto che questa nuova versione
dell’imperialismo italiano aveva bisogno della pace e che per raggiungere la sospirata
pace bisognava vincere la guerra, sia dall’Italia che dall’Eritrea vennero allora inviati
30
in Tripolitania
nuovi mezzi e nuove truppe, soldati spesso volontari e
particolarmente aggressivi, che raggiunsero le 80mila unità.
Contemporaneamente si ripresero però anche le trattative che – di fronte alla
rinnovata minaccia - il 16 aprile 1919 si conclusero con un accordo concretizzato il 1
giugno in uno Statuto in base al quale ai tripolitani veniva concessa una cittadinanza
italiana (non valida in Italia), veniva abolita la leva obbligatoria, istituito un
Parlamento e altri organi elettivi locali (naturalmente sotto il controllo delle autorità
italiane), parificata la lingua araba a quella italiana e garantita la libertà di stampa,
mentre gli arabi accettavano di cessare la guerra, di consegnare le armi e di
permettere una qualche penetrazione italiana nell’interno.
Lo Statuto della Tripolitania ricordava da vicino l’accordo con la Cirenaica di tre anni
prima e inizialmente sembrò che un equilibrio fosse finalmente stato raggiunto, tanto
che in pochi mesi il corpo di occupazione italiano si ridusse fino a 25mila uomini, ma
fu tutto fumo negli occhi: in realtà infatti le indecisioni, i contrattempi, i dissidi
interni fra i capi locali arabi e berberi (fomentati dagli italiani) e fra gli stessi organi
di governo italiani, la sfiducia, la slealtà, il sabotaggio e ogni altro impedimento da
parte italiana furono tali che lo Statuto rimase sempre un inattuato pezzo di carta.
Mentre si moltiplicavano oscillazioni e sbandamenti, incertezze ed instabilità,
nell’estate 1921 giunse a Tripoli il vicerè Gioacchino Volpi e la situazione non potè
che degenerare: le truppe italiane ed eritree aumentarono nuovamente di numero e gli
scontri armati ripresero con crescente frequenza né a qualcosa servì la nomina di
Giovanni Amendola a ministro per le Colonie nel febbraio 1922, visto che mentre
egli continuava a insistere sulla possibilità di un accordo – cioè di un patto leonino cogli indigeni, la ripresa della guerra in Tripolitania era ormai una realtà.
In Cirenaica la situazione era sembrata ancora una volta migliore perché il 25 ottobre
1920 a er-Règima era stato firmato un nuovo accordo con Mohammed Idris in base al
quale la sovranità italiana veniva estesa anche all’altopiano e l’anno seguente era
stato addirittura eletto un Parlamento, ma nel dicembre i combattenti tripolini
offrirono a Mohamed Idris di divenire emiro della Tripolitania e della Cirenaica e di
unificare così per la prima volta l’intero Paese (e la lotta anticoloniale).
Mentre in Tripolitania la guerra divampava più accesa che mai, il 2 novembre 1922 –
dopo un lungo imbarazzo - Mohammed Idris accettò l’offerta: era la rottura definitiva
con l’Italia (pochissimi giorni dopo la marcia su Roma) e la guerra in tutto il Paese.
Così si concluse il periodo coloniale dei governi liberali: guerre e guerriglie
sanguinose, distruzioni e devastazioni, spese enormi e del tutto improduttive, mentre
nella inconsultamente celebrata ‘terra promessa’ libica poterono trasferirsi solo poche
decine di agricoltori italiani e solo poche migliaia di ettari finirono in mano ad
aziende italiane (che oltretutto si servivano spesso della manodopera locale meno
costosa).
Eppure la guerra di Libia cambiò l’assetto del Mediterraneo e suscitò un grande
consenso in Italia – e questa è una realtà tanto vergognosa quanto semplicemente
incomprensibile.
31
VIII
Il fascismo fece propria e adottò tutta la politica espansionistica e colonialistica dei
nazionalisti e la fuse con tutta la sua retorica della ripresa della ‘missione di Roma’: i
temi classici del colonialismo liberale - la soluzione del problema dell’emigrazione
attraverso il popolamento dell’Africa italiana (‘espansione o esplosione’), il prestigio
e la necessità strategica di occupare territori in Africa e la volontà di rimediare alla
cronica mancanza di materie prime in Italia - si fusero così con quelli del nuovo
regime (favorire il ritorno degli emigrati nelle Americhe e una spiccata politica volta
all’aumento demografico, essenziale se si voleva avere quel surplus di italiani da
destinare alle colonie).
La violenza venne apertamente esaltata e il razzismo – già presente e comunque
presupposto del colonialismo stesso – venne affermato a gran voce insieme al
sentimento di superiorità degli italiani.
Ovviamente colla soppressione di ogni opposizione in Italia anche la voce degli
anticolonialisti (pochi in verità) venne annullata: la martellante propaganda e
l’ideologia del regime non poteva essere contraddetta mentre la Chiesa procedeva
nella sua opera missionaria collaborando attivamente (come d’altronde aveva sempre
fatto) col colonialismo ormai imperante.
Mentre lo statuto del 1919 venne abolito così come la cittadinanza libica e i diritti
politici dei libici, il primo passo del fascismo sulla strada del rinnovato imperialismo
fu la ripresa con ben maggior decisione della guerra per la conquista della Libia, fino
a quel momento ancora larghissimamente autonoma e di fatto in gran parte
indipendente dall’Italia.
A fare materialmente la guerra non furono però soldati italiani perché, come segnala
Angelo Del Boca, ‘Quanto alle truppe impiegate, esse saranno pressochè interamente
mercenarie (eritree, etiopiche, sudanesi e libiche), al punto che in Italia quasi non si
avvertirà il peso della guerra, anche se destinata a durare dieci anni’: il lavoro sporco
fu compiuto quindi da africani per tutta una serie di motivi economici, politici e
anche perché per far la guerra nei deserti africani ci volevano soldati africani.
Questi soldati coloniali al comando del generale Graziani furono relativamente poco
numerosi (30mila) ma molto aggressivi e ben armati ed equipaggiati: tuttavia si fece
ampio ricorso anche ad accordi coi capi locali sfruttando (come sempre) le loro
reciproche rivalità.
IX
Il primo passo della nuova spinta espansionistica in Libia (che al censimento del 1
dicembre 1921 aveva registrato la presenza di 27.495 italiani) fu l’accordo sulle
frontiere libiche con l’Egitto – divenuto (almeno formalmente) indipendente nel 1922
– che portò all’occupazione dell’oasi di Giarabub (nella Cirenaica orientale).
Intanto si sviluppava l’offensiva militare dell’inverno 1922-23 volta a conquistare
tutta la Tripolitania ‘utile’ ed a ‘pacificarla’ negli anni immediatamente seguenti, il
cui culmine fu l’atto di sottomissione che molti capi tripolitani nel corso del 1925
32
dovettero compiere: la guerra fu condotta con metodi spietati anche sulla popolazione
civile nei cui confronti si procedette con brutali rappresaglie nel tentativo di isolare le
mobilissime formazioni partigiane che più venivano date per spacciate più
ritornavano decise e determinate (‘il loro calvario, da un deserto all’altro, costituisce
una vicenda epica, che ancora attende uno storico di talento’ commenta Angelo del
Boca), tanto che fu necessario far giungere nuove truppe dall’Italia (seppur senza che
la stampa potesse darne notizia).
La popolazione era ridotta in condizioni miserabili mentre le varie tribù tripolitane
spesso erano in disaccordo fra loro.
Nelle zone via via ‘liberate’ si dette comunque subito inizio a numerose opere
pubbliche (strade, ponti, porti, acquedotti, reti telefoniche e telegrafiche, macelli,
ambulatori, ecc.), naturalmente grazie al lavoro spesso coatto dei tripolitani secondo i
canoni classici del colonialismo che per l’Italia erano poi ancor più urgenti e sentiti
data la volontà di popolare quei territori con propri emigranti: oltre a ciò, si espropriò
la terra ai ‘ribelli’ o la si acquisì al costo di rari e miseri indennizzi, ma la si concesse
a chi aveva i mezzi per poterla gestire e dunque raramente ai contadini nullatenenti,
quanto piuttosto alle grandi corporazioni e agli speculatori.
Come si è già detto, in genere questi ultimi si servivano della manodopera locale
meno costosa e a questo proposito fu estremamente rivelatore ciò che il
sottosegretario alle Colonie Cantalupo sostenne apertamente (ma era un segreto di
Pulcinella): ‘Di tanto in tanto … si ode qualcuno dire che ‘bisogna eliminare
interamente gli arabi’. Più grossa eresia non è possibile dire in materia coloniale. La
ricchezza dei territori coloniali africani consiste, almeno per metà, nelle
popolazioni. Le colonie prive di manodopera indigena rappresentano il più
grave problema dell’Africa moderna’.
L’affermazione di Cantalupo ha almeno il pregio della sincerità: ai colonialisti non
bastava portar via tutto agli indigeni perché senza il loro lavoro il furto subito non
sarebbe stato produttivo e questo brutale ma franco riconoscimento aveva almeno il
pregio di mettere fine una volta per tutte alla costante retorica della Libia (e non
solo) come terra per gli emigranti italiani senza terra perché la terra andò invece alle
grandi società e agli speculatori che facevano lavorare i libici da servi là dove fino a
un momento prima erano stati padroni.
Sistemata la Tripolitania, fu poi la volta del Fezzan e della Cirenaica.
La spinta verso sud proseguì infatti con l’occupazione delle oasi del Fezzan
(l’immensa distesa a sud della Tripolitania) e di Ghat (al confine del Fezzan
meridionale con l’Algeria), concluse nel 1929-30 e che avrebbero dovuto riaprire la
via dei traffici dall’Africa subsahariana verso il Mediterraneo.
Nel 1929-30 nel Fezzan (il solito) Graziani portò avanti con spietatezza l’opera di
repressione contro le intrepide popolazioni nomadi, circondate, cacciate, inseguite
senza pietà dalle sue colonne mobili e dall’aviazione nelle loro migrazioni con donne,
vecchi, bambini e bestiame: nonostante tutto il loro valore alla fine i fezzanesi non
poterono che essere sconfitti e assoggettati senza che nulla fosse stato risparmiato al
loro martirio.
33
X
Venne infine l’ora della ben più ostica Cirenaica da cui Mohammed Idris era
emigrato in Egitto nel gennaio 1923 ma dove la resistenza fu animata dall’eroico,
imprendibile, abilissimo vecchio Omar al-Mukhtar, vero genio della guerriglia e sua
indiscussa guida.
Le operazioni ebbero inizio fin dal 1 gennaio 1928 ma la (solita) sproporzione delle
forze in campo, gli aerei, le violenze senza fine, tutti i ritrovati bellici moderni, i
rastrellamenti, le requisizioni, la distruzione dei raccolti, i bombardamenti aerei anche
col gas (il fosgene fu così impiegato per la prima volta in Africa), il terrore, le ingenti
perdite umane inflitte al nemico, non bastarono ad aver finalmente ragione del grande
combattente che pure disponeva solo di pochissime migliaia di guerriglieri: in un
decennio i 53 combattimenti e i 210 scontri non piegarono infatti i cirenaici perchè
Omar el-Mukhtar riuscì sempre a eludere le manovre dell’avversario - il solito
Graziani sempre più esasperato in mezzo a una popolazione ostile e sfuggente - ed a
contrattaccare.
La vittoria degli italiani non arrivava e mentre ogni territorio dato per conquistato
veniva subito perso, per gli italiani la situazione divenne così grave e imbarazzante
che per venirne a capo dovettero ricorrere a misure ancor più drastiche e radicali si
quelle finora adottate (!).
Fra il maggio e l’agosto 1930 l’intera popolazione (100mila persone) del vasto e
fertile altopiano del Gebel Achdar (alle spalle della fascia costiera) venne
deportata in appositi (e pessimi) campi di concentramento: Badoglio, nuovo
governatore della Libia, stabilì che ‘nessun indigeno dovrà più trovarsi
sull’altipiano, e chiunque sarà incontrato sarà passato per le armi’.
Il trasferimento a marce forzate dell’intera popolazione e del bestiame fu durissimo e
la scarna relazione che lo descrisse è inequivocabile: ‘Non furono ammessi ritardi
durante le tappe. Chi indugiava veniva immediatamente passato per le armi’ e il
disprezzo per questa gente tanto eroica quanto sfortunata arrivò al punto che non si
tennero nemmeno registri né furono fatti conteggi di questa vera e propria marcia
della morte.
Per isolare finalmente i guerriglieri l’immensa regione venne interamente spopolata e
la terra espropriata.
Inascoltate furono le proteste di chi si opponeva alla fucilazione anche di donne e di
bambini mentre a causa delle pessime condizioni dei campi di concentramento i
decessi vi continuarono in quantità inaudita: al censimento del 21 aprile 1931 furono
contati 142mila cirenaici dai 200mila che erano stati e, tenuto conto dei circa 20mila
scampati in Egitto, si può dunque calcolare che i morti per la guerra e per le
deportazioni ammontarono al 20% della popolazione - e queste sono cifre da
genocidio.
Il bestiame poi, la principale risorsa dei nativi insieme all’orzo (che naturalmente non
potè essere coltivato), subì un calo del 90-95% e dell’80%.
Massima ironia e ulteriore violenza, fu dai campi di concentramento che si
arruolarono gli ascari, i nuovi combattenti libici da porre al servizio dell’Italia.
34
Per quanto estrema, nemmeno questa infame misura riuscì però a piegare
l’indomabile Omar el-Mukhtar e i suoi guerriglieri che ricevevano aiuti e rifornimenti
dall’Egitto (dove numerosi libici avevano trovato rifugio) e per impedire l’arrivo di
queste carovane fu così necessario costruire sul confine un reticolato lungo 270 km.
vigilato da fortini, aerei e pattuglie (!).
Solo con queste misure gli italiani riuscirono ad avere ragione del vecchio (73 anni) e
zoppicante (per la gotta) indomito ed eccezionale comandante Omar el-Mukhtar, che
su delazione di informatori traditori finalmente l’11 settembre 1931 fu catturato,
processato (?) e giustiziato.
Ormai anche gli ultimi focolai di resistenza vennero infine spenti e per la Cirenaica
distrutta, e quindi anche per la Libia tutta, la guerra era finita: nel 1932-33 i deportati
cirenaici cominciarono così a poter tornare sulle loro terre o, meglio, su quelle
peggiori che gli italiani lasciarono loro.
Dopo che già nel 1929 Tripolitania e Cirenaica erano state dichiarate unite, nel
dicembre 1934 un Regio Decreto proclamò ufficialmente la colonia di Libia: la
colonia contava allora 700mila abitanti, il 13% in meno di quando gli italiani erano
sbarcati per la prima volta sulle sue coste, una generazione prima.
XI
Man mano che il territorio veniva conquistato le terre coltivabili venivano strappate
ai libici e indemaniate a favore degli italiani: i concessionari e gli speculatori che in
un primo momento se le erano accaparrate le avevano presto abbandonate o lasciate
deperire così nei secondi anni Venti il dirigenti fascisti decisero di continuare sì ad
affidarle ai concessionari, a patto però che questi ci facessero lavorare famiglie di
contadini italiani.
Fu così che nel 1929 arrivarono in Libia 455 famiglie rurali (1.778 persone) e che nel
1933 le famiglie divennero1.500 (7.000 persone), ma di fatto era lo stato che
sosteneva alte spese per ottenere risultati davvero modesti, soprattutto se confrontati
con le fantasiose previsioni e nonostante intanto fossero state scoperte nuove falde
acquifere.
Oltre che con le concessioni, si volle poi favorire l’insediamento permanente dei
coloni con l’assegnazione diretta di poderi per novant’anni: data la scarsa esperienza
dei contadini italiani sulle terre africane, si cercò di reclutare quelli più esperti che
risiedevano in Tunisia e i 3.619 ettari assegnati nel 1922 già nel 1928 erano diventati
90mila.
Anche in questo caso era naturalmente lo stato a fornire capitali, mezzi, premi e
assistenza, mentre parallelamente molto deciso era lo sforzo (al solito) nel campo dei
lavori pubblici (398 km. di ferrovie, strade, aeroporti, ecc.).
Nel 1929-33, mentre la guerra infuriava ancora nel Fezzan e in Cirenaica, in
Tripolitania vennero colonizzati 50mila ettari e nel 1932 venne varato il piano per la
colonizzazione della Cirenaica stessa che prevedeva la valorizzazione e il
popolamento addirittura di 1 milione di ettari, ma si erano fatti i conti senza l’oste.
35
La distanza, il clima inclemente, la terra poco fertile e il disinteresse dei contadini
italiani per uno sforzo così notevole in luoghi così inospitali si accompagnarono alla
rabbia degli autoctoni che reagirono con l’insubordinazione ed anche con la
guerriglia: il risultato fu che nel 1934 gli italiani in Libia erano meno di 70mila
mentre l’interscambio commerciale era addirittura diminuito.
Di fronte alle numerose ed evidenti difficoltà il regime fascista però non demordeva.
XII
Conclusa vittoriosamente e definitivamente la guerra, per il regime fascista sorse ora
la necessità di riorganizzazione ed organizzare in tempo di ‘pace’ la Libia ormai
saldamente italiana e a questo scopo il 1 gennaio 1934 fu nominato vicerè Italo Balbo
che effettivamente si dedicò all’opera con grande energia e determinazione.
Innanzitutto egli volle conquistare i cuori e le menti dei libici, così chiuse gli ultimi
campi di concentramento, liberò molti prigionieri politici, alzò sensibilmente il livello
educativo dei bambini e dei giovani, creò addirittura delle avanguardie fasciste
libiche (GAL, Gioventù Araba del Littorio, i nuovi ascari che sarebbero stati spediti
da lì a qualche anno a combattere in Etiopia), operò un gran numero di riforme in tutti
i settori (non ultimo quello della ricerca scientifica) e diede il via a tutta una serie di
imponenti lavori pubblici secondo lo schema classico del colonialismo - che nel caso
italiano era ancora più sentito perché più forte era la volontà fascista di impadronirsi
e di popolare la nuova terra conquistata.
In sintesi si può affermare che Balbo concepì il colonialismo nel modo più aperto e
avanzato possibile, ma sempre di colonialismo si trattava: la distanza fra le due razze
rimaneva incolmabile anche se Balbo tentò (e con un certo successo) di convincere i
libici della bontà della loro nuova condizione di subordinati offrendo loro
concessioni, mettendo in campo tutte le misure possibili per integrarli nella loro
nuova (e immodificabile) condizione (di soggiogati) e facendo loro intravedere i
vantaggi per tutti che lo sviluppo portato dagli italiani stava oggettivamente offrendo
al Paese.
Soprattutto però Balbo credette nel popolamento italiano della Libia e ne riprese in
pieno il progetto: trasformato l’ECC (Ente per la Colonizzazione della Cirenaica)
nell’ECL (Ente per la Colonizzazione della Libia), il 17 maggio 1938 a Roma venne
adottato il suo piano ‘grandioso ed organico’ di colonizzazione basato su fortissimi
incentivi statali per far giungere in Libia 20mila coloni all’anno per cinque anni.
I risultati questa volta cominciarono a vedersi.
Angelo Del Boca scrive che ‘L’illusoria prospettiva del facile benessere, abilmente
propagandata dall’apparato comunicativo del regime attraverso un linguaggio
trionfalista e spettacolare, capace di unire le immagini patinate delle bellezze al
bagno sulle spiagge libiche a quelle del mastodontico piano di popolamento rurale
intrapreso da Italo Balbo, carismatico governatore della Libia, abbaglia soprattutto gli
italiani del sud, i contadini e i braccianti delle zone depresse della pianura padana
che, pur di sfuggire alla fame e alla miseria, inseparabili compagne di vita quotidiana,
36
decidono di intraprendere l’affascinante avventura in questa terra che, incontaminata
e fertile, attende soltanto braccia in grado di farla fruttare.’
Mentre nel 1937 la popolazione agricola italiana della Libia era comunque composta
da 2.711 famiglie (12.488 persone), nel 1938 il numero previsto di contadini
(attentamente selezionati) sbarcò effettivamente sulle coste africane con partenze e
arrivi di massa, spettacolari e celebrati con grande pompa, ma l’anno seguente,
mentre in Europa era intanto scoppiata la guerra, gli arrivi già si dimezzarono e nel
1940, con l’ingresso dell’Italia in guerra, si fermarono del tutto.
Alla vigilia della guerra erano così presenti 3.960 famiglie coloniche (23.919
persone) in Tripolitania e 2.206 (15.014 persone) in Cirenaica per un totale di 6.166
famiglie (38.933 persone), molto prolifiche e considerate non solo per il loro lavoro
ma anche per la loro funzione di veri e propri agenti e avanguardie dell’imperialismo
italiano: grazie a questi italiani lo sviluppo dell’agricoltura in Libia fu indubbiamente
notevole e, anche se ottenuto a costi altissimi e con la spoliazione dei libici, Miège
conclude che “ ‘La quarta sponda dell’Italia’ sta proprio per diventare un
prolungamento umano della penisola”.
L’incomprensibile e dissennata partecipazione dell’Italia alla seconda guerra
mondiale travolse tutte queste possibilità distruggendo anni di sforzi e di spese, di
sogni e di speranze.
XIII
In questa sede le (poche) nozioni utili sugli eventi bellici in Nordafrica sono già state
date nel capitolo sulla Tunisia e qui basterà solo ricordare che il 28 giugno 1940
l’aereo di Balbo venne abbattuto per errore dalla contraerea italiana e che al suo posto
venne nominato Graziani: la scarsità dei mezzi dell’Italia, entrata follemente in un
gioco tanto più grande di lei, è cosa nota e risaputa, ma in Libia essa comportò
oltretutto la necessità per Graziani di utilizzare tutto il materiale possibile e
immaginabile ai fini bellici e spesso di smontarlo e di trasportarlo al fronte.
Tante fatiche, tante costruzioni, tante realizzazioni e tanti investimenti vennero
vanificati in un attimo e quando nel dicembre 1940 gli inglesi, dopo essere stati
attaccati in Egitto, contrattaccarono spazzando via intere divisioni italiane e libiche,
occupando la Cirenaica e minacciando la Tripolitania (Graziani venne sollevato
dall’incarico), fornirono anche l’occasione tanto attesa per lunghi anni da Idris e dai
fuorusciti libici.
D’accordò con gli inglesi, Idris organizzò con fuorusciti e prigionieri di guerra libici
la Lybian Arab Force, in Tunisia venne allestito un analogo piccolo esercito libico
alleato (dei francesi), ma in Tripolitania furono gli italiani a costituire truppe di libici.
Le continue avanzate e ritirate degli eserciti che si susseguirono nei tre anni di guerra
causarono comunque enormi danni, distruzioni e sofferenze alle popolazioni libiche e
italiane, il cui grande lavoro andò largamente devastato e perso.
In Cirenaica sulla scia degli eserciti alleati gli arabi tornarono con le loro mandrie
sui terreni che erano stati strappati loro dagli italiani: Idris invitò pubblicamente alla
clemenza nei confronti degli ex-padroni coloniali (!) tanto che in un primo momento
37
furono proprio gli arabi che protessero gli italiani (!) dalle ben più temibili violenze
delle truppe di occupazione inglesi, ma nondimeno la seconda invasione inglese
diede loro un colpo durissimo e prima della terza (alla fine del 1942) anche gli ultimi
italiani che erano restati dovettero fuggire in Tripolitania fra mille pericoli e disagi.
L’inevitabile massiccia emigrazione di militari e di civili italiani in Tripolitania
(13mila ragazzi erano stati trasferiti intanto in Italia) fu interamente affrontata e
sostenuta dalla comunità italiana che, concentrata nella capitale, riuscì a provvedere
al loro sostentamento.
La Cirenaica era comunque ormai perduta e completamente sgombra di italiani ma
anche la Tripolitania ben presto fu persa: Tripoli venne occupata dagli Alleati il 23
gennaio 1943, il 3 febbraio 1943 l’ultimo soldato dell’Asse abbandonò il suolo libico
e nel più grande marasma molti italiani non poterono che abbandonare il Paese.
La guerra uscì così dal suolo libico ma vi lasciò dai 5 ai 14 milioni di mine anti-uomo
e anti-carro, problema gravissimo e a tutt’oggi non ancora risolto.
XIV
L’art. 23 e l’appendice 11 del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 privarono l’Italia
di tutte le sue colonie e anche in Libia si pose dunque il problema del destino degli
italiani che vi risiedevano (oltre naturalmente ai soldati fatti prigionieri).
Nel 1940 erano vissuti in Libia circa 120mila italiani (Balbo aveva progettato di
raggiungere il mezzo milione negli anni Sessanta), in buona parte concentrati a
Tripoli che da sola ne contava 41.304 (il 37% della popolazione complessiva!): tutti
questi dovettero affrontare il grosso problema di un eventuale, difficile e triste ritorno
in patria.
Già prima della fine della guerra un grosso numero era comunque ritornato nella
madrepatria e alla fine del conflitto i profughi giunti in Italia dalla Libia erano
stati ben 93.721.
Fra questi, il destino più triste fu sicuramente quello dei circa 13mila bambini che,
per motivi di sicurezza, nell’imminenza del conflitto erano stati rimpatriati su navi
della marina militare e ospitati nelle colonie della GIL: per anni queste piccole
vittime innocenti vissero separate dalle proprie famiglie e ancor oggi, inascoltate, le
loro associazioni chiedono invano risarcimenti e il riconoscimento delle loro
sofferenze.
I profughi dalla Libia furono sicuramente la componente più consistente rispetto
a quelli dall’Etiopia (54.878), dall’Eritrea (45.142) e dalla Somalia (12.124).
Il governo italiano cercò di assistere come potè questa umanità dolente e sconvolta
che oltre a tanti sogni, speranze e illusioni aveva perso anche tutto quello che aveva
posseduto, ma nell’Italia provata dalla guerra, sconfitta e povera, la vita era difficile
per tutti e solo poco più della metà dei rimpatriati riuscì a provvedere a se stessa
mentre gli altri 101.236 furono ospitati nei centri di raccolta profughi in attesa del
loro lento riassorbimento nelle maglie della società italiana.
Per parte loro, gli italiani rimasti a Tripoli vennero spogliati ed emarginati ma non
subirono violenze o rappresaglie: 1.281 impiegati e funzionari pubblici rimasero
38
addirittura al loro posto di lavoro su precisa richiesta inglese e, soprattutto nel settore
agricolo, furono ancora gli italiani a compiere lo sforzo maggiore per ricostruire e
rimettere in funzione quel che era possibile, tanto che l’80% delle fattorie rimasto
nelle loro mani continuò a produrre (e anche a prosperare!).
Ma non poteva durare: le tensioni fra arabi e italiani non potevano che crescere anche
perché con la fine della guerra alcune migliaia di italiani, ed anche quei ragazzi
evacuati qualche anno prima, rientrarono in Tripolitania (ma non in Cirenaica e nel
Fezzan, abbandonati per sempre) col chiaro ed evidente intento di continuare come
prima e come se in fondo nulla fosse successo (!).
Nel 1948 gli italiani in Tripolitania erano così risaliti a 44.364 (di cui 23.894 a
Tripoli) e, dato il loro background e tagliati fuori da tutto com’erano, non poterono
che accentuare (tranne poche eccezioni) il loro nazionalismo e il loro fascismo.
XV
Nonostante le improvvisate e insensate manovre e i testardi e patetici tentativi
dell’Italia di mantenere il possesso almeno della Tripolitania, o in seguito la sua
amministrazione fiduciaria, il Trattato di Pace del 1947 non riconobbe ancora
l’indipendenza della Libia la cui amministrazione venne anzi divisa fra Inghilterra
(Tripolitania e Cirenaica) e Francia (Fezzan) nell’ambito della gestione fiduciaria
dell’ONU: solo il 24 dicembre 1951 – in base alla risoluzione 289 (21 novembre
1949) dell’ONU - venne proclamata l’indipendenza della Libia, monarchia ereditaria
e costituzionale sotto re Idris al-Senus.
Il 15 dicembre 1950 l’Assemblea Nazionale libica espropriò i beni dello stato italiano
e del partito fascista, ma lasciò agli italiani le terre date in concessione ai privati dagli
Enti allora preposti ‘a condizione che siano state legittimamente acquistate’, e ciò
avrebbe dato luogo a lunghe diatribe.
Con l’indipendenza e nell’ambito di un rinnovato spirito patriottico e autonomistico
si verificò presto un nuovo esodo degli italiani ancora presenti nel Paese.
Il 2 ottobre 1956 Italia e Libia raggiunsero finalmente un accordo che compensava la
Libia con 4.812.000.000 lire italiane per le sofferenze patite a causa del colonialismo
(seppur sotto la dicitura ‘quale contributo alla ricostruzione economica della Libia’),
lasciava agli italiani le loro proprietà ma non parlava di danni di guerra perché si
sostenne che allora la Libia faceva parte dell’Italia e che dunque nessun risarcimento
le era dovuto (!).
Gli Enti poterono ora dedicarsi con sicurezza ai loro progetti di avvaloramento,
bonifica e sviluppo, ma una legge del 24 maggio 1960 vietò l’acquisto di beni
immobiliari da parte di stranieri (pur senza aver valore retroattivo) mentre la
comunità italiana, per quanto attiva e produttrice di ricchezza, rimaneva pur sempre
una spina nel fianco di un Paese che era finalmente diventato indipendente: i coloni
italiani dovettero ora scegliere fra il mantenimento della cittadinanza italiana e
l’acquisto di quella libica e il risultato fu che l’anno seguente il 70% dei poderi già in
mano agli italiani era stato venduto agli arabi e che nel 1964 delle 2.098 famiglie
insediate da Balbo ne erano rimaste 120, tutte in villaggi ormai arabi.
39
Dopo quello in periodo bellico, fu questo l’inevitabile secondo ciclo di espulsioni,
un esodo però non troppo drammatico visto che per molti fu un affare vendere a
prezzi di mercato terre per cui non avevano dovuto pagare nulla: la comunità italiana
dalle 45mila unità dei primi anni Cinquanta scese comunque a 27mila (di cui 24mila
a Tripoli).
XVI
L’evento che avrebbe trasformato radicalmente la storia della Libia fu la scoperta del
petrolio: il 10 giugno 1959 da un pozzo della Esso uscì il primo getto e da allora le
perforazioni furono continue e sempre più fortunate generando un imponente ed
improvviso boom economico che trasformò per sempre la Libia arricchendola in
misura assolutamente imprevedibile.
In questa nuova Libia il 1 settembre 1969 re Idris viene deposto da un gruppo di
ufficiali nasseriani guidati dal colonnello Mu’ammar Gheddafi (operazione
‘Gerusalemme’) che subito lanciò un programma di nazionalizzazione delle imprese
e dei possedimenti italiani (e chiuse inoltre le basi militari statunitensi e britanniche
ancora presenti sul territorio libico): nei quattro mesi successivi almeno 830 italiani
partirono in tutta fretta, alcuni senza nemmeno il visto e in modo anche rischioso,
mentre nel primo semestre del 1970 se ne andarono altri 3mila.
Il 21 luglio 1970 tre leggi stabilirono la confisca di tutti i beni degli italiani e degli
ebrei e che essi dovevano lasciare il Paese entro il 15 ottobre 1970: gli ultimi 20mila
italiani ancora rimasti dovettero così partire abbandonando per sempre tutte le loro
proprietà e potendo portare con sé solo 25 sterline e le valigie.
Fu questo il terzo ed ultimo ciclo di espulsioni degli italiani di Libia che dovettero
affrontare lo stesso duro destino dei tanti che li avevano preceduti.
Due anni dopo fu smantellato anche il sacrario militare di Tripoli e l’Italia dovette
traslare le spoglie dei suoi 20.492 caduti colà sepolti.
XVII
Appena salito al potere Gheddafi si riprese quel che riteneva fosse stato rubato al suo
popolo con la confisca di 40mila ettari di terra, di oltre 1.700 case e di oltre 500
attività commerciali per un valore totale di 200 miliardi di lire di allora (senza tener
poi conto dell’ammodernamento e dello sviluppo tecnologico portati dagli italiani in
Libia): espropri e nazionalizzazioni si accompagnarono poi ad una politica volta alla
riappropriazione anche della propria identità, così ad esempio le chiese vennero
mutate in moschee, molti monumenti ridotti in polvere, i cimiteri degli italiani
profanati e distrutti.
Insomma: con rabbiosa convinzione il nuovo regime rivoluzionario volle cancellare
l’umiliante e doloroso passato coloniale.
Finchè visse Gheddafi rinfacciò sempre agli italiani il loro colonialismo e, nonostante
i numerosi, ottimi e lucrosi affari conclusi con l’Italia, le chiese sempre il
risarcimento per i danni di guerra mettendola spesso in difficoltà: egli fu l’unico capo
40
di stato a ricordare alla ex-potenza coloniale tutto il male che aveva fatto e a porla
periodicamente di fronte alle sue passate responsabilità: aveva ragione?
La risposta è difficile perché da una parte tutto ciò che Gheddafi rinfacciava e
rivendicava era sicuramente vero, ma dall’altra è altrettanto vero che il passato è
passato e che non si può continuare a rivangarlo all’infinito: a un certo punto bisogna
saper chiudere, andare avanti e lasciare il campo agli storici.
Ma non basta ancora perché oggi le nazioni europee pretendono di dimenticare quel
che hanno fatto finchè hanno potuto ai Paesi e ai popoli extraeuropei o addirittura
elencano anche i benefici che questi ultimi avrebbero comunque ricevuto grazie
all’ammodernamento di tutte le loro strutture e al progresso portato loro proprio dal
colonialismo e dunque non è affatto inopportuno che ogni tanto qualcuno faccia loro
ripassare un po’ di storia.
Non basta ancora anche perché oggi le nazioni europee si ergono a difenditrici della
democrazia e dei diritti civili e li raccomandano magari proprio a coloro su cui
infierirono senza pietà finchè poterono e certe troppo facili e troppo convenienti
amnesie, come certe rinnovate pretese di essere (ancora!) di esempio e modello da
seguire e cui ispirarsi, non sono francamente accettabili ed anzi suonano decisamente
offensive.
Gheddafi diceva insomma una scomoda verità e la verità non è mai, né può mai
essere, superata e rimossa anche se non deve essere di ostacolo al miglioramento dei
rapporti – e infatti i rapporti di Gheddafi con l’Italia furono buoni anzi ottimi per più
di un decennio, prima che altre complicazioni li guastassero (mai comunque troppo).
XVIII
In ogni caso in Libia il conto lo pagarono comunque gli italiani che vi si erano
stabiliti e che persero tutto: fu giusto?
La risposta non può che essere affermativa: furono infatti loro che, in seguito a una
guerra di aggressione condotta per vent’anni con assoluta violenza, occuparono
materialmente terre e sfruttarono risorse che non gli appartenevano; furono
materialmente loro che sottomisero, che fecero lavorare forzatamente, che privarono
dei loro diritti, che disprezzarono, che giudicarono irrimediabilmente inferiori
persone che non avevano chiesto, e non chiedevano, altro che vivere libere e in pace
nel loro Paese natale nè si erano mai nemmeno sognate di far del male a chi le
opprimeva tanto.
Certamente molti (non tutti!) italiani che si trasferirono in Libia spesso lo fecero
perché invitati e sollecitati dal loro stesso governo; certamente la mentalità del
tempo era allora diversa rispetto a quella di oggi (ma essa non è cambiata
spontaneamente e per un ripensamento autonomo, ma per una sconfitta subita!);
lo si ammetta pure, si concedano pure attenuanti, ma sia ben chiaro che le attenuanti
si riconoscono ai colpevoli, non agli innocenti.
41
Etiopia colonia effimera (del vacuo Impero)
Più o meno al tempo della penetrazione in Eritrea l’Italia aveva cominciato anche
quella in Etiopia e ben presto aveva cercato di imporle il suo protettorato: la
situazione si era complicata e una prima guerra italo-abissina si era conclusa col
disastro di Adua (1 marzo 1896) che aveva bloccato ogni aspirazione italiana sul
Paese.
Gli italiani avevano però continuato a rimanere in qualche modo presenti sul
territorio, in competizione ed in un gioco triangolare con Francia e Inghilterra (che
voleva controllare le acque del lago Tana e quindi del Nilo) tanto che l’Italia per
ingraziarsi il negus aveva sostenuto l’ingresso dell’Etiopia nella Società delle Nazioni
(28 settembre 1923).
Tale politica di amicizia (e di penetrazione pacifica) procedette fra alti e bassi e con
le complicazioni delle manovre e degli interessi francesi e inglesi finchè Hailé
Selassié (il nuovo nome del ras Tafari, nuovo negus dal 2 novembre 1930) cominciò
ad escludere sistematicamente gli italiani dall’opera di modernizzazione del Paese
(per evitare il loro troppo soffocante abbraccio) e a rivolgersi ad altri Paesi.
Tuttavia l’ascesa al potere di Hitler (31 gennaio 1933) alterò profondamente
l’equilibrio politico europeo e Mussolini seppe approfittarne così da ottenere
finalmente da parte di Francia e Inghilterra mano libera in Etiopia: ancora una volta
le sorti dell’Africa erano state decise dall’altra parte del Mediterraneo (anche se
riguardavano un membro della Società delle Nazioni!) e comunque l’Italia aveva
optato per la guerra d’Etiopia fin dal 1932 (cioè fin dalla conclusione di quella in
Libia) e attendeva solo l’occasione e il momento opportuno per scatenarla.
Come sempre, fu semplice per l’Italia moltiplicare gli incidenti di frontiera (somala
ed eritrea) e quello di Ual Ual (5 dicembre 1934) fu agitato come scusa per
l’invasione (come se qualcuno potesse mai credere a queste manovre): propaganda e
stampa suscitarono in Italia un sincero e diffusissimo entusiasmo per la guerra, sentita
anche come una riscossa per Adua e per le supposte umiliazioni subite (?!), in un
clima di esaltazione, di orgoglio nazionale fondati sulla pretesa che l’Italia avesse
diritto (?!) a colonie meno limitate e marginali di Eritrea, Somalia e Libia.
Del tutto inutili le (solite) frenetiche trattative dell’ultimo momento: i preparativi di
guerra furono imponenti, i rapporti con Francia e Inghilterra si guastarono, il 28
settembre 1935 l’Italia abbandonò la Società delle Nazioni (che comunque non aveva
risposto all’appello di Hailé Selassié), il 2 ottobre Mussolini annunciò l’inizio
dell’invasione dell’Etiopia dall’Eritrea e già l’11 l’attacco partì anche dalla Somalia.
I
Quando l’esercito italiano (che sarebbe arrivato a contare quasi mezzo milione di
uomini e 82mila quadrupedi!) attraversò il Mareb (il confine con l’Eritrea) aveva
dietro di sé la nazione compatta e solidale col suo Duce mentre la reazione
internazionale mostrò tutta la sua impotenza, la sua indecisione, la sua debolezza (in
42
Europa nessuno aveva seriamente l’intenzione di scomporsi più di tanto per i destini
di una nazione africana e del suo sfortunato popolo) ma anche la sua malafede perché
decretò l’embargo dei rifornimenti bellici ad ambedue i belligeranti, di fatto colpendo
così solo l’Etiopia: il blocco commerciale (le famose ‘inique sanzioni’) imposto poi il
10 ottobre dalla Società delle Nazioni all’Italia fu peggio di un colabrodo, del tutto
inefficace ma facilmente sfruttato dal regime fascista per rafforzare ancor di più la
solidarietà nazionale in favore del fascismo e della sua nuova avventura.
Fu infatti facile imputare all’egoismo delle Potenze europee i problemi e i disagi
economici dell’Italia (dovuti in realtà agli altissimi costi della guerra) e oltretutto,
mentre all’interno del Paese già era in vigore la disciplina di guerra, il regime con la
scusa del pur inefficacissimo blocco economico potè varare l’autarchia, rafforzando
così ulteriormente la sua presa sulla società.
Per parte loro, gli eventi bellici andarono come non potevano non andare: potendo
oltretutto contare sul sostegno dei Galla (musulmani e tradizionali nemici degli
etiopi), gli italiani avevano mezzi troppo superiori, non ebbero il minimo scrupolo
nell’impiegarli e gli etiopi sbagliarono tattica perché li affrontarono in campo aperto
anziché ricorrere alla guerriglia e al logoramento dell’invasore: già il 5 maggio 1936
le truppe italiane entravano in Addis Abeba e Mussolini proclamò a una folla
delirante che sui ‘colli fatali di Roma’ era rinato l’Impero (anche se 2/3 del Paese
dovevano essere ancora conquistati).
Fu questo il momento in cui il consenso popolare e nazionale al fascismo e personale
a Mussolini raggiunse il suo vertice massimo: nel bruciante delirio di massa le
febbrili celebrazioni e le lodi sperticate al Duce, fondatore dell’Impero e geniale e
coraggioso sconfiggitore di tutto e di tutti, furono spontanee e sincere.
In campo internazionale poi il 4 luglio 1936 la Società delle Nazioni a grande
maggioranza revocò le (inutili) sanzioni e respinse la richiesta di aiuto del negus
abbandonando l’Etiopia al suo destino, il 26 ottobre la Germania (alleata dell’Italia
nella guerra di Spagna) riconobbe l’Impero italiano e nel gennaio 1937 l’Inghilterra –
ritirata dal Mediterraneo la Home Fleet – firmò a Roma un ‘Gentlemen’s
Agreement’, cioè riprese le relazioni amichevoli con l’Italia.
II
La guerra tuttavia non si era ancora conclusa (Addis Abeba fu addirittura
praticamente sotto assedio per sette mesi!) ma nell’indifferenza internazionale
(soprattutto inglese) per il destino del disgraziato Paese africano l’opera di conquista
italiana riprese subito dopo la fine della stagione delle piogge.
Mussolini ordinò al vicerè Graziani di imporre in Etiopia un ‘regime di assoluto
terrore’ e le violenze sulla popolazione etiope furono spaventose, indiscriminate,
costellate di brutalità e di ferocie di ogni genere: sostenuti da eritrei, somali, da capi
locali collaborazionisti e dai mussulmani Galla (come ricorda anche Wilbur Smith in
‘Cry Wolf’), gli italiani non esitarono a compiere stragi, veri e propri bagni di sangue,
sistematiche e spietate distruzioni di villaggi e deportazioni delle popolazioni in lager
che assomigliavano sinistramente a veri e propri campi di sterminio.
43
Furono questi i ripetuti e costanti esempi della sbandierata opera di civilizzazione
italiana.
Nel febbraio 1937 infine, in seguito alla cattura ed all’esecuzione del ras Destà,
l’ultimo resistente in campo, Mussolini potè dichiarare ufficialmente che la conquista
definitiva del Paese era stata ultimata, ma i suoi costi erano stati altissimi, come
informa Matteo Dominioni (‘Lo sfascio dell’impero’): ‘Dall’ottobre 1936 al dicembre
1937, alla volta dell’Africa orientale vennero imbarcati circa 852.214 militari e
65.697 civili e inviate 193.659 tonnellate di materiale. Dall’Africa orientale
rimpatriarono, passando per Napoli, 426.774 uomini. Dalla tappa di Siracusa … si
imbarcarono 18.545 soldati di truppa e rimpatriarono in 23.058.’
L’operazione sembrò comunque aver avuto successo: dice Angelo Del Boca che
dopo la sconfitta del ras Destà, l’ultimo resistente, ‘con le operazioni di grande
polizia … che si concludono nel marzo 1937, l’occupazione dell’impero può dirsi
conclusa e integrale. In poco più di dieci mesi, quattro dei quali vanificati dalle
piogge, … La vasta operazione per la quale sono stati impegnati non meno di
200mila uomini’ sembrava aver posto termine alla lotta degli etiopi, ma in realtà non
fu affatto così perché la resistenza etiope, pur ripetutamente sconfitta, in realtà
continuò sempre e non si fermò mai.
Anche dopo la proclamazione mussoliniana della vittoria e della fine delle ostilità fu
invece necessario continuare a contrastare la diffusa guerriglia impegnando sul
terreno ‘213mila soldati, di cui 88mila nazionali e 125mila coloniali, e una flotta
aerea di 189 apparecchi, di cui soltanto 137 efficienti. Anche se più che dimezzato …
si tratta pur sempre di un notevole esercito, particolarmente oneroso per
l’erario.’(Angelo Del Boca)
Queste semplici cifre sono eloquentissime nel mostrare come – anche se nel maggio
1936 Mussolini aveva proclamato la nascita dell’Impero e l’anno dopo che la guerra
era finita – in realtà essa era ancora in pieno svolgimento, alimentata dall’inesausta
resistenza degli etiopi.
III
Avvenuto del tutto inaspettatamente, l’attentato a Graziani (che rimase solo ferito)
del 19 febbraio 1937 per tre giorni scatenò la violenza incredibile, indiscriminata e
soprattutto spontanea da parte di tutta la comunità italiana di Addis Abeba che si
dedicò con furia selvaggia ad uccidere ciecamente e senza alcuna distinzione tutti gli
etiopi che trovava o riusciva a scovare: la brutalità gratuita anche di tante persone
fino a un minuto prima ritenute tranquille, non dedite alle armi e che non avevano
partecipato alla conquista nè alla guerra, resta emblematica dimostrazione dell’odio,
della paura e del disprezzo razzista degli italiani per gli indigeni, ma la reazione
ufficiale delle autorità e delle forze armate fu ancora più grave.
L’attentato rappresentò infatti il pretesto per portare definitivamente a compimento il
progetto genocida del dominio italiano, per decapitare per sempre la società etiope
di tutta la sua classe dirigente, intellettuale e religiosa, sia che avesse fatto atto di
sottomissione oppure no, sia che si fosse dimostrata disposta a collaborare oppure no,
44
e di sottomettere e di schiavizzare il resto della popolazione, da impiegare per i propri
scopi e i propri interessi: i bersagli più fortunati della repressione, quelli cioè che
almeno scamparono alla morte, furono deportati in Italia insieme alle loro famiglie.
L’ondata di terrore che si abbattè senza distinzioni sull’Etiopia (del tutto simile a
quella che sarebbe stata ripetuta tre anni dopo dai tedeschi in Polonia) non conobbe
soste e fu del tutto indifferente ad ogni distinzione fra persone sospette, infide,
ritenute colpevoli, oppure del tutto innocenti, sottomesse e che addirittura stavano
collaborando con gli italiani, ma fu contemporaneamente tanto feroce quanto cretina.
Fu evidente infatti che se non serviva a niente arrendersi o accettare di sottomettersi tanto si veniva ammazzati lo stesso - agli etiopi non restava che combattere, ed essi
combatterono: la rivolta scoppiò così più diffusa di prima e si estese a macchia d’olio,
portata avanti non più dalle forze imperiali o da quel che ne era rimasto, ma dagli
‘arbegnuoc’ (patrioti), partigiani sostenuti dalla popolazione: la guerriglia continuò
senza sosta e con costi umani e materiali semplicemente proibitivi.
La cieca e folle repressione operata dagli italiani era a sua volta complementare e
funzionale alla decisione da parte del fascismo di adottare in Etiopia (come nel resto
dell’Impero) la politica del dominio diretto, cioè di escludere dal governo e
dall’amministrazione qualsiasi apporto e collaborazione da parte dell’elemento locale
che secondo la concezione schiettamente razzista e nettamente prevalente doveva
esercitare solo mansioni subalterne e subordinate, cioè obbedire e servire.
Il significato di questa decisione è ben messo in luce da Angelo Del Boca (prefazione
a ‘Lo sfascio dell’impero’ di Matteo Dominioni): in Etiopia ‘Mussolini … impose un
modello di dominio diretto … . Questa decisione, di una gravità incalcolabile,
metteva in evidenza che il duce e i suoi consiglieri … ignoravano totalmente la storia
millenaria dell’Etiopia, il peso e la funzione della nobiltà tradizionale, l’importanza
fondamentale della chiesa cristiano-ortodossa, la rilevanza delle consuetudini.
Un’ignoranza che era innanzitutto originata dal disprezzo per l’africano, per il
‘diverso’, per un individuo considerato inferiore, subumano. E che avrebbe
inevitabilmente creato in Etiopia il peggior regime segregazionista, più tardi preso a
modello dall’élite bianca sudafricana per costruire l’inferno dell’ apartheid.’
IV
Posto comunque di fronte al fallimento dell’opera di contrasto della rinata guerriglia
etiope, nel dicembre 1937 Mussolini impose il rimpatrio del vicerè Graziani e la
sostituzione del potente e invadente Ministro delle Colonie Lessona con Teruzzi: con
l’arrivo del nuovo vicerè, il duca Amedeo d’Aosta (che riuscì dopo qualche tempo ad
avere come vice il generale Nasi) si cominciò tuttavia a moderare (per quanto
possibile) la violenza e l’arbitrio della repressione e ad attenuare il rigore del dominio
diretto per orientarsi seppur timidamente verso quello indiretto, permettendo ad
esempio il rientro in patria di alcuni nobili internati in Italia e affidando alcune
funzioni di governo ad elementi locali (pur sotto il controllo e la vigilanza delle
autorità italiane), ma fu troppo poco e comunque era ormai troppo tardi per fermare la
resistenza.
45
Dal 1938 i partigiani etiopici iniziarono oltretutto a ricevere aiuti dalla Francia
(giustamente preoccupata per la sicurezza di Gibuti) e dalla primavera 1939 anche
dall’Inghilterra (che ormai non poteva più sperare di tenere separata l’Italia dal Terzo
Reich): ciò significò invio di armi, rifornimenti, istruttori e l’acquisizione di
informazioni preziose nell’imminenza della guerra che ormai bussava anche alle
porte dell’Africa.
V
La guerra d’Etiopia segnò comunque una forte accelerazione della politica fascista,
estera e interna: in politica estera il regime sviluppò tutte le sue pretese di grandezza
nazionale perché progettò di fare delle colonie del Corno d’Africa (unificato da
Mussolini nell’Africa Orientale Italiana, un’area di 1.701.000 kmq.) il trampolino di
lancio per una vasta e ulteriore espansione dell’Italia – non più ristretta e chiusa nel
Mediterraneo! - in Asia mentre in politica interna venne definitivamente lanciato il
progetto della rigenerazione maschia, guerresca, conquistatrice, intrepida, audace e
avventurosa della società italiana e della costruzione dell’ ‘uomo nuovo’ fascista.
Questo era – almeno sulla carta - l’Impero italiano nel 1937 (al quale tre anni dopo si
sarebbe aggiunta l’Albania).
46
Subito venne poi avviato un colossale programma per la colonizzazione dei nuovi
possedimenti: con rinnovato vigore venne ribadito che l’Impero non doveva essere
soltanto commerciale e/o di sfruttamento ma anche e soprattutto di popolamento.
Grazie a un vigoroso afflusso di masse di contadini, operai, commercianti,
imprenditori, ecc. (moltiplicati dalla martellante battaglia demografica per aumentare
le nascite), nelle nuove terre si sarebbero dovuti riprodurre tutti gli ‘aspetti
civilizzatori’ della madrepatria in modo da creare una nuova ‘Italia d’oltremare’,
premessa indispensabile per l’ulteriore e continua espansione sulle orme e
sull’esempio della celebratissima antica Roma.
In un clima di delirante nazionalismo (e razzismo) nei territori africani (come
ovviamente in Italia) si doveva formare un nuovo tipo di italiano, cosciente erede del
‘colono romano’ e ‘perfetto fascista’ che col suo alto tasso di fertilità avrebbe dovuto
via via soppiantare la decisamente inferiore popolazione indigena che, come si è
visto, venne separata, sottomessa e segregata da quella dei dominatori.
VI
Al momento della sua conquista l’Etiopia per gli italiani era ancora un Paese del tutto
sconosciuto e subito si moltiplicarono così le spedizioni esplorative e scientifiche che
dovevano fornire quella conoscenza necessaria a qualsiasi opera di penetrazione e di
colonizzazione.
Dalle poche centinaia del 1935 alla fine degli anni Trenta i coloni in Etiopia erano
saliti a 35mila (di cui 20mila ad Addis Abeba), soprattutto maschi: in tutta l’AOI gli
italiani erano 185.617 ma a questi vanno sommati gli altri 200mila che giunsero in
Africa per costruirvi le infrastrutture.
Essi costituivano solo una frazione minima della popolazione complessiva
dell’Etiopia, che nel 1940 contava oltre cinque milioni di abitanti, eppure in
pochissimi anni realizzarono grandi opere ed ottennero risultati lusinghieri.
Il fascismo volle fare infatti le cose in grande: se la popolazione contadina costituì
solo una piccola parte dell’emigrazione in Etiopia, in soli cinque anni gli italiani
seppero realizzarvi però innanzitutto una prima e seria modernizzazione delle vie di
comunicazione.
Prima dell’arrivo degli italiani in Etiopia non erano esistite strade (!), ma dove prima
c’erano state soltanto piste venne costruita una linea ferroviaria a grande traffico
Assab-Addis Abeba di circa 900 km: già nel 1938 esisteva una rete (3.284 km.) di
strade principali (‘imperiali’) larghe sette metri, massicciate e bitumate con
caratteristiche ancora inesistenti allora in Italia, più altre migliaia di km. di altre
strade secondarie e di piste camionabili, e tutto ciò nonostante i cantieri fossero
spesso attaccati dalle bande armate dell’incessante guerriglia partigiana etiope.
I costi di questa impresa faraonica (‘Mai potenza colonialista ha investito tanto
denaro in un solo progetto e ha imposto tempi così brevi alla sua realizzazione’
commenta Angelo Del Boca) sono impressionanti: tutto doveva essere importato e
trasportato dall’Italia e sul posto i prezzi erano altissimi, superiori di decine di volte
quelli in Italia, mentre i salari dei lavoratori (così come quelli dei 20mila funzionari e
47
impiegati) erano molto elevati tanto che la manodopera italiana dalle 146.161 unità
del 1936 si ridusse progressivamente alle 23.801 del 1939 (molti tonarono comunque
malati e affetti da malaria) in favore di quella indigena che era ovviamente molto
meno costosa.
Fu questo un duro colpo alle frenetiche aspettative dei 600mila italiani che subito
avevano chiesto di essere trasferiti in Etiopia ed alla politica di popolamento stessa,
ma l’assunzione di operai etiopi ebbe conseguenze anche sulla popolazione indigena
perché il loro salario era pur sempre quattro volte superiore a quanto guadagnava un
contadino e si verificò quindi una fuga dalle campagne e un non indifferente
squilibrio e mobilità nella fino allora statica società etiope.
In Etiopia gli italiani stimolarono inoltre l’economia locale e fondarono tutta una
serie di Compagnie ciascuna col suo proprio campo di studio, di ricerca e di attività
(cotone, fibre tessili vegetali, semi e frutti oleosi, latte e derivati, lavorazione delle
carni, cementifici, studi e allevamenti zootecnici, laterizi, pelli grezze, essenze
legnose, miniere, imprese elettriche, forniture e impianti telegrafonici, flora etiopica,
esplosivi, birra, vastissimi trasporti automobilistici) più, naturalmente, numerose
aziende particolari, filiali, officine e indotto vario (nel 1941 c’erano 4.007 aziende
industriali e 4.785 commerciali): i loro guadagni furono eccezionali perché alla fin
fine era lo stato che pagava e i beneficiari (come i famosi ‘padroncini’ dei camion)
godevano della mancanza di concorrenza.
Dati tuttavia i costi proibitivi della colonizzazione (tutto, anche il grano, doveva
essere importato dall’Italia e le esportazioni dell’Impero erano sempre più ridotte a
causa dell’aumento interno dei consumi) in Etiopia la parte del leone la fecero sedici
grandi compagnie, le uniche che disponevano dei grandi capitali necessari, che
organizzarono lo sfruttamento delle risorse quasi in regime di monopolio e anche
questa – dato il largo ricorso alla manodopera indigena – fu una doccia fredda sulle
speranze dei tanti lavoratori italiani cui era stato promesso un felice e prospero
avvenire in Africa.
Anche dal punto di vista urbanistico i progetti furono semplicemente favolosi
(soprattutto quello pensato per Addis Abeba) e testimoniano la vera e propria
megalomania del regime e di Mussolini stesso, del tutto disancorata dalla realtà: il
ministro degli Scambi e Valute Guarneri spesso lanciava i suoi inutili allarmi a
Mussolini mostrandogli come ‘l’Impero sta ingoiando l’Italia’ e come la fortuna di
pochi fosse caramente pagata da tanti, ma per Mussolini l’Impero coi suoi slogan del
‘posto al Sole’ e dello ‘spazio vitale’ aveva la precedenza su tutto e su tutti.
VII
Il progetto peggio riuscito e più deludente fu comunque proprio quello che il regime
aveva ritenuto il più importante e su cui aveva esercitato il massimo sforzo
propagandistico, quello cioè del popolamento dell’Impero con famiglie di agricoltori.
Dopo una vasta disamina di tutti i tentativi effettuati Angelo Del Boca trae la sue
meste conclusioni: ‘in cinque anni, dei milioni di coloni previsti, l’Italia non è riuscita
a trasferirne in Etiopia che un numero del tutto trascurabile, che oscilla fra i 500 e gli
48
800 a seconda delle fonti. Nello stesso periodo, sono stati coltivati appena 10mila
ettari, dei 29mila assegnati e dei 179mila richiesti’: le cose sono andate un po’ meglio
in Eritrea e in Somalia, comunque il 27 aprile 1940 i dati forniti alla Camera dal
ministro Teruzzi parlano di 31mila persone rurali complessivamente trasferite nella
AOI (cifra oltretutto ridimensionata da altre fonti).
I motivi di un disastro simile meritano una spiegazione.
L’entusiasmo e la convinzione di compiere una missione storica che con la
costruzione di una nuova e unitaria entità eurafricana avrebbe trasformato l’Italia in
un Impero originale e mai visto sfociarono in una martellante e delirante - ma
creduta, accettata e sentita - propaganda: le prospettive che allora vennero proposte
con tanta convinzione inebriarono la fantasia di molti, ma nondimeno poggiavano su
contraddizioni insormontabili che le avrebbero portate al sicuro fallimento:
innanzitutto la sproporzione fra i mezzi semplicemente del tutto insufficienti di cui
poteva disporre l’Italia e il fine di edificare un impero così ambizioso;
in secondo luogo l’affermazione dell’Impero avrebbe dovuto logicamente comportare
il genocidio degli etiopi (e degli altri indigeni), ma senza di loro sarebbe venuta a
mancare l’imprescindibile e necessaria forza-lavoro;
in terzo luogo, l’Impero (come si vedrà nel prossimo capitolo) si fondava
sull’accettazione da parte degli etiopi (e degli altri indigeni) della loro inferiorità
razziale (quindi ineliminabile) con la conseguente subalternità permanente nei
confronti dei padroni italiani, proprio mentre gli etiopi continuavano a ribellarsi e a
tenere il Paese sotto la costante minaccia della guerriglia.
VIII
Come se tutto questo non bastasse, mentre Mussolini e il fascismo 1) erano impegnati
in un progetto così immenso e sentito, 2) con uno sforzo gigantesco che richiedeva
spese ingentissime e mai viste, 3) con un esercito che era appena in grado di
contenere la guerriglia ma non certamente di sostenere una guerra contro potenze
industrializzate e 4) con i rifornimenti che in caso di guerra non sarebbero più potuti
arrivare nella AOI, non solo risulta del tutto incomprensibile la decisione di
Mussolini di entrare in guerra, ma ancor di più quella di muovere addirittura
all’attacco in Africa Orientale (!).
Completamente privo di una corretta conoscenza delle vere forze in campo e
inebriato dai suoi megalomani sogni di grandezza senza fondamento, Mussolini
pensò infatti di poter approfittare della potenza tedesca per condurre la sua
inconsistente ‘guerra parallela’ allo scopo di allargare i confini del suo impero (!!!)
come mostra la seguente cartina.
49
(I territori dell’Impero nel 1940 sono quelli in verde scuro e in verde chiaro quelli di
cui si progettò la conquista.)
La guerra andò così come non poteva non andare: in Africa Orientale (l’unico settore
nel quale non fu sostenuto dalle armate tedesche!) – in un impero isolato, circondato
da colonie nemiche e con 4.800 km. di confine terrestre e 3.900 di confine marittimo
- l’esercito italiano, pur forte di 300mila soldati e quindi numericamente superiore
dieci volte a quello inglese, ma di gran lunga meno armato ed equipaggiato, fu
disastrosamente e velocemente sconfitto.
Scartata l’invasione del Sudan che, seppure sguarnito, non sarebbe stato possibile
difendere e impediti di occupare Gibuti (sotto l’alleata Repubblica di Vichy), dopo
aver invaso e occupato in brevissimo tempo (3-19 agosto) la Somalia Britannica (che
comunque gli inglesi riuscirono a sgombrare infliggendo agli attaccanti perdite otto
volte superiori alle proprie) l’esercito italiano fu completamente travolto dal
contrattacco inglese mentre le popolazioni locali insorgevano, oltretutto ringalluzzite
dall’arrivo a Khartoum di Hailé Selassié il 2 luglio.
Dopo la Somalia e l’Eritrea gli inglesi proseguirono lanciatissimi alla riconquista
dell’Etiopia in quella che fu poco più di una passeggiata militare in un territorio
praticamente privo di difese mentre la guerriglia si scatenava ancora più incontenibile
e le diserzioni dei soldati coloniali erano un fiume inarrestabile: era questa,
commenta Angelo Del Boca ‘quell’ ‘armata nera’ con la quale Mussolini aveva
confidato per qualche tempo di conquistare l’intero continente’.
Gli italiani non poterono fare altro che ripiegare e ritirarsi (quando pur ci riuscirono)
o semplicemente scappare incalzati dal ‘più travolgente inseguimento che la storia
ricordi’ (Angelo Del Boca): il 3 aprile 1941 gli inglesi entrarono in Addis Abeba
(proclamata città aperta) e – mentre funzionari, dirigenti e fascisti l’abbandonarono
in una vergognosa fuga in automobile - dilagarono poi in tutta l’AOI fra folle di
etiopi in delirio e partigiani che entravano vittoriosi in città: il bottino di cui i
vincitori si impadronirono fu poi enorme e di tutti i tipi.
50
Mentre ad Addis Abeba i 35mila italiani rimasero sotto la protezione della PAI
(polizia africana italiana) e degli inglesi e continuarono comunque a far funzionare la
città, le truppe italiane, pur in ritirata, continuarono a combattere ad oltranza in tre
distinti settori.
Il primo fu l’inspiegabile trinceramento sull’Amba Alagi dove 7.000 soldati italiani e
circa 3.000 indigeni agli ordini di Amedeo duca d’Aosta resistettero all’assedio per
un mese (17 aprile-17 maggio 1941) finchè, mentre i soldati coloniali disertavano in
massa, si dovettero arrendere dopo la (solita) valorosa resistenza che comunque valse
ai superstiti (4.000 di cui 400 indigeni) l’onore delle armi e le lodi sperticate del
regime per un’azione che ancor oggi è celebrata come eroica.
Il secondo fu la difesa del Galla e Sidama ad opera di 70mila uomini al comando del
generale Gazzera (17 maggio-4 luglio 1941) mentre la popolazione locale, fino ad
allora abbastanza tranquilla, si sollevava e le diserzioni dei soldati indigeni si
moltiplicavano: l’inevitabile resa finale permise di dichiarare la capitale Gimma città
aperta e dunque di salvare i 10mila italiani che vi risiedevano, ma le perdite (morti,
feriti e dispersi) ammontarono ad oltre 2.300 nazionali e a quasi 20mila coloniali ed
anche in questo caso il bottino dei vincitori fu enorme (senza contare tutto quello che
era stato razziato).
Il terzo fu nei baluardi che culminavano in Gondar dove i 40.000 uomini (17mila
nazionali e 23mila indigeni) al comando dell’abile e stimato generale Nasi si erano
trincerati e dove il 17 maggio subirono il primo attacco: i baluardi caddero uno dopo
l’altro (e ogni volta si ripetè la storia dell’ingente bottino, delle razzie, delle rivolte e
dei saccheggi) - né sarebbe potuto essere diversamente - finchè il 28 novembre a Nasi
non restò che arrendersi (anche se Gondar non venne dichiarata città aperta perché le
600 famiglie degli 1810 italiani erano già state evacuate per tempo).
IX
Il 28 novembre 1941 nell’Africa nera ex-italiana la guerra era dunque finita e
l’Impero (la ‘più grande avventura di massa alla quale gli italiani abbiano partecipato
dall’unità d’Italia’ secondo Angelo Del Boca) era miseramente crollato: secondo un
calcolo piuttosto approssimativo essa era costata la vita a 50mila indigeni e a 15mila
italiani, cioè a ben oltre il 22% degli effettivi all’inizio delle ostilità, senza contare le
tante vittime sconosciute della guerriglia: enormi poi erano state le violenze, le
distruzioni, le perdite materiali dei cinque mesi di ostilità mentre gli inglesi poterono
- giustamente - vantarsi dei loro brillanti successi, irridere gli italiani e sottolineare la
scarsità delle proprie perdite.
A parte l’assurdità dell’entrata in guerra dell’Italia, verrebbe spontaneo chiedersi che
senso abbia avuto per gli italiani continuare a resistere e a combattere quando ormai
era chiaro che si trattava di una causa persa e dunque di sacrifici e di morti (a dir
poco) inutili, e se non avessero avuto ragione il generale Pesenti, che dopo la perdita
dell’Eritrea e della Somalia propose al duca d’Aosta di negoziare una cessazione
delle ostilità, e Togliatti che si sarebbe chiesto ‘Se Mussolini era convinto che
51
l’impero fosse necessario all’Italia, perché lo ha arrischiato e perduto in un modo così
sciocco …?’, ma queste domande non tengono conto della situazione del 1940-41.
Quando si combattè nell’AOI la Wehrmacht aveva conquistato l’Europa continentale
e stava avanzando vittoriosa in URSS; in Nordafrica la partita era ancora tutta da
giocare; i giapponesi dominavano l’Estremo Oriente, non avevano ancora attaccato
Pearl Harbour e dunque gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra: non era
insomma del tutto illogico sperare che la vittoria sugli altri fronti avrebbe comportato
la rivincita su quello del Corno d’Africa o comunque il mantenimento dell’Impero
africano di Mussolini che fin dall’inizio si era messo nelle mani dei tedeschi e che
aveva puntato tutto su di loro.
Insomma: la guerra nell’AOI fu ovviamente un errore (per non dire altro) ma
commesso nell’ambito di quello generale (e imperdonabile) di tutta la seconda guerra
mondiale .
Questo spiega anche perché in tutta l’AOI una qualche guerriglia italiana continuò
ancora per un paio d’anni (sostenuta anche da etiopi nemici del Negus!) e perché gli
italiani (e il regime fascista, s’intende) continuassero a sperare che sarebbero rimasti
nel Corno d’Africa visto che dopotutto avevano subito sì una sconfitta, ma non
ancora perso la guerra, né era facile allora riconoscere l’irreversibilità del fatto
compiuto.
In realtà tutto era invece perduto e anche gli italiani in Etiopia dovettero affrontare il
dramma del ritorno in patria che avvenne con le modalità già illustrate a proposito
dell’Eritrea (quasi 55mila si imbarcarono sulle ‘navi bianche’).
La guerra nell’AOI aveva infine causato ulteriori e profonde sofferenze alle
popolazioni indigene che avevano dovuto sopportarne i pesi maggiori
(bombardamenti, requisizioni, razzie, devastazioni, distruzioni, ecc.): si è già visto
infine come i soldati dell’esercito italiano erano in maggior parte coloniali e
quanto maggiore sia stato il numero dei loro morti in confronto a quello degli italiani
stessi, ma anche nelle fila inglesi i combattenti erano per lo più indiani, sudafricani,
etiopi, ecc., e naturalmente furono questi a subire le perdite maggiori.
Strano destino quello dei popoli colonizzati che dopo essere stati conquistati ed
asserviti, sfruttati e depredati, dovevano fornire anche soldati che combattessero per i
loro padroni e signori, per garantire cioè che le catene che li tenevano avvinti fossero
ancor più salde e strette: e quanto erano fedeli e coraggiosi questi arruolati di colore!
X
Hailé Selassié, reinsediato sul trono dagli inglesi, dimostrò nell’occasione un grande
senso umano e pratico perché non si incattivì contro gli italiani che pure tanto male
avevano fatto a lui, al suo Paese e al suo popolo, e preferì invece adottare nei loro
confronti una politica di grande moderazione tanto che continuò a volerli ancora sulla
sua terra (!): il 20 gennaio 1941, appena rimesso piede sul territorio etiopico, il Negus
emanò il decreto di San Michele che concedeva l’amnistia a tutti gli etiopici che
avevano collaborato con gli italiani e invitava tutti al rispetto dei prigionieri italiani:
‘vi raccomando di accogliere in maniera conveniente e di prendere in custodia tutti
52
gli italiani che si arrenderanno, con o senza armi. Non rinfacciate loro le atrocità che
hanno fatto subire al nostro popolo. Mostrate loro che siete dei soldati che possiedono
il senso dell’onore ed un cuore umano. Vi raccomando particolarmente di rispettare la
vita dei bambini, delle donne e del vecchi. Non saccheggiate i beni altrui anche se
appartengono al nemico. Non incendiate le case.’
Questo appello al popolo etiopico ridusse le violenze e in generale fu rispettato dalle
truppe agli ordini diretti dell'imperatore e dalla resistenza popolare monarchica.
Il 5 maggio 1941 (nel quinto anniversario dell’occupazione degli italiani), entrato
trionfalmente ad Addis Abeba, Hailé Selassié emanò poi un Editto di Perdono che
vietava le rappresaglie e le vendette nei confronti dei circa 35mila civili italiani
concentrati nella capitale (di cui 11mila erano donne e 7mila bambini): ‘Poiché oggi è
un giorno di felicità per tutti noi, dal momento che abbiamo battuto il nemico,
rallegriamoci dello spirito di Cristo. Non ripagate dunque il male con il male. (...)
Prenderemo le armi al nemico e lo lasceremo andare a casa per la stessa via dalla
quale è venuto’.
Ovviamente il negus era mosso anche da considerazioni molto più pratiche dei suoi
nobili fini morali perché apprezzava l’utile e ingente lavoro svolto della comunità
italiana - ora non più minacciosa – oltre al fatto che intendeva servirsene come
contrappeso all’ingombrante presenza degli inglesi che non sembravano per niente
intenzionati ad andarsene e che infatti rimasero in Etiopia anche dopo che il 31
gennaio 1942 ne riconobbero l’esistenza come stato libero e indipendente.
Il loro comportamento fu tale che Angelo Del Boca scrive che ‘gli etiopici non
tardarono molto ad accorgersi che gli inglesi liberatori non erano molto diversi dagli
italiani’, ma questo giudizio non è assolutamente accettabile perché gli inglesi non si
macchiarono certo dei delitti, delle stragi e delle repressioni cui gli italiani si erano
invece dedicati con tanto impegno anche se cercarono di mantenere il Paese sotto il
loro controllo (e il 23 settembre 1948 gli restituirono l’Ogaden che l’Italia aveva
annesso alla Somalia).
Mentre gli inglesi di dedicarono comunque a smontare e a trasferire in Kenya tutto
quello che gli italiani avevano costruito nell’AOI, il negus comprendeva invece
l’utilità di conservare tutte le strutture e i quadri dirigenti del colonialismo italiano
che intendeva utilizzare sia per il mantenimento delle strutture stesse che per la
ricostruzione del Paese: per questo egli si scontrò addirittura con gli inglesi a
proposito del numero di italiani che potevano rimanere in Etiopia.
Andando contro l’opinione dei gruppi più intransigenti, per tutti questi motivi Hailé
Selassiè volle mantenere e favorì quanto più possibile gli ex-coloni italiani, oltretutto
ben inseriti in alcuni settori economici fondamentali (trasporti, piccola industria
alimentare, import-export, ingegneria, ecc.): per parte loro, gli ex-coloni italiani
rimasti in Etiopia collaborarono col governo nell’amministrazione e nei settori già di
loro competenza mentre alcuni di essi si integrarono addirittura nella nascente
borghesia etiope.
Le cose si spinsero tanto avanti che Hailé Selassié condusse trattative segrete con
l’Italia stessa (!) in vista di una possibile alleanza (!) e addirittura di un protettorato
italiano (!), ma tutto questo terminò bruscamente con la sconfitta definitiva di
53
Rommel a El Alamein (autunno 1942), cioè con lo sfumare definitivo di un possibile
arrivo di truppe dell’Asse dal fronte nordafricano.
XI
Opportunista o no, Hailé Selassié mostrò insomma una grande umanità e un
apprezzabile e realistico senso di equilibrio che rende ancor più odioso e meschino il
comportamento degli italiani che Angelo del Boca ricorda citando i dati ufficiali
presentati dal governo etiopico nel 1945: alla resistenza etiopica gli italiani avevano
risposto con gas asfissianti (per decenni negati dall’Italia), feroci repressioni e
fucilazioni di massa. Nel 1935-36 l’invasione e la ‘pacificazione’ avevano causato la
morte di 275mila persone tra civili e soldati; tra il 1936 e il 1941 erano stati uccisi
75mila resistenti e 17.800 civili erano periti, in genere vittime di bombardamenti
aerei e di artiglieria (anche con i gas, soprattutto dal 1936 al 1939); 30mila civili
erano stati passati per le armi (soprattutto dopo il fallito attentato al governatore
Graziani (che ordinò massicce e indiscriminate rappresaglie anche contro il clero
copto del tutto estraneo alla vicenda); 24mila prigionieri erano stati fucilati e 35mila
erano morti in prigionia (inclusi membri della famiglia imperiale, dell’alta
aristocrazia e dell’intellighenzia nazionale, deportati in Eritrea, in Libia ed anche in
Italia); infine, le privazioni economiche causate dalla guerra avevano comportato
migrazioni forzate, flussi di profughi, sconvolgimenti, diffusione di malattie, carestie,
ecc. che avevano causato la morte (soprattutto per fame e per dissenteria) di circa
300mila persone e che di fatto avevano svuotato interi villaggi.
Oltre a queste, vi erano state infine perdite considerevoli anche tra i gruppi etnici
(come i Galla), gli aristocratici e tutti coloro che avevano scelto di appoggiare e di
collaborare coi colonialisti italiani.
XII
Questa accorta politica (che aveva fatto dell’italiano la lingua franca del Paese) venne
bruscamente interrotta quando Hailé Selassié fu defenestrato (e presto eliminato) dal
colpo di Stato militare del 1974: il Derg e il suo leader Menghistu erano marxisti e
subito instaurarono il (solito) violento, indiscriminato e brutale ‘Terrore rosso’ così
che i circa 16mila italiani furono costretti ad abbandonare in massa e in tutta fretta
l’Etiopia mentre le loro proprietà furono nazionalizzate.
Alla fine degli anni Ottanta non ne erano rimasti che poco più di un migliaio ma la
vera fine della storia della presenza italiana nel Corno d’Africa fu comunque sancita
nell’Agreement fra Etiopia e Italia firmato il 17 ottobre 1982 in base al quale l’Italia
rinunciava ad ogni indennizzo per gli espropri dei beni dei suoi cittadini e l’Etiopia
alla riscossione delle tasse da questi non pagate (fino a quel momento il visto di
uscita era rifiutato a coloro che non erano in regola col fisco).
Dopo anni di guerriglia, repressioni, violenze, carestie e impoverimento (insomma
dopo tutto il triste corollario dei regimi marxisti) nel 1987 il Derg finalmente fu
rovesciato e negli anni duemila molte ditte italiane poterono così tornate ad operare in
54
Etiopia, ma oggi solo pochi discendenti dei coloni italiani vivono ancora nelle
principali aree metropolitane del Paese: un’altra pagina di storia è stata cancellata.
XIII
In Etiopia la bestialità del colonialismo italiano fu ancor più spinta che in Libia e ciò
anche per il disprezzo razziale verso i negri (anche se cristiani), più accentuato di
quello nei confronti degli arabi (di cui si apprezzava la religione islamica come utile
freno morale e fattore di controllo sociale).
Contemporaneamente però l’opera ammodernatrice, costruttrice e pionieristica e il
progresso scientifico, tecnologico e industriale portato dagli italiani furono innegabili
e rivoluzionarono per sempre quei popoli e quei Paesi, ma questo in nessun modo può
costituire titolo di vanto o di merito nei confronti dei nativi perché i colonialisti
italiani compirono le loro pur spettacolari imprese unicamente per se stessi e a
proprio esclusivo vantaggio, nella convinzione che sarebbero restati padroni e
sfruttatori di quelle terre e di quelle risorse (e di quelle persone!) per sempre.
Dovunque il colonialismo è crollato e naturalmente più facilmente quello italiano,
ultimo arrivato ma più ambizioso di tutti: quegli italiani che si recarono in Etiopia
in cerca di fortuna e di avventura (e di lavoro) a spese altrui non meritano
alcuna solidarietà perché lo fecero nel sangue e nella violenza, nella spoliazione e
nella rapina, mentre chi li cacciò fu più che giustificato nel voler voltare
finalmente pagina e tornare padrone e libero in casa sua.
Certamente anche nel caso dell’Etiopia molti credettero sinceramente nelle
parole di Mussolini e ne seguirono fiduciosi gli ordini e gli inviti, le direttive e le
parole d’ordine, ma questa non è una scusante perché sapevano benissimo cosa
si stava facendo alle popolazioni locali per far largo a loro: insomma: agli
italiani d’Etiopia è andata fin troppo bene e avrebbero dovuto ringraziare per
come gli era andata invece di continuare a sperare che un giorno sarebbero
ritornati.
Razzismo italiano
Il 1938 fu l’anno delle famigerate Leggi Razziali: il 5 agosto uscì il primo numero
della rivista ‘La difesa della razza’ che pubblicò, appunto, un ‘Manifesto degli
scienziati razzisti’ (o ‘Manifesto della Razza’) che affermava che le razze erano una
realtà biologica, che ormai esisteva addirittura una ‘razza italiana’ di origine e di
civiltà ariana e che gli ebrei non ne facevano parte; il 5 settembre seguì il Regio
Decreto ‘Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista’ e quello del 7
settembre ‘Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri’; il 6 ottobre il Gran
Consiglio del Fascismo approvò una ‘Dichiarazione sulla razza’ che venne infine
ripresa nel Regio Decreto del 17 novembre.
L’obiettivo delle Leggi Razziali era evidentemente antisemita e con esse il fascismo
si accodava ancor più al nazismo allora trionfante nella discriminazione degli ebrei
che poi sarebbe sfociata nella persecuzione fino al genocidio nei campi di sterminio.
55
Questo è ciò che si sa e si pensa oggi del razzismo italiano, ma riducendolo a questo
solo aspetto si dimentica che purtroppo esso era di più vecchia data e ben più esteso
di quello soltanto antisemita.
I
Nei confronti dei popoli extra-europei infatti già l’Italia liberale aveva in genere
condiviso i pregiudizi razzistici allora prevalenti (e scontati) in Europa, fondati sulla
convinzione della barbarie delle razze di colore e soprattutto di quella negra: anche in
Italia questo pregiudizio aveva molte sfumature che andavano dal disprezzo nei loro
confronti al riconoscimento della possibilità di ‘educarle’ e di ‘elevarle’, dalla
mancanza di scrupoli nel loro sfruttamento alla volontà di assimilarle e di convivere
con loro, giudicandole e volendole mantenere comunque in uno stato di perenne
inferiorità.
Senza questo sfondo razzistico il colonialismo e lo stesso ardore missionario non
sarebbero stati nemmeno concepibili, così come non si può né si deve dimenticare
che sentimenti di superiorità e di disprezzo si sarebbero manifestati apertamente
anche nei confronti degli slavi al tempo della prima guerra mondiale e delle
conseguenti pretese italiane sull’Istria, sulla Slovenia e sulla Dalmazia.
Fu però il fascismo a dare veste ufficiale e giuridica al razzismo italiano perché
codificò la supposta superiorità ‘bianca’, e più specificamente italiana, in un corpo di
leggi e di norme che avrebbero dovuto regolare su basi chiare e ben definite tutti i
rapporti fra le razze (bianca, araba e nera) all’interno dell’Impero: dopo la conquista
dell’Etiopia e la proclamazione dell’Impero il problema dei rapporti cogli indigeni fu
impostato infatti con chiarezza e rigore.
II
Come avrebbe chiarito nel 1939 l’Istituto Fascista dell’Africa Italiana (‘Nozioni
coloniali per gli iscritti alle organizzazioni del PNF’), ‘il problema di tutelare la
purezza della nostra razza … non esisteva quasi affatto per l’Italia coloniale di ieri,
quando Eritrea e Somalia non accoglievano che poche migliaia di coloni. Quanto alla
Libia, questa è una terra abitata da popolazioni arabe di razza bianca e di cultura
superiore, tenute a freno per giunta dalle rigorose norme morali della religione
musulmana: onde può dirsi che per esse il problema non abbia neppur ragione di
essere posto. … Nell’Impero dell’AOI la possibilità dell’incrocio fra Italiani e
indigeni si presenta invece gravissima, … [nel]l’accoppiamento con creature inferiori
… si annegherebbero le nostre migliori qualità di stirpi dominatrici. … una casta
meticcia [è un] ramo anormale della famiglia umana.’
Che gli africani fossero ‘creature inferiori’ dal punto di vista biologico e dunque
senza rimedio l’aveva sostenuto già l’anno prima anche Lidio Cipriani (‘Razzismo
coloniale’): ‘i sociologi moderni, i quali inculcarono nelle masse l’opinione
dell’uguaglianza psichica di tutte le razze … non seppero distinguere quanto nelle
56
razze è eredità culturale da un lato ed eredità biologica dall’altro, onde supposero
perfino un’influenzabilità di questa da parte di quella’.
Fin da subito si corse quindi ai ripari: innanzitutto, anche se con la legge n. 1019 del
1 giugno 1936 venne operata una certa distinzione tra somali ed eritrei da una parte
ed etiopi dall’altra (infatti i 50mila eritrei e gli 80mila somali che avevano combattuto
cogli italiani nella guerra d’Etiopia e nella sua ‘pacificazione’ e i loro orfani
godettero di tutta una serie di privilegi per quanto concerneva gli impieghi, le cariche
e le licenze), tuttavia ogni differenza di trattamento e di considerazione degli indigeni
dell’AOI cessava di fronte ai provvedimenti adottati per la difesa della razza
(italiana) perchè tutti i nativi furono sottoposti alla più netta segregazione.
Il 9 gennaio 1937 un primo decreto-legge intese infatti garantire la difesa della razza
vietando con gravi sanzioni penali la convivenza more uxorio di un italiano con una
donna nera: i matrimoni misti vennero dichiarati nulli e i funzionari pubblici che li
avessero celebrati sarebbero stati puniti, così come si sarebbe proceduto a proposito
di tutti i comportamenti ‘lesivi del prestigio della razza’.
Il 19 aprile 1937 una legge di un solo articolo non solo vietava assolutamente il
matrimonio fra uomini bianchi e donne nere (e viceversa) ma puniva con la
reclusione anche il ‘madamato’, cioè la convivenza (o il concubinaggio) degli italiani
con donne di colore in una sorta di matrimonio a tempo: il motivo di questa rigorosa
proibizione era sia ‘biologico’, cioè evitare la contaminazione della superiore
razza italiana con le razze inferiori, che politico, cioè mantenere la distanza fra
dominatori e dominati dando un taglio netto e definitivo ad ogni eventuale rapporto
troppo stretto fra le due razze.
A questo proposito Ernesto Galli della Loggia ha notato che proprio questo
intensificarsi di norme razziste contro i rapporti sessuali con donne di colore
testimoniò in realtà proprio la propensione degli italiani verso queste pratiche, cioè il
loro non-razzismo, a differenza per esempio degli inglesi che non avevano bisogno di
norme di questo genere perché ci pensavano da soli a non incrociarsi con le donne
indigene delle loro colonie: è una tesi originale che però non toglie che la dottrina
ufficiale e legalizzata del fascismo era ispirata al più rigoroso razzismo (anche
‘Faccetta nera’ venne censurata perché invitava i conquistatori di soddisfare
sessualmente le etiopi!).
III
Gli africani erano tuttavia indispensabili al funzionamento delle colonie stesse
quindi bisognava che, come ad esempio sostenne Raffaele Di Lauro, ‘il dominato
deve comprendere che noi lo consideriamo come un elemento particolarmente
necessario al nostro lavoro, che non intendiamo affatto restituirlo alla boscaglia o alla
steppa, ma invece farlo camminare – da noi inquadrato – sulla via della civiltà e del
progresso’ (sic).
Nel 1939 Martino Mario Moreno (‘Politica di razza e politica coloniale italiana’)
arrivò così a sostenere che ‘tali provvedimenti legislativi [sulla preservazione della
purezza della razza] … anziché essere ispirati al disprezzo dell’uomo di colore,
57
mirano alla sua tutela e alla sua elevazione e non sono destinati a suscitare
sfavorevoli reazioni tra gli aborigeni delle nostre colonie’ (sic).
Vale la pena ricordare che dieci anni dopo in Sudafrica questa mentalità sarebbe
sfociata nell’ ‘apartheid’.
Lo sfruttamento dei nativi era ovviamente molto conveniente visto che i loro salari
erano tre volte inferiori a quelli dei bianchi e che ad essi si poteva anche imporre il
lavoro forzato (decreto n. 917 del 27 aprile 1935), senza poi tener conto 1) delle
violenze, delle sopraffazioni e anche dei comportamenti inutilmente sadici cui tanti
italiani si abbandonavano (e per cui un certo numero fu punito e rimpatriato) nei
confronti dei nativi e 2) del fatto che a proposito dell’abolizione della schiavitù – su
cui pure si era menato tanto scandalo per giustificare la conquista dell’Etiopia – si
procedette molto lentamente e si addusse ogni sorta di scuse e di pretesti per limitarla,
ritardarla e non attuarla.
Visto poi che – come sostenne Moreno – ‘è … utopistico pensare che gli Africani
possono essere rapidamente elevati al livello occidentale ed affrancati un giorno dalla
tutela europea: si tratta di pupilli che non raggiungeranno mai la maggiore età’, fu lo
stesso ministro per l’Educazione Nazionale Bottai a chiarire che ‘La cultura
dell’indigeno deve essere mantenuta in limiti ben precisi’, cioè arrivare a fornire solo
quei livelli minimi necessari allo svolgimento di compiti subordinati e subalterni.
Insomma, come ben sintetizza Angelo Del Boca, ‘etiopici, eritrei e somali sono
assolutamente uguali e degradati, costituiscono un mondo a parte, dal quale gli
italiani debbono soltanto attingere manodopera e carne da cannone’.
IV
In ogni caso, la legislazione razziale e razzista da sola non avrebbe potuto rimediare
all’esecrata e temuta commistione fra razze ed essa era inoltre funzionale allo scopo
di fare dell’AOI una colonia di popolamento, come riconobbe nel 1938 Vittorio
Gorresio (‘Popolare l’Impero’): ‘il problema dei rapporti fra le razze … ha suscitato
allarmi probabilmente eccessivi. A proteggerci da un pericolo di commistione di
razze … nella stessa colonizzazione demografica è implicito il rimedio … che
veramente è la chiave di volta della valorizzazione dell’Impero: il popolamento
dell’Impero.’
Il popolamento come misura per mantenere ‘pura’ la razza italiana l’aveva
specificata ancor meglio Livio Livi (‘I fondamenti bio-demografici della
colonizzazione di popolamento’) nel 1937 quando aveva auspicato che: ‘il flusso
migratorio che dovrà colonizzare il nostro Impero sia inquadrato nei ranghi che la
natura vuole: cioè anzitutto per famiglie normalmente costituite, o almeno con
equilibrio dei sessi … Ma non basta ancora: occorrerà poi che la popolazione (e mi
riferisco specialmente a quella agricola) non venga dispersa, in quell’enorme
territorio, in famiglie o gruppi troppo esigui ed isolati. Bisognerà invece che ogni
individuo, ogni famiglia, possa svolgere liberamente le sue relazioni sociali entro una
cerchia sufficientemente vasta di connazionali’.
58
V
Per i razzisti italiani il problema più grave rimaneva comunque che dalle unioni
miste nascevano poi figli/e meticci/e: sempre Livi segnalò ad esempio che ‘la
pratica ha riscontrato il danno sociale apportato dal concubinato con donne indigene,
a motivo della procreazione di gruppi notevoli di meticci illegittimi, gruppi difficili
da assorbirsi nei quadri di un civile ordinamento. … L’azione che il governo si
prefigge svolgere contro il concubinato illegittimo sta quindi a tutela di reali e
naturali necessità.’
Moreno sostenne poi che: ‘Nel riversare in Africa Orientale Italiana centinaia di
migliaia non soltanto di soldati, ma anche di operai, l’Italia pensò alla grave
situazione che si sarebbe determinata se tutta questa massa di uomini si fosse data a
procreare con donne indigene. … Da queste unioni erano nati dei prodotti, che
costituivano un serio problema. Il meticcio, infatti, anche quando riconosciuto e
allevato all’europea, è sempre guardato con ripugnanza e con sospetto dalla società
bianca, che ravvisa in lui le stigmate di una razza inferiore, e vi scopre le tracce della
prima educazione materna.’
In Eritrea le unioni ‘miste’ erano state permesse fino all’avvento del fascismo:
nell’ambito della politica di popolamento delle colonie dal 1933 venne allora
proclamata la ‘difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana’ e
nella conseguente guerra contro la ‘piaga del meticciato’ fu addirittura vietato ai
padri di riconoscere i figli ‘meticci’.
Si trattò di una vera e propria odiosissima persecuzione verso i piccoli italo-eritrei
(chiamati con disprezzo ‘dqala’, cioè bastardi), almeno 15mila nei sessant’anni di
presenza italiana, spesso figli di uomini già sposati in Italia.
Mentre in Etiopia la madre aveva almeno la facoltà di indicare il cognome del padre
anche se già sposato, in Italia ciò non fu possibile fino alla riforma del diritto di
famiglia del 1975 (!).
Prima del 1936 ai/lle figli/e di padri italiani e di madri somale era concessa la
cittadinanza italiana se il padre li/e avesse riconosciuti/e come figli/e (e ciò valeva
anche per quei bambini/e i cui tratti fisici indicavano chiaramente che uno dei
genitori era bianco), ma la legge n. 882 del 13 maggio 1940 stabilì esplicitamente che
tutti i ‘mulatti’ (e già lo stesso termine aveva un chiaro significato dispregiativo)
assumevano lo status del genitore indigeno e non potevano essere riconosciuti
dal genitore italiano nè portarne il cognome: la volontà di vietare e di recidere ogni
legame fra gli italiani (praticamente solo maschi) e le persone (donne) di altre razze
era talmente sentita che - oltre a non voler ‘inquinare’ il sangue dei primi con quello
‘inferiore’ delle seconde – si stabilì che per rendere ‘inferiore’ un individuo bastava
che solo uno dei due genitori lo fosse, come se l’altro non c’entrasse niente con la sua
nascita e la sua (diciamo così) natura!
L’unica eccezione a questa vergogna fu che in Somalia gli 800 meticci che avevano
acquistato la cittadinanza prima del 1936 (cioè prima della fondazione dell’Impero)
erano riconosciuti come italiani, ma molti di questi, pur ormai cittadini italiani,
furono ugualmente emarginati e discriminati.
59
Eppure il vero boom delle nascite di italo-somali di sangue misto ci verificò al tempo
dell’amministrazione fiduciaria, quando cioè molti italiani inviati in Somalia, pur se
in maggioranza sposati e con famiglia nella madrepatria, ebbero figli con donne
somale per i quali non era però ancora possibile divenire italiani: le leggi razziali del
periodo fascista continuarono infatti ad essere applicate nonostante l’Italia
repubblicana ed antifascista fosse lì proprio per riparare ai danni compiuti dal
fascismo stesso!
E’ vero che al momento della nascita dei/lle bambini/e di padri italiani le madri
somale dichiaravano la paternità italiana in modo da segnalare l’appartenenza dei/lle
bambini/e alla cosiddetta ‘etnia euro-africana’ e che per essi/e c’era un registro a
parte, ma questo non cambiava la situazione e oggi, dopo le guerre e il caos che regna
nel Paese, ritrovare questi documenti è particolarmente difficile se non impossibile.
Alcuni di questi/e bambini vennero infine strappati/e alle madri e portati/e in collegi
italiani dove li/e attese un triste destino e in ogni caso a questi/e sfortunati/e non fu
mai possibile vivere con tutti due i genitori (e a volte nemmeno con uno).
In Australia questa politica di non riconoscere i figli/e nati da matrimoni misti e di
volersene liberare sarebbe sfociata nell’abominevole pratica delle ‘generazioni
rubate’ (vedere in proposito il mio saggio).
Oltretutto, data la sua innaturalezza, la legislazione razzista fu inevitabilmente
inefficace, visto che le stime più prudenti parlano di almeno 10mila meticci nati nei
cinque anni di occupazione italiana dell’AOI.
VI
Se tutti gli italiani in AOI erano decisamente convinti che bisognava mantenere netta
la loro supremazia e il loro dominio sui popoli che avevano conquistato e sottomesso,
non altrettanto favorevoli furono nei confronti del divieto di avere rapporti sessuali
con le donne indigene, pratica che consideravano un loro diritto e anche un modo per
esercitare e rendere ancor più manifesto il loro potere signorile (mentre per il
legislatore in Italia ciò avrebbe avvicinato anziché tenuto ben separate le due razze).
C’era poi un motivo squisitamente oggettivo a rendere difficile, anzi impossibile, la
proibizione dei contatti sessuali fra bianchi e nere: per i 300mila fra soldati e civili
italiani nell’AOI c’erano solo poche migliaia di donne bianche che inoltre in genere
erano le mogli dei residenti nelle città principali (quindi non disponibili).
L’arrivo di prostitute italiane e l’apertura di case di tolleranza risultarono di gran
lunga insufficienti ed anche il ricorso a prostitute indigene (regolarizzate e visitate dal
medico due volte alla settimana), autorizzate ad esercitare nei loro tucul (diversificati
fra quelli per ufficiali, per civili e per soldati), non bastò, come dimostrarono le
lunghe e costanti file di maschi italiani in paziente attesa davanti a quelle misere
capanne senza acqua corrente nè luce.
La prostituzione clandestina dunque continuò creando fra l’altro allarmi per la
salute (tema dominante del romanzo di Ennio Flaiano ‘Tempo di uccidere’,
ambientato in Etiopia) come anche il madamismo (ufficialmente non più tollerato
dal 1936) che Alfio Beretta così descrisse: ‘Il bianco comperava un’indigena che
60
diveniva … sua schiava. … Un mammifero di lusso nero’, anche se in realtà c’erano
anche casi di reciproca accettazione e convenienza.
Nonostante le punizioni (anche di alcune donne bianche!) non fu oggettivamente
possibile prevenire le continue e costanti violazioni delle leggi sulla difesa della
purezza della razza e dei loro divieti, tanto che così Angelo Del Boca riassume
l’intera questione: ‘appare sempre più evidente … che gli italiani conquistatori
dell’Etiopia rischiano di essere a loro volta conquistati dagli etiopici mediante il
sesso’.
Insomma: come tante altre politiche del fascismo, anche questa ossessione razziale e
razzista finì per risultare, oltre che odiosa, anche grottesca e addirittura ridicola.
VII
Per quanto riguardava gli arabi libici, nel 1927, man mano che il loro territorio veniva
conquistato, essi vennero nettamente separati dagli italiani (mentre nel 1919 si era
tentato – almeno sulla carta - di equipararli) ma senza abbassarli al livello infimo dei
negri dell’AOI: nel 1927 venne infatti concessa una ‘cittadinanza italiana libica’,
nettamente diversa da quella dei metropolitani e valida solo in Libia dove agli
indigeni erano comunque vietati tutti i diritti politici e di libertà del pensiero.
Governo e amministrazione erano completamente nelle mani degli italiani e i libici ne
erano totalmente esclusi così come erano anche esclusi dall’istruzione (a parte i
rudimenti minimi) e dalle scuole.
Nel 1938 Italo Balbo (‘La politica sociale fascista verso gli arabi della Libia’) operò
una chiara distinzione ‘sulla natura etnica degli abitanti’: ‘… bisogna distinguere fra
le genti della zona del Sud, oggi delimitata anche amministrativamente col nome di
‘Sahara libico’, e le genti del territorio costiero … il ‘Sahara libico’ è … popolato da
genti di razze negroidi …: gli arabi e i berberi dei territori costieri costituiscono
invece una popolazione di razza superiore influenzata dalla civiltà mediterranea. …
Simili genti Roma trasformava un tempo da sottomesse in alleate fino ad incorporarle
nello Stato con la cittadinanza romana. … i tempi sono maturi per l’elargizione di un
nuovo tipo di cittadinanza che conceda all’arabo della Libia la dignità di ‘cittadino’
italiano’.
Questa cittadinanza valeva ovviamente solo in Libia e grande fiducia fu posta nella
(solita) opera di ‘civilizzazione’ (scuole) fino alla istituzione di una Gioventù Araba
del Littorio per ‘creare un nuovo tipo di cittadino italiano libico’ così che ‘avremo in
Libia non dominatori e dominati, ma italiani cattolici e italiani musulmani’.
Ma si trattava di processi previsti su tempi lunghissimi e per il momento era la
separazione a prevalere e ad essere giudicata semplicemente ‘normale’.
61
Conclusione
Con le consuete competenza e precisione Angelo Del Boca riferisce che, militari a
parte, ‘al censimento del 12 novembre 1949 i profughi dall’Africa risulteranno quasi
206mila, così ripartiti per colonie di provenienza: 54.878 dall’Etiopia, 45.142
dall’Eritrea, 12.124 dalla Somalia, 93.721 dalla Libia’: se a questi si aggiungono gli
oltre 60mila dalla Tunisia, gli oltre 50mila dall’Egitto, qualche centinaio dalla Cina,
gli oltre 300mila dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia, e quelli dalle isole
del Dodecaneso, si arriva a circa 650mila italiani rimpatriati nel secondo dopoguerra.
Come si è già specificato, alcuni di questi 650mila furono vittime del tutto innocenti,
sfortunate e/o perseguitate, ma altri avevano invece profittato (o cercato di profittare)
degli immani disastri che il colonialismo aveva inflitto a popolazioni e Paesi del tutto
incolpevoli del loro tragico destino e dunque in nessun modo si può pretendere che
abbiano subito un torto o patito un’ingiustizia quando senza tanti complimenti
vennero privati del maltolto e cacciati via.
Sarebbe necessario, giusto e opportuno che questa distinzione fosse ben presente
nella nostra stessa coscienza nazionale, ma da quest’orecchio l’Italia davvero non ci
sente né ci ha mai sentito: nemmeno dopo la caduta del fascismo e il trionfo della
Resistenza gli africani ottennero almeno il riconoscimento delle enormi sofferenze e
dei gravissimi torti che avevano subito, né tantomeno giustizia.
Mentre nella Penisola venivano pronunciate le più sonanti e sentite esaltazioni dei
valori finalmente ritrovati, mentre ci si indignava e si piangevano gli ebrei vittime
della follia nazifascista, mentre il regime fascista e i suoi uomini venivano sottoposti
a giudizio, in quel momento di rinascita democratica della giustizia e della libertà,
‘nessuno dei 500mila italiani che sono stati in AOI tra il 1935 e il 1941 è chiamato a
rispondere del suo operato. Una amnistia, mai promulgata, ma sottintesa, cancella
tutti i genocidi, le rapine, i furti, le violenze, le deportazioni in massa, la distruzione
delle chiese, l’uso sistematico della guerra chimica, lo sterminio dell’intellighenzia
etiopica.’ (Angelo Del Boca, che qui stava riflettendo su uno dei tanti crimini
commessi dai colonialisti italiani, seppur forse il più grave).
Nemmeno Graziani e gli altri massimi responsabili (fra cui Badoglio) dell’orrore
coloniale di cui gli etiopi chiedevano la consegna perché venissero processati come
criminali di guerra rischiarono nulla perché nessuno si sognò mai di esaudire la
richiesta di giustizia da parte di un popolo africano nei confronti di cittadini
europei né di istituire una Norimberga anche per i crimini di guerra e contro
l’umanità commessi dagli europei in Africa.
E non basta ancora, perché la presenza italiana in Africa continuò a venir giudicata
positivamente in quanto ritenuta portatrice di civiltà e di progresso: nell’immediato
dopoguerra i partiti antifascisti (antifascisti) e i governi repubblicani esaltarono
l’opera fruttifera dei colonizzatori italiani, ribadirono ancora la necessità di popolare
con italiani quelle terre a causa del sovrappopolamento della Penisola e furono
unanimi nel pretendere e nel cercare di conservare all’Italia le ‘sue’ colonie, o almeno
quelle prefasciste (Eritrea, Somalia e Libia), così che quando a Parigi non le
62
ottennero l’opinione pubblica si risentì e giudicò che l’Italia era stata trattata
ingiustamente (sic).
Alle elezioni del 1948 tutti (tutti) i partiti sostennero una politica nazionalistica nei
confronti delle ex-colonie e anche l’URSS appoggiò tali rivendicazioni (!): tutti (tutti)
in Italia concordarono che essa non poteva venir allontanata dall’Africa.
Col tempo queste posizioni si sarebbero stemperate, sarebbero cambiate e ci si
sarebbe comodamente - troppo comodamente! - dimenticati dell’intera questione ma,
nelle rare volte in cui pur se ne parla, ancor oggi gli italiani che andarono a
conquistare ed a colonizzare l’Africa vengono giudicati ‘brava gente’ (!!!): oltre che
ignoranza, questo è razzismo.
Orrori, stragi e violenze di ogni tipo - come ad esempio quelle in Eritrea dal 1888-90
insabbiate dalla commissione d’inchiesta governativa (dopo la prima caduta di
Crispi) che scaricò le colpe dei ‘pochi abusi’ sui gendarmi eritrei e sulle vittime
stesse (!) - segnarono infatti il nostro colonialismo fin dall’inizio ma pochissimi in
Italia sembrano rendersene conto anche per l’indubbio successo dell’opera di
rimozione dalla memoria collettiva di questa intera, dolorosissima e vergognosa
pagina della nostra storia.
Si è già detto – e qui si ripete – che Gheddafi fu l’unico a non mollare la presa e a
continuare a ricordare all’Italia tutto il male che aveva fatto al suo Paese e a chiederle
almeno il risarcimento dei danni materiali.
I
Complementare all’ipocrisia italiana a proposito delle colpe gravissime del suo
colonialismo è il riconoscimento – oltretutto! - del suo esito fallimentare.
Dopo la conquista dell’Etiopia, quando il programma imperiale italiano emerse
compiutamente in tutti i suoi aspetti, l’Istituto Coloniale Fascista (‘Elementi pratici di
vita coloniale per le organizzazioni femminili del PNF’) disse chiaramente come
dovevano essere gestite le colonie italiane: ‘Per noi ‘colonia’ vuol dire un lembo della
nostra Patria, dove l’opera intelligente e superiore del metropolitano ed il lavoro
dell’indigeno debbono agire concordi pel benessere e la potenza della nazione’.
Nelle sue colonie l’Italia compì così sforzi notevoli e si adoperò con tenacia per la
loro valorizzazione, ma si trattò di una causa persa e sbagliata fin dall’inizio.
L’impossibilità pura e semplice dell’Impero era 1) innanzitutto una banale
questione economica di entrate e di uscite: l’Impero costava troppo più di quel che
rendeva e che avrebbe mai potuto rendere e dissanguava la madrepatria; oltretutto
non vennero mai trovate risorse minerarie di un qualche rilievo mentre l’agricoltura,
pur se furono create aziende anche di una certa importanza, registrò la scarsissima
presenza di coltivatori italiani così che il progetto di costituire colonie di
popolamento fallì completamente; 2) era poi una ovvia questione politica: non si
poteva ragionevolmente sperare di tenere sottomesse (o di combattere) le popolazioni
autoctone per sempre, né tantomeno di convincerle della bontà della loro condizione
di soggiogate, come pure con grottesco ed autocompiaciuto orgoglio si credette utile
e possibile; 3) era poi un’evidente questione di strategia industriale: nel XX secolo
63
era ben più remunerativo investire per eccellere o comunque avanzare in campo
tecnologico piuttosto che per elevare un territorio ancora industrialmente del tutto
arretrato col concretissimo rischio di venir superati mentre ci si ostinava a spendere in
modo tanto meno produttivo; 4) era poi una semplice questione morale: il
colonialismo imponeva e presupponeva valori antitetici a quelli professati
ufficialmente dalle società europee, anche se su questo punto bisogna però
riconoscere che il fascismo fu almeno coerente perché cercò di cambiare questi valori
anziché vivere di doppiezze e di ipocrisie, di silenzi e di autoassoluzioni, come
avevano fatto i suoi predecessori liberali e come spesso avrebbero fatto i suoi
successori democratici.
L’Impero fascista fu insomma sbagliato e fallimentare fin dall’inizio e nella sua
concezione stessa: la guerra persa non fece altro che accelerarne la fine,
risparmiando così all’Italia di dover affrontare e sostenere le guerre di
liberazione nazionale (che ad esempio avrebbero invece impegnato ed esaurito
Francia e Inghilterra).
Anche per questo per l’Italia fu vantaggioso aver perso la guerra (!!!): non solo si
liberò così del fascismo e rinacque democratica, ma la sconfitta risolse anche il
problema del fardello coloniale che altrimenti l’avrebbe affaticata ed azzoppata per
chissà quanto altro tempo ancora.
Che assurdo e terribile paradosso! Si sparse tanto sangue e si causarono tante
sofferenze, si distrusse e si lavorò tanto … per rimetterci sempre e comunque (!!!)
visto che l’unico affare l’Italia lo fece solo quando finalmente venne sbarazzata delle
sue colonie!!!
Nonostante il dramma e il dolore senza fine sembra davvero che la miglior critica e il
giudizio più sensato sul colonialismo italiano sia una incredula, per quanto
amarissima, risata in faccia a chi lo volle con tanta convinzione.
64
Appendice
Piccolo colonialismo italiano in Cina
Alla fine dell’Ottocento l’Italia cercò di organizzare una sua penetrazione coloniale
anche in Cina: l’Impero di Mezzo allora si dibatteva in una grave crisi che le sconfitte
nelle due ‘guerre dell’oppio’ - la prima (1839-42) contro l’Inghilterra e la seconda
(1856-60) contro la Francia e l’Inghilterra - e quella contro il Giappone (1894-95)
avevano messo impietosamente a nudo.
Dopo ogni sconfitta la Cina aveva dovuto cedere territori, riconoscere concessioni,
garantire interessi e piegarsi ai vincitori ed ai loro alleati, tanto che si diceva che
veniva ‘affettata come un melone’: anche l’Italia cercò allora di ritagliarsi una fettina
del ricco bottino.
Nell’ottobre 1898, confidando sull’appoggio diplomatico inglese, presentò così al
governo cinese la richiesta di affitto per 40mila dollari della baia di San Mun (poco
meno di 300 km. a sud di Shangai) nella provincia di Chekiang ed il riconoscimento
dell’influenza italiana sul resto della provincia, ma il momento scelto non poteva
essere più sbagliato: a parte il fatto che l’Inghilterra appoggiava solo la richiesta sulla
baia di San Mun e non l’espansione nell’interno, ormai nella Cina umiliata e
calpestata dominava il risentimento, la voglia di riscossa e la xenofobia che proprio
nel 1898 stavano montando pericolosamente e che ben presto avrebbero fatto
scoppiare la famosa rivolta dei Boxers.
La Cina si era insomma decisa a resistere ad ogni ulteriore pretesa delle Potenze
straniere e respinse seccamente la richiesta italiana: offesa e scossa nel suo amor
proprio (tre anni dopo Adua!), il 10 marzo 1899 l’Italia lanciò addirittura un
ultimatum e inviò nel Mar Giallo una divisione navale per occupare, se necessario
con la forza, la baia di San Mun.
La mossa ebbe conseguenze più grosse del previsto perché ‘Nell’incubazione del
movimento dei Boxers, l’ultimatum dell’Italia … fu l’ultima goccia che fece
traboccare il vaso’ (Luigi Goglia e Fabio Grassi: ‘Il colonialismo italiano da Adua
all’Impero’) e la Cina, che potè contare sulla decisa opposizione inglese
all’intimazione italiana, fu in grado di respingere anche l’ultimatum.
Pur bloccata per due volte, l’Italia non aveva però rinunciato ai suoi obiettivi, come
fu presto evidente.
I
L’Italia colse l’occasione per rimettersi in gioco in Cina partecipando infatti alla
spedizione internazionale per sedare la rivolta nazionalista, xenofoba e anticoloniale
dei Boxers, il cui momento culminante fu il famoso assedio di 55 giorni delle
legazioni straniere a Pechino: il 19 luglio 1900 salpò così da Napoli un contingente di
duemila uomini e di sei navi che, anche se entrò raramente in azione (le perdite
65
furono una trentina di soldati di cui solo diciotto in combattimento), permise
comunque all’Italia di sedere al tavolo dei vincitori.
Il conto presentato dai diplomatici occidentali ai plenipotenziari cinesi il 22 dicembre
1900 conteneva la (solita) richiesta dei colonialisti, la concessione cioè di basi e di
porzioni di territorio per potervi esercitare a proprio piacimento il commercio e tutte
le attività economiche connesse: cinque giorni dopo la richiesta degli occidentali non
potè che essere accettata, anche se la firma ufficiale del Protocollo di Pace (sic)
avvenne solo il 7 settembre 1901.
Il punto saliente del Protocollo era l’art. IX che stabiliva che ‘Il Governo cinese ha
riconosciuto alle Potenze … il diritto di occupare alcuni punti, da definire tramite un
accordo fra di loro, per mantenere le comunicazioni libere tra la capitale e il mare’ - e
nell’elenco di questi ‘punti’ (tredici in totale) c’era anche Tianjin (oggi Tientsin):
insomma: tutte le Potenze che avevano partecipato alla missione contro i Boxers si
accordarono fra loro per spartirsi porzioni di territorio cinese e poi avviarono
trattative con la Cina - che non poteva certo negarle – per ottenerle in forma ufficiale.
Il 12 marzo 1902 venne raggiunto l’accordo definitivo e l’Italia ottenne la sua
concessione a Tianjin che comunque aveva già occupato da qualche mese, visto che
quelle che contavano veramente erano le decisioni che le Potenze prendevano fra loro
e che poi imponevano al governo cinese.
La concessione italiana a Tianjin si estendeva su un’area di ½ kmq. scarso (447.647
mq.), fra le nove straniere presenti in città era più grande solo di quella del Belgio, si
trovava nella zona più povera e malsana della città e vi risiedevano allora appena
sedici italiani: i suoi esordi furono stentati tanto che dieci anni dopo gli italiani
residenti erano saliti solo a ventisei.
66
II
Dal 1912 la concessione cominciò però a svilupparsi da tutti i punti di vista (anche
urbanistico e architettonico) e divenne una vetrina che assicurò all’Italia anche un
certo prestigio a livello internazionale.
Anche se alla fine della prima guerra mondiale la Cina nazionalista cominciò a
mettere in discussione le concessioni straniere e a chiedere l’abolizione della loro
extraterritorialità, le Potenze riuscirono comunque a tergiversare e a rimandare ogni
decisione in merito, affermando che la disorganizzazione interna del Paese non
permetteva ancora di abbandonare tutti quei privilegi di cui esse avevano goduto fino
a quel momento.
L’Italia in particolare sosteneva poi che la sua concessione era un esempio di
‘colonialismo benevolo’, impegnato cioè a portare migliorie e progresso nel Paese e
insomma a fargli solo del bene: non sorprendentemente, fu naturalmente il fascismo
che insistette su questa supposta opera meritoria della presenza italiana in Cina, ma in
fondo era questa la pretesa e la giustificazione di tutti i colonialisti, sempre convinti
della superiorità della loro civiltà e della necessità storica di diffonderla – a
qualunque costo - in ogni angolo del globo.
Il colonialismo italiano in Cina fu comunque completamente diverso da quello
africano: l’esistenza in Cina di uno stato (per quanto in crisi), la distanza dalla
madrepatria e la presenza delle altre Potenze, ben più affermate e sviluppate,
permisero all’Italia di ottenere solo una concessione su un’area ridottissima: parlare
di colonia di popolamento e/o di meta dell’emigrazione sarebbe stato poi
semplicemente assurdo e impensabile.
Tianjin fu solo una base commerciale e la sede per la rappresentanza, l’assistenza, il
monitoraggio e la comunicazione degli interessi economici estremamente limitati
della madrepatria nel Paese: nel 1936, nel momento del massimo sviluppo della
concessione, la sua popolazione complessiva era di 7.954 residenti di cui 394 erano
italiani e 146 europei.
III
In Asia quella che sarebbe diventata la seconda guerra mondiale cominciò il 7 luglio
1937 con l’invasione giapponese della Cina: già alla fine del mese sia Pechino che
Tianjin erano cadute sotto il controllo dell’Impero del Sol Levante, ma l’Italia riuscì a
non subire conseguenze negative di tali eventi perché era alleata della Germania
(nell’Asse Roma-Berlino del 24 ottobre 1936), a sua volta alleata del Giappone (nel
Patto Anti-Komintern del 25 novembre 1936), e infine perché il 6 novembre 1937
aderì lei stessa al patto Anti-Komintern.
Insomma: la concessione italiana di Tianjin era ora in qualche modo riparata e
protetta nella zona di influenza dell’alleato giapponese.
L’attacco tedesco all’URSS (22 giugno 1941) interruppe però la Transiberiana, la
principale via di comunicazione degli italiani di Tianjin con la madrepatria,
isolandoli ulteriormente e rendendo più precaria la loro posizione.
67
All’inizio del 1943 il Giappone occupò direttamente Tianjin e questa occupazione
rese nulle le richieste del governo nazionalista cinese di Chiang Kai-shek che, entrato
il 9 gennaio 1943 in guerra anche contro l’Asse, subito iniziò anche la ‘battaglia delle
concessioni’ chiedendo ai suoi alleati occidentali di rinunciare a tutti i patti, trattati,
diritti di extraterritorialità e concessioni che fin dall’Ottocento erano stati estorti alla
Cina con la forza.
L’8 settembre 1943 terremotò infine anche la concessione italiana di Tianjin: gli
italiani, che fino a quel momento avevano goduto dei vantaggi dell’immunità e
dell’extraterritorialità, vennero immediatamente privati di ogni diritto e protezione,
spesso derubati e imprigionati.
In seguito alla nascita della Repubblica Sociale Italiana (23 settembre) i militari e i
civili italiani a Tianjin dovettero scegliere se aderire alla RSI o porsi dalla parte del re
(e finire ai lavori forzati nei terribili lager giapponesi): non c’è da stupirsi se
praticamente tutti si pronunciarono a favore della RSI, ma era comunque evidente che
la presenza coloniale italiana a Tianjin era arrivata al capolinea.
Fedeli al loro slogan ‘l’Asia agli asiatici’ (cioè a loro stessi) anche i giapponesi
avversavano infatti ogni forma di colonialismo occidentale in Asia e il 14 luglio 1944
fecero così firmare alla RSI e al governo collaborazionista di Nanchino la revoca
della concessione a partire dal 27 dello stesso mese.
Abbandonati a loro stessi e senza più alcuna protezione, quegli italiani che non erano
stati rimpatriati si trovarono in balìa degli eventi e dovettero affrontare prove
durissime fra cui l’internamento negli orrendi campi di prigionia giapponesi: ancora
una volta l’inesorabile ruota della storia schiacciava chi anche senza colpa si trovava
sul suo cammino.
Terminata finalmente la guerra, fra le numerosissime clausole del Trattato di Parigi
(10 febbraio 1947) ci fu anche quella che sanciva la definitiva restituzione della
concessione di Tianjin alla Cina, infimo e trascurabile dettaglio perso nelle pieghe
della vasta e complessa risistemazione dell’intero assetto internazionale.
La maggior parte degli italiani venne rimpatriata e quei pochi che scelsero di restare
dovettero frettolosamente seguirli quando Mao vinse la guerra civile e fondò la
Repubblica Popolare Cinese (1 ottobre 1949).
Oggi nell’ex-concessione non risiede più nessun italiano anche se ogni tanto qualche
viaggiatore o qualche giornalista ammira ancora gli edifici costruiti dagli italiani,
ultima testimonianza di questa piccola pagina di una piccola storia in un luogo tanto
remoto e lontano.
Sottomarina 18 giugno 2016