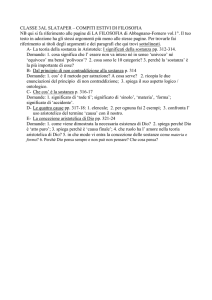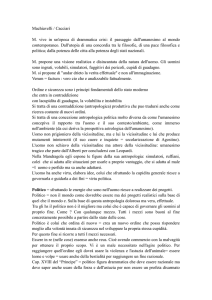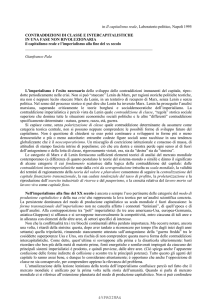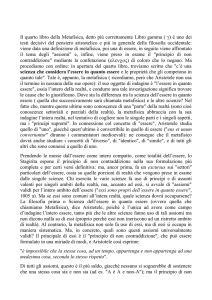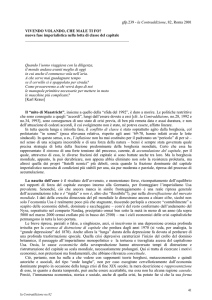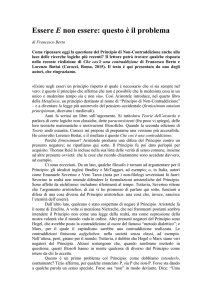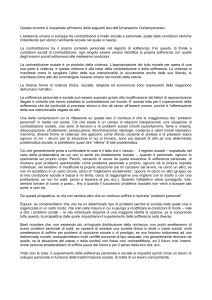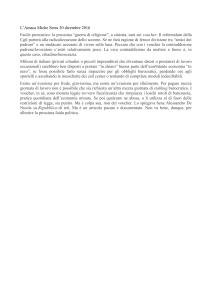gfp.219 - la Contraddizione, 73, Roma 1999
STATISOVRASTATI
riferimenti in margine a un convegno su marxismo e istituzioni
__________________________________________________
Si è tenuto a Roma, sabato 26 giugno 1999, presso la Casa delle culture, il convegno “Statisovrastati Marxismo e istituzioni”, organizzato dalla Rete dei comunisti. Hanno partecipato, in forma discorsiva di
discussione seminariale e confronto, Vincenzo Accattatis, Guglielmo Carchedi, Mauro Casadio, Andrea
Catone, Luigi Cortesi, Salvatore d’Albergo, Carla Filosa, Roberto Fineschi, Stefano Garroni, Alessandro
Mazzone, Gianfranco Pala; sono intervenuti Umberto Calamita e Guglielmo Musso; ha coordinato Sergio
Cararo. [Roberto Galtieri, Domenico Losurdo, Malcolm Sylvers e Maria Turchetto hanno aderito ma non
sono poi potuti intervenire]. Dedichiamo la riflessione a Gianfranco Ciabatti, che fin dal no.0 della rivista (e
anche prima) si impegnò per affrontare a fondo questo tema.
Col presente resoconto redazionale (che non coinvolge la responsabilità diretta degli intervenuti), si
vogliono solo dare alcuni riferimenti generali e preliminari delle tematiche affrontate. Questo resoconto non
pretende completezza e sarà perciò sicuramente insufficiente. Ma serve per rinviare successivamente i lettori
al volume [per le edizioni La Città del Sole di Napoli] che in autunno raccoglierà gli interventi scritti dei
partecipanti (non propriamente gli “atti” del convegno, di difficile utilizzabilità immediata, dato il ricordato
carattere discorsivo dell’incontro).
La discussione prende le mosse dalla preliminare individuazione di cinque punti, tra loro strettamente
interconnessi: i. l’approfondimento della contraddizione tra stato e società civile - e dunque anche della
reciproca rispondenza (pure formale, dal suffragio universale al maggioritario); ii. la trasformazione del
rapporto tra classi e stato - lo stato di classe, col governo “comitato d’affari” della borghesia, di contro allo
stato universale, con le sue mistificazioni di “stato sociale” e di “democrazia”; iii. lo spostamento delle
decisioni al livello sovrastatuale e sovranazionale (Fmi, Nato, Ue, ecc.) - in contraddizione con la sovranità
nazionale, e dunque sempre più con perdita di democrazia; iv. l’accentuazione del carattere coercitivo delle
istituzioni - epperò nelle sembianze formalmente consensuali e falsamente garantiste del neocorporativismo;
v. la contraddizione della disgregazione statuale col ricorso a violenza e guerra - di fronte all’esigenza
imperialistica di “stabilità” nel contrasto crescente tra mercato mondiale e stati nazionali, a esso resi
conformi e funzionali.
Codeste tematiche rimandano, per un dibattito marxista che pretenda di essere scientificamente tale, ai
fondamenti della teoria dello stato. Il rapporto tra classi e stato impone una concezione dello stato come
organizzazione di classe e del dominio di classe, laddove la forma organizzata del potere e della violenza
(controllo e repressione militare e giudiziaria) pone i rapporti di proprietà come fondamento del potere, del
diritto, delle istituzioni e dello stato stesso. Lo stato capitalistico si rappresenta dunque storicamente come
coercizione di classe, dittatura della borghesia, in contrapposizione all’idea dello stato universale, di tutti i
cittadini, mettendo in evidenza l’antiteticità tra il concetto di classe e la figura di cittadino. La funzione dello
stato borghese si distacca, perciò, dalla sua figura universale per la necessità di mediazione interna alle
componenti della classe dominante, e non tra le classi. In codesta funzione, la corrispondenza storica delle
forme dello stato nazionale alle forme del capitale è tale da non annullare, bensì trasformare, la forma di
stato nazionale, attraverso il suo adeguamento alla fase sovranazionale del capitalismo imperialistico. Precisamente in tale adeguamento si pone la duplicità di forma degli stati nazionali, dominante in continuo
accentramento e dominato in via di disgregazione; a siffatto processo rispondono perciò, specificamente, le
forme sovrastatuali delle istituzioni sovranazionali.
Sulla base di questi fondamenti teorici, le forme della democrazia storicamente determinate mostrano
quale sia, di fatto, l’equivalenza del problema della democrazia e di quello dello stato (per dirla con Lenin),
attraverso le diverse interpretazioni storiche e teoriche di democrazia; del resto, è evidente anche la
contraddizione in termini di “democrazia borghese”, capace con un’aggettivazione che limita il potere a una
classe minoritaria di annullarne la generalità popolare. Il potere della borghesia capitalistica e le sue
corrispondenti forme statuali e sovrastatuali adatta l’immagine della propria dittatura di classe all’assetto
delle istituzioni formalmente democratiche. Sicché la questione democratica si mostra nelle forme della
rappresentanza politica, e la “repubblica democratica” (secondo l’insegnamento di Marx e Engels) segue il
contraddittorio percorso storico del suffragio universale, fino alla sua vanificazione: il sistema parlamentare
&%PAGINA&
ed elettorale, sotto i colpi della centralizzazione monopolistica finanziaria del dominio imperialistico, scivola
dal voto di censo al maggioritario e svuota i parlamenti, col sostegno del “cretinismo parlamentare”
dell’asinistra.
Il problema delle istituzioni, pertanto, lungi dal poter essere espunto dalla riflessione e dalla lotta relativa
alla riproduzione e trasformazione dei rapporti sociali - rapporti sociali di produzione, in primo luogo - ne è
parte integrante a tutti gli effetti sostanziali e di contenuto. La tendenziale supremazia dell’esecutivo sul
legislativo e il giudiziario, e la pratica della repressione democratica nello stato di diritto, al pari dei
referendum come forma di cattura plebiscitaria, passiva e qualunquista, reazionaria di massa - una “nuova
plebe” costituita in antitesi al riconoscimento di classe - sono la precisa raffigurazione del ruolo moderno
delle istituzioni della borghesia capitalistica. Di qui, è possibile individuare quali siano le diverse forme della
rappresentanza di classe: da un lato, il governo e tutto l’apparato racchiuso nel formalismo parlamentare si
configurano agevolmente come organizzazione istituzionale diretta delle diverse frazioni della classe
dominante nel potere statuale; dall’altro, il partito, nelle sue mutevoli determinazioni storiche, non serve in
quanto tale alle classi proprietarie ma può porsi unicamente come forma di opposizione organizzata delle
classi lavoratrici, non già come opzione ma come loro espressione soggettiva in quanto riflesso
oggettivamente necessario dei rapporti di proprietà e potere [non per caso la revocabilità è principio di
base peculiare della rappresentanza proletaria].
La specificità storica delle funzioni economiche dello stato borghese, nelle società in cui predomina il
modo di produzione capitalistico, è quindi la tematica che sorge nell’epoca moderna per la difesa di classe violenta fino alla forma armata - della proprietà privata delle condizioni oggettive della produzione,
configurando in tal modo i nuovi compiti statuali. Il superamento dalla mera esazione fiscale ed erogazione
di spesa istituzionale (beni pubblici, militare, giustizia) segue l’adeguamento crescente alle forme di funzione
del capitale. Sicché, mentre vi è il mantenimento diretto da parte del capitale delle prevalenti funzioni
produttive e mercantili, lo stato nazionale, prima, e le istituzioni sovrastatuali, poi, sono chiamati in causa in
relazione alla forma di funzione nella metamorfosi del capitale monetario. L’identificazione della peculiarità
monetaria, quindi, assegna allo stato e alle istituzioni come ruolo economico principale quello adeguato al
compimento di tale ciclo di metamorfosi.
L’assunzione storica delle funzioni di controllo della moneta (banca centrale e debito pubblico) sono il
segno impresso dal denaro capitale, e la gestione “pubblica” della moneta ne è la figura di controllo
capitalistico, del denaro in quanto capitale nella circolazione del plusvalore. L’amplificazione della funzione
monetaria dello stato nello sviluppo monopolistico finanziario transnazionale del capitale conduce
all’estensione di tale funzione agli organismi sovrastatuali, a carattere prevalentemente monetario (Fmi, Bm,
Bri, Bce-Maastricht). In questo senso, le funzioni monetarie statuali e sovrastatuali sono - e altro non possono essere - le intrinseche e necessarie conseguenze della mediazione interborghese: mai possono divenirne
cause prime, e perciò esse ne costituiscono la parvenza fenomenica “che abbaglia l’occhio”, e che confonde.
Nel generale processo di trasformazione del rapporto funzionale tra capitale, stato e istituzioni, il
neocorporativismo può essere inteso come tendenza universale nella fase dell’imperialismo transnazionale
in tutto il mercato mondiale - in una forma consensualmente coatta del potere di classe che l’ideologia
geopolitica e sociologica della “globalizzazione” prova a nascondere. Infatti, le differenti articolazioni e
forme di esistenza del sistema neocorporativo del cosiddetto “nuovo ordine mondiale” si estrinsecano
attraverso la diversa posizione gerarchica degli stati, dominanti e dominati, secondo i rapporti di classe che
mediante essi si impongono appunto su scala mondiale.
Il neocorporativismo ha ormai portata mondiale - e non come semplice propaganda - bensì con la sua
capacità di imporre la coesistenza e la cooperazione nella stabilità imperialistica del “nuovo ordine”, con la
guerra e con la pace, con la guerra fredda e con la pace armata. Il fondamento di tutto ciò sta nella crisi
irrisolta del capitalismo monopolistico finanziario, che cerca di recuperare, insieme all’appropriazione di
plusvalore, il controllo sulla scienza e il comando politico. Il processo di accumulazione su scala mondiale,
al quale guarda il neocorporativismo sovranazionale, deve oggi attraversare ancòra un lungo processo di
distruzione e ricostruzione del capitale. Le guerre servono anche, se non soprattutto, a questo; e, abbassando
le generali condizioni di vita delle popolazioni coinvolte, distruggono anche la parte variabile del capitale in
eccesso, attraverso la riduzione del salario sociale - in misure e forme diverse - sia nei paesi deboli
disgregati e sconfitti sia in quelli imperialisti dominanti (l’esperienza pilota del fascismo sul taglio dei salari
è esemplare). Con la crisi di lavoro lo “stato sociale” non serve più per il capitale all’interno degli stati
nazionali, e l’oppressione delle masse è il segno che le classi lavoratrici sono sconfitte ovunque. Nel
neocorporativismo mondiale si può riconoscere oggi il fascismo senza “camicia nera”, senza personaggi da
operetta, ma piuttosto celato dietro le forme “umanitarie” di un mercato tanto della pace quanto della guerra.
Ma l’unificazione del mercato mondiale è una necessità economica e politica del neocorporativismo
transnazionale - non è un’opzione ideologica - per tentare di risolvere la crisi di accumulazione. Entro tale
processo diminuisce vieppiù la riconoscibilità nazionale, attraverso la funzionalità universale della
flessibilità nel comando sul lavoro, della concertazione dettata dall’organizzazione di classe proprietaria, e
la Contraddizione no. 73
&%pag
della conseguente stabilità economica, sociale e politica: il tutto è servito in tavola con sparizione del nemico
e insieme a esso della conflittualità. Il comando internazionale di classe passa negli organismi sovrastatuali
ed è delegato agli stati nazionali (o magari a loro organismi specifici, come la banca centrale più che il
governo - la Fed più che Clinton) per carpire il consenso coatto sulla politica economica e sulla gerarchia
interstatuale, anche sul piano militare condiviso dall’“approvazione” delle masse.
La complessiva strutturazione del sistema neocorporativo, pertanto, passa dalle sue forme materiali
(rapporti di produzione), a quelle istituzionali (di tipo statuale) e ideologiche. In tal senso, è importante
seguire la dinamica del processo di corrispondenza storica delle forme del capitale e del potere - ossia del
loro omomorfismo. Dalle precedenti figure dello stato liberale, rispondente alle esigenze dello sviluppo del
capitale concorrenziale (dopo la fase della cosiddetta “accumulazione originaria”, durante la quale anche le
istituzioni dello stato erano solo formalmente sussunte da quelle assolutiste del passato prossimo), il capitale
monopolistico finanziario ha messo in movimento un lungo processo di trasformazioni istituzionali per
giungere a una nuova fase di sottomissione reale dello stato, ormai inadeguato come “stato di diritto” nelle
vesti liberaldemocratiche cucitegli addosso dal liberoscambismo nella fase precedente di sottomissione reale
dell’epoca della prima rivoluzione industriale.
Nel riassetto delle istituzioni statuali, la forma stato contemporanea opera come riflesso del capitale
monopolistico finanziario transnazionale che l’informa di sé, con la medesima simultaneità di
accentramento forte (operatività decisionistica dell’esecutivo) accompagnato da un decentramento diffuso,
“modello” mutuato dall’organizzazione della holding (avocazione assolutistica del processo decisionale
strategico presso l’impresa madre; parvenza del decentramento “partecipativo” a unità produttive di
dimensioni ridotte, con dislocazione, esternalizzazione, “filiera”, “impresa-rete” ecc.). Siffatto omomorfismo
tra capitale e istituzioni, tra microstrutture aziendali e macrostrutture statuali e sovrastatuali (corrispondenza
“formalmente formale” - minoranze che comandano grazie a sistemi maggioritari, decentramenti operativi
federati sotto il controllo centralizzato delle strutture decisionali e del “presidente” dell’organismo di potere,
ecc.), si estende sistematicamente: significativo è l’esempio di qualsiasi “banca centrale”, formalmente
separata dal governo nazionale, la quale, attraverso il “governo della moneta”, è l’anello di congiunzione
superiore degli apparati di governo (centrale e locali) con gli omologhi organismi sovrastatuali, a loro volta
espressione politica del grande capitale finanziario transnazionale.
La metamorfosi degli stati nazionali segna questo nuovo passaggio - dalla fase di sottomissione formale
della vecchia configurazione istituzionale (quella liberista concorrenziale) alla fase monopolistica finanziaria
transnazionale di sottomissione reale di stati e nazioni alla gerarchia del nuovo ordine mondiale - in una
forma duplice: l’una dominante coesa, l’altra dominata e disgregata; due modelli di stato, attraverso la
disgregazione delle vecchie formazioni nazionali nelle zone oggetto delle reciproche contese
interimperialistiche tra gli stati forti per il loro espansionismo (rete bellica di scontri per il dissolvimento
istituzionale, politico e sociale delle regioni mondiali colpite, con la mistificazione di autonomie
subnazionali e regionali, territoriali ed etniche o religiose).
L’odierna fase - dove il “anche diritto del più forte è un diritto, e il diritto del più forte continua a vivere
sotto altra forma anche nel loro stato di diritto” (per dirla con Marx), come diritto delle classi dei grandi
proprietari - impone oggettivamente, come si precisa nel prosieguo del dibattito, la costruzione di binomi
quali centralizzazione produttiva ed esecutivo presidenzialistico, controllo di minoranza dei “pacchetti di
sindacato azionario” e sistema maggioritario, decentramento produttivo e federalismo amministrativo, joint
venture, opa e amministrazioni controllate (“protettorati” imperialistici) di sottostati disgregati, ecc. Sicché
gli elementi del neocorporativismo possano mostrarsi oggi apertamente nelle forme statuali, non più come
arbitrio dispotico (che rimane di riserva, all’occorrenza), bensì come “democrazia autoritaria”, falsamente
partecipata ma realmente tirannica; così, siffatto dominio neocorporativo, nelle ricordate forme del consenso
coatto, appare condiviso e partecipato anche nella repressione mirata e selettiva. Per questa via, nel rapporto
tra società civile e stato, che all’inizio si è detto appunto essere contraddittorio, alla divaricazione reale il
neocorporativismo sovrappone codesta corrispondenza estraniata, appunto quale contraddizione in processo
[la storia dello “stato sociale”, nel processo di adeguamento della società al capitale e di mistificazione di
forme mutuate di “socialismo” dal capitale, può essere proficuamente letta in questa prospettiva].
I 150 anni trascorsi dal Manifesto del partito comunista (e quella è stata l’occasione originaria per il
presente dibattito) offrono il materiale storico reale per convalidare l’attualità dei concetti là formulati, e allo
stesso tempo per indagare, sulla base da essi rappresentata, le nuove caratteristiche (politiche sociali
economiche) assunte dallo stato e dalle istituzioni sovrastatuali nella fase dell’imperialismo transnazionale. I
riferimenti qui proposti considerano il dibattito sullo stato - capace di superare le “specializzazioni”
disciplinari - come premessa necessaria per un approfondimento, sia scientifico che politico, della
comprensione dei processi nazionali e internazionali, che non sono necessariamente corrispondenti, costretti
come sono a operare in condizioni determinate.
&%PAGINA&
Per fondare categorialmente la teoria dello stato - nel puro concetto stesso di “stato”, come espressione
della volontà interindividuale, laddove gli individui diventano soggetti - si può trovare nella teoria hegeliana,
che Marx ha ereditato, la soluzione del problema di Rousseau: ma già in Hegel è possibile rintracciare le
classi. Lo stato moderno si presenta concettualmente come corpo collettivo, soggetto alla volontà universale.
Senonché, con Marx, diviene esplicito, nello stato e nella società civile, il rapporto tra le classi - come modo
di esistenza delle forze produttive e come egemonia, in senso proprio - che, nella dittatura della borghesia in
quanto egemonia di classe nelle cui forme si riproducono i rapporti sociali capitalistici, vanifica ogni
dimensione universalistica, etica e ideale, del concetto di stato.
Muovendo dalla definizione marxista di stato nel modo di produzione capitalistico - lo stato borghese
come stato del capitale, senza altre specificazioni quali democratico, sociale, libero, costituzionale, ecc.,
inutili orpelli incapaci di modificarne il predicato di “borghese” - la supponente sua socialità universalistica
si capovolge nel carattere di classe dello stato borghese separato e sovrimposto alla società civile. Sicché l’estensione dei “servizi sociali” a tutti i “cittadini” è parte dell’equivoco del supposto universalismo dello stato
(sociale). Nella fase dell’imperialismo transnazionale si sovrappone un’altra metafora di “universalismo”,
data dal carattere sovrastatuale delle istituzioni sovranazionali di classe gestite da quell’aggregato spurio
costituito dalla grande borghesia monopolistica finanziaria; tanto spurio e astorico che essa è costretta a
un’autorappresentazione, ma in nome dell’universalità dell’umanità, contro tutti gli “altri da sé”: il vero
nemico mondiale della borghesia imperialistica rimane sempre il proletariato di tutti i paesi, con le
popolazioni di cui esso è parte. Agli stati forti e ai loro organismi sovrastatuali non occorre più invocare la
“patria”: per un capitale la cui patria è il mondo intero, basta il richiamo alla solidarietà intorno ai diritti
umanitari, occultando la contraddizione posta nell’antagonismo sociale e nella lotta di classe.
Sul rapporto tra stato e società civile, diverse sono state le interpretazioni del marxismo; se, da un lato, la
storia dei movimenti comunisti offre importanti indicazioni, dall’altro, le basi teoriche delle opere di Marx e
Engels meritano un più preciso e attento riferimento, in quanto i messaggi non possono passare traducendo
analisi scientifiche in parole d’ordine. In Italia, a es., la lettura datane da Gramsci, su entrambi i piani,
conduce allo snodo teorico del confronto con Bordiga; per altri versi, ad altro livello, è significativo il
passaggio da Lenin a Stalin. I molti equivoci della tradizione gramsciana - fino a quella che, nel gramscismo
togliattiano, secondo alcune letture critiche è una “strozzatura” del marxismo - hanno condotto al
riassorbimento del partito comunista nello stato. In questo senso, il percorso del comunismo italiano entro le
istituzioni può essere di insegnamento, prima di cercare affrettatamente nuove scappatoie, se utilizzato come
“modello di laboratorio” per spiegarne la decadenza - fino alla morte del Pci: ma, contro ogni
provincialismo, va detto che alla proposta comunista non è affatto mancato un radicamento storico.
Cionondimeno, in Italia quel poco di democrazia (e la sua stessa parvenza) che c’è è stata conquistata dal
movimento operaio con le lotte di quattro generazioni: lotte che hanno seguìto il ciclo di accumulazione,
ottenendo concessioni parziali sulla spesa sociale, con bruschi tagli e strette autoritarie in concomitanza con
le fasi di crisi.
L’esperienza del comunismo italiano, da Bordiga e Gramsci al togliattismo, presenta problemi di storia
che sono fondamentali e seri: e non tanto come riflessione sull’azione politica, quanto come questione
teorica, ossia come ulteriore indagine concettuale [se si vuol dar credito alla convinzione di Marx che il
proletariato fosse l’erede della filosofia classica tedesca]. In una fase “non rivoluzionaria” come l’attuale, le
scelte politiche e culturali rimandano perciò alla rappresentanza di classe, fino alla questione
dell’internazionalismo proletario.
Ma nello spostamento di peso dall’elemento strutturale a quello sovrastrutturale, si può equivocare sul
processo di presa di potere che, secondo Marx, ha motivazioni oggettive economiche e solide basi
materiali, non potendosi cioè ridurre a mera egemonia politica e ideologica. Il rapporto tra struttura e
sovrastruttura, infatti, è anzitutto categoriale e va seguìto nel suo processo di costruzione, come Marx fa
nel Capitale in quanto teoria della società, e della riproduzione pratica di questa nelle classi e nello stato:
da lì occorre partire.
Prevale, tuttavia, nell’effettualità storica la falsa coscienza comune del superstizioso idealismo e
formalismo dello stato (Marx), che pretende di indicare lo stato stesso come super partes: da qui proprio il
neocorporativismo è diventato patrimonio ideologico dell’asinistra, fino a presentarsi, per mascherare
l’autoritarismo col consenso coatto, come trasfigurazione mutuata dal socialismo [è sia il caso poliedrico
dello “stato sociale”, sia soprattutto quello del fascismo, parto degenere del socialismo massimalista, ma
anche forse delle forme paternalistiche, retoriche e assitenzialiste, del realsocialismo burocratizzato].
Se lo “stato ideale” di Rousseau non c’è, rimane solo la coercizione di classe del presente, al più
mascherata col consenso plebiscitario che - proprio col “corporativismo” - conferisce una falsa immagine di
sé come “corpo collettivo”. In realtà c’è lo smembramento dello stesso stato di diritto, in una soffusa
invisibilità del processo in atto, mediante la disgregazione della coscienza di classe e l’azzeramento della
mediazione della soggettività (per sé), lasciando operare solo la mera oggettività della classe (in sé) incapace
di darsi un’organizzazione. Sicché, col neocorporativismo - con l’imbrigliamento della volontà e il dominio
la Contraddizione no. 73
&%pag
ideologico - l’azzeramento dell’antagonismo provoca la fine del conflitto di classe nell’azione soggettiva del
proletariato, ma non nella realtà.
Le forme storiche dell’imperialismo contemporaneo connesse all’irrisolta crisi da sovraproduzione (di
merci e di capitali, inclusi gli uomini come forza-lavoro ridotti a “neoplebe”) si mostrano come tirannide che è la “verità” di una “democrazia” che non esiste, né in Italia né altrove nel mondo in cui predomina il
modo di produzione capitalistico - esercitata da una borghesia transnazionale (che non è classe egemone,
come furono le borghesie storiche) in una forma che fa leva sullo squilibrio tra processo mondiale di
integrazione reale e svuotamento della politica, fino nelle diaspore del localismo etnicistico, senza lasciare
spazio inutile alle illusioni.
Nel processo che va dal plebiscito ai referendum, ci si chiede in quale “democrazia” viviamo: una falsa
democrazia che riscopre il bonapartismo delle lobbies, perfino nella corruzione della mitica Svizzera. L’equivoco della democrazia diretta è sbandierato dal populismo che, attraverso azioni come quelle di Pannella &
Bonino, punta all’affermazione del leader carismatico - uno scivoloso “unto del signore” come vorrebbe
essere Berlusconi che, in stile fascistico, dice: “col cuore sono sociale” - per il controllo del potere, e grazie a
esso dei mezzi di comunicazione e dell’ideologia. Infatti, il problema sta nel contrasto tra rappresentazione
della realtà e realtà stessa, sicché il compito teorico politico comunista è nell’essere all’altezza di saper
cogliere quel contrasto, dato che in ultima analisi non sono i mezzi di comunicazione che dànno il potere, ma
questo che permette l’uso di quelli (il monopolio tv è esercitato in violazione della sentenza formale della
corte costituzionale).
Ma, approfondendo l’analisi, si capisce che al di là delle vesti da buffone indossate dal ducetto di turno,
ben prima del fascismo il liberalismo (e quello italiano è incluso) si è sempre mostrato autoritario, mutuando
sia il bonapartismo francese sia il bismarckismo tedesco. Infatti, andando da prima a dopo il fascismo,
occorre sottolineare come il codice tuttora vigente in Italia sia di quel periodo, dunque anagraficamente ben
più vecchio della costituzione, che pure è additata come politicamente obsoleta. Sicché i due poli del
liberismo si mostrano chiaramente come stato poliziotto più stato liberale, entrambi però rivolti contro la
critica marxista della proprietà, critica contro la quale soltanto è realmente indirizzato il cosiddetto “pensiero
unico”: cosicché tale oppressione statale permanga anche nelle forme assistenziali e “sociali”. Di fronte a ciò
sta la miseria del tatticismo sulle forme istituzionali e di governo - il decisionismo tradotto in premeriato,
cancellierato, presidenzialismo, ecc.; il parlamentarismo raggirato col neo-parlamentarismo (come il
marxismo col neo-marxismo ...) - che approda, con Schmitt e Tronti, alla pretesa “autonomia del politico”.
La prospettiva giuridica non è un cascame della teoria marxista, se quest’ultima la si vuole considerare
nella sua totalità rispetto all’evoluzione dello stato moderno. Viceversa, una “marxologia” ripiegata su se
stessa, e divisa da esperienze chiuse e divaricate, non sa separare nell’interpretazione la teoria marxista dello
stato dalla concezione borghese dello stato liberale e dello stato di diritto, da cui in definitiva è
completamente catturata. Più in generale, diventa sempre meno di moda “studiare” e sempre più, al
contrario, seguire l’ideologia dell’avversario permeata di irrazionalismo e popolata da “soggetti desideranti”
che accettano le mistificazioni. Sicché, pure la corrispondente teoria del partito (lasciata nelle mani di
intellettuali e accademici) si rabbassa a un esercizio meramente autoreferenziale dei gruppi dirigenti, che al
massimo diventano liberali di seconda mano.
Certo, la critica di Gramsci è stata prevalentemente rivolta contro la cultura borghese, quale
rovesciamento della realtà, anche di quella formale e istituzionale (come nel caso della teoria fascista della
“costituzione materiale” concepita per legittimare la sistematica violazione della carta vigente). La
borghesia, infatti, ha scritto quei pezzi di “carta” proprio per garantirsi e per sancire il suo potere, e li
rispetta solo finché non gli si trasformino in altrettanti vincoli: al che può accadere, come oggi in Italia, che
vengano nominalmente difesi singoli punti della carta costituzionale, epperò nella completa accettazione
della sua generale modifica, in nome di una realtà che l’ha resa obsoleta. Ma una critica culturale,
propriamente detta - come appunto quella gramsciana - non è affatto solo ideologica, come molti
“comunisti” intendono. Allora se, rispetto a Marx, si entra nel merito della critica gramsciana della cultura
borghese, la stessa ideologia appare come il modo in cui gli agenti della produzione esprimono la loro
consapevolezza - o i limiti di essa - in merito alla discrepanza che deriva dal rapporto tra forze produttive e
rapporti di produzione (da intendere, ovviamente, non in senso dogmatico). Purtuttavia, la valenza strutturale
della lettera di Marx è spesso sminuita in molto marxismo politico.
Cionondimeno, la cultura borghese - e quella del diritto ne fa pienamente parte, come quella dell’economia, della storia, ecc. - serve per capire, e criticare, la struttura del potere (forse non per caso la magistratura
si è rivelata essere l’unico spazio di democrazia politica nelle istituzioni). Codesta cultura serve per capire, a
es., il passaggio dal liberalismo al fascismo e al nazismo, oppure il suo apparente percorso inverso fino al
neocorporativismo. La diffusione di tale intelligenza critica può far comprendere al movimento operaio anche contro la falsa sinistra - significato e limiti della democrazia. Solo così, a es. in Europa, si capisce il
significato della supremazia del Consiglio sul parlamento (che non fa leggi), o il senso del governo di
&%PAGINA&
burocrati e giudici della Corte (che fa prevalere la costituzione liberista europea su quella sociale italiana,
annullandola), o ancora la portata dell’“indipendenza” della Bce (i cui dirigenti operano per conto del
capitale finanziario), o infine perché il segretario della Nato aggressiva (Solana, ex “pacifista socialista”) sia
nominato ministro della difesa europea (Pesc).
Soltanto se svolta su tali basi materiali e culturali, l’opposizione al potere borghese non rimane puramente
ideologica; giacché è proprio l’ideologia borghese che ha sue carenze strutturali intrinseche (nel concetto di
“persona”), le quali riflettono il compimento della missione storica del capitale che se, da un lato, non
essendo “uno”, è incapace di autogoverno a causa della sua insopprimibile molteplicità, dall’altro, non può
esso stesso produrre nuovi soggetti come espressione univoca e non contraddittoria del proprio modo di
produzione. Questo è il significato più rilevante della “provvisorietà”, per così dire, dello stato nazionale
nel suo còmpito di mediare gli interessi particolari tra la molteplicità dei centri di decisione capitalistici (la
loro immanente concorrenzialità) attraverso la giurisdizione su un mercato nazionale: ciascuno stato di
contro a ciascun altro, mobilitando tutte le forze “interne” economiche, politiche e militari. Senonché,
appena il capitale aspira a forme sovrastatuali del “governo mondiale” si aggira nella “cattiva infinità” di
un processo di approssimazione empirica a esso (com’è stato per il superimperialismo revisionistico), e per
ciò stesso irraggiungibile.
Perciò, laddove la dimensione nazionale e le forme di aggressione illimitata sono occultate nella
sovrastatualità dell’alternanza dialettica tra pace e guerra, la delegittimazione del diritto internazionale serve
per affermare il diritto dell’arbitrio e della forza, come nuova forma dell’imperialismo transnazionale: la
Nato ne è oggi la rappresentazione più cospicua. L’impotenza delle masse si misura constatando come, al
cospetto di codesto processo involutivo, si riscontrino sempre più appena “opinioni” contrarie, prive di
capacità di controllo.
Si assiste a una esibizione di “faciloneria”, assai pericolosa politicamente, quando si passa dalla
concezione di uno stato che è tutto a quello di uno stato che non c’è più. Del resto, se si ritenesse che non ci
sia decadimento dello stato nazionale, il ricorso alla guerra richiederebbe allora un’altra spiegazione: posto
che la mondializzazione è sempre stata inscritta nel mercato capitalistico - di fronte alle mode ambigue della
“geopolitica” e della “geoeconomia”, caratterizzanti la cosiddetta “globalizzazione”, ideologicamente
costruita per offuscare la categoria di imperialismo - è opportuno considerare lo stato nella sua funzione di
mediazione tra dimensione nazionale e internazionale. Senonché su tale funzione incombe il peso enorme del
rischio di guerra totale con ordigni nucleari.
L’organizzazione della forza dell’imperialismo europeo attua una propria strada, e cerca di trovarla
soprattutto nell’incorporazione militare della Ueo nella Ue. Dal patto originario del 1948 tra Gran Bretagna,
Francia e Benelux per costituire il pilastro europeo difensivo della Nato (ossia degli Usa), contro la
“minaccia” sovietica, qualsiasi crescita d’importanza della Ueo avrebbe significato un indebolimento della
Nato. Cosicché, dissolta l’Urss, gli Usa hanno stretto i tempi per subordinare l’Europa, “nel suo stesso
interesse” e per assolvere a còmpiti “umanitari”, allestendo la trappola di un “imperialismo dal volto umano”, che evita così di essere attaccato se non mostra alla “plebe” la sua chiara aggressività. La recente
aggressione Nato ha questo significato profondo, al di là delle tragiche manifestazioni esteriori, in quanto
processo oggettivo che si riflette sui soggetti reali. E la Nato è la maschera indossata dal governo Usa, per
coprire lo “scandalo biblico” dei bombardamenti con la strumentalizzazione dei “diritti dell’uomo”. Ma
l’Onu, con i suoi silenzi, non è meglio della Nato.
Quindi, da un lato, ciò ha determinato un processo di integrazione e omogenizzazione istituzionale con
effetti di ampia diffusione, dall’altro, ha sempre più acceso in tale processo gli interessi dei singoli stati, in
forme che si cumulano vicendevolmente. Il sommarsi di quei due aspetti ha indotto una crescente
integrazione del mercato europeo, la quale ha le sue radici in un passato (ormai anche abbastanza remoto),
sia per evitare il ripetersi del vecchio protezionismo sia per contenere allora il “pericolo comunista” e
bloccare allo steso tempo il revanchismo espansionista tedesco. Senonché codesto disegno non poteva che
riprodurre su scala allargata le medesime contraddizioni, determinando i caratteri dell’espansionismo
europeo in chiave fortemente protezionistica continentale. Entro le reciproche limitazioni tra Germania e
Francia (fin dall’inizio della “guerra fredda”), il polo imperialistico europeo - nella sua forma storicamente
nuova composta da stati diversi, rappresentati direttamente da grand commis provenienti dall’oligarchia del
capitale finanziario - si è posto in funzione anti-Usa, per concorrere alla suddivisione dei vantaggi dell’intero
sistema imperialistico, in una sorta di joint venture o di opa ostile.
In questo senso non basta e non serve al proletariato mondiale un ruolo antiamericano, nella
contrapposizione tra imperialismo a base Usa e imperialismo a base europea, se si smarrisce il senso di
classe dell’imperialismo tutto. Gli organismi sovrastatuali, pertanto, servono per mediare tra gli interessi
reciprocamente conflittuali dei capitalisti transnazionali e tra questi e i perduranti interessi localistici
“nazionali”, incorporati e rappresentati nei rispettivi stati nel processo di sottomissione reale. La
conflittualità intercapitalistica, attraverso la crisi, nella guerra economica e commerciale, trova la sua
traduzione militare (a opera degli stati forti, entro le mutate forme sovrastatuali) nelle nuove tipologie di
la Contraddizione no. 73
&%pag
guerra armata di “debole intensità” e “alta tecnologia”, diffusa e permanente, sotto il dominio della
“condizione atomica”.
Il disegno disgregatore ha le sue premesse nel piano Kissinger 74 rinnovate nella “guida di difesa
strategica” Wolfowitz-Cheney 93, ed è entrato nel pieno della sua attuazione con la crisi “finanziaria”
Messico 94, la crisi “etnica” Bosnia 95, la “bolla speculativa” Estasia 97, il collasso Russia 98, fino alla
deflagrazione Balcani 99. Si tratta di un’unica linea di sviluppo della controffensiva imperialistica a guida
Usa, con la joint venture europea ogni volta che è stato possibile (livello minimo di partecipazione: Gran
Bretagna).
La disgregazione degli stati deboli, a opera di quelli forti, ha avuto una sua peculiare attuazione
nell’Europa del dopo ‘89, dove tanti nuovi più piccoli stati - tre volte tanti - sono scaturiti da quelle che
furono Urss, Cecoslovacchia, Jugoslavia. Ma la fine del “realsocialismo” non è certo stata la causa della cosiddetta mondializzazione [alla francese; o globalizzazione all’inglese, secondo la prevalente accentuazione
culturale, prima che linguistica], bensì il suo prodotto. La formazione di un mercato mondiale unificato
imponeva la fine del Comecon, giacché il capitale, per sua natura, si pone come capitale globale, tendente a
rompere ogni barriera statale. Da questo punto vista (quale che fosse la reale “natura sociale” dell’Urss,
come si diceva una volta) il realsocialismo poteva comunque rappresentare una forma di controllo tale da
ostacolare il movimento transnazionale del capitale.
Dopo la I guerra mondiale, con il fascismo e con la crisi del 1929, il capitalismo monopolistico di stato
(così com’era concepito in Occidente) poneva lo stato come forma di sostegno per il capitale stesso,
pienamente espressosi con la fase dell’accumulazione del secondo dopoguerra. Ma con la nuova fase di crisi,
apertasi prima degli anni ‘70, quella medesima funzione dello stato, considerato inefficiente per il suo
assistenzialismo, sembra essa stessa entrare in crisi dando il via al processo di privatizzazioni, in quanto
queste rispondono alle esigenze di espansione del capitalismo imperialistico transnazionale. I grandi
conglomerati, gruppi e holding, possono solo travalicare i limiti statali - e questo era già chiaro a Marx nella
sua epoca. Lo stato si è sempre strutturato come strumento del capitale - concettualmente apartitico e
anazionale - in una continua trasformazione che segue l’evoluzione del ciclo di accumulazione del modo di
produzione capitalistico; al punto che la maggiore sua efficienza richiesta dal capitale fa sì che, pure con le
privatizzazioni, aumenti l’intervento statale complessivo, e soprattutto nella forma militare a scapito di quella
sociale, per proseguire ad alimentare lo scontro interimperialistico.
Dunque, lo stato nazionale non è l’ideale dello stato etico della nazione, ma soltanto l’apparato statale
organizzato su un dato territorio. [Nel secolo scorso l’“economia nazionale” - e così si chiamava in tedesco
l’economia politica - era semplicemente il luogo di operazione del capitale]. Perciò, la funzione degli stati
nazionali fu quella di creare mercati nazionali più vasti, anche se tardivi come per Germania e Italia.
Siccome il capitale transnazionale non ha più il bisogno unilaterale e limitato di un mercato nazionale, la
tendenza contemporanea è alla rottura degli stati nazionali per la formazione di stati regionali (o di macroregioni transfrontaliere), compatti ma integrati in più vaste “comunità di mercati” (come le chiama
Omahe). Da qui deriva quel duplice processo che vede, da un lato, ipotesi di separatismo negli stati
capitalistici avanzati (Paesi baschi, Quebec, Padania, ecc.) e, dall’altro, frantumazione indotta degli stati subalterni dominati (Russia, Jugoslavia, ecc.) per avere “sottostati” deboli da opprimere e da controllare
direttamente e agevolmente.
Ma in entrambi i casi, dati i profondi mutamenti della fase di sviluppo del modo di produzione
capitalistico, la richiesta di separazione o autonomia entro uno stato centrale assume un significato assai
diverso che in passato, forse anche opposto. Se la “federazione” proviene dall’esterno o dall’alto degli interessi del capitale transnazionale, per rompere il centralismo dello stato unitario, allora si tratta di
disgregazione, piuttosto che di autodeterminazione. Il giudizio comunista su tale questione, oggi, non può
prescindere dalla fase storica e dalle forme del processo che il federalismo assume. Il federalismo stesso si è
trasformato: dagli elementi di progressività che, pur entro la salvaguardia dell’unità dello stato centrale,
presentava nell’800, in quei casi in cui forme di autodeterminazione erano avanzate da “popoli con una
storia”, si è giunti al controllo imperialistico dispotico che del federalismo conserva solo la forma vuota di un
decentramento delegato.
Nella trasformazione delle contraddizioni del rapporto tra stato e società civile, il ruolo del sociale, per
adeguare le capacità di lotta, segue la subalternità crescente delle istituzioni nazionali alle strutture
sovrastatuali nelle forme del neocorporativismo. Quando Engels parlava di “superstizione dello stato” intendeva mettere in guardia contro l’illusione di autonomia universalistica dello stato stesso; e proprio codesta
illusoria superstizione è così in grado di disgregare la coscienza di classe, sostituendola prima con la finzione
formalistica dello stato di tutti e poi introducendo dall’alto elementi di dissoluzione dell’autentica solidarietà
orizzontale di classe e di popolo, fino alle mistificazioni etniche e religiose. Del resto, tale è la pervasività del
capitale finanziario che esso, non potendo assolutamente fare a meno dello stato, fa sì che i poteri occulti e
mafiosi che promanano dal suo corpo si presentino in forme “istituzionali”.
&%PAGINA&
Il nemico di classe ha vinto strategicamente tre volte su scala mondiale: con la fine del protosocialismo
sovietico, ha avviato il ricordato processo di disgregazione internazionale, configurando quella lunga
strategia di guerra che è appena cominciata. Di questa vittoria serve individuare la nozione globale della
catena che ci lega, andando al di là della descrizione di aspetti parziali della “fenomenologia del potere”. La
giusta denuncia di indignazione va bene, ma solo essa altro non è che un sostituto romantico della politica.
Per comprendere le ragioni di quella vittoria, che è la nostra sconfitta, occorre riprendere lo studio dei
concetti che spieghino nei dettagli il funzionamento del modo di produzione capitalistico contemporaneo.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
dei relatori (pervenuti o reperiti)
Aa.Vv.: Conflitti di classe e “riforme istituzionali” [cur. Angelo Ruggeri, con interventi di Catone,
d’Albergo, Filosa, Pala], il Lavoratore, Milano 1996; Lo stato a/sociale [con interventi di Filosa, Pala],
Laboratorio politico, Napoli 1998 - Vincenzo Accattatis: Il governo dei giudici fra realtà e ideologia,
Invarianti 23, 1993; Il sovrano prigioniero, Invarianti 27, 1995; Il mercato e lo stato sociale, Invarianti 28,
1996; Governo delle leggi e non degli uomini, Invarianti 30, 1997; Per uno spazio pubblico europeo,
Alternative Europa 8, 1998; Il liberalismo come realtà e come ideologia, Invarianti 32, 1998; Destra e
sinistra, Alternative Europa 9, 1999; Unione europea e Usa, Alternative Europa 10, 1999 - Guglielmo
Carchedi e Bruno Carchedi: La Nato e l’Europa, Alternative Europa 12, 1999 - Andrea Catone: Nazionalismi
e crisi dello stato-nazione, Giano 16, 1994; Stati-regione, federalismo, separatismo, nella fase del capitale
transnazionale, l’Ernesto 6, 1996; Sotto il segno del capitale, Laboratorio politico, Napoli 1997; La
transizione bloccata, Laboratorio politico, Napoli 1998; Dell’imperialismo e della guerra - la fase del
capitale transnazionale, la Contraddizione 72, 1999 - Gianfranco Ciabatti: Neocorporativismo, la
Contraddizione 0, 1987 (70, 1999); La Grande Riforma, la Contraddizione 1, 1987 (42, 1994) ; Il giudice e il
tiranno, la Contraddizione 46, 1995; Il neocorporativismo, Laboratorio politico, Napoli 1996 - Luigi Cortesi:
“Stato-guerra” e lotta per la pace, Giano 8, 1991; Guerra civile, nemico interno e “doppio stato”, Giano
26, 1997; Banalità della condizione atomica, 29-30, Giano 1998; Una crisi di civiltà: cronache di un
decennio, Esi, Napoli 1999 - Salvatore D’Albergo: Imperialismo e istituzioni, la Contraddizione 36, 1993;
Colpo di stato, tecnico e pulito, la Contraddizione 36, 1993; La legge finanziaria, la Contraddizione 45,
1994; Il federalismo, espediente classista, la Contraddizione 49, 1995; La costituzione tra democratizzazione
e modernizzazione, Ets, Pisa 1996; Riforme istituzionali e partito di massa, la Contraddizione 53, 1996;
“Cancellierato” e potere, la Contraddizione 55, 1996; Marasma costituzionale, la Contraddizione 69, 1998;
Maggioritario e referendum - due strumenti di passivizzazione sociale, la Contraddizione 71, 1999 - Carla
Filosa: Vizi privati, pubbliche vergogne, la Contraddizione 17, 1990; L’ultima enciclica del capitale: Novus
ordo, la Contraddizione 24, 1991; Lo stato separato, la Contraddizione 31, 1992; Il protocollo d’intesa
neocorporativa: l’armonia prestabilita del 3 luglio, la Contraddizione 38, 1993; Stato e nazione come
rapporto di capitale, Giano 18, 1995; La democrazia reale, la Contraddizione 54, 1996; Le classi e la storia,
Laboratorio politico, Napoli 1996; Stato e sovranazionalità globale, la Contraddizione 69, 1998; La
superstizione democratica dello stato, Invarianti 32, 1998; Paesi in via di armonizzazione, unitevi neocorporativismo di sistema, la Contraddizione 71, 1999; “Cultura di guerra” - disvelamento della natura
economica della violenza, la Contraddizione 72, 1999 - Roberto Fineschi: Il concetto di storia, la
Contraddizione 72, 1999 - Domenico Losurdo: Marx e il bilancio storico del novecento, Bibliotheca, Gaeta
1993; Democrazia e bonapartismo, Boringhieri, Torino 1993; Utopia e stato d’eccezione, Laboratorio
politico, Napoli 1996; Fuga dalla storia?, la Città del sole, Napoli 1999 - Alessandro Mazzone: La
temporalità specifica del Modo di produzione capitalistico, In Marx e i suoi critici, Quattroventi, Urbino
1987 - Gianfranco Pala: L’ultima crisi, Angeli, Milano 1982; Sublimazione dell’imperialismo, Invarianti 910, 1989; L’imperialismo multinazionale e lo stato, Economia pubblica 5, 1989; Il nuovo ordine
imperialistico mondiale, Politica e classe 9, 1991; Lo stato asociale del capitale, la Contraddizione 31, 1992;
Stato, superstato & co., la Contraddizione 38, 1993; Il declino dell’impero americano nel nuovo ordine
mondiale, Economia pubblica 20, 1993; L’eredità dell’impero, Giano 12, 1993; Economia nazionale e
mercato mondiale, Laboratorio politico, Napoli 1995; La storia e la rivoluzione, Laboratorio politico, Napoli
1995; Il Fondo monetario internazionale, Laboratorio politico, Napoli 1996; Il gambero e il guscio, la
Contraddizione 60, 1997; Classe, salario, stato, in Lo stato a/sociale, Laboratorio politico, Napoli 1998;
L’organizzazione dei capitali uniti: le istituzioni dell’imperialismo transnazionale, Invarianti 31, 1998;
Burgravi e dichiliasti - la II repubblica, la Contraddizione 69, 1998; Stati di disgregazione - strategia
sovrastatuale dell’imperialismo transnazionale, la Contraddizione 72. 1999.
la Contraddizione no. 73
&%pag