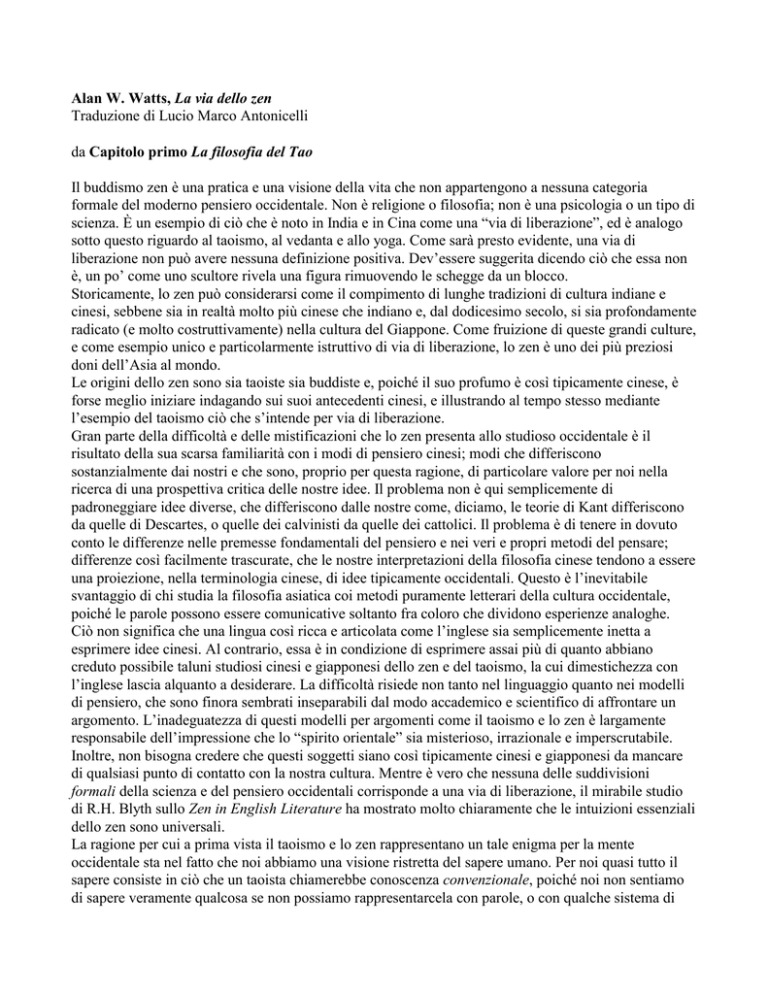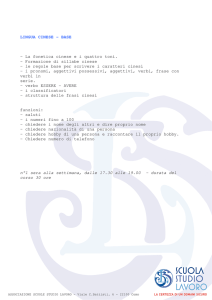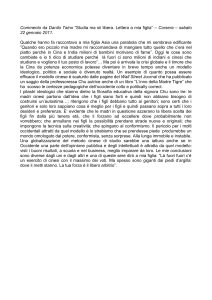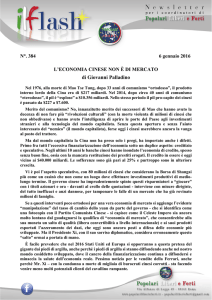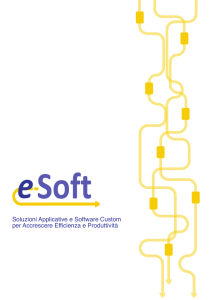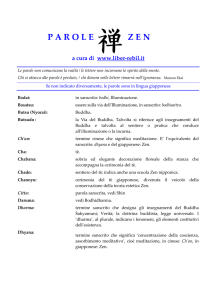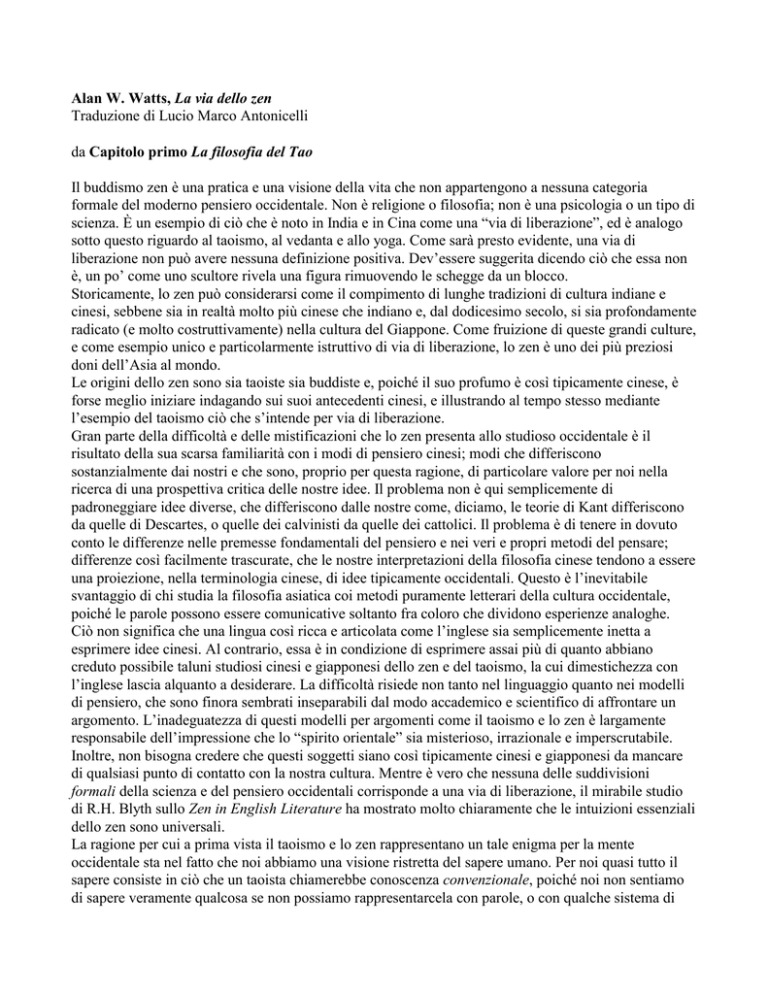
Alan W. Watts, La via dello zen
Traduzione di Lucio Marco Antonicelli
da Capitolo primo La filosofia del Tao
Il buddismo zen è una pratica e una visione della vita che non appartengono a nessuna categoria
formale del moderno pensiero occidentale. Non è religione o filosofia; non è una psicologia o un tipo di
scienza. È un esempio di ciò che è noto in India e in Cina come una “via di liberazione”, ed è analogo
sotto questo riguardo al taoismo, al vedanta e allo yoga. Come sarà presto evidente, una via di
liberazione non può avere nessuna definizione positiva. Dev’essere suggerita dicendo ciò che essa non
è, un po’ come uno scultore rivela una figura rimuovendo le schegge da un blocco.
Storicamente, lo zen può considerarsi come il compimento di lunghe tradizioni di cultura indiane e
cinesi, sebbene sia in realtà molto più cinese che indiano e, dal dodicesimo secolo, si sia profondamente
radicato (e molto costruttivamente) nella cultura del Giappone. Come fruizione di queste grandi culture,
e come esempio unico e particolarmente istruttivo di via di liberazione, lo zen è uno dei più preziosi
doni dell’Asia al mondo.
Le origini dello zen sono sia taoiste sia buddiste e, poiché il suo profumo è così tipicamente cinese, è
forse meglio iniziare indagando sui suoi antecedenti cinesi, e illustrando al tempo stesso mediante
l’esempio del taoismo ciò che s’intende per via di liberazione.
Gran parte della difficoltà e delle mistificazioni che lo zen presenta allo studioso occidentale è il
risultato della sua scarsa familiarità con i modi di pensiero cinesi; modi che differiscono
sostanzialmente dai nostri e che sono, proprio per questa ragione, di particolare valore per noi nella
ricerca di una prospettiva critica delle nostre idee. Il problema non è qui semplicemente di
padroneggiare idee diverse, che differiscono dalle nostre come, diciamo, le teorie di Kant differiscono
da quelle di Descartes, o quelle dei calvinisti da quelle dei cattolici. Il problema è di tenere in dovuto
conto le differenze nelle premesse fondamentali del pensiero e nei veri e propri metodi del pensare;
differenze così facilmente trascurate, che le nostre interpretazioni della filosofia cinese tendono a essere
una proiezione, nella terminologia cinese, di idee tipicamente occidentali. Questo è l’inevitabile
svantaggio di chi studia la filosofia asiatica coi metodi puramente letterari della cultura occidentale,
poiché le parole possono essere comunicative soltanto fra coloro che dividono esperienze analoghe.
Ciò non significa che una lingua così ricca e articolata come l’inglese sia semplicemente inetta a
esprimere idee cinesi. Al contrario, essa è in condizione di esprimere assai più di quanto abbiano
creduto possibile taluni studiosi cinesi e giapponesi dello zen e del taoismo, la cui dimestichezza con
l’inglese lascia alquanto a desiderare. La difficoltà risiede non tanto nel linguaggio quanto nei modelli
di pensiero, che sono finora sembrati inseparabili dal modo accademico e scientifico di affrontare un
argomento. L’inadeguatezza di questi modelli per argomenti come il taoismo e lo zen è largamente
responsabile dell’impressione che lo “spirito orientale” sia misterioso, irrazionale e imperscrutabile.
Inoltre, non bisogna credere che questi soggetti siano così tipicamente cinesi e giapponesi da mancare
di qualsiasi punto di contatto con la nostra cultura. Mentre è vero che nessuna delle suddivisioni
formali della scienza e del pensiero occidentali corrisponde a una via di liberazione, il mirabile studio
di R.H. Blyth sullo Zen in English Literature ha mostrato molto chiaramente che le intuizioni essenziali
dello zen sono universali.
La ragione per cui a prima vista il taoismo e lo zen rappresentano un tale enigma per la mente
occidentale sta nel fatto che noi abbiamo una visione ristretta del sapere umano. Per noi quasi tutto il
sapere consiste in ciò che un taoista chiamerebbe conoscenza convenzionale, poiché noi non sentiamo
di sapere veramente qualcosa se non possiamo rappresentarcela con parole, o con qualche sistema di
segni convenzionali come le notazioni della matematica e della musica. Tale conoscenza è detta
convenzionale perché è un fatto di convenzione sociale né più né meno che i codici del linguaggio.
Proprio come la gente che parla il medesimo linguaggio ha taciti accordi riguardo le parole da usare per
indicare determinate cose, così i membri di ogni società e di ogni cultura sono tenuti uniti da vincoli di
comunicazione che poggiano su ogni specie di accordo riguardo la classificazione e la valutazione di
azioni e di cose.
Così, il compito dell’educazione consiste nel rendere i fanciulli adatti a vivere in una società,
persuadendoli a imparare e ad accettare i suoi codici, ossia le norme e le convenzioni dei rapporti
mediante le quali la società si mantiene unita. V’è dapprima la lingua parlata. Al bambino si insegna ad
accettare “albero” e non “brum-brum” come segno convenuto per quella cosa (indicando la cosa). Non
abbiamo alcuna difficoltà a comprendere che la parola “albero” è una questione di convenzione. Meno
ovvio è invece il fatto che la convenzione governa anche la definizione della cosa alla quale la parola è
assegnata. Difatti al bambino non si deve soltanto insegnare con quali parole indicare le cose, ma anche
il modo in cui la sua cultura ha tacitamente convenuto di distinguere le cose, di segnarne i confini, nei
limiti della nostra quotidiana esperienza. Così, la convenzione scientifica decide se un’anguilla debba
essere un pesce o un serpente; e una convenzione grammaticale determina quali esperienze debbano
essere definite oggetti e quali eventi o azioni. Quanto sia arbitraria tale convenzione lo si può vedere
dalla domanda: “Che cosa avviene del mio pugno (nome-oggetto) quando apro la mano?”. L’oggetto
svanisce come per miracolo, poiché un’azione era mascherata da un nome generalmente assegnato a
una cosa. In inglese le differenze fra cose e azioni sono distinte in modo netto, seppure non sempre
logico, ma un gran numero di parole cinesi ha funzione sia di nome che di verbo, così che una persona
che pensi in cinese non incontra serie difficoltà a rendersi conto che gli oggetti sono anche eventi, che il
nostro mondo è una raccolta di processi piuttosto che di entità.
Oltre al linguaggio, il bambino deve accettare molte forme di codici, poiché le esigenze del vivere
associato richiedono convenzioni come i codici di legge e di etica; di etichetta e di arte; di pesi, misure
e numeri; e – soprattutto – di “ruolo”. V’è difficoltà a comunicare fra di noi, se non possiamo
identificarci in termini di ruolo: padre, insegnante, lavoratore, artista, “bravo ragazzo”, gentiluomo,
sportivo, e così via. Nella misura in cui ci identifichiamo con tali stereotipi e con le regole a essi
collegate di condotta sociale, noi sentiamo di essere qualcuno, e i nostri compagni hanno meno
difficoltà ad accoglierci (ossia, a identificarci e a sentire che siamo “sotto controllo”). L’incontro di due
estranei a un ricevimento è sempre un po’ imbarazzante quando l’ospite non ne abbia specificato i
“ruoli” nel presentarli, poiché nessuno dei due sa quali regole di conversazione e di condotta osservare.
Ancora una volta, è facile rendersi conto del carattere convenzionale dei ruoli o condizioni. Un uomo
che sia padre, infatti, può essere anche medico e artista, allo stesso modo che impiegato e fratello. Ed è
ovvio che pure la somma totale di questi ruoli-etichette sarà lontana dal fornire una descrizione
adeguata della personalità dell’uomo, anche se può collocarlo nell’ambito di una certa classificazione
generale. Ma le convenzioni che dominano l’identità umana sono più sottili e molto meno ovvie di
queste. Noi impariamo perfettamente, seppure molto meno esplicitamente, a identificare noi stessi con
una veduta del pari convenzionale della nostra personalità: l’“io”, o la “persona”, convenzionale è
composto in misura prevalente di una storia che consiste di memorie selezionate, a partire dal momento
della nascita. Secondo la convenzione, io non sono semplicemente ciò che sto facendo ora: sono anche
ciò che ho fatto; e la mia versione convenzionale del mio passato è fatta in maniera da sembrare quasi
più il reale “me stesso” di ciò ch’io sono in questo momento. Quel che io sono – infatti – appare così
fuggevole e intangibile, mentre quel che io sono stato è fisso e definitivo. È la solida base per le
previsioni di quel che sarò in futuro, e ne consegue che sono più strettamente identificato con ciò che
non esiste più che con ciò che è realmente!
È di grande importanza riconoscere che le memorie e gli eventi passati, che costituiscono l’identità
storica di un uomo, altro non sono che una selezione. Dalla concreta infinità di eventi e di esperienze,
taluni sono stati scelti – cioè astratti – come significativi, e questa significanza è stata naturalmente
determinata da modelli convenzionali. Infatti, la conoscenza convenzionale denuncia nel suo carattere
stesso di essere un sistema di astrazioni; consistente di segni e di simboli nei quali cose ed eventi sono
ridotti ai loro contorni generali, come il carattere cinese jen sta per “uomo”, essendo l’estrema
semplificazione e generalizzazione della forma umana.
Lo stesso dicasi di parole non ideografiche: le parole “uomo”, “pesce”, “stella”, “fiore”, “corsa”,
“crescita” denotano tutte classi di oggetti e di eventi che si possono riconoscere come membri della loro
classe da semplicissimi attributi, astratti dalla intera complessità delle cose medesime.
L’astrazione è in tal modo quasi una necessità per comunicare, giacché ci rende capaci di rappresentare
le nostre esperienze con semplici e rapide “prese” mentali. Quando noi diciamo di poter pensare solo
una cosa alla volta è come se dicessimo che l’Oceano Pacifico non può essere inghiottito tutto d’un
fiato. Dev’essere preso in una tazza e mandato giù a sorsate. Le astrazioni e i segni convenzionali sono
come la tazza: riducono le esperienze a unità abbastanza semplici da poter essere comprese una alla
volta. In maniera analoga, le curve si misurano riducendole a una sequenza di minuscole linee diritte, o
pensandole in termini di quadrati che esse attraversano quando vengono tracciate su di un grafico.
Altri esempi dello stesso processo sono le fotografie dei giornali e le trasmissioni televisive. Nelle
prime, una scena naturale è riprodotta in una serie di puntini chiari e scuri disposti su uno schermo o
“retino” così da dare l’impressione di una fotografia in bianco e nero, se guardata senza lente di
ingrandimento. Per quanto possa rassomigliare alla scena originale, la fotografia riprodotta non è che
una ricostruzione della scena in termini di piccoli segni; un po’ come le nostre parole convenzionali e i
nostri convenzionali pensieri sono ricostruzioni di esperienze in termini di segni astratti. In modo
ancora più simile al processo del pensiero, la telecamera trasmette una scena naturale attraverso una
serie lineare di impulsi che possono passare lungo un filo.
Così, la comunicazione mediante segni convenzionali di questo genere ci dà una traduzione astratta,
“una cosa per volta”, di un universo in cui le cose accadono “tutte in una volta”; di un universo la cui
realtà concreta sfugge sempre, in questi termini astratti, a una perfetta descrizione. Con questi mezzi, la
descrizione perfetta di una particella di polvere richiederebbe un tempo infinito, dato che si dovrebbe
tener conto di ogni punto del suo volume. […]