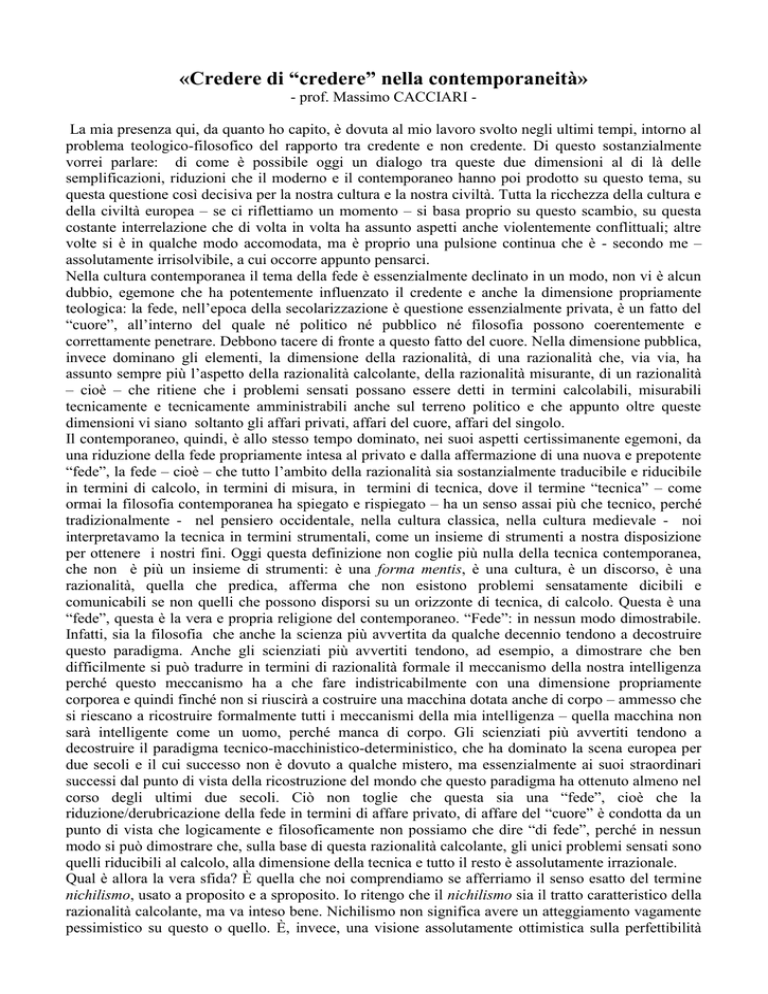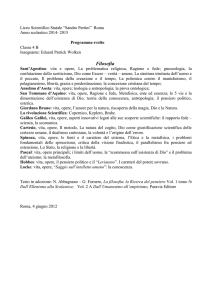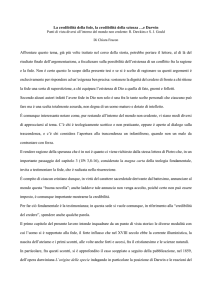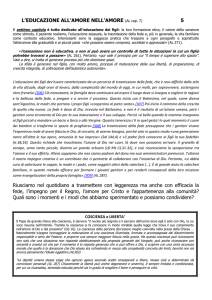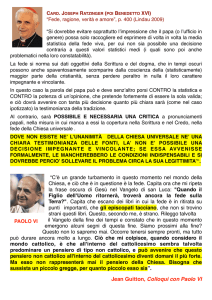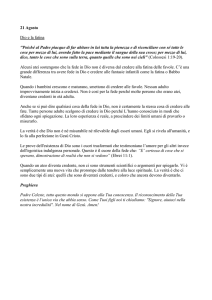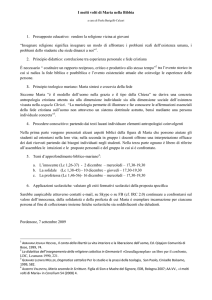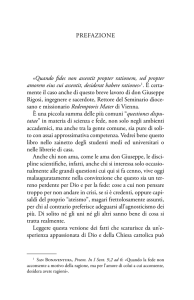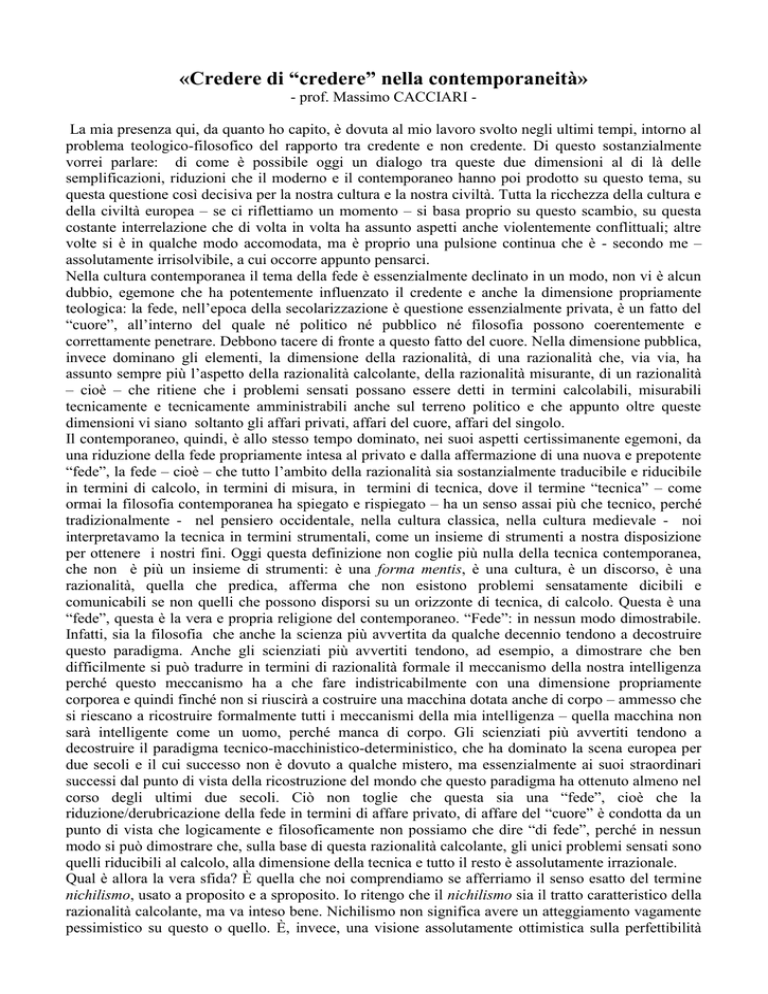
«Credere di “credere” nella contemporaneità»
- prof. Massimo CACCIARI La mia presenza qui, da quanto ho capito, è dovuta al mio lavoro svolto negli ultimi tempi, intorno al
problema teologico-filosofico del rapporto tra credente e non credente. Di questo sostanzialmente
vorrei parlare: di come è possibile oggi un dialogo tra queste due dimensioni al di là delle
semplificazioni, riduzioni che il moderno e il contemporaneo hanno poi prodotto su questo tema, su
questa questione così decisiva per la nostra cultura e la nostra civiltà. Tutta la ricchezza della cultura e
della civiltà europea – se ci riflettiamo un momento – si basa proprio su questo scambio, su questa
costante interrelazione che di volta in volta ha assunto aspetti anche violentemente conflittuali; altre
volte si è in qualche modo accomodata, ma è proprio una pulsione continua che è - secondo me –
assolutamente irrisolvibile, a cui occorre appunto pensarci.
Nella cultura contemporanea il tema della fede è essenzialmente declinato in un modo, non vi è alcun
dubbio, egemone che ha potentemente influenzato il credente e anche la dimensione propriamente
teologica: la fede, nell’epoca della secolarizzazione è questione essenzialmente privata, è un fatto del
“cuore”, all’interno del quale né politico né pubblico né filosofia possono coerentemente e
correttamente penetrare. Debbono tacere di fronte a questo fatto del cuore. Nella dimensione pubblica,
invece dominano gli elementi, la dimensione della razionalità, di una razionalità che, via via, ha
assunto sempre più l’aspetto della razionalità calcolante, della razionalità misurante, di un razionalità
– cioè – che ritiene che i problemi sensati possano essere detti in termini calcolabili, misurabili
tecnicamente e tecnicamente amministrabili anche sul terreno politico e che appunto oltre queste
dimensioni vi siano soltanto gli affari privati, affari del cuore, affari del singolo.
Il contemporaneo, quindi, è allo stesso tempo dominato, nei suoi aspetti certissimanente egemoni, da
una riduzione della fede propriamente intesa al privato e dalla affermazione di una nuova e prepotente
“fede”, la fede – cioè – che tutto l’ambito della razionalità sia sostanzialmente traducibile e riducibile
in termini di calcolo, in termini di misura, in termini di tecnica, dove il termine “tecnica” – come
ormai la filosofia contemporanea ha spiegato e rispiegato – ha un senso assai più che tecnico, perché
tradizionalmente - nel pensiero occidentale, nella cultura classica, nella cultura medievale - noi
interpretavamo la tecnica in termini strumentali, come un insieme di strumenti a nostra disposizione
per ottenere i nostri fini. Oggi questa definizione non coglie più nulla della tecnica contemporanea,
che non è più un insieme di strumenti: è una forma mentis, è una cultura, è un discorso, è una
razionalità, quella che predica, afferma che non esistono problemi sensatamente dicibili e
comunicabili se non quelli che possono disporsi su un orizzonte di tecnica, di calcolo. Questa è una
“fede”, questa è la vera e propria religione del contemporaneo. “Fede”: in nessun modo dimostrabile.
Infatti, sia la filosofia che anche la scienza più avvertita da qualche decennio tendono a decostruire
questo paradigma. Anche gli scienziati più avvertiti tendono, ad esempio, a dimostrare che ben
difficilmente si può tradurre in termini di razionalità formale il meccanismo della nostra intelligenza
perché questo meccanismo ha a che fare indistricabilmente con una dimensione propriamente
corporea e quindi finché non si riuscirà a costruire una macchina dotata anche di corpo – ammesso che
si riescano a ricostruire formalmente tutti i meccanismi della mia intelligenza – quella macchina non
sarà intelligente come un uomo, perché manca di corpo. Gli scienziati più avvertiti tendono a
decostruire il paradigma tecnico-macchinistico-deterministico, che ha dominato la scena europea per
due secoli e il cui successo non è dovuto a qualche mistero, ma essenzialmente ai suoi straordinari
successi dal punto di vista della ricostruzione del mondo che questo paradigma ha ottenuto almeno nel
corso degli ultimi due secoli. Ciò non toglie che questa sia una “fede”, cioè che la
riduzione/derubricazione della fede in termini di affare privato, di affare del “cuore” è condotta da un
punto di vista che logicamente e filosoficamente non possiamo che dire “di fede”, perché in nessun
modo si può dimostrare che, sulla base di questa razionalità calcolante, gli unici problemi sensati sono
quelli riducibili al calcolo, alla dimensione della tecnica e tutto il resto è assolutamente irrazionale.
Qual è allora la vera sfida? È quella che noi comprendiamo se afferriamo il senso esatto del termine
nichilismo, usato a proposito e a sproposito. Io ritengo che il nichilismo sia il tratto caratteristico della
razionalità calcolante, ma va inteso bene. Nichilismo non significa avere un atteggiamento vagamente
pessimistico su questo o quello. È, invece, una visione assolutamente ottimistica sulla perfettibilità
indefinita della razionalità tecnico-scientifica. Tutti i problemi possono essere sensatamente posti nei
termini di questa razionalità e qui risolti.
Il nichilismo, dunque, non significa ritenere che questo o quello è niente, ma significa – e qui è la
sfida – ritenere che tutto ciò che non è ente, non è riducibile al “dato di fatto”. Fermo restando che
“dato di fatto” è una espressione contraddittoria: abbiamo a che fare con fatti e non con dati. La forza
della razionalità tecnico-scientifica sta, appunto, nella sua capacità di ricostruire il nostro mondo, non
semplicemente di intervenirci con degli strumenti: questo è il suo fine. Ma noi abbiamo a che fare con
fatti. Il greco aveva una bella parola per dire ciò: per dire una cosa, usa il termine pragma/pragmata
(stessa radice di prassi); le “cose” sono “fatti”, mai come nel contemporaneo. A noi interessano le
cose in quanto trasformate. In questo c’è una profondissima radice cristiana: la tecnica moderna e
contemporanea nasce e si sviluppa nell’ Europa o Cristianità e non sarebbe concepibile in nessun altro
contesto. Leggevo una famosa epistola di Ambrogio nel famoso dibattito-scontro con Simmaco a
proposito dell’Altare della Vittoria, che Ambrogio voleva che non venisse più restaurato nell’aula
senatoria di Roma, mentre Simmaco voleva che restasse e sosteneva che è male muovere le vecchie
leggi. Ambrogio lo accusò di essere un bieco reazionario, perché tutto va in melius: «non vedi che la
natura è andata sempre migliorando? All’inizio era una massa informe, era un caos e poi, via via, è
andata migliorando, fino a che è apparso l’ agricola, il contadino, e soltanto allora la natura –
attraverso il lavoro del contadino – è diventata bella».
L’idea che la natura vada in meglio grazie all’azione progressiva dell’artefice è quint’essenzialmente
cristiana, c’è una radice cristiana nella tecnica che va guardata ad occhi lucidi, faccia a faccia, anche
se può apparire un volto di Medusa.
Allora nichilismo vuol dire che esistono soltanto enti, o meglio “fatti” e ciò che non è “fatto” non vale
nulla. Questa è la definizione esatta di nichilismo: tutto ciò che non è “fatto” è nulla proprio nel
significato latino del nihil che indica il filo d’erba, l’oggetto insignificante. Questa è la posizione del
nichilismo, che non ha niente a che vedere con pessimismo, con ritenere che questo o quello non
valgono nulla. Nichilismo significa che solo i fatti valgono e ciò che non è fatto, cioè il non ente, il
niente, è nulla, non mi interessa, non ha a che fare con la mia dimensione spirituale e/o intellettuale.
"Viva il fatto!" Il nichilismo è una civiltà che si vuole basare sul fatto visibile, calcolabile, misurabile
e sul mio intervento di artefice sui fatti in modo che tutto vada provvidenzialmente in melius grazie
alla potenza indefinita della tecnica, nel senso più che tecnico dell’espressione .Qui è la sfida! Questo
è il presupposto! Accettare questo paradigma significa abbattere ogni presupposto, ogni fondamento
di un discorso filosofico e ogni presupposto di una fede, qualunque essa sia. Il discorso filosofico è
comunque un intelligere Deum: anche quello di Nietzsche, anche i grandi ateismi sono sempre un
intelligere Deum, per arrivare alla fine a dire:”non l’ho capito” oppure “non è comprensibile”, ma il
senso del discorso filosofico non può essere diverso. Se perde questo senso, il discorso filosofico si
frammenta in una serie di discorsi particolari, si settorializza in aree, domini particolari, che sono
quelli dei pragmata. Allora diventerà politica, scienza, morale, e cosi via: si suddivide in scienze
particolari, e cessa di essere filosofia. Quindi, se si accetta il nichilismo in questa accezione,
dominante nel contemporaneo, si abbatte ogni presupposto di un discorso filosofico e di una fede,
poiché anche la fede è pur sempre – se si declina il termine pistis in tutto il vangelo – una fede
“verso” (eis), è sempre una fede che non è mai il possesso della cosa amata come se si trattasse di una
cosa. “Amo il cuore di coloro che cercano sempre” dice Agostino: la fede del credente è una fede
“verso”, mai a casa, mai assicurata, mai fondata, sempre rinnovata. Ma, essendo sempre rinnovata, è
sempre anche angosciosa, come dice Kierkegaard, che definiva la fede come una angosciosa certezza.
Sia la filosofia, sia la fede non hanno a che fare con pragmata, o meglio non possono avere a che fare
solo con pragmata e si confrontano, si contraddicono con i fatti, ma mai possono essere
semplicemente un discorso sul fatto, perché il loro”fatto”, ciò che loro interessa, è il Deum,
l’intelligere Deum, fine di una ricerca, di una indagine che può concludersi in naufragio, naufragium
fecit bene navigavi oppure, appunto, nella fede del credente, qualunque sia il suo livello di cultura, che
è sempre pistis eis, almeno nella cristianità. Altro sarebbe il discorso per le ortodossie giudaiche e
islamiche, ma per la cristianità non vi è alcun dubbio. Tutti i grandi Padri, i grandi Maestri hanno
sempre insistito – a partire da Tommaso – su questo carattere indagando della verità di questa fede:
veritas indaganda, non indagata e risolta. Veritas indaganda: una verità che è sempre nell’ambito
dell’indagine, deve essere sempre interrogata ed indagata.
La sfida fondamentale, quindi, è questa: capire il significato del nichilismo, capire che non ci si sbriga
del problema semplicemente svanverando sul nichilismo come fosse caduta dei valori, “tutto e
niente”, “nulla vale”, ecc., che è la quintessenza di un atteggiamento proprio della cultura moderna e
contemporanea, per cui solo i pragmata valgono, pragmata metafisicamente distinti dal semplice
“dato”. Nulla è dato, tutto è costruito per la cultura moderna, come l’esperienza kantiana che è
costruzione che noi operiamo in base alle nostre forme a-priori della natura: la natura è sempre il fatto
di una esperienza, è una esperienza della natura e mai la natura. Non abbiamo a che fare con natura,
ma con l’esperienza della natura. Ciò esclude o relega l’intelligere Deum, la pistis eis nell’ambito
degli affari del cuore. E’ un sentimento. E qui è la sfida! Perché noi, filosofi e teologi, credenti e non
credenti (e torneremo sul significato di “non-credente”), dobbiamo rispondere a questa sfida che si
rinnova, in termini diversi, ma che è sempre quella sostanzialmente: questa separazione del credere, o
di quell’indagine verso il non-ente – Deum, che non è cosa, che non è ente, dal sapere fatti,
costruzioni di fatti, esperienza. Intelligere Deum – pistis eis: niente, oppure sentimento, cuore.
Credo che si possa “lottare”, perché ritengo che il termine non sia inadeguato. Lottare contro questa
visione del mondo, contro questa fede che tutto sia riducibile a pragmata, fede che tuttavia ha avuto
uno straordinario successo pratico, effettuale, che è effettivamente riuscita a trasformare il mondo.
Lottare affrontando almeno due questioni:
1. Il primo è un tema che tornava tra i grandi problemi che citava il prof. Monticone: LIBERTA’.
Rispetto all’ambito di quel nichilismo di cui abbiamo parlato, è radicalmente contestata la
possibilità di “sapere” la libertà; non possiamo essere liberi, pena il cadere nell’irrazionalità, non
possiamo essere liberi rispetto ad un puro interesse, ad un nostro essere puramente,
semplicemente, nell’ambito dei pragmata. Una nostra libertà, anche in senso kantiano, come
condizionatezza rispetto ai legami causali naturali ci è negata, o meglio, non è rappresentabile, non
possiamo rappresentarcela. Qui una buona filosofia e la posizione del credente possono
confondersi senza mescolanza, perché il filosofo deve riconoscere l’indimostrabilità della libertà,
il suo carattere noumenico: la libertà la penso, ma non è “cosa”. Come faccio a dimostrarla?
Questa esigenza che non riesco a soffocare,non riesco a reprimere, di intendermi come libero
rispetto alla condizionatezza della causalità naturale, come posso rappresentarla in termini logicoscientifici? Provate a pensare di dimostrare che siete liberi! E’ assolutamente impossibile. Però
questo credere, questa fede nella libertà è o no assolutamente insopprimibile? Quindi è un “fatto” è
nella dimensione dei “fatti” questa insopprimibile esigenza: vi è qualcosa che non è in alcun modo
riducibile al “fatto”, che non può essere in alcun modo spiegabile come io spiego – sulla base delle
leggi della causalità naturale, in termini più o meno deterministici – ogni altro fatto che non può
essere in alcun modo spiegabile come io spiego, sulle basi della causalità naturale in termini più o
meno deterministici, ogni altro fatto; però è un fatto. Il filosofo qui si arresta, ma è un arrestarsi
molto in là, perché a questo punto io ho decostruito nel suo punto fondamentale anche
esistenzialmente più delicato quel nichilismo che pretendeva che la razionalità tecnico-scientifica
potesse davvero affrontare e risolvere ogni significativo problema per quella “macchina pensante”
che siamo, ma – anche ammesso che accettiamo un’antropologia di questo genere – forse che da
quella macchina possiamo astrarre quell’esigenza? Non è un fatto che quell’esigenza ci muove, ci
agita e ci fa anche pensare, cogitare? Qui il filosofo si arresta molto in là, si arresta ad una critica
radicale di quell’approccio e in termini non opposti a quelli del credente. Il filosofo, che creda o
non creda, deve fare il filosofo e il teologo il teologo, altrimenti il teologo diventa una figura
diabolica, come diceva Kierkegaard, se si immagina di dimostrare ciò che afferma; e il filosofo
quando fa il teologo diventa un predicatore e basta. Invece l’interesse del rapporto fra le due figure
sta nel mantenerli rigorosamente distinti. Il filosofo riconosce nel teologo colui che argomenta
sulla base di una rivelazione, di una parola che non è la sua ma è di Dio, riconosce che quella
spiegazione che narra il teologo è assolutamente ammissibile, ossia in alcun modo confutabile. “Io
credo che la mia libertà sia un dono”: questa è la posizione del credente. Il credente riconosce
perfettamente, come il filosofo che ragiona, che la libertà non è in alcun modo dimostrabile,
rappresentabile, lo avverte come un dono del libero arbitrio a libertade, il sommo dono. Entriamo,
quindi, in quella dialettica dinamica del dono che, per un pensiero tecnico-scientifico, è di nuovo
niente, poiché non può in alcun modo essere spiegata in questo caso sulla base di alcuna
razionalità tecnico-mercantile, di scambio; è qualcosa di gratuito nel senso più radicale del
termine, qualcosa che non può essere riducibile a quei meccanismi di relazione e di scambio che io
posso tecnicamente osservare e calcolare. Quindi il filosofo, di fronte a questa affermazione del
credente, cosa può dire? La può sentire soltanto come un complemento del suo discorso, che lui in
quanto filosofo non può affermare, perché la filosofia non si basa su alcun presupposto, mentre la
teologia si basa su quel presupposto che è il revelatum. In questa distinzione, però, non vi è
alcuna opposizione; anzi, sono entrambe discorsi che danno senso nella direzione che afferma che,
in questo caso, l’essenziale dell’esperienza dell’ “esserci” che siamo è questa dimensione di libertà
irriducibile a quelle relazioni di causalità naturale di cui si interessa la tecnica. E’ un risultato di
straordinaria importanza da cui ne nasce un secondo – anche questo è un discorso già indicato dal
prof. Monticone:
2. che è quello del rapporto tra IDENTITÀ e ALTERITÀ. Il filosofo dice: “io so di credere di essere
libero”, cioè “io so che non posso dimostrare di essere libero e quindi so di non poter che credere
di essere libero”; il credente dirà: “credo di essere libero poiché credo in Lui che mi ha liberato”
(distinzione rigorosa ma nessuna contrapposizione ed entrambe, invece, contrapposte rispetto al
discorso nichilistico). Io affermo questa mia libertà o questo credere nella mia libertà perché
voglio affermare la mia identità, la mia singolarità, quel singolo che voglio essere, altrimenti cosa
me ne farei della mia libertà? Questa esigenza insopprimibile di pensare la mia libertà da che cosa
deriva, se io non mi sentissi quel singolo, una singolarità irriducibile all’insieme? É da qui che
nasce questa esigenza di definire la mia identità. Guai a saltare questo passaggio. La costruzione
dell’identità deriva con ferrea logica dal discorso sulla libertà che abbiamo appena tentato di fare.
Ma come si sviluppa questa costruzione dell’identità? Naturalmente lo sviluppo non ha niente di
cronologico, è un ragionamento tutto in sincronia, anche se voi sentite un discorso che va avanti
nel tempo e avete la sensazione che un concetto segua all’altro cronologicamente. Come si
sviluppa, si articola questo discorso dell’identità? All’inizio, non cronologico, si porrà quasi
necessariamente sul piano conflittuale, guai a noi se pensiamo di poter evitare questo rischio
saltandola…poiché sappiamo che la costruzione dell’identità all’inizio comporta il rischio della
contrapposizione tra identità, saltiamo la fase dell’identità e passiamo immediatamente a non so
quale vago “abbracciamoci tutti”: negheremmo tutto il presupposto del pensiero della libertà che
abbiamo fatto. Allora c’è questo conflitto, questo possibile conflitto fra le identità – dico possibile
ma, a mio avviso, è assolutamente necessario – non può non esserci: io affermo la mia libertà,
penso, credo di essere libero, so di credere di essere libero, comunque affermo la mia libertà in
quanto singolo e voglio essere riconosciuto in questa mia identità, voglio che gli altri mi
riconoscano questa mia identità. Qui nasce un conflitto, e come può articolarsi, maturare? Soltanto
allorchè io maturo l’idea, il pensiero che proprio il mio voler essere riconosciuto nella mia identità
comporta la necessità dell’altro, poiché come - altrimenti - potrei sapere la mia identità ed essere
conosciuto dalla mia identità se non ci fosse chi la riconosce? Allora quell’altro chiamato a
riconoscere la mia identità mi è assolutamente necessario affinché io sia quel singolo. La
costruzione della mia singolarità avviene soltanto in un contesto plurale, non può mai essere
egocentrica. L’io non è nient’altro che uno dei protagonisti della mia identità, gli altri protagonisti
sono gli altri che la riconoscono e riconoscendola entrano nella mia identità, ne fanno parte
costitutiva. Qui deve combinarsi un rapporto di reciprocità, ma se non si combina questo rapporto
è il conflitto. Nulla ci assicura che questo conflitto non possa esplodere in modo devastante, ma
non vi sono scorciatoie. La reciprocità che dobbiamo maturare, costruire comporta il rischio di una
identità esclusiva, un rischio per quell’identità stessa, poiché se il rapporto di reciprocità non
funziona esplode anche la mia identità, poiché la mia identità è possibile soltanto logicamente
sulla base del riconoscimento dell’altro. Quando l’altro è annullato, sono annullato anch’io perché
chi mi riconosce? Dove scopro la mia identità e la mia libertà? Quindi il conflitto che avviene
sulla base del fallimento del gioco di reciprocità è un conflitto che annulla entrambi i contendenti.
Ecco perché il grande poeta tedesco Hölderlin diceva che ciò che c’è di più divino in noi è il
colloquio, ein Gespräch. Noi siamo un colloquio e questo è il dono degli dèi, il dono essenziale
degli dèi. Soltanto se si sente come un colloquio questo gioco di reciprocità e di riconoscimento
di identità, di riconoscimento reciproco, allora esprime la propria libertà e quell’esigenza di libertà
viene espressa. Di nuovo, dunque, il discorso logico-filosofico fatto è distinto e allo stesso tempo
coerente con quanto la teologia cristiana, in questo caso, deve ripensare: il discorso trinitario, che è
– senza alcun dubbio – la base teologica anche di quello che il prof. Monticone diceva poco fa. Lo
sfondo teologico è proprio quello: una identità che è un colloquio, che è il Dio cristiano. Una
identità che non è che un colloquio e non si chiude mai in una posizione che esclude l’altro.
Come già detto, esiste una differenza tra il teologo e il filosofo: il teologo narra di un revelatum, il
quale afferma che in quel dialogo che è il divino, il Dio cristiano, il Deus Trinitas, quel colloquio è
perfettamente risolto in un vincolo di agape, di caritas, e il filosofo, che indaga sull’ “esserci”
vedrà l’analogia con il Deus Trinitas, nel senso più forte e più fondato. Possiamo, dunque, avere
mescolanza, intesa, comunicazione tra queste due dimensioni del sapere filosofico e del credere,
nel contemporaneo, senza nessuna confusione e una mescolanza tra queste due dimensioni che
reagisce a quella che è la sfida fondamentale della cultura moderna contemporanea a questo tipo di
dar senso, di prospettiva, la quale afferma che al di là degli enti, dei pragmata non vi è che nulla,
niente può interessarci. Occorre comprendere che questa è la proposizione fondamentale sostenuta
da teologi, da filosofi, da coloro che sanno e da coloro che credono, ma in quella mescolanza
senza confusione questa proposizione fondamentale, questa cultura, questo pensiero egemone non
potrà che vincere, se non ha già vinto.
Dal dibattito:
La libertà, nella sua quintessenza, è uno spogliarsi. Io sono libero nella misura in cui non dipendo da
alcun bene. I Padri dicevano che i bona sono impedimenta. Nella Divina Commedia di Dante il
discorso sulla libertà si conclude nei Canti in cui Dante affronta il problema del voto. Mi dimostro
totalmente libero, quando mi spoglio di tutto, anche della mia libertà, votandomi. La mia libertà si
esprime perfettamente quando mi libero di tutto, anche di quel supremo dono che è stata la mia libertà,
facendone dono. Allora sono davvero ad immagine del dono che Dio mi ha fatto liberandomi
svuotandosi di quella sua presupposta Onnipotenza (Incarnazione, Kenosi , ecc ).
La fede deve avere una dimensione “pubblica”: praedicare Verbum, “andate e predicate”. Si presume
che quel Verbum sia predicabile in tutte le lingue. Una predicazione pubblica universale.
L’integralista quasi sempre pensa di possedere la verità nel suo cuore, nel suo privato: ciò di cui
intende convincere l’universo è ciò che lui tiene fermo nel suo cuore: la sua verità. Mentre il
praedicare Verbum che risuona nel vangelo si edifica proprio nel colloquio (vedi Paolo ad Atene). La
Parola si edifica, non è un fatto del cuore che esprimo fuori di me, fatto del cuore in base a cui cerco
di convincere gli altri. L’atteggiamento dell’integralista mette a repentaglio, quando addirittura non
nega, il valore costruttivo ed edificante – nel senso letterale del termine – proprio del colloquio e non
ha nulla a che fare con quella Veritas indaganda di tutta la grande teologia cattolica. La Verità è un
mio fatto e lo ritengo sufficientemente potente per essere – quando lo esprimo – convincente, nel
senso più forte e prepotente del termine. Tutto diverso è il praedicare Verbum, che è in gioco, che dà
da pensare nel vangelo.
Per il credente la dimensione pubblica della fede io ritengo sia essenzialmente il fare scandalo in ciò che si dice, in ciò
che si predica, in ciò che si fa, qualcosa che per il mondo è follia. Qualcosa, allora, che arresta il mondo, lo fa pensare:
“Cosa succede qui? Qui i miei conti non tornano, perché vi è una testimonianza: vi è quel matto, quel folle, che fa delle
cose che sono inciampo, che sono impedimento per il mondo”. Questa è, per me, la dimensione pubblica della fede,
altrimenti sarà un “fare” tra gli altri, più o meno nobile, ma un fare tra gli altri. Se non appare una follia al mondo, che
senso ha dire che quello è il “fare” del credente nel Deus Trinitas?
Testo ricavato dalla registrazione e non rivisto dall’autore
Massimo Cacciari: note biografiche
VITA
Massimo Cacciari è nato a Venezia il 5 giugno 1944, si è laureato in filosofia a Padova ed è
ordinario di Estetica presso l'Università della sua città. E' stato tra i fondatori di alcune delle più
importanti riviste italiane di filosofia e cultura, da Angelus Novus (1964-1974) a "Contropiano"
(1968-1971), a Laboratorio politico (1980-1985), a Il Centauro (1980-1985) fino a Paradosso,
nata nel 1992 e diretta con S.Givone, C.Sini e V.Vitiello. E' stato deputato al Parlamento dal 1976
al 1983. E' membro di diverse istituzioni filosofiche europee, tra cui il Collège de philosophie di
Parigi. Sindaco di Venezia nella penultima legislatura.
OPERE
Sulla genesi del pensiero negativo, in Contropiano, 2, 1968; Ristrutturazione e analisi di classe,
Padova, 1973; Piano e composizione di classe, Milano, 1975 (con p. perulli). Metropolis, Roma,
1973; OIKOS. Da Loos a Wittgenstein, Roma, 1975 (con f. amendolagine); Krisis, Milano 1976;
Pensiero negativo e razionalizzazione, Venezia, 1977; Dallo Steinhof, Milano 1980; Icone della
legge, Milano 1985; L'Angelo necessario, Milano 1986; Dell'inizio, Milano 1990.
PENSIERO
La ricerca filosofica di Cacciari prende avvio dallo studio del "pensiero negativo", anti-dialettico,
tra Schopenhauer e Nietzsche, di cui analizza le connessioni con la cultura letteraria, artistica e
scientifica del primo Novecento, soffermandosi in particolare sulla finis Austriae. In particolare
l'approfodimento del Nietzsche di Heidegger lo ha portato a una riconsiderazione dell'intera storia
della metafisica e dello stesso paradigma interpretativo heideggeriano. Nei suoi ultimi lavori la
problematica filosofica si intreccia con quella teologica, secondo una linea che si potrebbe definire
di rivisitazione critica della tradizione platonica. Parafrasando Heidegger, il suo problema
potrebbe essere sintetizzato così: che cosa significa "pensare", in un'epoca in cui la filosofia
appare definitivamente specializzata in ambiti particolari ? Vi è "inizio" del pensare, nel senso che
il pensare possa assumere proprio l'"inizio" a suo problema ? La storia filosofico-teologica
europea incentrata sulla nozione di "Deus-Esse" quale "principio" è interrogata dall'Autore alla
luce di questa domanda.