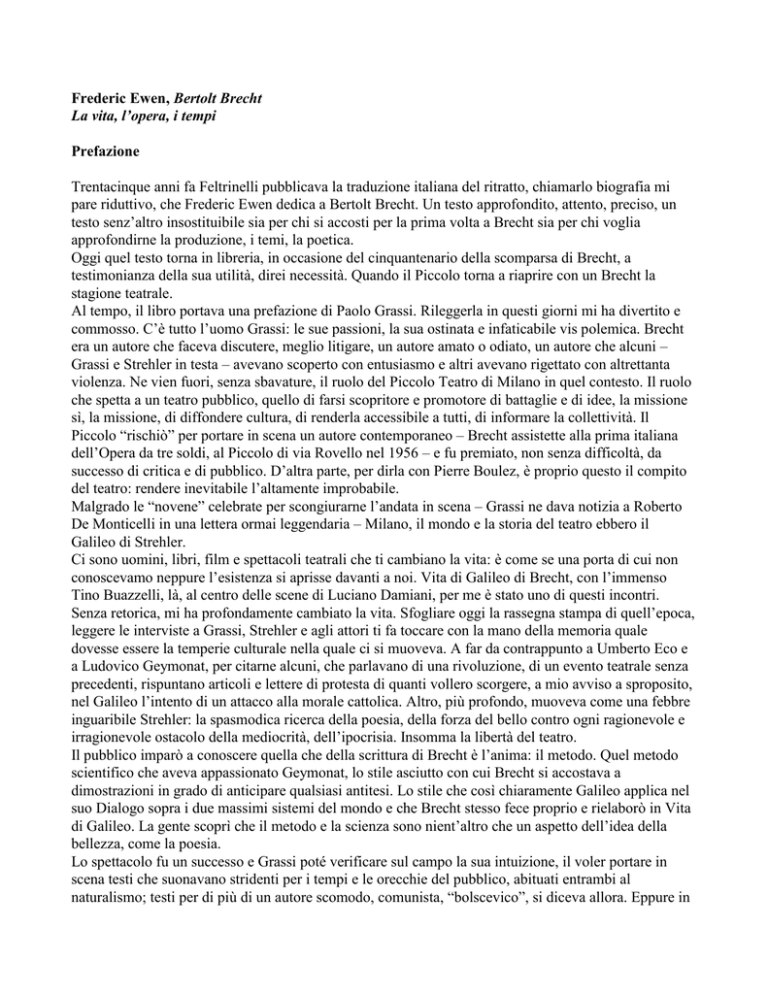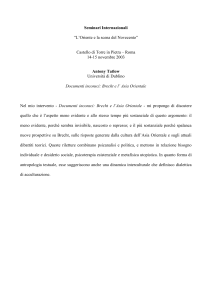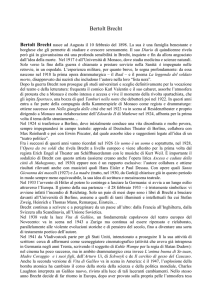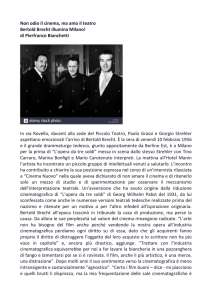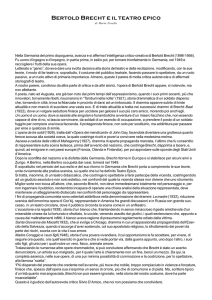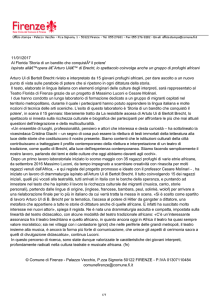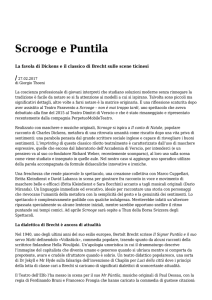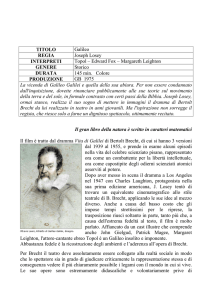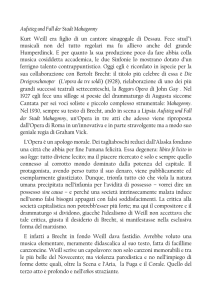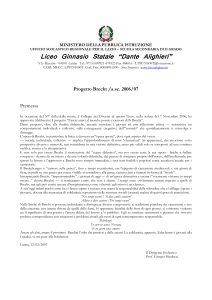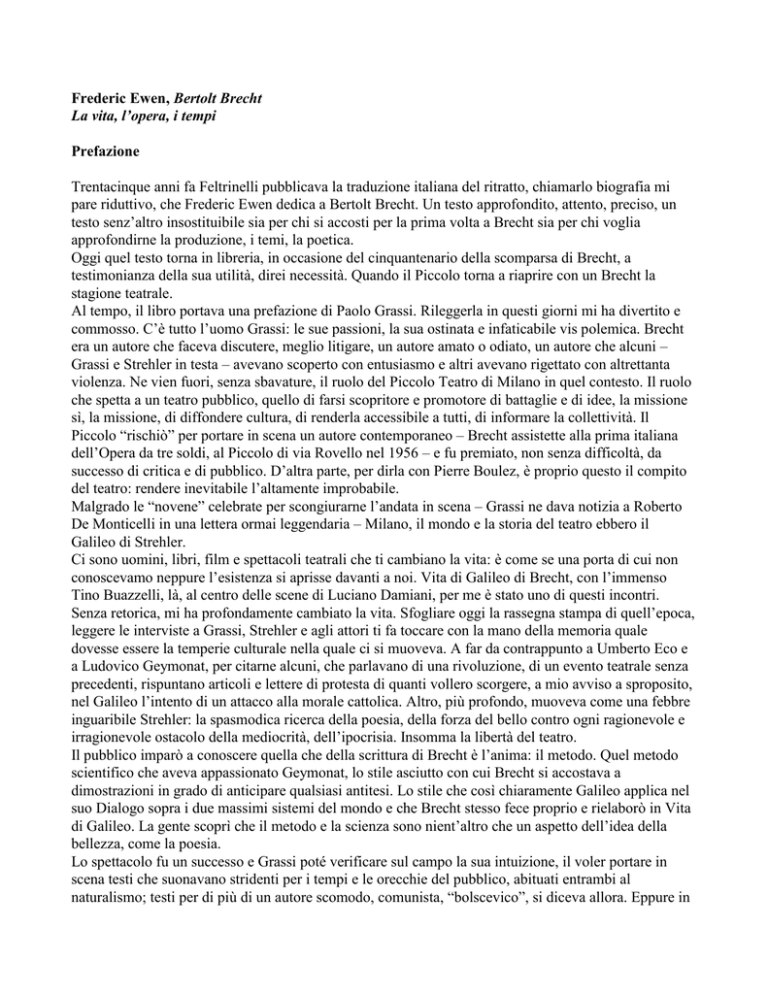
Frederic Ewen, Bertolt Brecht
La vita, l’opera, i tempi
Prefazione
Trentacinque anni fa Feltrinelli pubblicava la traduzione italiana del ritratto, chiamarlo biografia mi
pare riduttivo, che Frederic Ewen dedica a Bertolt Brecht. Un testo approfondito, attento, preciso, un
testo senz’altro insostituibile sia per chi si accosti per la prima volta a Brecht sia per chi voglia
approfondirne la produzione, i temi, la poetica.
Oggi quel testo torna in libreria, in occasione del cinquantenario della scomparsa di Brecht, a
testimonianza della sua utilità, direi necessità. Quando il Piccolo torna a riaprire con un Brecht la
stagione teatrale.
Al tempo, il libro portava una prefazione di Paolo Grassi. Rileggerla in questi giorni mi ha divertito e
commosso. C’è tutto l’uomo Grassi: le sue passioni, la sua ostinata e infaticabile vis polemica. Brecht
era un autore che faceva discutere, meglio litigare, un autore amato o odiato, un autore che alcuni –
Grassi e Strehler in testa – avevano scoperto con entusiasmo e altri avevano rigettato con altrettanta
violenza. Ne vien fuori, senza sbavature, il ruolo del Piccolo Teatro di Milano in quel contesto. Il ruolo
che spetta a un teatro pubblico, quello di farsi scopritore e promotore di battaglie e di idee, la missione
sì, la missione, di diffondere cultura, di renderla accessibile a tutti, di informare la collettività. Il
Piccolo “rischiò” per portare in scena un autore contemporaneo – Brecht assistette alla prima italiana
dell’Opera da tre soldi, al Piccolo di via Rovello nel 1956 – e fu premiato, non senza difficoltà, da
successo di critica e di pubblico. D’altra parte, per dirla con Pierre Boulez, è proprio questo il compito
del teatro: rendere inevitabile l’altamente improbabile.
Malgrado le “novene” celebrate per scongiurarne l’andata in scena – Grassi ne dava notizia a Roberto
De Monticelli in una lettera ormai leggendaria – Milano, il mondo e la storia del teatro ebbero il
Galileo di Strehler.
Ci sono uomini, libri, film e spettacoli teatrali che ti cambiano la vita: è come se una porta di cui non
conoscevamo neppure l’esistenza si aprisse davanti a noi. Vita di Galileo di Brecht, con l’immenso
Tino Buazzelli, là, al centro delle scene di Luciano Damiani, per me è stato uno di questi incontri.
Senza retorica, mi ha profondamente cambiato la vita. Sfogliare oggi la rassegna stampa di quell’epoca,
leggere le interviste a Grassi, Strehler e agli attori ti fa toccare con la mano della memoria quale
dovesse essere la temperie culturale nella quale ci si muoveva. A far da contrappunto a Umberto Eco e
a Ludovico Geymonat, per citarne alcuni, che parlavano di una rivoluzione, di un evento teatrale senza
precedenti, rispuntano articoli e lettere di protesta di quanti vollero scorgere, a mio avviso a sproposito,
nel Galileo l’intento di un attacco alla morale cattolica. Altro, più profondo, muoveva come una febbre
inguaribile Strehler: la spasmodica ricerca della poesia, della forza del bello contro ogni ragionevole e
irragionevole ostacolo della mediocrità, dell’ipocrisia. Insomma la libertà del teatro.
Il pubblico imparò a conoscere quella che della scrittura di Brecht è l’anima: il metodo. Quel metodo
scientifico che aveva appassionato Geymonat, lo stile asciutto con cui Brecht si accostava a
dimostrazioni in grado di anticipare qualsiasi antitesi. Lo stile che così chiaramente Galileo applica nel
suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e che Brecht stesso fece proprio e rielaborò in Vita
di Galileo. La gente scoprì che il metodo e la scienza sono nient’altro che un aspetto dell’idea della
bellezza, come la poesia.
Lo spettacolo fu un successo e Grassi poté verificare sul campo la sua intuizione, il voler portare in
scena testi che suonavano stridenti per i tempi e le orecchie del pubblico, abituati entrambi al
naturalismo; testi per di più di un autore scomodo, comunista, “bolscevico”, si diceva allora. Eppure in
una Milano che sosteneva Grassi col successo di botteghino, con la “complicità” del 99%
dell’intellighenzia e con l’appoggio delle istituzioni – per le prove del Galileo il Piccolo rimase chiuso
tre mesi, una situazione ora inimmaginabile! – anche allora, sulle pagine di quella prefazione scritta per
Feltrinelli nel 1970, Grassi sentiva già la necessità di giustificare, di difendere questa scelta: doveva
difendere Brecht, doveva attaccare chi lo criticava. Usava termini come “battaglia culturale”,
“polemica”.
Vivevamo in tempi oscuri? Non saprei. Forse ora la luce abbagliante che sembra pervadere ogni angolo
della nostra vita è in realtà artificiale, privata di passioni e di idee.
Allora, tra polemiche e battaglie, gli spettacoli andavano comunque in scena ed erano recensiti da tutti i
giornali, e i libri erano pubblicati: ora le luci si accendono solo sugli “eventi”.
E oggi? Possiamo dire che Brecht sia un autore che ancora spinge il pubblico a riflettere, a pensare, a
interrogarsi sul destino dell’essere umano? Io credo proprio di sì e mi oppongo a quanti lo considerano
superato perché ritengono che siano ormai venute meno le congiunture che lo portarono a scrivere i
suoi testi.
Brecht è un classico, e come tutti i classici “ti legge dentro”, e come tutti i classici non finirà mai di
dover essere interpretato: questa è la vera “prova del nove” di un classico, ancor più dell’essere, come è
accaduto a Brecht, tra i libri di testo dei nostri figli.
Questo significa che il teatro non può prescindere da Brecht e dalla sua lezione e che esiste, per la storia
del teatro occidentale, un “prima di Brecht” e un “dopo Brecht”.
C’è un saggio bellissimo di Roman Ingarden che pone il problema insolubile dell’opera musicale e
della sua rappresentazione. Qual è la “vera” opera musicale? Con cosa si identifica? Con la partitura?
Impossibile, poiché essa è solo un’accozzaglia di segni grafici incomprensibile a chi non sappia leggere
la musica. Con la prima esecuzione assoluta? Non è detto, è possibile che essa non coincida con quanto
il compositore intendeva significare. Con l’esecuzione ad opera dell’autore stesso? Altrettanto
impossibile: di un’opera lirica può essere data una versione al pianoforte che nulla ha a che vedere con
l’esecuzione orchestrale. Conclusione: non esiste un’opera musicale, non esiste un canone ideale di
rappresentazione.
Lo stesso discorso, a mio avviso, può applicarsi in toto al teatro. In che modo oggi possiamo
rappresentare Brecht in maniera sensata?
La società contemporanea deve stringere un nuovo patto artistico con Brecht: quel Brecht che Grassi e
Strehler amarono e rappresentarono, proprio in quel modo lì e non in un altro, aveva un senso in quanto
nasceva da un contesto storico e sociale che determinava uno stile, una cifra artistica oggi scomparsi. Il
teatro, come tale, vive solo e soltanto nel momento in cui si realizza la magia dell’incontro fra autore e
attori da un lato e pubblico dall’altro. Il Brecht che leggiamo e rappresentiamo oggi deve essere il
“nostro” Brecht, un Brecht che parla, meglio legge, nel cuore e nella testa degli spettatori con lo stesso
nitore che aveva allora.
La libertà straordinaria che i classici ci regalano è quella di essere opere aperte e definitive, di fare della
imperfezione della loro interpretazione la forza e non la debolezza del nostro lavoro. Madre Coraggio,
oggi, è una creatura tristemente contemporanea. Il suo istinto di sopravvivenza, la sua ambiguità che
passa sopra a tutto e a tutti è lo stesso sentimento che anima i profughi dei paesi che oggi sono teatri di
guerra (sarebbe meglio dire scene del crimine...). L’idea che la guerra arricchisca pochi grazie al
sacrificio di molti è della stessa terrificante attualità: finché c’è guerra c’è speranza diranno sempre i
mercanti d’armi e i venditori di morte.
La stessa formula di “classico-e-perciò-contemporaneo” può essere con altrettanta facilità applicata a
moltissime altre opere brechtiane: penso all’Eccezione e la regola, a Quanto costa il ferro?, entrambe
ferocemente legate ai vizi della società degli uomini, di un mondo dominato e ottenebrato dall’interesse
economico a discapito di qualsiasi rudimento di umana pietà.
L’arte di Brecht coincide anche con un altro valore assoluto dell’arte: la poesia, che in Brecht assume –
alcuni direbbero “inaspettatamente”, abituati alla durezza e al sarcasmo dell’Opera da tre soldi o della
Resistibile ascesa di Arturo Ui – tratti di toccante tenerezza; penso all’Anima buona di Sezuan e alla
sua struggente riflessione sull’impossibilità di essere buoni in un mondo divoratore o proprio al
Galileo: “com’è la notte? Chiara...”.
E penso anche alla profonda influenza estetica che l’opera brecht- iana ha esercitato su alcuni grandi
maestri del nostro cinema contemporaneo, artisti che sposano un nuovo modo moderno e
originalissimo di usare la cinepresa a uno stile che in Brecht trova il suo capostipite: Dogville di Lars
von Trier non è che il primo esempio illustre che mi viene ora in mente. Cinema didattico? Dopo il
teatro didattico? Molto di più, una feroce ironia che si sposa ad un distacco, apparente, dalla realtà che
si vuole rappresentare. Quanta passione in quelle immagini. Quanta passione in quelle parole.
Rileggere Brecht non può più dare, per chi ci abbia mai creduto, la “linea politica”. Ci può, per
contrasto, far capire dove siamo arrivati: ideologie anemiche di passioni che nascondono le stesse
atrocità. Oggi possiamo guardare a Brecht con un effetto di straniamento: raggiungere il cuore del suo
pensiero.
“Un altro libro su Brecht? Certo, dal momento che si è appena incominciato, questa è la verità che non
va dimenticata, a lavorare con lui.” Così concludeva Grassi in quella lunga prefazione del 1970.
“Ancora Brecht?” possiamo dire noi, oggi. Certo, perché ri- pubblicarne la biografia – e, perché no,
anche gli altri testi lette- rari – e rimetterlo in scena con occhi nuovi, con diversa sensibilità, con un
nuovo bagaglio culturale e storico è un’esigenza che sentiamo primaria.
Brecht, ci piace pensarlo, ci guarderebbe sornione, con l’immancabile sigaro e gli occhi abitati dalla
luce penetrante dell’intelligenza.
Sergio Escobar
Direttore Piccolo Teatro di Milano