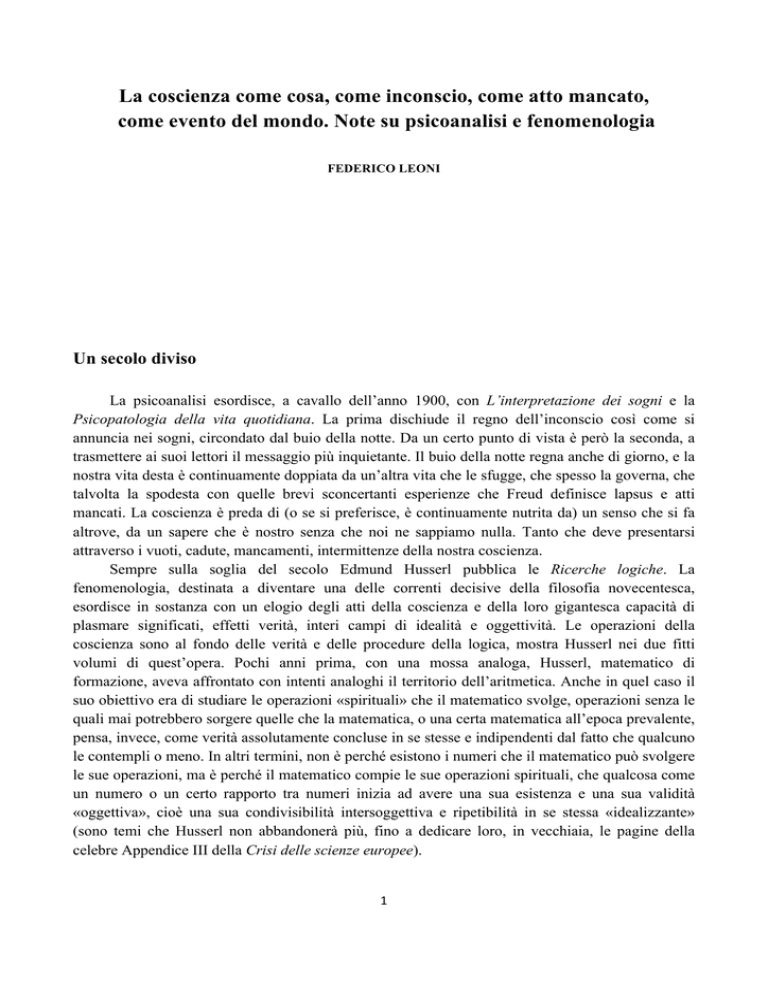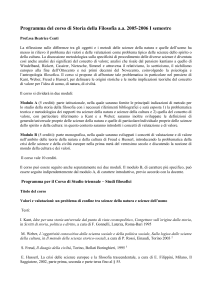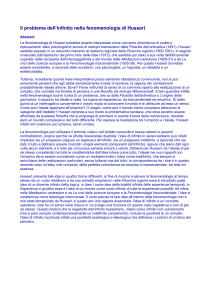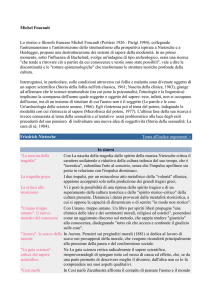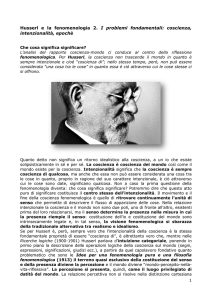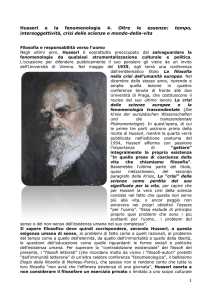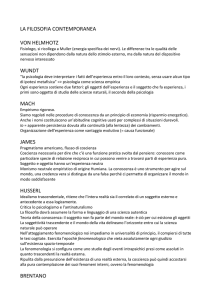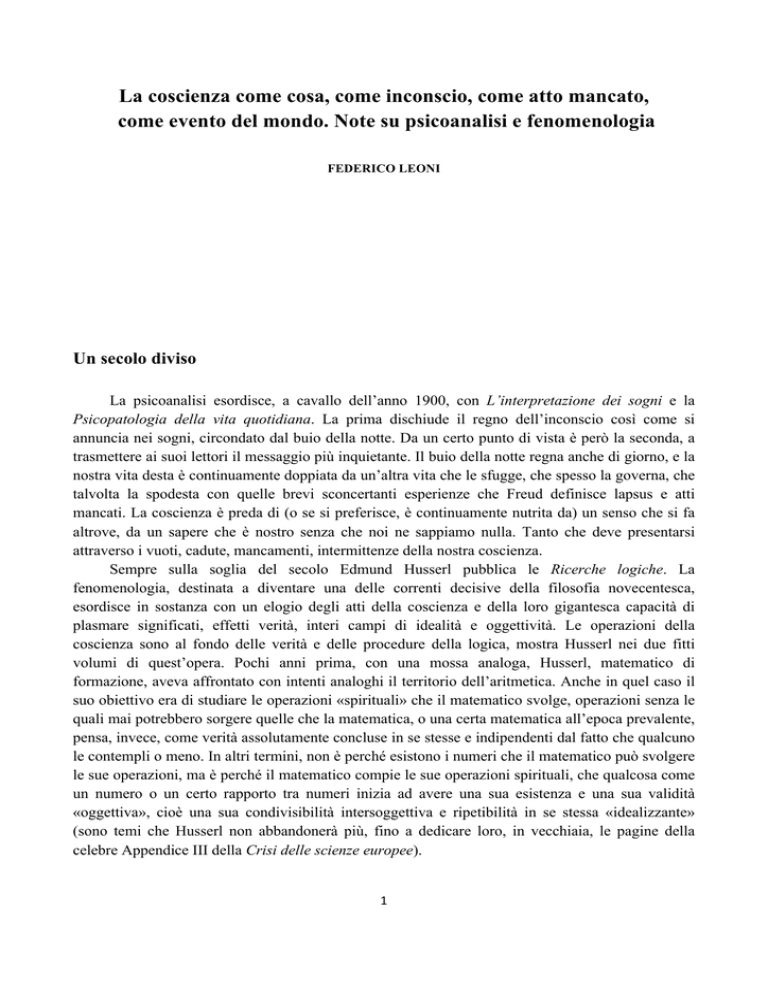
La coscienza come cosa, come inconscio, come atto mancato,
come evento del mondo. Note su psicoanalisi e fenomenologia
FEDERICO LEONI
Un secolo diviso
La psicoanalisi esordisce, a cavallo dell’anno 1900, con L’interpretazione dei sogni e la
Psicopatologia della vita quotidiana. La prima dischiude il regno dell’inconscio così come si
annuncia nei sogni, circondato dal buio della notte. Da un certo punto di vista è però la seconda, a
trasmettere ai suoi lettori il messaggio più inquietante. Il buio della notte regna anche di giorno, e la
nostra vita desta è continuamente doppiata da un’altra vita che le sfugge, che spesso la governa, che
talvolta la spodesta con quelle brevi sconcertanti esperienze che Freud definisce lapsus e atti
mancati. La coscienza è preda di (o se si preferisce, è continuamente nutrita da) un senso che si fa
altrove, da un sapere che è nostro senza che noi ne sappiamo nulla. Tanto che deve presentarsi
attraverso i vuoti, cadute, mancamenti, intermittenze della nostra coscienza.
Sempre sulla soglia del secolo Edmund Husserl pubblica le Ricerche logiche. La
fenomenologia, destinata a diventare una delle correnti decisive della filosofia novecentesca,
esordisce in sostanza con un elogio degli atti della coscienza e della loro gigantesca capacità di
plasmare significati, effetti verità, interi campi di idealità e oggettività. Le operazioni della
coscienza sono al fondo delle verità e delle procedure della logica, mostra Husserl nei due fitti
volumi di quest’opera. Pochi anni prima, con una mossa analoga, Husserl, matematico di
formazione, aveva affrontato con intenti analoghi il territorio dell’aritmetica. Anche in quel caso il
suo obiettivo era di studiare le operazioni «spirituali» che il matematico svolge, operazioni senza le
quali mai potrebbero sorgere quelle che la matematica, o una certa matematica all’epoca prevalente,
pensa, invece, come verità assolutamente concluse in se stesse e indipendenti dal fatto che qualcuno
le contempli o meno. In altri termini, non è perché esistono i numeri che il matematico può svolgere
le sue operazioni, ma è perché il matematico compie le sue operazioni spirituali, che qualcosa come
un numero o un certo rapporto tra numeri inizia ad avere una sua esistenza e una sua validità
«oggettiva», cioè una sua condivisibilità intersoggettiva e ripetibilità in se stessa «idealizzante»
(sono temi che Husserl non abbandonerà più, fino a dedicare loro, in vecchiaia, le pagine della
celebre Appendice III della Crisi delle scienze europee).
1 Si diceva di una certa matematica all’epoca prevalente. Dal punto di vista di questa
matematica, che per un verso può apparire molto positivistica e razionalistica, per un altro
semplicemente e sfrenatamente platonica e molto tradizionalmente metafisica, la mossa di Husserl
appare senza dubbio come un attentato propriamente irrazionalista alla dignità perfettamente
autonoma degli oggetti e delle verità su cui opera il matematico. La coscienza del matematico si
limita a scoprire oggetti e rapporti tra oggetti del tutto indipendenti da lui. Se tutto si fondasse sulla
coscienza, sulle operazioni della ragione umana, allora dell’oggettività della più oggettiva delle
scienze non ne sarebbe più nulla. Dal punto di vista di Husserl, la tesi della fenomenologia non fa,
invece, che prolungare il progetto illuminista di una compiuta rifondazione delle scienze e delle loro
verità nella ragione e nelle operazioni della ragione, esse stesse razionalmente esplorate e illuminate
in ogni dettaglio e ogni piega nascosta, in ogni possibilità di evoluzione e in ogni limite di senso. La
verità e l’oggettività del sapere, questo il punto di mira ultimo dell’impresa husserliana,
mostreranno infine di non avere né più né meno validità di quella che garantisce loro il fondamento
delle operazioni della coscienza da cui esse discendono in linea diretta. E proprio questo è l’esito
speculativamente più profondo dell’itinerario complessivo di Husserl. La coscienza è il limite di
validità della verità, ma anche la fonte di validità della verità e dell’oggettività; in ultima analisi, la
coscienza è una sorta di cammino hegeliano verso l’autocoscienza, in grado di giungere a un punto
di perfetta autotrasparenza in cui limite della verità e validità della verità si rivelano come le due
facce di uno stesso foglio e si «salvano» l’un l’altra dai rischi simmetrici del realismo platonicopositivista e dell’infondatezza empiristico-relativista.
I due volti di Descartes
Si direbbe, così, che il secolo scorso sia iniziato all’insegna di una scissione. Da un lato chi ha
voluto mettere la verità sul conto della coscienza, dall’altro chi ha voluto metterla sul conto
dell’inconscio. Ma non è così.
Per comprenderlo, è sufficiente risalire alle spalle di Husserl, e rileggere Husserl alla luce
della sua stessa provenienza, cogliendo così il senso, oltre che la lettera, del suo coscienzialismo.
Ora la mossa husserliana è una mossa essenzialmente cartesiana, e per comprenderla è utile
rimetterla in prospettiva a partire, se non altro, quella che è la «scena» cartesiana più nota e più
paradigmatica. Descartes è, per antonomasia, il pensatore razionalista, il pensatore della trasparenza
del cogito, della coscienza come fondamento unico e ultimo della soggettività del soggetto non
meno che della verità e dell’oggettività delle scienze. Ma anche Descartes è un pensatore dai due
volti, stranamente divisi e implicati l’uno nell’altro, e con quei due volti il cartesianismo non ha mai
finito di fare i conti – compreso il cartesianismo della fenomenologia husserliana e, per tanti versi,
posthusserliana.
Dunque, il primo volto di Descartes è quello dell’Ego cogito. Il testo chiave, in questo caso, è
quello del Discorso sul metodo, mentre l’esposizione più ampia e complessa si trova nelle
Meditazioni sulla filosofia prima. La tesi cartesiana è una sola, semplice a dirsi quanto sconcertante
a pensarsi. Tutto è, anzitutto, una mia rappresentazione. Questa è la sola certezza. Potrei dubitare
dell’esistenza di ogni cosa, questo tavolo e questa lampada potrebbero essere illusioni, ma di una
cosa non posso dubitare: io sto, appunto, dubitando, e quindi pensando, ad esempio queste stesse
rappresentazioni intorno a cui dubito e penso. Questa scena contiene il paradigma del Descartes
2 coscienzialista, padre nobile di Kant e di Husserl, appunto. L’Io, la coscienza, sono il fondamento a
partire da cui ricostruire l’enciclopedia delle scienze. È questa la sola certezza a partire dalla quale
ricostruire l’edificio della verità, tra le macerie dei saperi tradizionali e delle loro infinite
contraddizioni e approssimazioni.
Il cammino della ricostruzione cartesiana è lungo e complesso; non lo seguiremo in queste
pagine; limitiamoci ad annotarne, per quanto qui importa, questo punto di partenza; la certezza
indubitabile coincide con una formula che recita: «ego cogito, ego sum». Il secondo Descartes è
inscritto in queste poche mosse speculative, forse in questa stessa formula così sintetica e profonda,
come una specie di loro controcanto nascosto. È sufficiente osservare, per iniziare a cogliere
qualcosa di quel controcanto, che questo «Io» che pensa, questa «coscienza» che scopro come
fondamento ultimo, sono anch’essi dei contenuti, delle rappresentazioni, delle «cose» che incontro
pensando e dubitando, al pari del tavolo e della lampada di cui sopra. La coscienza, l’Io di cui
stiamo parlando, sono, in altri termini, degli oggetti, o se si preferisce delle rappresentazioni. Ciò
che so, compreso il fatto che lo so, e che lo so di un sapere tutto «mio», tutto inscritto in quell’«Io»
che io appunto sono, presuppone così una coscienza ulteriore, che agisce un passo a lato rispetto a
quell’io e a quella coscienza che pensavo di aver individuato come fondamento ultimo; coscienza
ulteriore che rimane sempre perfettamente inafferrabile in ciascuno dei contenuti che pure le
appartengono, in cui pure si dà a vedere obliquamente, come di sbieco. Non si troverà in Descartes
un’affermazione netta e univoca di questo rovescio del suo discorso, ma tutte le premesse di questo
rovescio sono date nella scena poco fa evocata. La conclusione è inevitabile, egli stesso la lascia
balenare qua e là. Husserl non potrà non vederla e affermarla a chiare lettere, quando ripercorrerà a
suo modo la via cartesiana. Merleau-Ponty, ideale discepolo di Husserl e suo interprete ad oggi più
originale e profondo, dedicherà alla questione le ultime lezioni del suo ultimo corso al Collège de
France (Merleau-Ponty, 1960-61).
La situazione, nel suo nocciolo speculativo, potrebbe essere così sintetizzata. C’è una
coscienza come atto; questa coscienza come atto è cosciente di varie cose (questa lampada, ad
esempio), e anche di sé (sono proprio io a pensare questi pensieri, e così via). Ma, appunto, è
cosciente di sé non come coscienza in atto, bensì come coscienza-fatto, come coscienza-oggetto,
come coscienza-cosa tra le cose, come coscienza rappresentata e fatta oggetto di riflessione e
rappresentazione (nel senso che, se ne ho esperienza, ho già solo per questo presupposto, a lato,
quest’altra esperienza «in cui» ne ho appunto esperienza, rappresentazione o riflessione). Come
atto, come coscienza non «che è rappresentata» ma «che rappresenta», la coscienza è invece
integralmente inconoscibile, anche se non sta altrove che nel conoscibile e nel conosciuto, sorta di
bordo impalpabile, di limite privo di spessore e di figura, senza il quale tuttavia nessuna figura
dell’esperienza potrebbe disegnarsi e prendere corpo. L’atto della coscienza è strutturalmente
inconscio. Conscio è, piuttosto, il «fatto» della coscienza. Ma quel fatto, per esserci per noi, deve
sfuggire interamente a noi in quanto atto, gesto, movimento, evento. Per quanto paradossale, è
questa l’unica formulazione in grado di documentare il senso della remota e inaggirabile avventura
cartesiana in direzione dei fondamenti ultimi del sapere e dell’esperienza umana. L’atto della
coscienza, potremmo dire, è, per definizione, un atto mancato. Mancato, cioè, dalla coscienza
stessa, che può certo tentare di saperlo, ma che, proprio tentando di saperlo, non fa che afferrarlo
per un verso, e per altro verso proiettarlo in avanti, come un oggetto tra gli oggetti, retrocedendo se
3 stessa alle spalle di quell’oggetto, come a delineare un nuovo margine non saputo, orlo inafferrabile
di quello stesso afferrare.
L’assoluto della fenomenologia
È quanto Husserl vede perfettamente, a qualche anno di distanza dalle Ricerche logiche,
quando la sua indagine non si rivolge più all’ambito della coscienza in maniera per così dire
strumentale, intendendola come il luogo costitutivo delle verità e delle oggettività logiche o
aritmetiche, che erano obiettivo privilegiato delle sue prime ricerche, ma si rivolge alla coscienza
facendone il campo stesso e il fine ultimo della riflessione fenomenologica (si pensi, in particolare,
alle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica).
Ciò che Husserl vede a quest’altezza è che la coscienza, insieme, è l’orlo di ogni cosa e una
delle cose iscritte in quell’orlo. I riferimenti testuali si potrebbero moltiplicare. «Il mondo è nel
supporto della coscienza, ma la coscienza non ha bisogno di supporto», si legge nelle lezioni del
1907 su La cosa e lo spazio (Husserl, 1973, 40). La coscienza «vera», in altre parole, non è la
coscienza che individuo come fondamento, come cosa nel mondo, ma è quel margine che sfugge
proprio a partire dalla coscienza-fondamento, è quel movimento che si allontana dalla coscienzaoggetto e dalla coscienza «saputa», come quella coscienza inconoscibile che la pone e la orla
assentandovisi ogni volta. Quel margine non ha un margine ulteriore, non è inscritto in un altro
perimetro. Che non abbia bisogno di supporto, significa peraltro non che esso sia un punto fermo,
ma che esso si muove in una fuga incessante.
«L’io stesso è già una cosa», scrive ancora Husserl in quel testo, «che può costituirsi e
rendersi presente solo entro la cornice e le forme dell’intenzionalità» (Husserl, 1973, 40-41).
Dunque, potremmo chiosare, l’intenzionalità, altro nome husserliano della coscienza, non ha nulla
dell’Io, del suo sapere, della sua presa sulle cose. È senza nome, senza contenuto, senza luogo.
Ancora: «L’io che attingo nell’epoché (...) è denominato io soltanto per un equivoco» (Husserl,
1954, 210). Infine, nella stessa pagina «Il pensiero a cui si giunge, qui, è il pensiero di nessuno». Se,
fenomenologicamente, ogni cosa è un «fenomeno», cioè un oggetto dato «alla coscienza», un
oggetto che è oggetto di esperienza «per la coscienza» che lo percepisce, lo ricorda, lo immagina, lo
intenziona (compreso quell’Io di cui facciamo esperienza come del nostro Io), allora la coscienza,
nel suo movimento ultimo, non è affatto «per» altro e per qualcuno o «di» qualcuno; è, piuttosto,
ciò «per il quale» ogni cosa è data, o ciò «nel quale» ogni cosa è data. La coscienza è l’orlo ultimo
nel quale ogni coscienza è inscritta, e poiché quell’orlo non è iscritto in nessuna altra cosa,
quell’orlo è assoluto. Ovvero, è letteralmente assolto da ogni relazione, e segnatamente è assolto
dalla relazione di datità ad altro e per altro.
Così, la coscienza è un assoluto, o è il nome «fenomenologico» dell’assoluto, non nel senso
che, come spesso si sente ripetere, la coscienza sarebbe interamente trasparente a se stessa, o che la
fenomenologia creda alla possibilità di portare alla trasparenza l’intero dell’esperienza. Questo è
solo un primo livello del discorso husserliano. L’assolutezza della coscienza significa precisamente
il contrario: che tutto ciò che viene all’esperienza, tutto ciò che ci è «dato» e che vale per noi come
un oggetto di percezione o ricordo, come una cosa vissuta o un contenuto di sapere, «viene»
all’esperienza a partire dalla soglia di quella stessa esperienza, che è perciò stesso radicalmente
4 sottratta alla possibilità di farsi oggetto d’esperienza. Che essa sia assoluta significa non che sia
stabile e determinabile, ma al contrario che sia indicibile e inconoscibile (se non a partire dal detto e
come una sorta di resto evidente e inoggettivabile di ogni cosa detta, saputa, oggettivata in un
sapere, articolata in un’esperienza). Essa non è altro che questo puro «venire», questo evento
assolutamente spoglio e anonimo. Ciò che nella lingua di Descartes si enuncia «ego cogito, ego
sum», nel linguaggio fenomenologico di Heidegger si dice «essere-nel-mondo». Del resto, voler essere coscienti della coscienza sarebbe un po’ come voler vedere la luce. Se
la luce è ciò che illumina e rende visibile, vedere significa sempre vedere qualcosa di illuminato,
non ciò che illumina; significa vedere sempre un effetto, non la sorgente di quell’effetto.
«Inconscio», nel senso della fenomenologia, non è, dunque, un ordine di significati o di
rappresentazioni che si fanno in me, ma a mia insaputa, come ad opera di un altro me stesso; e
neppure è un altro Io, che lavora di nascosto da quell’Io che sta parlando e riflettendo in questo
momento. Inconscio è semplicemente il fatto che qualcosa accede alla coscienza, grazie al lavoro
della coscienza. Inconscio è il modo d’essere o di operare della coscienza. Meglio, è il fatto stesso
che la coscienza non è nulla se non un operare, un accadere. Per questo stesso motivo, nessuno dei
termini abitualmente connessi all’idea della coscienza può più legittimamente applicarsi a essa. La
coscienza non sarà «mia», poiché «Io» e «mio» sono contenuti di coscienza, resi possibili dalle
operazioni della coscienza, ma niente affatto coincidenti con la coscienza stessa. La coscienza non
sarà nulla di «personale», poiché tutto ciò che è personale è dell’ordine del contenuto, della vicenda
biografica, dell’oggettivazione e dell’auto-oggettivazione. La coscienza non sarà nulla di intimo o
di interiore, dato che l’idea stessa che ci sia un dentro e un’interiorità presuppone l’idea di una serie
di contenuti che riempirebbero quel dentro, e presuppone la rappresentazione di quel dentro come
esso stesso un contenuto o un oggetto. Non sarà nulla di «storico», nel senso di un luogo in cui si
sedimentano ricordi ed esperienze, perché sarà il puro movimento in virtù del quale qualcosa passa
e si sedimenta, non il risultato di quel passare e sedimentarsi. Né sarà qualcosa di «esteriore», nel
senso di un oggetto o di una serie di oggetti comunque sperimentabili e conoscibili, vuoi nel senso
di un oggetto «spirituale», come alcune psicologie hanno ipotizzato (e alcune logiche; in fondo, lo
stesso Frege pensava così gli oggetti logico-matematici), vuoi come di un oggetto «naturale», come
ogni scienza presuppone (non notando quello che Husserl in vecchiaia porrà al centro del suo
lavoro, che, cioè, ogni oggettività scientifica va spiegata con quelle operazioni «vitali» o
«spirituali» che essa pensa invece di poter spiegare).
L’evento del mondo
Né interna né esterna, né presente né passata, né mia né non-mia, la coscienza è ciò in cui
interno ed esterno, presente e passato, mio e non-mio coincidono perfettamente, così perfettamente
da non essere affatto quelle due cose insieme, ma non ancora l’una né l’altra. Ed è anche ciò che
ogni volta tuttavia introduce, in quel blocco originario e inimmaginabile, delle discriminazioni,
delle differenze, dei significati articolati, delle oggettività «sapute» e coscienti, alle quali perciò
stesso si sottrae.
In una parola, la coscienza non sarà nulla di «consistente», nulla di solido e determinato, nulla
di indagabile per sé. La sua esistenza potrà essere inferita soltanto obliquamente; si dovrà ipotizzare
5 la sua esistenza a partire dagli effetti che essa produce, ma non accedervi direttamente e
positivamente; si darà a vedere in ciò che vediamo come una sorta di lacuna o di mancanza, non
come un elemento stabilmente definito; si dovrà coglierla in ciò che essa supporta e alimenta,
sottraendovisi come un vuoto e una caduta sempre imminente. Essa avrà, se si vuole, la struttura di
un lapsus nel tessuto bene ordinato del nostro discorso corrente; avrà la movenza improvvisa e
imprevedibile di un atto mancato, che scompagina i nostri progetti con la forza di un «no» tenace
quanto indeterminato positivamente. Peraltro, anche questa strana successione di «non», attraverso
cui stiamo tentando di definirla, va guardata con sospetto e merita qualche dubbio. Ci apparirebbe
forse come qualcosa di positivo, se solo immaginassimo per un istante di poterci installare in quel
punto assolutamente estraneo a noi, in cui essa accade in noi. La coscienza in atto non è nessuno dei
suoi contenuti, ma sono i contenuti a costituirne una «diminuzione». L’atto è negativo se misurato
sul metro del fatto, ma assolutamente positivo, o al di qua della distinzione tra positivo e negativo,
se pensato per se stesso. E pensato per se stesso, questo atto in cui viene all’esperienza l’intero
mondo di cose e volti di cui facciamo continuamente esperienza, non è che l’evento stesso del
mondo. Inconscio, in una parola, è l’evento della coscienza in quanto soglia del mondo, che è
contemporaneamente del mondo e fuori dal mondo. Inconscia è la venuta del mondo all’esperienza
e la nostra «consustanzialità» col mondo che viene all’esperienza, consustanzialità che si rinnova
ogni volta nella soglia comune di quella stessa venuta.
Fenomenologia terminabile e interminabile
Il che offre un buon punto d’osservazione per chi voglia riflettere sulla natura della
fenomenologia, che in questo senso è molto più un esercizio (come sottolineava l’ultimo Husserl)
che un sapere codificato, molto più una pratica (come in Italia hanno mostrato ad esempio Enzo
Paci [1961] e Carlo Sini [1997]) che una teoria.
Ciò che il fenomenologo fa, in ultima analisi, è partire da certi oggetti dell’esperienza, da
certe evidenze di fronte alle quali ci troviamo, e notare anzitutto che quegli oggetti sono tutt’uno
con l’esperienza che ne abbiamo, cioè che è impossibile scorporare l’oggetto dall’esperienza
dell’oggetto (in quanto l’oggetto scorporato dall’esperienza dell’oggetto è ancora un oggetto
esperito: esperito, appunto, come un oggetto scorporato dal nostro esperire; sicché anche lo
scorporare è un esperire, o in altri termini è per me che un oggetto può apparire in sé). Notata questa
connessione ineliminabile tra l’oggetto e la coscienza che ne abbiamo, il fenomenologo si dedica a
studiare la coscienza stessa, che è quanto dire la superficie in cui ogni oggettività è iscritta, il campo
che decide della forma e del significato di quell’oggettività, e in questo senso il piano del vero
«essere» delle cose. Il fenomenologo mira quindi a riportarsi a quel punto originario
dell’esperienza, a quella linea di coincidenza tra il dentro e il fuori, tra il passato e il presente, tra il
mio e il non mio, per poi vederne discendere gli effetti di evidenza e di sapere che l’osservatore
ignaro di fenomenologia assume come sussistenti in sé; per notarne cioè la cogenza e insieme la
perfetta contingenza rispetto a quel piano «assoluto» in cui sono iscritti.
Ed è a quest’altezza che il fenomenologo nota che riportarsi a quel punto significa però
obiettivarlo, isolarlo in una sorta di figura o di oggetto, dunque tradirlo in quanto orlo
inoggettivabile di ogni oggettivazione; e quindi è a quest’altezza che il fenomenologo ricomincia da
capo e non può non ricominciare da capo. La fenomenologia è, così, un’analisi dell’esperienza
6 assolutamente «terminabile» sul piano dei contenuti: posso ben dire che cos’è la coscienza secondo
Husserl, o scrivere un articolo sul tema della coscienza, magari affermando che la coscienza è
radicalmente inconscia e che la coscienza può essere definita solo per via negativa, o come evento
del mondo e delle cose dell’esperienza, così esaurendo quella che vale come una sorta di «prima»
analisi del problema. Ma, appunto, questi sono solo contenuti della fenomenologia come sapere,
come insieme di teorie, come repertorio di mosse metodologiche e verità derivanti da quelle mosse;
altro è l’esercizio che stava dietro quei contenuti, che ora è svanito come la mano dal foglio su cui
resta scritto un appunto. Non c’è che da ricominciare, da trasmetterlo ad altri, in primis a quegli altri
che tutti noi diventiamo di continuo rispetto a quanto ha scritto e pensato poco fa, anche, tra l’altro,
per il fatto di averlo scritto e pensato. E su questo versante l’analisi fenomenologica è propriamente
interminabile, perché produce continuamente ciò che andrà poi ad analizzare, cioè la coscienza
delle cose e l’esperienza del mondo che via via incontriamo; e la produce come ciò che deve
sottrarsi all’analisi stessa, proprio in quanto rende quell’analisi possibile. Perciò la fenomenologia
ricomincia sempre da capo, come Husserl diceva, non per un suo difetto rispetto alla «cosa» che
dovrebbe esplorare, ma per la natura di quella stessa cosa, che è di non essere una cosa ma un
evento. Portarsi a lambire quell’evento che non è nulla di commensurabile significa portare la
propria esperienza e la propria misura a lambire qualcosa che resta incommensurabile, cioè
strutturalmente «inconscio»; e che si produce e riproduce di continuo come incommensurabile,
come inconscio, pur senza essere altrove che nella nostra misura e per la nostra misura. Se si vuole,
è un esercizio che ha qualcosa di ascetico e paradossale, che a molti è destinato a restare estraneo e
che può senza dubbio apparire esasperante e inconcludente: sfiorare l’accadere del mondo, nel quale
coincidiamo col mondo e perciò nulla sappiamo del mondo; per poi rimbalzarne via, perdendo di
nuovo quell’accadere; guadagnandolo perciò in una distanza in cui imparare a «saperlo»; e ancora,
in quella distanza, reimparare a perderlo nel sapere, per tornare a sfiorarlo come evento.
SINTESI
Freud e Husserl sembrano guardare all’enigma del senso da prospettive divergenti : l’uno
assegnerebbe la genesi del senso alla dimensione dell’inconscio, l’altro alla dimensione della coscienza.
Avvicinarsi al pensiero fenomenologico della coscienza significa invece scompaginare questa partizione, e
vedere nel pensiero fenomenologico della coscienza il farsi dell’esperienza al di sotto della soglia dei
significati che abitualmente leggiamo e progettiamo in essa. La coscienza è, così, il nome fenomenologico
dell’inconscio.
PAROLE CHIAVE: fenomenologia, psicoanalisi, coscienza, inconscio
BIBLIOGRAFIA
E. Husserl (1954), Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie,
hrsg. W. Biemel, «Husserliana», Bd. 6, M. Nijhoff, Den Haag.
E. Husserl (1973), Ding und Raum. Vorlesungen 1907, hrsg. v. U. Claesges, Husserliana, Bd. VI, Nijhoff,
Den Haag.
E. Paci (1961), Diario fenomenologico, Bompiani, Milano.
C. Sini (1997), Scrivere il fenomeno. Fenomenologia e pratica del sapere, Morano, Napoli.
M. Merleau-Ponty (19060-1961), L’ontologie cartesienne et l’ontologie d’aujourd’hui, in Notes de cours au
Collège de France 1958-59 et 1960-61, Gallimard, Paris 1996.
7 8