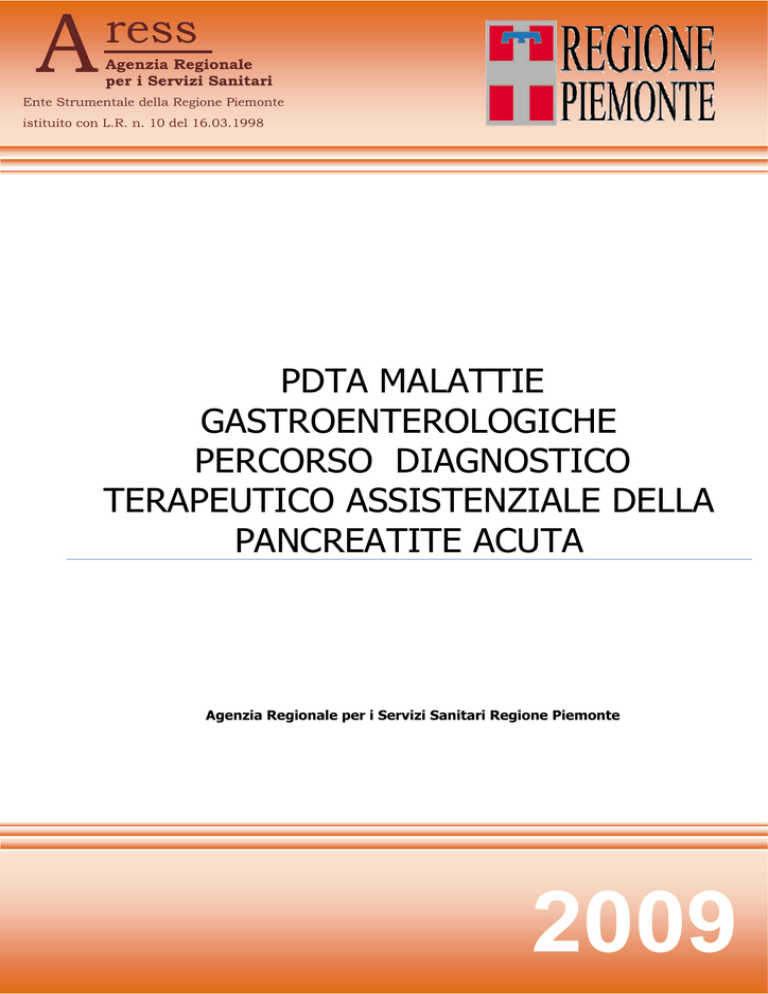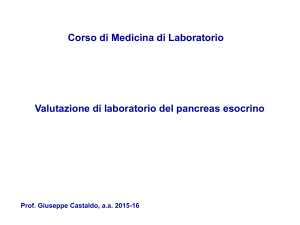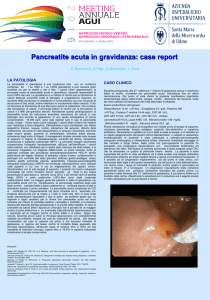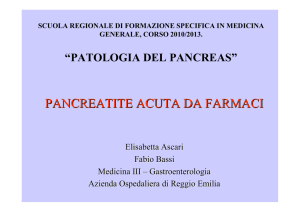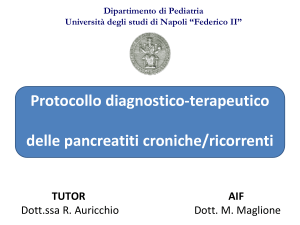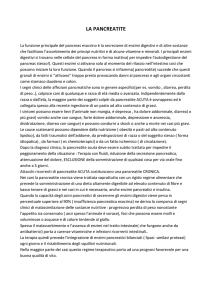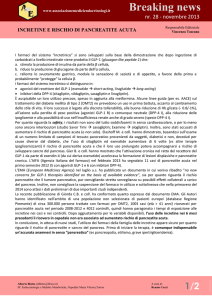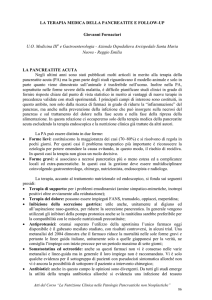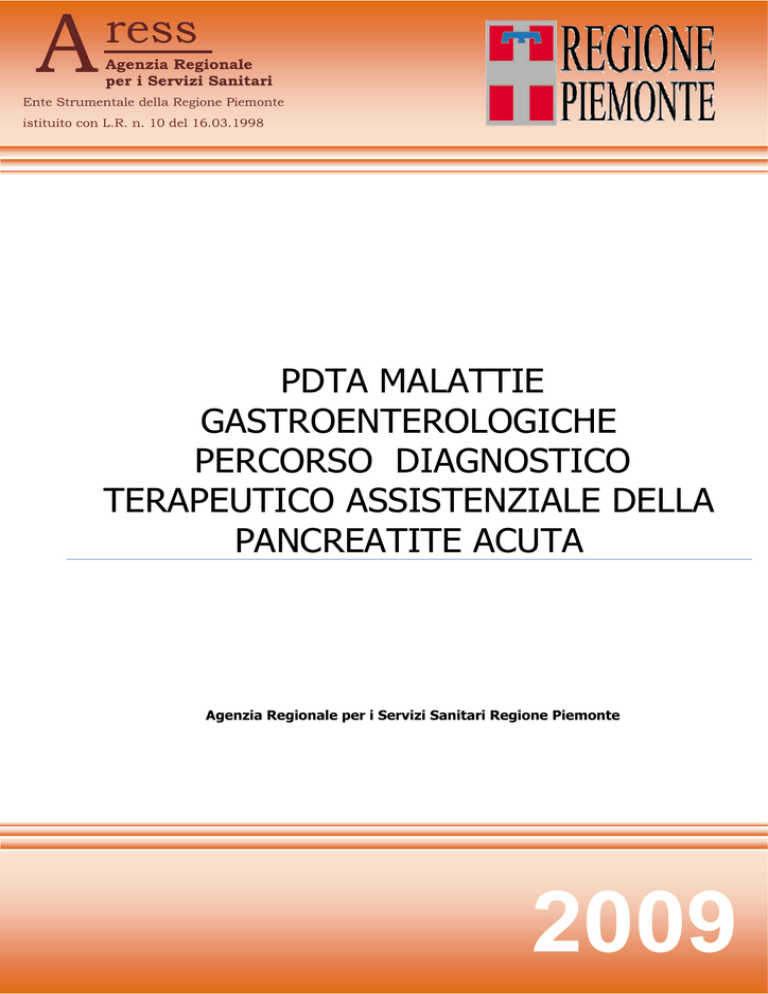
A
ress
Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari
Ente Strumentale della Regione Piemonte
istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998
PDTA MALATTIE
GASTROENTEROLOGICHE
PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DELLA
PANCREATITE ACUTA
Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Regione Piemonte
2009
S OMMARIO
1.DESCRIZIONE GENERALE DEL DOCUMENTO
1.1 Il committente………………………………………………………………………………………….
3
1.2 Il gruppo di lavoro…………………………………………………………………………………….
3
1.3 Coordinamento del gruppo…………………………………………………………………………
3
1.4 Abbreviazioni usate nel testo……………………………………………………………………..
4
1.5 Definizioni………………………………………………………………………………………………..
5
1.6 Premessa……………………………………………………………………………………………… ….
5
2. METODOLOGIA
2.1 ricerca della letteratura……………………………………………………………… ….. ……….
9
2.2 valutazione con metodo Agree…………………………………………………………………….
9
2.3 il percorso di riferimento……………………………………………………………………………..
10
2.4 discussione del documento………………………………………………………………………….
10
3. CRITERI DI ELEGGIBILITA’ E DI INCLUSIONE
3.1 criteri di eleggibilità……………………………………………………………………………………
11
3.2 criteri di inclusione……………………………………………………………………………………..
11
4. LA PANCREATITE ACUTA: INQUADRAMENTO CLINICO…………………….
12
5. LINEE GUIDA E LETTERATURA DI RIFERIMENTO
5.1 linee guida…………………………………………………………………………………………………
15
5.2 letteratura di riferimento……………………………………………………………………………..
15
5.3 valutazione linee guida con metodo Agree……………………………………………………
17
5.4 livelli di prove scientifiche e grading delle raccomandazioni……………………………..
19
ALLEGATO 1: FLOWCHART “PDTA PANCREATITE ACUTA”………………………
21
6. IL PERCORSO DI RIFERIMENTO
6.1 VALUTAZIONE/ PERCORSO DEL PZ AL D.E.A………………………………………………….
22
6.1.1 triage………………………………………………………………………………………………………
22
6.1.2 anamnesi, esame obiettivo…………………………………………………………………………
23
6.1.3 monitorizzazione dei parametri vitali…………………………………………………………….
25
6.1.4 esami ematochimici……………………………………………………………………………………
25
6.1.5 terapia di supporto…………………………………………………………………………………….
25
6.1.6 terapia antisecretiva e antiproteasica…………………………………………………………..
26
6.1.7 profilassi/terapia antibiotica………………………………………………………………………..
26
6.1.8 terapia nutrizionale…………………………………………………………………………………….
27
6.1.9 terapia del dolore……………………………………………………………………………………….
27
6.1.10 radiologia tradizionale……………………………………………………………………… ……….
28
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
1
61.11 ecografia…………………………………………………………………………………………………….
28
6.2
VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’…………………………………………………………………….
28
6.2.1 score di gravità…………………………………………………………………………………………….
28
6.2.2 valutazione TAC a 72 ore……………………………………………………………………………….
29
6.3 TERAPIA DELLA PANCREATITE ACUTA SEVERA…………………………………………………..
31
6.3.1 centri di riferimento per il trattamento della pancreatite acuta……………………………
31
6.3.2 profilassi/terapia antibiotica…………………………………………………………………………….
31
6.3.3 terapia nutrizionale………………………………………………………………………………………..
32
6.3.4 terapia antisecretiva e antiproteasica……………………………………………………………….
35
6.3.5 terapia del dolore…………………………………………………………………………………………..
35
6.4 TRATTAMENTO DELLA LITIASI BILIARE……………………………………………………………..
35
6.4.1 trattamento della litiasi della V.B. in fase precoce……………………………………………..
35
6.4.2 trattamento della calcolosi della colecisti………………………………………………………….
35
6.4.3 trattamento della calcolosi della V.B. in fase tardiva………………………………………….
35
6.5 RADIOLOGIA INTERVENTISTICA……………………………………………………………………..
36
6.5.1 prelievo per esame batteriologico……………………………………………………………………
36
6.5.2 drenaggio radiologico di raccolte asessuali………………………………………………………
36
6.6
MONITORAGGIO DELLA PA……………………………………………………………………………
37
6.6.1 monitoraggio clinico………………………………………………………………………………………
37
6.6.2 monitoraggio strumentale………………………………………………………………………………
37
6.7 GESTIONE DELLA PA MODERATA……………………………………………………………………..
37
6.7.1progilassi/terapia antibiotica…………………………………………………………………………….
37
6.7.2 terapia nutrizionale……………………………………………………………………………………….
37
6.7.3 terapia antisecretiva e antiproteasica……………………………………………………………….
38
6.7.4 terapia del dolore…………………………………………………………………………………………..
38
6.8 TRATTAMENTO DELLA LITIASI COLECISTO COLEDOCICA……………………………………
38
6.8.1 trattamento della calcolosi della colecisti………………………………………………………….
38
6.8.2 trattamento della calcolosi della V.B………………………………………………………………..
39
6.9
TERAPIA INTENSIVA……………………………………………………………………………………..
39
6.9.1 indicazioni al ricovero in UTI…………………………………………………………………………..
39
6.9.2 trattamento in UTI…………………………………………………………………………………………
39
6.9.3 indicazioni chirurgiche nel pz ricoverato in UTI………………………………………………..
41
7. INDICATORI…………………………………………………………………………........
43
Allegato 2: attività di collaborazione nucleo tecnico HTA per la pancreatite acuta ..
45
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
2
1. DESCRIZIONE GENERALE DEL DOCUMENTO
1.1 IL COMMITTENTE
Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità- Regione Piemonte
1.2 IL GRUPPO DI LAVORO
Carlo Cametti
Donata Campra
Pietro Caramello
Cristina Cibin
Paolo Del Gaudio
Mauro Frascisco
Ezio Gaia
Franco Lupano
Rodolfo Rocca
Carlo Senore
Marco Tinivella
Nucleo Tecnico HTA*
Radiologo ASL TO2
Chirurgo Generale AOU S. Giovanni Battista di Torino
Infettivologo ASL TO2
Infermiera AOU S. Luigi Gonzaga- Orbassano
Rianimatore AOU S. Giovanni Battista di Torino
Medico D’Urgenza AOU S. Luigi Gonzaga- Orbassano
Gastroenterologo AOU S. Luigi Gonzaga- Orbassano
MMG ASL TO5
Gastroenterologo AOU Mauriziano di Torino
Epidemiologo CPO – Torino
Dietologo AOU S. Luigi Gonzaga- Orbassano
A.Re.S.S.
1.3 COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO
Tito Soldati
Ezio Gaia
Angelo Pera
A.Re.S.S. Piemonte- Metodologo, Referente del
Progetto
Gastroenterologo AOU S. Luigi Gonzaga- Orbassano
Referente scientifico “Rete Regionale di
Gastroenterologia”
*Nucleo Tecnico HTA: Alessandro Beux, Elisa Giani, Chiara Rivoiro, Valeria Romano, Fabio
Trimaglio, Marina von Pinoci
Alla redazione del presente documento hanno collaborato il Dr. Stefano Silvestri, medico in
formazione specialistica, e la Sig.a Maria Rita La Torre, della segreteria organizzativa
A.Re.S.S. Piemonte
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
3
1.4 ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO
ACRONIMO
AAA
ARDS
ASR
BEE
CID
CVC
DEA
EBP
ESPEN
EUS
FC
FIMAD
FNAb
GCS
GEL
HTA
IAPgs
IAP
JPN
Kcal n.p.
LEA
LG
MMG
MOF/ MODS
NE
NP
OMS
pa
PCA
PCR
PDTA
PIC
PVC
RCT
Q
SIRS
UK
UTI
VAS
VNS
VRS
DESCRIZIONE
Aneurisma Aorta Addominale
Sindrome da distress respiratorio acuto
Azienda sanitaria Regionale
Basal energy expenditure
Coagulazione intravasale disseminata
Catetere venoso centrale
Dipartimento Emergenza e Accettazione
Evidence Based Practice
ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition
Ecoendoscopia
Frequenza cardiaca
Federazione Italiana malattie apparato Digerente
Biopsia con ago sottile
Glasgow Coma Scale
Gastroenterologia
Health Technology Assessment
IAP Guidelines for the Surg Management of Acute Pancreatitis
Pressione intraddominale
JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis
Kcalorie non proteiche
Livelli essenziali assistenza
Linee guida
Medico di Medicina Generale
Insufficienza multi organo
Nutrizione enterale
Nutrizione parenterale
Organizzazione Mondiale della Sanità
Pancreatite Acuta
Patient controlled analgesia
Proteina C reattiva
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
Percorso integrato di cura
Pressione venosa centrale
Randomized clinical trials
Questionario
Sindrome da risposta infiammatoria sistemica
UK Guidelines for the management of acute pancreatitis
Unità di Terapia Intensiva
Scala analogica visiva
Scala numerica verbale
Scala di valutazione verbale
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
4
1.5 DEFINIZIONI
TERMINE
Prevalenza
Incidenza
Dispepsia
DESCRIZIONE
Probabilità a priori di malattia
Probabilità di insorgenza di nuovi casi
Digestione laboriosa, sazietà precoce, dolore e pirosi gastrica
1.6 PREMESSA
Uno dei principali obiettivi dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) della Regione Piemonte è quello di promuovere
l’integrazione organizzativa e clinica tra le A.S.R. nell’ottica di un miglioramento continuo
della qualità, favorendo l’uniformità, la congruità e la continuità degli interventi.
Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale(PDTA) è uno strumento di “Clinical
Governance” che, attraverso un approccio per processi, consente di strutturare e integrare
attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e aree d’azione
(territorio, ospedale ecc) sono coinvolte nella presa in cura del cittadino con problemi di
salute. Il PDTA consente inoltre di valutare la congruità delle attività svolte rispetto alle
linee guida di riferimento, agli obiettivi e alle risorse disponibili, conducendo, attraverso la
misura delle attività e degli esiti, al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza di ogni
intervento.
Nel Giugno 2007 è stato avviato, a cura dell’A.Re.S.S. e su mandato della Regione
Piemonte, il progetto “Rete Regionale di Gastroenterologia”, con i seguenti obiettivi:
•
Conoscere la distribuzione delle strutture, delle risorse e delle competenze
presenti sul territorio.
•
Costruire una Rete Regionale di Gastroenterologia finalizzata alla riorganizzazione
delle strutture e delle risorse attualmente allocate in modelli
organizzativi
disomogenei, estremamente variabili, nonché dispersivi.
•
Definire PDTA e PIC, con particolare attenzione all’appropriatezza d’uso delle
tecnologie e dei farmaci, anche attraverso la sensibilizzazione dei MMG.
La selezione delle patologie su cui sviluppare i PDTA in ambito gastroenterologico è stata
basata su criteri relativi al carico assistenziale e alla variabilità nell’uso delle risorse per la
gestione e il trattamento dei pazienti.
Al fine di disporre degli elementi necessari alla valutazione è stata condotta un’analisi dei
ricoveri con DRG medico per patologie di pertinenza gastroenterologia, relativi ai MDC 6/7,
estratti dall’archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera della Regione Piemonte sul
periodo 1/1 – 31/12 -2006
Sono stati analizzati i seguenti parametri:
• proporzione di ricoveri attribuibile a ciascuna diagnosi principale e a ciascun DRG
• proporzione di ricoveri ripetuti per lo stesso DRG, nell’arco dei 12 mesi di
osservazione per ciascun DRG e per reparto di dimissione
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
5
•
proporzione di casi trattati in regime di DH per DRG e reparto di dimissione
L’analisi della distribuzione delle diagnosi principali di ricovero evidenzia come (tab.I)
pancreatite, epatopatie e dolore addominale rappresentino le prime 5 cause in termini di
frequenza, per un complessivo 20% dei ricoveri ordinari.
TABELLA I
Codice N
5715
5770
5712
5609
78900
1834
1399
1296
1105
887
% cumulata diagnosi principale
5,6%
4,2%
3,9%
3,3%
2,7%
5,6%
9,8%
13,7%
17,0%
19,7%
CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOL
PANCREATITE ACUTA
CIRROSI EPATICA ALCOLICA
OCCLUSIONE INTESTINALE NON SPECIFICATA
DOLORE ADDOMINALE
La valutazione (tab.II) del carico assistenziale (proporzione di ricoveri ordinari attribuibili a
specifiche patologie e proporzione di ricoveri ripetuti nell’arco del periodo di osservazione
per la stessa patologia) e della variabilità osservata nella gestione dei pazienti (variazioni
nella proporzione di ricoveri ripetuti per tipo di specialità del reparto e nella proporzione di
ricoveri in regime di DH sul totale dei ricoveri) ha confermato che a questi gruppi di
patologie è attribuibile una quota consistente dei ricoveri con DRG medico di area
gastroenterologica; questi episodi di ricovero vengono gestiti con modalità e intensità di
impegno di risorse molto diversificati tra i diversi reparti.
La patologie non neoplastiche del pancreas pesano per circa un 5% sul totale dei ricoveri di
area gastroenterologica: è frequente il ricorso al ricovero in area chirurgica (46% dei
ricoveri ordinari), malgrado la pancreatite sia una patologia quasi esclusivamente di
interesse internistico e nel 14% dei casi i pazienti vanno incontro a ricoveri ripetuti per la
stessa patologia nell’arco di un anno
La gestione di questa patologia richiede il frequente ricorso a diagnostica per immagini
(TAC multi-banco, colangioRNM, RUS) e spesso anche a procedure di radiologia
interventistica e di endoscopia di elevata tecnologia e specializzazione, senza che sia
codificata la successione delle procedura.
Abbiamo condotto in particolare una valutazione (vedi allegato 2) dell’evidenza disponibile
relativamente ai requisiti di qualità (strutturale e di formazione degli operatori) per una di
queste procedure – ERCP- , raccomandata dalle linee guida considerate e un’analisi degli
esiti dei pazienti ricoverati con diagnosi di pancreatite acuta in Piemonte sul triennio 20052007 per verificare il possibile impatto dell’adozione di percorsi di gestione di questi
pazienti che comportassero la scelta di concentrare il trattamento di casi acuti in centri
specializzati, come indicato da diverse linee guida.
La realizzazione del presente PDTA “pancreatite acuta”, ha lo scopo di offrire, a tutti gli
operatori interessati nel processo di diagnosi e cura di tale patologia, linee di indirizzo per
la gestione del paziente, anche in rapporto alla diversa gravità della patologia, con i
seguenti obiettivi:
•
Costruzione del percorso ottimale nel processo diagnostico e terapeutico della
pa, tale da ottenere un adeguato livello di cura in tutto il territorio regionale
•
Identificazione degli attori responsabili e dei rispettivi ruoli all’interno del
PDTA
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
6
•
Definire i criteri necessari affinché una Struttura abbia i requisiti per trattare la
pa severa con minimo rischio di complicanze
• Identificazione di indicatori di processo e di esito per verificare l’applicazione
del percorso
L’elaborazione di questo documento, merito del lavoro di un gruppo multiprofessionale e
multispecialistico coordinato dall’A.Re.S.S., si avvale del supporto metodologico fornito dal
documento propedeutico “Raccomandazioni per la costruzione di Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali e Profili Integrati di Cura nelle Aziende Sanitarie della Regione
Piemonte”.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
7
TABELLA II
%
cumulativa
sul totale
dei
ricoveri
ordinari
% sul
totale
dei
ricoveri
ordinari
10,1%
10,1%
32,6%
16,7%
36,8%
14,3%
4,2%
22,5%
1,9%
14,5%
0,2%
19,6%
19,4%
4,9%
22,0%
%
ricoveri
ripetuti
% ricoveri in DH
DRG
DESCRIZIONE
12,6%
202
74,2%
5,7%
205
59,2%
25,0%
0,0%
200
14,1%
3,0%
11,9%
0,8%
204
2,6%
12,7%
11,9%
30,6%
7,8%
179
CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA
MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO
NEOPLASIE MALIGNE,CIRROSI,EPATITE
ALCOLICA,CON CC
PROCEDURE DIAGNOSTICHE
EPATOBILIARI NON PER NEOPLASIE
MALIGNE
MALATTIE DEL PANCREAS ECCETTO
NEOPLASIE MALIGNE
MALATTIE INFIAMMATORIE
DELL'INTESTINO
27,4%
5,4%
12,6%
7,0%
35,3%
5,1%
208
30,0%
2,6%
11,2%
0,0%
9,1%
0,9%
180
34,0%
4,0%
11,1%
1,3%
13,0%
1,1%
181
37,0%
3,0%
9,7%
63,6%
87,9%
42,0%
206
48,4%
11,4%
5,9%
7,4%
71,3%
7,9%
183
55,8%
7,4%
4,8%
12,3%
87,5%
9,1%
184
62,7%
6,9%
9,5%
0,9%
2,4%
1,9%
174
65,7%
3,0%
8,3%
9,8%
24,3%
2,5%
188
72,2%
6,5%
7,8%
2,2%
19,7%
1,8%
182
76,1%
3,9%
6,5%
2,5%
16,5%
1,8%
175
81,0%
5,0%
6,1%
29,9%
78,2%
11,7%
189
82,5%
1,5%
5,3%
17,4%
46,2%
0,0%
190
82,9%
0,4%
4,8%
3,9%
57,1%
5,1%
178
83,2%
0,3%
2,3%
0,0%
20,0%
1,3%
177
92,0%
8,8%
26,3%
14,6%
17,9%
4,6%
203
92,5%
0,4%
25,7%
2,5%
16,7%
0,0%
199
95,0%
2,5%
13,6%
22,5%
37,9%
8,5%
173
MALATTIE DELLE VIE BILIARI, SENZA CC
OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE, CON
CC
OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE,
SENZA CC
MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO
NEOPLASIE MALIGNE,CIRROSI,EPATITE
ALCOLICA, SENZA CC
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E
MISCELLANEA DI MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA` >17
SENZA CC
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E
MISCELLANEA DI MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA` < 18
EMORRAGIA GASTROINTESTINALE, CON
CC
ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO
DIGERENTE, ETA` > 17 CON CC
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E
MISCELLANEA DI MALATTIE
DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA`>17
CON CC
EMORRAGIA GASTROINTESTINALE, SENZA
CC
ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO
DIGERENTE, ETA` > 17 SENZA CC
ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO
DIGERENTE, ETA` < 18
ULCERA PEPTICA NON COMPLICATA,
SENZA CC
ULCERA PEPTICA NON COMPLICATA, CON
CC
NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO
EPATOBILIARE O DEL PANCREAS
PROCEDURE DIAGNOSTICHE
EPATOBILIARI PER NEOPLASIE MALIGNE
NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO
DIGERENTE, SENZA CC
99,5%
4,5%
15,9%
2,1%
6,8%
1,0%
207
MALATTIE DELLE VIE BILIARI, CON CC
100,0%
0,5%
11,3%
12,6%
6,3%
11,4%
19,0%
45,6%
Chirurgia
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
GEL
Medicina
176
4,3%
7,6% Totale
ULCERA PEPTICA COMPLICATA
8
2.METODOLOGIA
Nel realizzare il presente PDTA sono state recepite le indicazioni e sono state seguite le
tappe fondamentali specificate nel manuale “Raccomandazioni per la costruzione di
percorsi diagnostico Terapeutici Assistenziali e profili integrati di cura nelle
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte”.
Il piano di elaborazione del percorso ha seguito le seguenti fasi:
• Individuazione di un gruppo di esperti multiprofessionale e multispecialistico.
• Ricerca della letteratura scientifica con una strategia in grado di rintracciare le
evidenze scientifiche, le linee guida, le revisioni sistematiche più recenti.
• Valutazione delle linee guida.
• Definizione del percorso assistenziale, contenente le raccomandazioni derivate da
linee guida e consigli derivati dal parere di esperti del
tavolo
di
lavoro
regionale (percorso di riferimento).
• Discussione della bozza del documento con i componenti del tavolo di
lavoro
“Rete Regionale di Gastroenterologia”, contenente rappresentanti delle Società
medico-scientifiche.
• Redazione finale del documento.
2.1 RICERCA DELLA LETTERATURA
La ricerca della letteratura è stata effettuata in base alla seguente strategia:
1.
Ricerca di linee guida in vigore
2.
Ricerca bibliografica su banche dati (Studi di coorte, prospettici)
La ricerca è stata effettuata nelle seguente basi di dati e siti internet:
o
Pubmed
o
National Guideline Clearinghouse
o
SNLG Sistema Nazionale Linee Guida
o
CMA Infobase
o
NLH Guidelines Finder
o
SIGN
2.2 VALUTAZIONE DELLE LINEE GUIDA
La valutazione delle Linee Guida è stata eseguita con il metodo Agree.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
9
2.3 IL PERCORSO DI RIFERIMENTO
Il percorso di riferimento è il PDTA raccomandato e rappresenta la pianificazione logica e
cronologica degli interventi necessari e ottimizzati per la diagnosi e la terapia della pa.
Sono indicate come “raccomandazioni” tutte le attività, interventi o procedure supportate
da evidenze nelle linee guida e letteratura di riferimento; sono indicate come “consigli” le
indicazioni derivate dal parere degli esperti e del tavolo di lavoro regionale.
2.4 DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO
La discussione del documento con i componenti del tavolo di lavoro “Rete Regionale di
Gastroenterologia”, nel quale sono rappresentate le Società medico-scientifiche, è
avvenuta in data 29 settembre 2009
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
10
3. CRITERI DI ELEGGIBILITA’ E DI INCLUSIONE
3.1 CRITERI DI ELEGGIBILITA’
I criteri individuati nella scelta della pa, d’interesse nella costruzione di un PDTA a
carattere regionale, sono i seguenti:
•
elevato numero di ricoveri ordinari
•
frequente ricorso al ricovero in area chirurgica, malgrado la pa sia una patologia
quasi esclusivamente di interesse internistico.
•
frequente ricorso a diagnostica per immagini (TAC multi banco, ColangioRM,
EUS) e/o a procedure di radiologia interventistica e di endoscopia ad elevata
tecnologia, senza che
sia codificata la successione degli eventi diagnosticoterapeutici.
3.2 CRITERI DI INCLUSIONE
Vengono inclusi tutti i soggetti con dolore addominale e valore delle amilasi e delle lipasi
3 volte superiore alla norma.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
11
4. LA PANCREATITE ACUTA: INQUADRAMENTO CLINICO
La pancreatite acuta è una patologia che riconosce numerose cause, ha patogenesi
complessa e in parte ignota e un’evoluzione spesso imprevedibile. La definizione clinica è
di processo infiammatorio acuto del pancreas che può coinvolgere i tessuti circostanti o
organi distanti mentre dal punto di vista anatomo-patologico è un’infiammazione
(autodigestione) della ghiandola pancreatica caratterizzata da edema interstiziale ed
infiltrato infiammatorio che nei casi più gravi può evolvere verso la necrosi cellulare.
Dal punto di vista epidemiologico, l’incidenza appare variare nelle aree geografiche in
modo verosimilmente legato a fattori ambientali quali la prevalenza della litiasi biliare e
l’abuso alcolico.
In accordo con l’Atlanta International Symposium on Acute pancreatitis del 1992. è
possibile classificare le due forme di espressione clinica della pa:
1. Pancreatite Acuta Lieve nel 75-85% dei casi: decorso senza complicanze, minima
disfunzione d’organo, restitutio ad integrum del pancreas e spesso autorisoluzione.
2. Pancreatite Acuta Severa 15-25% dei casi: prevalenza del processo digestivo
autolitico, insufficienza multiorgano associata a complicanze locali e/o sistemiche.
Eziopatogenesi
Il quadro clinico della pa è il risultato dell'attivazione intraparenchimale del corredo
enzimatico pancreatico con il relativo danno al parenchima ghiandolare, ai tessuti
circostanti e a livello sistemico.
La litiasi biliare è tra le cause più frequenti; l’abuso alcolico può essere responsabile di un
primo episodio di pancreatite acuta, ma più frequentemente di una riacutizzazione della
pancreatite cronica. Altre cause meno frequenti sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alterazioni metaboliche: iperlipoproteinemia (tipo IV,V,I), iperparatiroidismo ed altre
ipercalcemie
ostruzione al deflusso pancreatico: neoplasie pancreatiche e ampollari, ipertono
dell’Oddi, coledococele, parassitosi, diverticoli duodenali periampollari, pancreas
divisum con ostruzione del dotto accessorio
farmaci: azatioprina e mercaptopurina, acido valproico, estrogeni, tetracicline,
metronidazolo, nitrofurantoina, furosemide e diuretici tiazidici, metildopa, ranitidina,
eritromicina, salicilati, mesalazina
ERCP, sfinterotomia endoscopica
traumi addominali
interventi chirurgici addominali
forme idiopatiche (micro litiasi biliare?)
tossine: etanolo, metanolo, veleno di scorpioni
infezioni da parassiti: ascaridi, clonorchiasi
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
12
•
•
•
•
infezioni da virus e da batteri: parotite, rosolia, HAV, HBV, HCV, EBV, CMV, HIV /
mycoplasma, legionella, leptospirosi, M. tuberculosis
autoimmunità: LES, PAN, sindrome di Sjogren
gravidanza
forme famigliari
Il parenchima pancreatico sembra rispondere con lo stesso meccanismo alle noxae
patogene. I momenti fisiopatologici responsabili del danno pancreatico sono: l’attivazione
intraparenchimale e l’autolisi. In situazioni non patologiche, esistono diversi dispositivi
fisiologici, le antiproteasi endogene, che impediscono l’attivazione dei proenzimi
pancreatici isolati in vacuoli citoplasmatici: in presenza di una noxa patogena l’attivazione
enzimatica raggiunge rapidamente livelli non più controllabili. La mancata clearance o il
reflusso di bile, tripsina e chimotripsina inducono il danno all’epitelio duttale, la cui alterata
permeabilità è causa iniziale della reazione flogistica interstiziale. La tripsina è l’attivatore
più importante dei proenzimi pancreatici. Attiva infatti:
• fosfolipasi A-2 che agiscono scindendo i fosfolipidi della membrana cellulare
distruggendola e sono in grado di inibire il surfattante polmonare
• elastasi che sono in grado di lisare l’elastina presente nelle pareti vascolari e
nei tessuti connettivi
• callicreina che stimola il rilascio di prostaglandine vasoattive co-responsabili
insieme all’ipovolemia dello stato di shock e della insufficienza multiorgano
(MOF) nelle forme gravi
La tripsina è implicata in un’altra via che conduce alla genesi del danno cellulare:
l’attivazione del sistema a cascata del complemento e di alcuni fattori della coagulazione,
tra cui il fattore XII, con la compartecipazione del sistema delle chinine e delle
prostaglandine. Tali meccanismi di lisi cellulare possono innescarsi, sia pure in minima
quantità, anche in condizioni normali; ma ad essi si contrappongono efficacemente i
sistemi di inattivazione enzimatica rappresentati dalle antiproteasi: l´a1-antitripsina e l´a2macroglobulina in particolare. Quando l´equilibrio tra questi due sistemi si altera, si
innesca il processo che porta alla distruzione cellulare massiva. Altri fattori, oltre
all´enterochinasi, possono attivare il tripsinogeno con un meccanismo di autoattivazione:
le tossine batteriche, i fattori del complemento e, almeno in vitro, il tripsinogeno presente
in eccesso. Le ragioni per le quali la pancreatite acuta è lieve nella maggioranza dei casi e
severa nella minoranza non sono chiare. E’ probabile che meccanismi protettivi
intrapancreatici prevalgano sugli enzimi digestivi attivati per cui la pancreatite rimane
edematosa. Se al contrario si determina una prevalenza della componente enzimatica, si
osserva il procedere verso una forma severa.
L´azione enzimatica e tossica locale, secondaria al processo autolitico, può diffondersi,
amplificarsi e indurre effetti sistemici, talora drammatici ed irreversibili. Alte concentrazioni
di radicali tossici dell’ossigeno si formano precocemente e contribuiscono ad aggravare il
danno pancreatico. Si verifica con frequenza la formazione di una notevole quantità di
trasudato e talora di essudato nel retroperitoneo peripancreatico. Inoltre spesso si osserva
una diffusione di liquido all´esterno del letto capillare nello spazio extravascolare in regioni
distanti dal pancreas (tessuto sottocutaneo, interstizio polmonare, cavità peritoneale,
ecc.). Le cause di questo stravaso di liquidi dallo spazio intra a quello extravascolare, con
conseguente ipovolemia, sono legate prevalentemente alla liberazione di sostanze
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
13
vasoattive e alla diminuzione della pressione colloido-osmotica intravascolare da perdita di
proteine e sequestro di liquidi da parte del versamento iperosmolare retro pancreatico.
Molto frequente è la comparsa di ipotensione ad eziologia multipla; si instaura infatti una
situazione cardiovascolare di tipo ipodinamico, simile a quella che si osserva in corso di
sepsi, nella quale concorrono tre fattori:
• l’ipovolemia assoluta
• l’ipovolemia relativa legata alla vasodilatazione secondaria alla liberazione di chinine
e di peptidi vasoattivi
• un´inadeguata risposta cardiaca alle diminuite resistenze periferiche, dove potrebbe
essere implicato un fattore miotossico deprimente la funzionalità cardiaca.
Alterazioni elettrolitiche e metaboliche (ipocalcemia, iperglicemia, acidosi metabolica e
lattica) si possono osservare anche precocemente in corso di pancreatite. L’ipocalcemia,
talora di grave entità, è correlata con il grado di severità della patologia. Nella maggior
parte dei casi la diminuzione dei livelli sierici di calcio è secondaria all’ipoalbuminemia
mentre le concentrazioni di calcio ionizzato sono ancora nei limiti di norma. In alcune
circostanze, tuttavia, compare anche una riduzione sensibile dei livelli di calcio non
complessato alle proteine, relata alla precipitazione di sali di calcio nelle aree di liponecrosi
mentre marginalmente può presentarsi anche un’incapacità del tessuto osseo a rispondere
alla liberazione di PTH.
Gli episodi più gravi di pancreatite acuta si associano frequentemente a riduzione graduale
della funzionalità renale (sino alla comparsa di una franca insufficienza renale) e a
insufficienza respiratoria.
L’insorgenza delle lesioni riscontrabili a livello polmonare e renale è multifattoriale, da
porsi in relazione alle sepsi e/o all´ipotensione.
Il decremento della funzionalità renale è generalmente di tipo prerenale. Si verificano,
inoltre, lesioni della membrana basale causate da complessi circolanti tipo enzima/enzimainibitore, da immunocomplessi o da enzimi proteolitici attivati e circolanti e dal blocco dei
capillari glomerulari causato dalla CID.
Il quadro clinico di insufficienza polmonare è sovrapponibile a quello che si riscontra in
corso di ARDS. Ad aggravare il danno concorrono anche fattori più specifici e tipici della
pancreatite; vi sarebbero modificazioni del surfattante indotte dalle fosfolipasi circolanti,
mentre la CID rappresenta l’evoluzione rara, finale e temibile della abnorme attivazione del
sistema della coagulazione da parte della tripsina. Tale situazione pro coagulante associata
al danno endoteliale determinato dalle elastasi attivate e dalle chinine crea una complessa
sequenza di eventi che talvolta può portare verso una CID franca. Tuttavia anche in casi
non così gravi, è osservabile una certa alterazione dei processi coagulativi e del
microcircolo periferico, co-responsabili delle alterazioni renali, polmonari ma anche
cerebrali. Queste ultime sono rare, ad insorgenza multifattoriale (enzimi tossici circolanti,
ipossia, ipertermia e squilibri elettrolitici) e si possono manifestare con alterazioni del
sensorio, disorientamento, agitazione psicomotoria e allucinazioni sino al coma nei casi più
gravi.
In conclusione l’attivazione degli enzimi con conseguente amplificazione delle diverse
cascate enzimatiche e delle citochine, determina un processo che si automantiene e si
amplifica determinando lo stato di SIRS. Dopo questa fase precoce, se il processo
pancreatitico non si risolve, il quadro clinico può evolvere verso una MOF conclamata e
piu’ tardivamente ( generalmente 14 giorni) verso un grave stato settico.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
14
5. LINEE GUIDA E BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
5.1 LINEE GUIDA
1 -ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Pancreas. Clinical Nutrition 2006;25:275-284
2 -IAP Guidelines for the Surgical Management of Acute Pancreatitis. Pancreatology 2002;2: 565-573
3 -JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006;13:1-68
4 -UK Guidelines for the management of acute pancreatitis. GUT 2005; 54:1-9
5.2 LETTERATURA DI RIFERIMENTO
METODOLOGIA
-AGREE uno strumento per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche. Regione Emilia-Romagna,
Agenzia Sanitaria Regionale, Centro di documentazione per la salute- 2002
-Quaderni Scientifici A.Re.S.S. Regione Piemonte “ Raccomandazioni per la costruzione di percorsi
diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e profili integrati di cura (PIC) nelle Aziende Sanitarie della
Regione Piemonte” 2007 reperibile su www.aress.piemonte.it/Pubblicazioni.aspx
LA PANCREATITE ACUTA:INQUADRAMENTO CLINICO
-Bradley EL III A clinically based classification system for acute pancreatitis. Summary of the International
Symposium of acute pancreatitis, Atlanta September 11 through 13, 1992. Arch Surg 1993; 128:586-590
VALUTAZIONE/PERCORSO DEL PZ. AL D.E.A.
-Dellinger EP, Tellado JM, Soto NE, et al. Early antibiotic treatment for severe acute necrotizing pancreatitis:
a randomized, double-blind, placebocontrolled study. Ann Surg 2007; 245:674–683
-Moyshenyat I, Mandell E, Tenner S. Antibiotic prophylaxis of pancreatic infection in patients with necrotizing
pancreatitis: rationale, evidence, and recommendations. Curr Gastroenterol Rep 2006; 8:121–126)
-Villatoro E et al. Antibiotic therapy for prophylaxis against infection of pancreatic necrosis in acute
pancreatitis Cochrane Database Syst Rev. 2006 Oct 18;(4):CD002941
VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’
-Beger G, Rau BM.Severe acute pancreatitis: clinical course and management.World J Gastroenterol 2007;
13 (38): 5043-51
-Dervenis C, Johnson CD, Bassi C, et al. Diagnosis, objectiveassessment of severity, and management of
acute pancreatitis.Santorini Consensus Conference. Int J Pancreatol 1999;25:195–210.
-Johnson CD, Toh SK, Campbell MJ.Combination of APACHE-II score and an obesity score(APACHE-O) for
prediction of severe acute pancreatitis.Pancreatology 2004; 4:1-6
-Pezzilli R, Uomo G, Zerbi A, Gabrielli, A, Frulloni L, De Rai P, Della Fave G, Di Carlo V. Diagnosis and
treatment of acute pancreatitis: the position statement of the Italian Association for the study of the
pancreas. Dig Liver Dis 2008; 40: 803-8
-Toouli J, Brooke-Smith M, Bassi c et al.Guidelines for management of acute pancreatitis. J Gastoenterol
Hepatol 2002; 17 (Suppl): S15-39.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
15
TRATTAMENTO DELLA PANCREATITE ACUTA SEVERA
-Dambrauskas Z, Pundzius J, Barauskas G. Predicting development of infected necrosis in acute necrotizing
pancreatitis. Medicina (Kaunas) 2006; 42:441–449
-Heinrich S, et al. Evidence-Based Treatment of Acute Pancreatitis. A Look at Established Paradigms. Ann
Surg 2006;243(2):154-168
-Matull WR, Pereira SP, O’Donohue JW. Biochemical markers of acute pancreatitis. J Clin Pathol 2006;
59:340–344
-Rau B, Pralle U, Mayer JM et al. Role of ultrasonographically guided fine-needle aspiration cytology in the
diagnosis of infected pancreatic necrosis British Journal of Surgery 1998, 85, 179–184
-Rau BM Early assessment of pancreatic infections and overall prognosis in severe acute pancreatitis by
procalcitonin (PCT): a prospective e international multicenter study Ann Surg. 2007 May;245(5):745-54)
Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock:
2008 Crit Care Med 2008; 36(1):296-327
-ESPEN Guidelines on parenteral Nutrition: pancreas. Clinical Nutrition 2009;30:1-8
TRATTAMENTO DELLA LITIASI BILIARE
-Aybu K, Imada R, Slavin J. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in gallstone-associated acute
pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2004
-Cotton PB, Baillie J, Pappas TN, et al.Laparoscopic cholecystectomy and the biliary endoscopist Gastrointest
Endosc 1991; 37: 94-7
-Cotton PB. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography and laparoscopic cholecystectomy.Am J Surg.
1993 Apr;165(4):474-8
-M Otsuki, M Hirota, S Arata et al. Consensus of primary care in Acute Pancreatitis in Japan. World J
Gastroenterol 2006;12(21):3314-3323
-Petrov MS, van Santvoort HC, Besselink MG, et al “Early endoscopic retrograde cholangiopancreatography
versus conservative management in acute biliary pancreatitis without cholangitis: a meta-analysis of
randomized triaLs” Ann Surg. 2008 Feb;247(2):250-7
-Chaudari M. ketamine for pain relief in acute pancreatitis. European Journal of Pain, 200-Pancreatology for
Gastroenterologists and Surgeon, 2005; Guidelines for the treatment of pain in acute pancreatitis
RIANIMAZIONE
-Al Bahrani AZ, Abid GH, Holt A et al. Clinical rilevance of intra-abdominal Hypertension in patients with
severe acute pancreatitis.Pancreas 2008; 36:39-43
-Cheatham ML, Manu L, Malbrain MLNG et al.Results from the international Conference of experts on intraabdominal hypertension and abdominal Compartiment syndrome. II. Recommendations.Intensive Care Med
2007; 33:951-962
-Chen H, Li f, Sun JB, Jia JG.Abdominal compartiment syndrome in patients with severe acute pancreatitis in
early stage. World J Gastroenterol 2008; 14: 3541-8
-Lee JK, Kwak KK, Park JK et al. The efficacy of nonsurgical treatment of infected pancreatic necrosis.
Pancreas 2007; 34: 399-404
-Uomo G, Miraglia S.Indication for surgery in severe acute pancretitis. Could it aslo be a “manometric”
question? JOP 2008; 9 (2). 240-3
-Uomo G. Non surgical treatment of infected pancreatic necrosis: a falling mith or a still impassable frontier?
JOP 2007; 8: 468-70
COMUNE
-AGA Institute Medical Position Statement on Acute Pancreatitis.Official recommendations of the American
Gastroenterological Association (AGA) Institute Gastroenterology 2007;132:2019–2021
-Bal-Balthazar EJ. Acute pancreatitis Assessment of severity with Clinical and CT evaluetion. Radiology
2002;223:603-13
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
16
-Ban-Banks PA, Freeman ML, and the Practice Parameters Committee of the American College of
Gastroenterology. Practice Guidelines in Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2006;101:2379–2400
-Brad-Bradley EL III. A clinically based classification system for acute pancreatitis. Summary of the
International Symposium of acute pancreatitis, Atlanta September 11 through 13, 1992. Arch Surg 1993;
128:586-590
-Del07-Dellinger EP, Tellado JM, Soto NE, et al. Early antibiotic treatment for severe acute necrotizing
pancreatitis: a randomized, double-blind, placebocontrolled study. Ann Surg 2007; 245:674–683
-Del08-Dellinger R.P., Levy M.M., Carlet J.M. et al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for
management of severe sepsis and septic shock: 2008 Crit Care Med 2008; 36(1):296-327
-Hei-Heinrich S, et al. Evidence-Based Treatment of Acute Pancreatitis. A Look at Established Paradigms.
Ann Surg 2006;243(2):154-168
-Rau BM Early assessment of pancreatic infections and overall prognosis in severe acute pancreatitis by
procalcitonin (PCT): a prospective e international multicenter study Ann Surg. 2007 May;245(5):745-54)
-Stephen A. McClave, Wei-Kuo Chang, Rupinder Dhaliwal, and Daren K. Heyland
Nutrition Support in Acute Pancreatitis: A Systematic Review of the Literature (SAGE) JPEN J Parenter
Enteral Nutr 2006 30: 143-156
5.3 VALUTAZIONE LINEE GUIDA CON METODO AGREE
Le linee guida individuate sono state valutate con il metodo Agree come di seguito
sintetizzato:
o JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis, 2006
1
2
3
4
5
6
AREA
Obiettivo e motivazione
Coinvolgimento delle parti in causa
Rigore della elaborazione
Chiarezza e presentazione
Applicabilità
Indipendenza editoriale
PUNTEGGIO
12/12
12/16
24/28
15/16
10/12
6/8
Giudizio complessivo
Fortemente raccomandata X
Raccomandata (con
riserva)
Non raccomandata
Non so
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
17
o
1
2
3
4
5
6
UK Guidelines for the management of acute pancreatitis, 2005
AREA
Obiettivo e motivazione
Coinvolgimento delle parti in causa
Rigore della elaborazione
Chiarezza e presentazione
Applicabilità
Indipendenza editoriale
PUNTEGGIO
12/12
10/16
20/28
13/16
9/12
6/8
Giudizio complessivo
Fortemente raccomandata X
Raccomandata (con
riserva)
Non raccomandata
Non so
o
1
2
3
4
5
6
IAP Guidelines for the Surgical Management of Acute Pancreatitis, 2002
AREA
Obiettivo e motivazione
Coinvolgimento delle parti in causa
Rigore della elaborazione
Chiarezza e presentazione
Applicabilità
Indipendenza editoriale
PUNTEGGIO
12/12
10/16
21/28
13/16
5/12
4/8
Giudizio complessivo
Fortemente raccomandata X
Raccomandata (con
riserva)
Non raccomandata
Non so
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
18
•
1
2
3
4
5
6
ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Pancreas, 2006
AREA
Obiettivo e motivazione
Coinvolgimento delle parti in causa
Rigore della elaborazione
Chiarezza e presentazione
Applicabilità
Indipendenza editoriale
PUNTEGGIO
11/12
14/16
28/28
15/16
10/12
5/8
Giudizio complessivo
Fortemente raccomandata X
Raccomandata (con
riserva)
Non raccomandata
Non so
5.4 LIVELLI DI PROVE SCIENTIFICHE
RACCOMANDAZIONI
E GRADING DELLE
Le prove scientifiche raccolte sono state valutate in base al sistema di grading presente
nelle linee guida adottate:
- secondo lo schema di SIGN e della Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR),
tab. III, per:
•
•
•
UK Guidelines for the management of acute pancreatitis
IAP Guidelines for the Surgical Management of Acute Pancreatitis
ESPEN Guidelines on enteral nutrition, pancreas
TABELLA III
Gradi di raccomandazione
A
Livelli di evidenza
Ia
Ib
B
IIa
IIb
III
C
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
IV
Requisito
Meta-analisi di trials controllati randomizzati
Almeno un trial controllato randomizzato
Almeno un trial controllato ben disegnato
senza randomizzazione
Almeno un altro tipo di studio quasisperimentale, ben disegnato
Studi descrittivi ben disegnati, non
sperimentali come studi comparativi, di
correlazione, caso-controllo
Opinioni di esperti e/o esperienza clinica
19
secondo la classificazione EB usata alla Cochrane Library: Oxford, centro per EBP, livelli di
evidenza per, tab. IV:
• JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis
schema di SIGN e della Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR)
TABELLA IV
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
20
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
21
6. IL PERCORSO DI RIFERIMENTO
In seguito all’analisi delle linee guida e della letteratura di riferimento, viene di seguito
descritta la pianificazione della sequenza logica e cronologica di tutti gli interventi
diagnostici, terapeutici e di follow up del paziente con sospetto e diagnosi di pancreatite
acuta, mantenendo l’obiettivo dell’appropriatezza delle prestazioni.
Il percorso di riferimento, che individua i ruoli e le responsabilità dei processi, è
rappresentato graficamente in 1 diagramma a matrice (allegato 1).
6.1 VALUTAZIONE/ PERCORSO DEL PZ. AL DEA
6.1.1 triage
In presenza di dolore addominale si consiglia il seguente schema di triage:
Assenza o grave compromissione del “Airway-Breathing-Circulation”
associato a grave alterazione dello stato emodinamico
ROSSO
Anamnesi positiva per AAA
Ematemesi in atto
Vomito incoercibile in atto con alvo canalizzato ai gas e alle feci
Dolore violento con insorgenza acuta
Dolore violento associato ad alterazione non critica dei parametri
vitali e/o sudorazione
Dolore acuto localizzato
Vomito episodico o riferito
ipertermia
Algie riferite non ingravescenti, risalenti a più giorni
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
GIALLO
VERDE
BIANCO
22
6.1.2 anamnesi, esame obiettivo
Si propongono i seguenti schemi in caso di sospetta pancreatite acuta
-anamnesi
Quando è insorto il dolore?
Data ………………….. Ora …………..
Sintomi di accompagnamento
Vomito
Assente Presente alimentare
Presente biliare
Nausea
Assente Presente
Alterazioni dell’alvo
Diarrea
Assente Presente
Chiusura dell’alvo Assente Alle feci Ai gas
Ha avuto precedenti episodi analoghi a questo?
No
Sì
Quante volte …………………..
Risultano familiari con pancreatite?
No
Sì
Non so
Le risulta di avere calcoli biliari (c.d. “al fegato” o “alla cistifellea”)?
No
Sì
Non so
Prima del dolore ha assunto alcoolici?
No
Sì
Di solito beve alcoolici?
No
Se “Sì” test CAGE
1
2
3
4
Sì
Risposte positive n.
Hai mai pensato di dover ridurre l'assunzione di alcolici?
Ti sei mai infastidito perché qualcuno ti ha criticato a causa del tuo bere ?
Ti sei mai sentito in colpa o cattivo a causa del tuo bere ?
Hai mai bevuto al mattino come prima cosa per rilassarti o per farti passare i postumi di una sbornia?
Fuma?
No
Sì
Assume farmaci?
No
Sì
Se “Sì”, elencare: ……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
23
-esame obiettivo
N.B. I reperti si riferiscono all’ipotesi clinica di “pancreatite acuta” e prescindono da un
esame obiettivo generale completo, comunque necessario.
Peso
Kg. ………..
Altezza mt. ……………
Polso
Freq ………/min
Ritmico
PAOS
………/……… mmHg
Temperatura
……… ° C
Freq. respiratoria
………… atti/min
Ittero
Presente
Aritmico
Assente
Stato di coscienza Punteggio GCS …………… vedi tab V
Dolore
Intensità
Scala numerica verbale (VNS) da 0 a 10 Stima …………..
Localizzazione (descrittiva)…………………………………………………
Peritonismo
Assente
Presente
Peristalsi
Assente
Presente
Masse addominali palpabili
Assenti
Presenti
Localizzazione …………………….
Presenti
Localizzazione …………………….
Soffi vascolari
Assenti
Giordano
Assente
Torace
Mobilità basi Normale
Versamento
Presente Lato
dx sn
Ridotta
Assente
Segni flebitici
Presenti
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
Assenti
24
TABELLA V: SCALA DI GLASGOW
apertura degli occhi
risposta verbale
risposta motoria
nessuna
A stimoli dolorosi
a stimoli verbali
spontanea
nessuna
suoni incomprensibili
inappropriata
confusa
orientata
Nessuna
Estensione al dolore
Flessione al dolore
Retrazione dal dolore
Localizzazione del dolore
Obbedisce ai comandi
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
Risultato: somma dei punteggi delle 3
prove
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
15
da 12 a 15
da 9 a 11
da 4 a 8
3
Nella norma
Alterazione lieve
Alterazione importante
Alterazione grave
Coma profondo
6.1.3 Monitorizzazione dei parametri vitali
E’ necessaria l’esecuzione di ECG, la monitorizzazione della temperatura corporea, della
PAO, della saturazione di O2 (in caso di sat. O2< 95%, si deve eseguire O2 terapia con
Venti-mask), della FC, della frequenza respiratoria e della diuresi. E’ consigliabile
l’applicazione di catetere vescicale nel pz instabile.
In caso di grave compromissione dei parametri vitali si ritiene utile immediata valutazione
rianimatoria e il supporto dei parametri vitali.
6.1.4 esami ematochimici
Sono utili per l’inquadramento clinico del pz i seguenti esami ematochimici, oltre alle
amilasi e alle lipasi [A,JPN-A,UK] : emocromo con formula, sodiemia, potassiemia,
creatinina, EGA arterioso (questi primi 5 esami sono necessari per la determinazione della
severità), glicemia, calcemia, ALT, AST, bilirubina totale, PCR (come valore basale da
ricontrollare nel tempo) LDH, INR, APTT, emocultura nel sospetto di sepsi. In caso di
parametri alterati, essi andranno corretti e monitorizzati.
Non appena possibile dovranno essere eseguiti γGT, fosfatasi alcalina, bilirubina
frazionata. Sarà inoltre utile il dosaggio dei trigliceridi serici, in regime di non urgenza,
allorquando si sospetta una pa di tipo dismetabolico.
6.1.5 terapia di supporto
Previo posizionamento di un catetere venoso periferico nel pz stabile e di di 2 cateteri
venosi periferici ( in 2 arti differenti) nel pz instabile, si consiglia l’utilizzo di cristalloidi con
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
25
volume di infusione di 60-160 ml/Kg peso, mantenendo la diuresi oraria > 1 ml/h/Kg,
eventualmente PAM > 85mmHg (consensus conference JPN). Nel caso si rendano
necessari elevati volumi di infusione, si ritiene utile il posizionamento di CVC e il
monitoraggio della PVC.
Per quanto non vi siano evidenze scientifiche, si consiglia la gastroprotezione con inibitori
di pompa
In caso di vomito frequente e ileo paralitico è utile l’applicazione di SNG[D,JPN].
6.1.6 terapia antisecretiva pancreatica e antiproteasica
Non vi sono chiare evidenze sull’efficacia dei farmaci antisecretivi (somatostatina e
analoghi).
Controverso è l’uso degli antiproteasici, che, comunque, non trovano indicazione fino a che
non è stabilito il grado di severità (JPN). Vedi § 6.3.3
6.1.7 profilassi/terapia antibiotica
L’infezione della necrosi infetta è una delle principali cause di morbidità e mortalità ed è
associata a una letalità più elevata (40%) (UK) rispetto alle forme di necrosi sterile (111%).
Circa 1/3 dei pazienti con pancreatite necrotica sviluppano una necrosi infetta (Banks,
IAP); il rischio di infezione è proporzionale all’estensione della necrosi (IAPgs, UK).
L’infezione si sviluppa talora precocemente, ma nella maggior parte dei casi avviene più
tardivamente, il 33% dopo circa 10 giorni dall’esordio clinico (nella maggior parte dei casi
nella seconda-terza settimana) (IAP).
Le infezioni sono monomicrobiche nel 75%; i germi sono principalmente di origine
intestinale: Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus spp. sono i germi più
comuni; possibile gli anaerobi; i funghi sono identificati nel 9% circa dei casi. Più frequenti
funghi e Gram positivi nei pazienti in profilassi antibiotica soprattutto quando per > di 1014 giorni (Banks, UK).
La prevenzione della conversione da necrosi sterile a infetta è discussa (UK, AGA, IAP). I
risultati degli studi e delle metanalisi sono contradditori e conflittuali. L’uso
dell’antibioticoprofilassi sembra ridurre i tassi di infezione senza migliorare la
sopravvivenza (IAP); non è raccomandata da Banks e dalle L.G inglesi in pz. con necrosi
inferiore al 30% (UK, AGA); la durata dovrebbe essere inferiore ai 14 giorni (UK, AGA).
Anche in presenza di antibiotico profilassi l’infezione è il principale rischio nella pancreatite
grave: essa si sviluppa in circa 1/3 dei pazienti in profilassi antibiotica con farmaci attivi e
con buona penetrazione nei tessuti (carbapenemici, pip/tzb, metronidazolo, cefalosporine
di III, fluorochinolonici).
Dal momento che il rischio di infezione è basso nei pazienti con estensione della necrosi
inferiore al 30% è opinione condivisa che la profilassi dovrebbe essere considerata
soltanto nei pazienti con necrosi >30%. Non c’è indicazione invece all’uso di antibiotici di
routine nella pancreatite moderata (IAP. UK).
La durata non deve eccedere 14 giorni[B,JPN].
Molti pazienti nei primi 7-10 giorni di malattia appaiono settici: in questo periodo la terapia
antibiotica può essere appropriata in presenza di segni e sintomi di infezione (es.
colangite) preceduta da un approfondito studio microbiologico diretto alla ricerca di
sorgente della infezione: emocolture da catetere venoso centrale centrale o periferico,
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
26
colture da ogni altra sede secondo indicazione clinica, studi strumentali per la ricerca di
origine della infezione
6.1.8 terapia nutrizionale
Non è consigliato alcun intervento nutrizionale, ma solo infusione di liquidi, non
essendo ancora definita la diagnosi, né il grado di severità [A ESPEN, JPN].
6.1.9 terapia del dolore
La pa è accompagnata da dolore addominale persistente e severo. L’analgesia è
fondamentale [A,JPN]
Per poter trattare adeguatamente il dolore è necessario poterne eseguire una
misurazione soggettiva, tramite punteggio:
•
Scala numerica verbale (VNS)
•
Scala analogica visiva (VAS)
•
Scala di valutazione verbale (VRS)
•
Scala di Wong-Baker (nei bambini e pazienti con deficit cognitivi)
ed una valutazione (sede, intensità, suscettibilità, irradiazione, tipo, modalità e tempo di
insorgenza, precedenti terapie antidolorifiche) che deve essere effettuata entro le prime
24 ore dall’ingresso del paziente e nuovamente dopo la somministrazione di farmaci
analgesici.
Eseguita l’anamnesi, valutato il tipo del dolore, misurata la sua intensità, si può passare
alla scelta del trattamento più adatto al singolo paziente.
La terapia antalgica è di fondamentale importanza anche per la prognosi, in quanto il
dolore produce un aumento del consumo di O2, del catabolismo e immunosoppressione; al
contrario la sua sedazione può contribuire ad inibire la secrezione pancreatica bloccando i
riflessi centrali ed evitando l’instaurarsi di alterazioni microcircolatorie a livello pancreatico.
Non sono state reperite linee guida per il trattamento del dolore acuto e le pubblicazioni
sulla terapia del dolore nella pa sono estremamente ridotte o fanno riferimento a studi
poco recenti, senza raccomandazioni specifiche ma solamente con evidenze di tipo C.
Faremo riferimento, pertanto, al trattamento antalgico schematizzato nella World Health
Organization analgesic ladder in quanto, nel dolore acuto in emergenza, si ritiene che
possano essere seguiti gli stessi suggerimenti del dolore postoperatorio, essendo uguale la
tipologia di dolore. Tale scala prevede 3 scalini:
• dolore lieve (VAS 1-3)
Dovrebbe essere sufficiente somministrare un fans o un oppioide debole. Se il tramadolo è
somministrato al dosaggio massimo e non si riesce a controllare il dolore, si può ricorrere
ad una associazione con un fans, dimezzando la dose( es: metimazolo 0,5 gx4+ tramadolo
200mgx2).
• dolore moderato (VAS 4-6)
si consiglia un’associazione tra fans e oppioide debole oppure fans e oppioide forte; nel
primo caso a dosaggio pieno per entrambi, nel secondo dimezzando il dosaggio
dell’oppioide forte (es: paracetamolo 1gx4+ meperidina 50mgx4).
•
dolore severo (VAS 7-10)
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
27
utilizzare oppioidi forti ed eventualmente associare fans a dosaggio pieno (es:meperidina
100mgx4+ metimazolo 1 gx4 oppure morfina 10mgx3+ diclofenac 100mgx2)
FANS - ANALGESICI
Paracetamolo
ASA
Metimazolo
Diclofenac
OPPIOIDI DEBOLI
Tramadolo
OPPIOIDI FORTI
Morfina
Meperidina
Buprenorfina
DOSAGGIO MASSIMO
4g/die
6g/die
4g/die
100mgx2
Vas 1-3
max 400mg/die- effetto tetto
Vas 4-6
mg/prime 24 ore=100-età pz
100mgx4-6/die
0,2mg ev poi 3 mg in drip
Vas 7-10
6.1.10 radiologia tradizionale
Nel sospetto di pancreatite acuta deve essere eseguita la radiografia del torace e
dell’addome, per cercare alterazioni causate dalla pancreatite [A,JPN].
La radiografia del torace è utile per visualizzare il versamento pleurico, la polmonite e la
sindrome respiratoria acuta da distress (ARDS).
La radiografia dell’addome permette di evidenziare l’ileo riflesso e diffuso (ansa
sentinella),la presenza di aria in peritoneo e nel retroperitoneo, calcificazioni nella colecisti
e nel pancreas.
6.1.11 ecografia
L’ecografia deve essere eseguita non appena possibile nel sospetto di pancreatite acuta
[A, JPN-C,UK]
Essa è assai attendibile nella valutazione della litiasi colecistica e permette di evidenziare
l’eventuale dilatazione delle vie biliari.
L’ecografia è talora in grado di dimostrare un ingrandimento della ghiandola pancreatica
e la presenza di raccolte [B,JPN];
bisogna, però, tener conto del fatto che in fase acuta spesso l’ileo riflesso ostacola la
valutazione ecografia[B,JPN].
6.2 VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’
6.2.1 score di gravità
La valutazione della gravità è importante per decidere il trattamento della pa e la
necessità di trasferire il pz. in un centro specializzato [A,JPN]. Deve essere fatta il prima
possibile.
L’identificazione dei fattori di rischio per lo sviluppo di PA severa già nelle prime ore
dall’esordio, può servirsi di criteri clinici, laboratoristici e radiologici semplici, rappresentati
da:
- Presenza obesità (BMI>30 kg/m2)
- Età del paziente (>70 anni)
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
28
-
Dosaggio creatininemia (>2 mg/dl)
Ematocrito> 40
Dosaggio Proteina C reattiva (> 150 mg/l )(attendibile a 48 ore)
Rx torace (presenza di versamento pleurico e/o addensamenti parenchimali)
In particolare la PCR è un utile indicatore per predire l’evoluzione da una forma lieve di
PA ad una forma severa [A-JPN; B-UK] .
Lo score che viene più frequentemente usato e il cui valore è stato sottolineato dai criteri
di Atlanta ( 1992) e dalla Consensus di Santorini (1999) è l’APACHE II.
Considera aspetti clinici, quali età, patologie associate(malattie renali, cardiache,
polmonari), stato neurologico, parametri quali la temperatura rettale, la pressione
arteriosa, la frequenza cardiaca e respiratoria, la PO2, il PH arterioso e la necessità di
apporto di ossigeno ed esami di laboratorio quali EGA, creatinina, sodiemia, potassiemia,
ematocrito, globuli bianchi.
L’APACHE II ha il vantaggio di predire la gravità della PA nelle prime 24 ore e di
monitorare l’evoluzione della pa, riconoscendo precocemente l’insufficienza organica.
Nel 2004 è stato proposto di considerare la presenza di obesità come fattore di rischio da
includere nell’APACHE II (APACHE-O).
Lo score APACHE II può essere facilmente reperito e calcolato nel sito internet
www.sfar.org.
La determinazione della severità, dopo le prime 72 viene fatta tramite lo score-TC,
importantissimo per le decisioni chirurgiche.
L’associazione dello score APACHEII e dello score TC porta ad una elevata accuratezza
nella determinazione della severità della PA.
6.2.2 valutazione TAC a 72 ore
La TC con mdc ev, ed in particolare la TC multidetettore, è sicuramente l’esame di
elezione per la valutazione dei pazienti con diagnosi clinica di pancreatite acuta [B, JPN] e
permette di valutare la gravità della malattia [C,UK- A, JP]. (tab. VI)
Si consiglia di limitare l’indicazione alla pancreatite acuta severa o nei casi di pancreatite
acuta a etiologia è incerta.
Tuttavia la TC non dovrebbe essere eseguita in fase iniziale in quanto sottostimerebbe sia
l’entità del coinvolgimento ghiandolare, sia l’estensione delle raccolte; supportata la
diagnosi clinica con gli esami ematochimici e con l’ecotomografia, la TC offrirà le maggiori
In alcuni casi, tuttavia, quando il quadro clinico non sia chiaro e ci si trovi di fronte ad
un quadro di addome acuto, è legittimo ricorrere alla TC in fase iniziale[C,UK].
La panoramicità di questa metodica la rende infatti senz’altro un’indagine di prima
scelta per la diagnostica differenziale a causa delle molteplici patologie che si possono
manifestare con una sintomatologia addominale acuta [B, JPN].Mentre in caso di addome
acuto, la TC è senz’altro l’esame che offre maggiori informazioni, nella valutazione della
pancreatite acuta le indicazioni della Risonanza Magnetica sono sostanzialmente
sovrapponibili a quelle della TC, con il vantaggio, per la RM di riconoscere più
agevolmente le emorragie parenchimali e di permettere lo studio delle vie biliari e del
dotto pancreatico mediante colangio-RM [B, JPN]. L’uso generalizzato di tale indagine è
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
29
tuttavia limitato dalla ancora scarsa diffusione di macchine di alta gamma e dai tempi di
esame molto più lunghi rispetto alla TC.
TABELLA VI: GRADAZIONE TC DELLA PANCREATITE ACUTA, (BALTHAZAR,2002)
GRADO TC
PUNTI
Segni TC
A
0
Pancreas normale
B
1
Pancreas ingrandito
C
2
D
3
Infiammazione/infiltrazione del pancreas
e/o del grasso peripancreatico
Singola raccolta fluida peripancreatica
E
4
Due o più raccolte fluide e/o presenza di
gas retroperitoneale
L’esame TC permette anche di riconoscere la presenza di necrosi ghiandolare e di
valutarne, anche approssimativamente, la percentuale (tab. VII)
TABELLA VII: Necrosi, (Balthazar,2002)
Percentuale
0
<30
30-50
>50
Punti addizionali
0
2
4
6
Il TC severity index, basato sulla valutazione della percentuale di necrosi pancreatica e
dell’estensione delle raccolte peripancreatiche, secondo le classificazioni di Balthazar, è in
grado di predire l’outcome della pancreatite acuta severa [A, JPN]. (tab.VIII)
Vi è infatti una correlazione statisticamente significativa tra l’insorgenza di complicazioni,
e la mortalità nei pazienti stratificati secondo l’indice suddetto [A, JPN]. (tab IX)
TABELLA VIII: CT Severity Index, (Balthazar,2002)
CT Grade
Punti
A
B
C
D
E
0
1
2
3
4
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
Percentuale
Necrosi
0
0
<30
30-50
>50
Punti
addizionali
0
0
2
4
6
Severity
Index
0
1
4
7
10
30
TABELLA XI: CT Severity Index, (Balthazar,2002)
punteggio
0-1
2
7- 10
Complicazioni gravi
0%
4%
92%
mortalità
0%
0%
17%
6.3 TERAPIA DELLA PA SEVERA
6.3.1 Centri di riferimento per il trattamento della pancreatite acuta severa
Le linee guida JPN raccomandano [A] il trasferimento della pa severa in centri
specialistici; quelle UK lo raccomandano [B] solo in presenza di estesa necrosi pancreatica
(>30%) o di altre complicanze che richiedano un ricovero in rianimazione o procedure di
radiologia interventistica, endoscopiche, chirurgiche [B].
Comunque la decisione del trasferimento deve essere presa dopo aver valutato l’effetto
del viaggio sulle condizioni cliniche del pz.(JPN).
Il centro specialistico deve essere dotato di un Team multidisciplinare di specialisti in
chirurgia, endoscopia, terapia intensiva, anestesia, gastroenterologia e nutrizione:
• Il chirurgo e il gastroenterologo devono possedere specifiche conoscenze in
malattie bilio-pancreatiche.
• Gli intensivisti devono essere esperti in pz. critici, con problematiche renali e
respiratorie.
• La radiologia deve essere dotata di TAC multislice, i radiologi devono avere
esperienza nell’applicazione di drenaggi percutanei
• gli endoscopisti devono avere esperienza in ERCP e manovre endoscopiche.
• gli ecografisti devono possedere particolare competenza nella US biliopancreatica.
(UK)
Il Tavolo che ha costruito il PDTA “pancreatite acuta” ha dato mandato al nucleo tecnico
HTA dell’A.Re.S.S. di valutare quali fossero i volumi di attività consigliabili per un cento di
riferimento per il trattamento della pancreatite acuta severa e l’esecuzione di esami
endoscopici ad elevata complessità, quale l’ERCP, talora necessario nel corso di tale
patologia. Il nucleo tecnico ha prodotto un documento approfondito (allegato 2) che, in
sintesi, per la pancreatite acuta severa, evidenzia una considerevole riduzione della
mortalità nei reparti che effettuano almeno 30 ricoveri per pancreatite acuta/anno e, per
l’ERCP, un aumento della qualità e degli esiti in quelle endoscopie che effettuano almeno
200 ERCP/anno.
6.3.2 profilassi/terapia antibiotica
Profilassi
I pazienti con dimostrata pancreatite necrotica che coinvolge >30% del parenchima
dovrebbero ricevere antibiotico [A,JPN-A,IAPgs].
I carbapenemici (imipenem/meropenem) sono i farmaci di scelta.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
31
Non vi è indicazione a trattamento antifungino empirico. [A,JPN]
La durata del trattamento antibiotico non dovrebbe eccedere i 14 giorni [B, UK].
Terapia
La distinzione tra necrosi sterile e infetta è difficile; le due condizioni possono condividere
le stesse alterazioni cliniche e biologiche; la presenza di aria in retro peritoneo (TC) è
caratteristica di una infezione. La diagnosi di necrosi infetta dovrebbe essere documentata
da prelievi microbiologici: l’aspirato con ago sottile (FNAB) è raccomandato per
differenziare le due condizioni nei pazienti che hanno necrosi e segni clinici di sepsi .
[B,UK]
E’ importante sottolineare la necessità di eseguire un esame microbiologico completo sul
materiale aspirato: esame microscopico (gram) e colturale per batteri e miceti.[IAPgs B].
Esistono marcatori biologici di gravità e di prognosi (procalcitonina e interleuchina-6); i
loro valori sono generalmente bassi nella pancreatite edematosa, mentre aumentano nella
necrosi infetta (procalcitonina) e nella necrosi sterile ed infetta (IL-6). Valori bassi di
entrambi sono fattori predittivi negativi di necrosi.
Scelta dell’antibiotico
la terapia dovrebbe essere impostata sulla base di isolamento e antibiogramma; i
carbapenemici sono di prima scelta per il trattamento empirico; il trattamento dovrebbe
essere successivamente guidato dai dati microbiologici: occorre ricordare che l’isolamento
di un solo microrganismo non significa che non vi sia flora polimicrobica (25% dei casi),
per cui è sempre necessario ottenere un esame microscopico (gram). Sono possibili
alternative di terapia empirica, basate sempre sulla conoscenza delle epidemiologia locale
(germi prevalenti, spettro di suscettibilità) e sulla storia clinica del paziente (recenti
ricoveri, terapia antibiotiche): ciprofloxacina+metronidazolo, cefalosporine di terza
generazione + metronidazolo; aggiungere farmaco anti-Gram positivo se tale è il risultato
dell’esame batterioscopico o del colturale; antifungino se miceti all’esame microscopico o
al colturale.
Una terapia antibiotica può essere appropriata in presenza di segni e sintomi di infezione:
deve essere preceduta da un approfondito studio microbiologico diretto alla ricerca di
sorgente della infezione: emocolture da catetere venoso centrale o periferico, colture da
ogni altra sede secondo indicazione clinica (urine, espettorato, ecc.), studi strumentali per
la ricerca di focus di origine della infezione
6.3.3 terapia nutrizionale (raccomandazioni da L.G. ESPEN)
In corso di pancreatite acuta si verificano alterazioni metaboliche specifiche e nonspecifiche [Ib].
Il metabolismo basale aumenta in risposta allo stress dovuto allo stato infiammatorio e al
dolore, conducendo ad un aumento della spesa energetica totale.
Nella PA severa necrotizzante, l’80% di tutti i pazienti è catabolico [Ib] con un’elevata
spesa energetica ed un aumentato catabolismo proteico [IIa].
Il bilancio azotato negativo può raggiungere i 40 gN/die (pari a circa 250 g di Proteine/die)
e può avere effetti deleteri sia sullo stato nutrizionale che sulla progressione di malattia.
Su questi presupposti si basa il razionale dell’intervento nutrizionale, che deve iniziare
dopo le prime 48 ore, a raggiunta stabilizzazione emodinamica del pz.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
32
Nutrizione entrale
La nutrizione entrale è indicata se possibile (ESPEN,A).
Recenti evidenze incoraggiano un maggiore uso della NE vs NP nella pancreatite acuta
severa, quando possibile: la NE riduce significativamente la SIRS, determina una down-
regulation della produzione di citochine splancniche e modula la risposta di fase acuta,
riducendo così il livello di catabolismo e preservando il patrimonio proteico [Ib].
La NE dovrebbe essere eseguita preferibilmente con una sonda digiunale [Ib] mediante
a) posizionamento a livello gastrico e successiva migrazione in digiuno oppure b) ausilio
fluoroscopio o, infine, c) guida endoscopica. Se tale posizionamento non è consentito si
può ricorrere alla sonda naso gastrica.
In uno studio recente la sonda naso-gastrica si è dimostrata sicura, dal momento che sono
state rilevate solo piccole differenze nel controllo del dolore, nella concentrazione di PCR o
nell’outcome clinico tra le due metodiche (digiunale o gastrica).
Nella PA severa con complicanze (fistole, ascite, pseudocisti) la nutrizione via sonda può
essere effettuata con successo. Nell’ostruzione allo svuotamento gastrico l’apice della
sonda dovrebbe essere posizionato distalmente all’ostruzione.
In caso di intervento chirurgico per la pancreatite è possibile posizionare una
digiunostomia intraoperatoria per la gestione della NE postoperatoria [C]. Comunque la
digiunostomia dovrebbe essere posizionata solo quando il rischio di dislocazione della
sonda è minimo.
Metodo di somministrazione.
E’ suggerito usare la NE in infusione continua in tutti i pz che la tollerano [C].
In accordo con l’opinione di esperti, la NE dovrebbe essere somministrata in continuo
(24h) attraverso sonda digiunale con pompa peristaltica, ma la base di evidenza per
questo statement è debole.
Tipo di miscela nutrizionale.
La miscela elementare può essere usata con sicurezza [A]. La miscela standard è
solitamente ben tollerata [C]. L’opinione di esperti oggi accreditata è di iniziare la NE con
una miscela standard e di passare a quella elementare qualora la prima non sia tollerata.
I fabbisogni nutrizionali per la NE sono i seguenti:
o energia: 25 – 35 kcal n.p./kg peso corporeo/die
carboidrati: 3 – 6 g/kg peso corporeo/die, in rapporto alla glicemia; è consigliato
mantenere valori vicini ai limiti di norma anche mediante l’infusione di insulina
esogena
lipidi: lipidi: fino a 2 g/kg peso corporeo/die in rapporto alla trigliceridemia; è
consigliato mantenere livelli compresi tra 180 e 270 mg/dl, interrompendo
l’infusione se i valori restano più alti per più di 72 ore
o proteine: 1.2 – 1.5 g/kg peso corporeo/die
Particolare attenzione deve essere posta alla gestione della nutrizione artificiale per evitare
un overfeeding:
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
33
•
•
In caso di SIRS o MODS o quando il paziente è a rischio di refeeding syndrome il
limite massimo di apporto calorico deve essere ridotto a 15 – 20 kcal n.p./kg peso
corporeo/die [B]
In caso di paziente obeso è più corretto definire il fabbisogno calorico in base alla
determinazione della spesa energetica basale (BEE).
Nel caso la NE non riesca a soddisfare il fabbisogno calorico-proteico del paziente è
necessario supplementare la quota mancante per via parenterale [A].
Si dovrà ricorrere alla NP nel caso in cui la NE non sia possibile per:
• difficoltà al posizionamento della sonda enterale
• intolleranza alla nutrizione enterale
• alterazioni della canalizzazione (ritardato svuotamento gastrico, ileo paralitico)
• fistola pancreatica ad alta gettata
• sindrome da compartimentalizzazione addominale
Nutrizione parenterale
Dovrebbe avvenire usando la via venosa centrale che deve essere preferita a quella
periferica. [B]
I fabbisogni nutrizionali per la NP sono i seguenti:
o energia: 20 – 30 kcal n.p./kg peso corporeo/die
carboidrati: 3 – 6 g/kg peso corporeo/die, in rapporto alla glicemia; è consigliato
mantenere valori vicini ai limiti di norma anche mediante l’infusione di insulina
esogena
lipidi: 0.8 – 1.5 g/kg peso corporeo/die in rapporto alla trigliceridemia; è
consigliato mantenere livelli compresi tra 180 e 270 mg/dl, interrompendo
l’infusione se i valori restano più alti per più di 72 ore
o proteine: 1.2 – 1.5 g/kg peso corporeo/die (da ridurre a 0.8 – 1.2 g/kg peso
corporeo in caso di insufficienza renale/epatica complicante la PA)
Particolare attenzione deve essere posta alla gestione della nutrizione artificiale per evitare
un overfeeding:
• In caso di SIRS o MODS o quando il paziente è a rischio di refeeding syndrome il
•
limite massimo di apporto calorico deve essere ridotto a 15 – 20 kcal n.p./kg peso
corporeo/die [B]
In caso di paziente obeso è più corretto definire il fabbisogno calorico in base alla
determinazione della spesa energetica basale (BEE).
Quando la nutrizione parenterale è indicata, la supplementazione ev con glutamina (0.3
– 0.5 g/kg peso corporeo del dipeptide Ala-Gln) deve essere considerata. [B]
Quando la NE non è consentita, è suggerito combinare la NP con un piccolo volume di
miscela enterale elementare o immunostimolante somministrato per via digiunale con
infusione continua a bassa velocità (10-30 ml/h)
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
34
Ripresa dell’alimentazione orale
Il passaggio dalla nutrizione artificiale a quella orale dovrebbe essere precoce e graduale,
in accordo con le condizioni cliniche del pz. e con il decorso della malattia; la sospensione
della nutrizione artificiale può avvenire,però, solo al raggiungimento di un apporto
alimentare sufficiente alla copertura dei fabbisogni nutrizionale del pz.
E’ consigliata una ripresa dell’alimentazione con una dieta ricca in carboidrati e proteine e
povera di grassi(‹30% delle calorie totali). (ESPEN)
6.3.4 terapia antisecretiva pancreatica e antiproteasica
L’uso di farmaci antisecretivi (Somatostatina e analoghi) e antiproteasici è controverso.
Le linee guida giapponesi raccomandano l’infusione continua intravenosa di alte dosi di
antiproteasici (Gabesato Mesilato), in quanto ridurrebbero l’incidenza di complicanze nella
fase precoce della pa severa [B,JPN].
Il dosaggio consigliato è di 900 mg/die
6.3.5 terapia del dolore
Vedi § 6.1.9.
Nella pa severa in pazienti settici o comunque con disturbi circolatori , respiratori ecc. può
essere utilizzata la ketamina in infusione continua (10 mg/h in drip) che controlla il dolore
senza interferire con l’emodinamica e la ventilazione.
PCA (patient-controlled analgesia) Potrebbe essere considerata un 4° gradino della scala
OMS. Questa tecnica prevede che delle piccole dosi di analgesico siano somministrate in
continuo per via endovenosa (ma anche per via sottocutanea o epidurale) al paziente
che, però, può iniettarsi una ulteriore dose, a richiesta.
6.4 TRATTAMENTO DELLA LITIASI BILIARE
6.4.1 Trattamento della litiasi della V.B. in fase precoce
Secondo le linee guida inglesi l’ERCP devrebbe essere eseguita entro 72 ore dalla
comparsa del dolore in pz. con pa severa, etiologia biliare sospetta o provata o quando vi
è colangite, ittero o V.B.P. dilatata; dovrebbe essere eseguita la sfinterotomia sia in
presenza di calcoli[B], sia in loro assenza[C].
Secondo le linee guida giapponesi l’ERCP in fase precoce deve essere eseguita in pz.
con pa nei quali si sospetta un’ostruzione della V.B. o vi è colangite.[A]
Dall’esame di recenti metanalisi si desume però che l’esecuzione della ERCP è mandatoria
nella pa severa, solo in presenza di colangite o di ostruzione persistente della via biliare.
6.4.2 Trattamento della calcolosi della colecisti
La colecistectomia, nei pz. con pa severa biliare e con rischio operatorio non alto, deve
essere eseguita al miglioramento delle condizioni cliniche del pz [C, UK].
6.4.3 Trattamento della calcolosi della V.B. in fase tardiva
Il primo “step”, in pazienti con colelitiasi, è quello di capire se persiste o meno il calcolo a
livello del coledoco; questo per non sottoporre ad inutili ERCP pazienti nei quali si è
assistito ad una migrazione di un calcolo dalla colecisti in coledoco, con sua successiva
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
35
spontanea espulsione. Secondo alcuni studi , è possibile stratificare il rischio (basso,
moderato o alto) di una litiasi coledocica associata, in base all’integrazione di alcuni
parametri clinici (presenza di colangite e/o pancreatite), morfologici ( il calibro della via
biliare principale) e bioumorali (i test di funzionalità epatica):
-
-
rischio basso (2-3%): assente alterazione degli enzimi epatici, colangite e/o
pancreatite e calibro della VBP inferiore a 7 mm.
rischio intermedio (20-50%): alterazione degli indici di funzionalità epatica (< 2
volte la norma), anamnesi positiva per colangite acuta o pancreatite biliare,
dilatazione del coledoco di 8-10 mm.
rischio alto (50-80%): alterazione indici di funzionalità epatica (> 2 volte la norma),
ittero, recente episodio di colangite e/o pancreatite biliare, dilatazione coledoco >
10 mm
In caso di basso rischio ( es. pancreatite lieve, minimo movimento degli indici di citolisi
prontamente rientrato, non dilatazione delle vie biliari all’eco o alla TAC) non vi è
indicazione all’esecuzione di ulteriori indagini ed il paziente è candidato alla colecistectomia
in elezione con eventuale colangiografia intraoperatoria ed eventuale trattamento con
rendez-vous intraoperatorio se riscontro di coledocolitiasi. In caso di rischio intermedio,
sono necessarie ulteriori indagini (ecoendoscopia, colangio-RM) per conferma od
esclusione della litiasi coledocica.
Qualora il rischio sia alto, è indicata l’ERCP senza alcun altra indagine intermedia.
6.5 RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
6.5.1 prelievo per esame batteriologico
Nel sospetto di necrosi pancreatica infetta è indicata l’esecuzione di FNA sotto guida TC
o EUS per l’esame batteriologico [A,JPN-UK-B,IAPgs] e per l’indicazione all’intervento
chirurgico [B,IAPgs].
6.5.2 drenaggio radiologico di raccolte ascessuali
In presenza di raccolte ascessuali pancreatiche vi è indicazione al drenaggio chirurgico o
radiologico, comprensivo di antibiogramma. [B,JPN-UK-IAPgs]. In caso di insuccesso, si
deve eseguire il drenaggio chirurgico [A,JPN].
Per quanto riguarda la necrosi pancreatica infetta, malgrado vi sia indicazione
all’intervento chirurgico, può essere previsto un tentativo di drenaggio radiologico [B,UKIAPgs], nonostante non vi siano, a questo riguardo, ampie casistiche.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
36
6.6 MONITORAGGIO DELLA PA
6.6.1 monitoraggio clinico
E’ necessario eseguire almeno quotidianamente il bilancio idro-elettrolitico, con
conseguente reintegro; frequentemente rideterminare gli score di gravità e la valutazione
della pressione intra-addominale(IAPgs); per quest’ultima vedi § 6.9.3
E’ inoltre utile il controllo di alcuni parametri nutrizionali. In particolare: a) valutare
l’efficacia del supporto nutrizionale mediante il monitoraggio dell’azoturia 24h (bilancio
azotato); b) verificare il recupero della capacità protidosintetica mediante dosaggio di
prealbumina (emivita 2-3 giorni), transferrina (emivita 8-10 giorni) o albumina (emivita 20
giorni), avendo cura di richiedere il dosaggio diretto dell’albumina e non il valore derivato
dall’elettroforesi delle proteine; c) verificare eventuali carenze nutrizionali specifiche (folati,
B12, tiamina, selenio, zinco)
6.6.2 monitoraggio strumentale
Durante il ricovero ospedaliero, nei pazienti con CT severity index 0 – 2 non pare
necessario un ulteriore controllo TC se il quadro clinico non suggerisce nuove
complicazioni. Nei pazienti con CT severity index 3 – 10 il controllo TC è opportuno sia
all’insorgenza di nuove complicazioni, sia nel caso di deterioramento delle condizioni
cliniche (UK).
Anche se l’andamento della malattia durante il ricovero è regolare, la TC di controllo dovrà
essere comunque eseguita prima delle dimissioni, per escludere la presenza di
complicanze anche asintomatiche, quali l’evoluzione delle raccolte in pseudocisti o gli
pseudoaneurismi (UK).
6.7 GESTIONE DELLA PA MODERATA
6.7.1 profilassi/terapia antibiotica
Profilassi
Non vi è indicazione alla profilassi in pz. Con pa moderata (Banks, AGA, UK, IAPgs)
Terapia
Un trattamento antibiotico può essere impostato in presenza di segni e sintomi di infezione
nell’ambito di un approfondito studio microbiologico (emocolture, uro coltura, escreato
ecc.) e strumentale per la ricerca della fonte della infezione.
6.7.2 terapia nutrizionale (raccomandazioni da L.G.ESPEN)
Dati della letteratura (Bradley EL. Atlanta Criteria. Arch Surg, 1993) confermano che il
75% circa dei pazienti affetti da pancreatite acuta presentano la forma lieve/moderata con
una mortalità < all’1%. In considerazione di ciò e dell’esperienza clinica, i pazienti con
PA moderata possono riprendere l’alimentazione orale dopo un breve periodo di digiuno se
il dolore è cessato e i valori di amilasi e lipasi sono in riduzione [Ib, A].
Quindi la nutrizione artificiale non è necessaria se il pz può riprendere una alimentazione
normale dopo 5 – 7 giorni [B]; entro questo limite non ha alcun impatto positivo sul
decorso della malattia e perciò non è raccomandata [Ib, A].
Lo schema suggerito è quindi il seguente:
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
37
o step 1 (dal giorno 2 al giorno 5)
digiuno
trattare la causa della pancreatite
trattamento del dolore
reintegro idro-elettrolitico
o step 2 (dal giorno 3 al giorno 7, in assenza di dolore ed in corso di regressione dei
valori enzimatici)
iniziale rialimentazione *
dieta post-pancreatite **
o step 3
dieta normale ***
* al primo giorno di ripresa dell’alimentazione, solo liquidi zuccherati
** dieta ricca in carboidrati e proteine e povera di grassi (< 30% delle calorie totali); utile
schema alimentare preparato da un Dietista e concordato con Reparto di degenza e
Cucina
*** in seguito dieta libera equilibrata e normo-ripartita con attenzione agli eccessi di
carboidrati, grassi e alcol
Bisogna considerare che una concentrazione di lipasi sierica > 3 volte il limite superiore ed
un alto punteggio al Balthazar rilevati all’inizio della rialimentazione sono identificati come
fattori di rischio per la ripresa del dolore (IIa).
In caso di ricorso alla Nutrizione Artificiale, come innanzi detto per la pa severa, la NE è
da privilegiare rispetto alla NP.
Per il passaggio dalla nutrizione artificiale a quella orale e la composizione della dieta, vedi
§ 6.3.2 (ripresa dell’alimentazione orale).
6.7.3 terapia antisecretiva e antiproteasica
Non vi è indicazione alla terapia con farmaci antisecretivi e antiproteasici.
6.7.4 terapia del dolore
Vedi § 6.1.8
6.8 TERAPIA DELLA LITIASI COLECISTO/COLEDOCICA
6.8.1 trattamento della calcolosi della colecisti
La colecistectomia, nei pz. con pa moderata biliare e con rischio operatorio non alto,
deve essere praticata appena superato l’attacco acuto, possibilmente durante lo stesso
ricovero o differita di 2 settimane [C,UK] allo scopo di ridurre il significativo rischio di
recidiva della pancreatite.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
38
6.8.2 trattamento della calcolosi della V.B.
Si rimanda al capitolo 4.5.3 la diagnostica ed il trattamento della litiasi sospetta o
accertata della via biliare.
6.9 TERAPIA INTENSIVA
6.9.1 indicazioni al ricovero Si rende necessario il ricovero in UTI allorquando insorga
un’insufficienza respiratoria che richieda il ricorso alla ventilazione meccanica o quando si
renda necessario un monitoraggio emodinamico invasivo.
6.9.2 trattamento in terapia intensiva
Durante la prima settimana 3 sono i problemi da affrontare: l'insufficienza respiratoria, lo
shock, l’insufficienza renale; più tardivamente la sepsi.
1. L' insufficienza respiratoria :
è da addebitare al rilascio di citochine (IL6, IL8) che provocano la trasudazione di fluidi dai
capillari polmonari agli alveoli. La grave ipossemia (pO2<= 60 mmHg) è legata, inoltre, a:
-Versamento pleurico (stravaso di essudato pancreatico attraverso canali linfatici)
-Atelectasia (la Fosfolipasi inattiva il surfattante alveolare)
-Ipoventilazione (antalgica).
Le metodiche di ventilazione (vam niv cpap psv sono le sigle che identificano il supporto
respiratorio attuabile in questi pazienti) esulano da questo PDTA ma sembra utile
accennare almeno agli obiettivi che ci si propone di raggiungere con la ventilazione
meccanica:
•
Target tidal volume di 6 ml/kg di peso (valore predittivo) in pazienti con ALI/ARDS
•
Pressione di plateau non inferiore ≤ 30 cm H2O. Considera sempre la compliance
della parete toracica quando regoli la pressione di plateau
•
Ipercapnia permissiva se c'è bisogno di ridurre o diminuire la pressione di plateau
ed il tidal volume.
•
La pressione positiva di fine espirazione deve essere settata per evitare il collasso
del polmone alla fine dell'espirazione. Il livello della peep impostata deve essere
guidato dalla FiO2 richiesta per mantenere una buona ossigenazione
•
Considerare l'uso della posizione prona nell'ARDS là dove bisogna altrimenti usare
pressioni di volume od avere livelli di FiO2 con metodiche ventilatorie lesive
dell'integrità polmonare
•
I pazienti devono essere ventilati normalmente in posizione semiseduta
2. Lo shock
Sequestro peripancreatico: formazione del III spazio, ipotensione. Si rende necessario un
aumento della gittata cardiaca tramite l'incremento della frequenza e della contrattilità.
Tuttavia non sempre è possibile ottenere un aumento della performance cardiaca sia per
una possibile preesistente cardiopatia alcolica che per la liberazione del MDF (Myocardial
depressant factor), una chinina liberata dal pancreas ad azione inotropa negativa.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
39
E’ necessario mantenere la PVC: ≥ 8 mm Hg (≥ 12 se ventilato) mediante l’infusione di
1000 ml di Cristalloidi oppure 300-500 ml di colloidi ogni 30 min.
Più rapidi e più elevati volumi di liquidi debbono essere dati là dove è presente una
ipoperfusione tissutale; la quantità di fluidi deve essere ridotta se vi è un aumento del
precarico senza miglioramento emodinamico.
I farmaci più frequentemente usati nella terapia dello shock sono:
- vasopressori
• Bisogna mantenere una pressione arteriosa media di ≥ 65 mmHg.
• Noradrenalina e dopamina in centrale sono i farmaci di prima scelta.
• Adrenalina, fenilefrina o vasopressina non devono essere somministrati all'inizio
dello shock settico.
• Vasopressina 0,03 units/min può essere aggiunta in un secondo tempo alla
noradrenalina con un effetto aggiuntivo equivalente alla noradrenalina da sola.
• L'Adrenalina può essere usata come primo vasopressore se la risposta alla
noradrenalina e alla dopamina è debole.
• Non usare basse dosi di dopamina a dosaggio dopaminergico per protezione renale.
• In pazienti che richiedono vasopressori, inserire un catetere arterioso per il
rilevamento della PA quanto prima possibile.
•
- inotropi
• La dobutamina va usata solo in caso di disfunzione cardiaca o là dove vi è un
aumento del precarico ed una bassa gittata cardiaca (bassa frazione d'eiezione).
• Cercare di non incrementare l'indice cardiaco al di sopra dei livelli di guardia.
•
- steroidi
• Usare l'Idrocortisone endovena nello shock settico dell'adulto poco rispondente alla
terapia con liquidi e vasopressori
• ACTH test di stimolazione non è raccomandato per identificare quegli adulti con
shock settico che potrebbero ricevere idrocortisone
• l'Idrocortisone è preferibile al Desametasone
• Fludrocortisone (50 microgr x os una volta die) può essere inserito in alternativa all'
idrocortisone là dove c'è una perdita di attività dei mineralcorticoidi.
• La terapia steroidea può essere sospesa quando i vasopressori non sono più
richiesti
• L' Idrocortisone potrebbe essere usato ad una dose ≤ di 300 mg al giorno
3. l' insufficienza renale
Dopo lo shock è la manifestazione più frequente della P.A. grave, è gravata da una
mortalità del 50%. La sua genesi è multifattoriale:
-Fattori meccanici che riducono la perfusione
-Shock ipovolemico, ipotensione
-Rilascio di vasopressina e riduzione del flusso renale
-Glomerulonefrite enzimatica
- Prodotti di degradazione della necrosi
In rianimazione veranno attuate metodiche di emofiltrazione CVVH e controllo metabolico.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
40
4. la sepsi
Dopo la prima settimana la complicanza più temibile è la sepsi causata dalla migrazione
batterica dal tratto gastrointestinale: Il trattamento antibiotico in rianimazione non si
discosta da quanto già detto in altra parte del DPTA. E', invece, possibile monitorizzare i
parametri emodinamici (gettata cardiaca, resistenze periferiche, consumo di O2, PVC)
sostituire la funzione respiratoria (peep,manovre di reclutamento ecc) detersione di focolai
necrotici (debridement chirurgico- vedi percorso successivo).
6.9.3 Indicazioni al trattamento chirurgico
Vi è indicazione al trattamento chirurgico in pz con pa severa, in ambiente rianimatorio,
nei seguenti casi:
• l’instabilità emodinamica in presenza di una necrosi sterile
• la sepsi causata da necrosi pancreatica infetta
-PA severa con necrosi pancreatica sterile
La necrosi sterile, caratteristica della fase precoce della PA severa (primi 15 giorni),
generalmente non è di interesse chirurgico e deve essere trattata conservativamente.
Vi è indicazione chirurgica solo in casi selezionati [B,JPN-IAPgs], come la presenza di
persistente compromissione d’organo, il deterioramento delle condizioni cliniche malgrado
sia stata instaurata una terapia rianimatoria massiva, lo stato di shock.
Tale situazione può verificarsi già nelle prime 72 ore e rende necessario, come fatto
eccezionale, un trattamento chirurgico in fase precoce, mentre generalmente la
chirurgia nelle prime fasi di una PA severa è da proscrivere perché aumenta la mortalità
[B,JPN-IAPgs] e interviene su una necrosi non ancora demarcata.
Recentemente (1-4),inoltre, è considerata una indicazione chirurgica la presenza in corso
di PA severa di una sindrome compartimentale addominale (ACS) dovuta ad un aumento
della pressione intra-addominale (IAP) determinata da vasta area di necrosi (> 50%),
raccolte
addominali,
ileo
paralitico
ed
edema
delle
anse
intestinali.
L’ACS, caratterizzata da importante distensione addominale e shock con disfunzioni o
insufficienza d’organo, si instaura quando la IAP è >20 mmHg.
La IAP viene determinata attraverso la misurazione della pressione endovescicale. Deve
essere effettuato un accurato monitoraggio della IAP con misurazioni ripetute nel corso
della giornata.
La IAP è considerata alta (IAH) quando è ≥ 12 mmHg (tab X). Quando la IAP raggiunge i
12mmHg si verifica una ipoperfusione del tratto gastrointestinale. Questa compromette la
permeabilità intestinale aumentando l’edema delle anse intestinali e la quantità di aria e
fluidi nei visceri con ulteriore aumento della IAP in un circolo vizioso. Se non vi è una
risposta alla terapia medica (infusione liquidi, miorilassanti,procinetici), si giunge alla ACS
con ipoperfusione splancnica e riduzione del ritorno venoso cardiaco. Questi fattori insieme
alla sovradistensione addominale causano una grave compromissione della funzionalità
renale, polmonare e cardiovascolare.
In questi casi può rendersi necessaria una rapida decompressione chirurgica mediante
una laparatomia con drenaggio delle raccolte addominali.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
41
Grado
IAP
Segni clinici
I
12-15 mmHg
Non segni di ACS
II
16-20 mmHg
21-25 mmHg
III
> 25 mmHg
IV
Raccomandazioni
Mantenere un adeguato
volume intravascolare
Oliguria e/o aumento del Mantenere un adeguato
picco della pressione
volume vascolare e
respiratoria (PAP)
stretto monitoraggio
Anuria, aumento PAP e/o Considerare
diminuzione gittata
decompressione
cardiaca
anche non chirurgica*
Anuria, aumento PAP e/o Decompressione
diminuzione gittata
chirurgica
cardiaca
TABELLA X: IAP, SEGNI CLINICI E RACCOMANDAZIONI
*tecniche per ridurre la IAP:
- SNG, sonda rettale
- utilizzo di farmaci sedativi, miorilassanti
- correzione del bilancio idro-elettrolotico
- decompressione endoscopica
-PA severa con necrosi pancreatica infetta
Sebbene ci siano lavori in letteratura (5-6) che ne propugnano il solo trattamento
conservativo non chirurgico (antibiotici, drenaggio radiologico) nei pazienti clinicamente
stabili, la necrosi infetta con segni clinici di sepsi è considerata tradizionalmente una
indicazione alla terapia chirurgica [B, JPN-UK-IAPgs].
Questa evenienza si riscontra in una fase tardiva della PA (generalmente dopo 15 giorni) a
causa di una sovrainfezione della necrosi da traslocazione batterica intestinale.
La diagnosi di necrosi infetta si pone quando siano presenti segni clinici che indicano la
sepsi (febbre, leucocitosi, MOF) ed alla TC addome si riscontri, come segno
patognomonico, la presenza di bolle di gas nella compagine della necrosi pancreatica.
Esistono però casi dubbi in cui può essere difficile fare una diagnosi differenziale tra
necrosi infetta e necrosi sterile.
Infatti una significativa SIRS ( temperatura >38, tachicardia, tachipnea, leucocitosi) può
simulare la presenza di sepsi. In questi casi è indicato il prelievo per esme batteriologico,
come indicato nel § 6.5.1
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
42
7. GLI INDICATORI
INDICATORI DI PROCESSO
1- Raccomandazione: La pa è accompagnata da dolore addominale persistente e severo.
L’analgesia è fondamentale [A,JPN]
Indicatore
N° di pz. con pancreatite acuta ai quali è stata somministrata terapia antidolorifica secondo schema
predeterminato/n° di pz ricoverati per pancreatite acuta
2- Raccomandazione: L’ecografia deve essere eseguita non appena possibile nel sospetto
di pancreatite acuta [A, JPN-C,UK]
Indicatore
N° di pz con pa che hanno eseguito l’ecografia entr o 24 ore/n° di pz con pa (soglia 95%)
Nel denominatore, sono esclusi i pz che, per dubbio diagnostico, hanno già eseguito TAC o RM
3- Raccomandazione: La valutazione della gravità è importante per decidere il trattamento
della pa e la necessità di trasferire il pz. in un centro specializzato [A,JPN].
Indicatore
N° di pz con pa cui è stato calcolato lo score di g ravità/n° di pz con pa (soglia 95%)
4- Raccomandazione: La TC con mdc ev, ed in particolare la TC multidetettore, è
sicuramente l’esame di elezione per la valutazione dei pazienti con diagnosi clinica di
pancreatite acuta [B, JPN] e permette di valutare la gravità della malattia (tab. VI)[C,UKA, JP]. Andrebbe eseguita non prima di 48-72 ore nel sospetto di pancreatite acuta severa
Indicatore
N° di pz con pa severa che hanno eseguita la TAC prima di 48 ore/n° di pz con pa severa (soglia 20%)
5- Raccomandazione: Il TC severity index, basato sulla valutazione della percentuale di
necrosi pancreatica e dell’estensione delle raccolte peripancreatiche, secondo le
classificazioni di Balthazar, è in grado di predire l’outcome della pancreatite acuta severa
[A, JPN].
Indicatore
N° di pz con pa severa cui è stato valutato il TC s everity index /n° di pz con pa severa che hanno ese guito la
TC (soglia 95%)
6- Raccomandazione: La durata della profilassi antibiotica non dovrebbe eccedere i 14
giorni [B, UK].
Indicatore
N° di pz con pa con che hanno eseguito profilassi antibiotica per n° giorni >14/n° di pz con pa che hanno
ricevuto profilassi antibiotica (soglia 10%)
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
43
Nel denominatore, sono esclusi i pz. nei quali è stata instaurata una terapia antibiotica
7- Raccomandazione: l’aspirato con ago sottile (FNAB) è raccomandato nei pz che hanno
necrosi e segni clinici di sepsi . [B,UK]
Indicatore
n° di pz con pa severa e segni di sepsi cui è stata eseguito l’aspirato con ago sottile/n° di pz con p a severa e
segni di sepsi (soglia 90%)
INDICATORI DI ESITO
8- mortalità nella pancreatite acuta ≤ 4%
9- mortalità nella pancreatite acuta severa ≤20%
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
44
Allegato 2
A CURA DI
NUCLEO TECNICO HTA- AReSS, Ileana Baldi (CPO Piemonte), Luca Scaglione (CPO
Piemonte), Carlo Senore (CPO Piemonte.- AReSS)
Introduzione .............................................................................................................. 46
Pancreatite acuta ....................................................................................................... 47
Dati di attività e dati epidemiologici (Pancreatite acuta) ........................................................ 48
ERCP ......................................................................................................................... 61
Dati di attività e dati epidemiologici (procedura ERCP) .......................................................... 60
Metodo di ricerca della letteratura ............................................................................... 62
Linee guida ERCP...................................................................................................................... 64
Raccomandazioni in campo pediatrico ............................................................................................ 67
Relazione volume /esiti ed aspetti organizzativi. .................................................................... 69
Competenza/curve di apprendimento ..................................................................................... 70
Conclusioni ................................................................................................................ 71
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
45
Introduzione
Le patologie del sistema epatobiliopancreatico sono condizioni ricorrenti nella pratica
clinica.
Un esame del dotto biliare o del dotto pancreatico è spesso richiesto per giungere ad una
diagnosi corretta e per la gestione completa del paziente. Negli ultimi anni, lo sviluppo
della tecnologia ha consentito l’introduzione della colangiografia e pancreatografia
endoscopica retrograda (ERCP) quale strumento per il trattamento di molte patologie
biliari e pancreatiche.
L’ERCP consente la visualizzazione dell’ampolla del Vater (punto di confluenza dei dotti
biliare e pancreatico) e, in combinazione con opportune tecniche radiografiche, consente
una visualizzazione di alta qualità dei dotti biliari e pancreatici.
Attraverso l’ERCP, si possono effettuare biopsie e brush per la raccolta di tessuto o cellule,
rimuovere calcoli nel dotto biliare e pancreatico, trattare stenosi delle vie biliari ed
effettuare interventi di palliazione per tumori maligni. L’ERCP espone a complicanze, quali
la pancreatite acuta, l’emorragia, la perforazione intestinale.
Il tavolo di esperti, costituito all’interno dell’A.Re.S.S., per lo sviluppo di una rete
gastroenterologica piemontese, affrontando lo sviluppo di un percorso diagnosticoterapeutico per la gestione delle Pancreatiti acute, si è rivolto, nel gennaio u.s., al nucleo
tecnico HTA per l’ approfondimento di alcuni specifici temi.
Al fine di una nuova organizzazione dell’attività dei centri diagnostico-terapeutici per le
patologie epato-biliari e pancreatiche ci sono stati esposti i seguenti quesiti:
•
in merito alla pancreatite acuta:
- reperimento delle linee guida più recenti per la diagnosi e la cura;
- valutazione dei bisogni:
analisi della letteratura al fine di stimare il numero di pancreatiti acute
(incidenza e/o prevalenza) in Piemonte;
analisi del tracciato delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) per
l’elaborazione del numero di ricoveri effettuati nella nostra Regione e
selezione di criteri per la definizione di severità della condizione
clinica;
- elementi organizzativi: ricerca in letteratura di indicazioni per l’organizzazione
di un centro di riferimento per la diagnosi e la cura (struttura dell’equipe
curante e dell’attrezzatura richiesta);
•
in merito alla procedura ERCP:
- individuazione di linee guida per rispondere ai quesiti relativi alle strutture
nelle quali deve essere eseguita, alla costituzione dell’equipe che effettua la
procedura, in particolare per la cura delle pancreatiti acute;
- elementi organizzativi: esistenza in letteratura di indicazioni per
l’organizzazione di un centro di riferimento per la cura delle pancreatiti acute,
ove venga effettuata l’ERCP, soprattutto al fine della massima sicurezza per il
paziente;
- relazione volume-outcome;
- valutazione della learning curve in letteratura per tale procedura;
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
46
-
in base all’analisi del tracciato SDO e del flusso C, quante ERCP vengono
eseguite ogni anno in Piemonte; in quali strutture? Associata a quali
diagnosi?
Pancreatite acuta
È stata effettuata una ricerca della letteratura per reperire le linee guida relative alla
gestione della pancreatite acuta. I metodi e l’elenco delle linee guida reperite sono di
seguito indicati:
Metodo di ricerca:
Sono stati interrogati i seguenti database di linee guida (n° documenti trovati):
Canadian Task force on preventive Health care: 0
- CMA Infobase: clinical practice guidelines (CPGs): 0
- Guidelines International network: 0
- Scottish Intercollegiate guidelines network: 0
- Sistema Nazionale Linee guida- Istituto superiore di Sanità: 0
- New Zealand Guidelines Group: 0
- National Guidelines Clearinghouse: 13
- National Library of Guidelines: 1
E’ stata interrogata la banca dati bibliografica Pubmed con le seguenti combinazioni di
parole chiave:
• "Pancreatitis"[Mesh] AND "Guidelines as Topic"[Mesh] -> (articoli Inglese, Tedesco,
Francese, Spagnolo, Italiano, escluse letter e editorial)
• "Pancreatitis"[Mesh] AND "Evidence-Based Emergency Medicine"[Mesh]
• "Pancreatitis"[Mesh] AND "Evidence-Based Practice"[Mesh]
• "Pancreatitis"[Mesh] Limits: Practice Guideline, English, French, German, Italian,
Spanish
• "Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde" [Mesh]
Risultati:
La ricerca ha condotto al reperimento di 12 documenti classificati come linee guida dai
database nei quali è stata effettuata la ricerca (per linee guida proposte dalle stesse
società/autori è stata presa solo la versione più recente).
1. Banks PA, Freeman ML; Practice Parameters Committee of the American College of
Gastroenterology. Practice guidelines in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol.
2006 Oct;101(10):2379-400.
2. Hirota M, Takada T, Kawarada Y, Hirata K, Mayumi T, Yoshida M, Sekimoto M,
KimuraY, Takeda K, Isaji S, Koizumi M, Otsuki M, Matsuno S; JPN Guidelines for the
management of acute pancreatitis: severity assessment of acute pancreatitis. J
Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13(1):33-41.
3. Isaji S, Takada T, Kawarada Y, Hirata K, Mayumi T, Yoshida M, Sekimoto M, Hirota
M, Kimura Y, Takeda K, Koizumi M, Otsuki M, Matsuno S; JPN. JPN Guidelines for
the management of acute pancreatitis: surgical management. J Hepatobiliary
Pancreat Surg. 2006;13(1):48-55.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
47
4. Kimura Y, Takada T, Kawarada Y, Hirata K, Mayumi T, Yoshida M, Sekimoto M,
Hirota M, Takeda K, Isaji S, Koizumi M, Satake K, Otsuki M, Matsuno S; J JPN
Guidelines for the management of acute pancreatitis: treatment of gallstoneinduced acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13(1):56-60.
5. Mayumi T, Ura H, Arata S, Kitamura N, Kiriyama I, Shibuya K, Sekimoto M, Nago N,
Hirota M, Yoshida M, Ito Y, Hirata K, Takada T; Working Group for the Practical
Evidence-based clinical practice guidelines for acute pancreatitis: proposals. J
Hepatobiliary Pancreat Surg. 2002;9(4):413-22.
6. Navarro S, Amador J, Argüello L, Ayuso C, Boadas J, de Las Heras G, Farré
A,Fernández-Cruz L, Ginés A, Guarner L, López Serrano A, Llach J, Lluis F, de
Madaria E, Martínez J, Mato R, Molero X, Oms L, Pérez-Mateo M, Vaquero E; Club
Español Biliopancreático para el Tratamiento de la Pancreatitis Aguda.
Recommendations of the Spanish Biliopancreatic Club for the Treatment of Acute
Pancreatitis. Consensus development conference. Gastroenterol Hepatol. 2008 JunJul;31(6):366-87.
7. Pancreatic Disease Group, Chinese Society of Gastroenterology & Chinese Medical
Association. Consensus on the diagnosis and treatment of acute pancreatitis. Chin J
Dig Dis. 2005;6(1):47-51.
8. Sekimoto M, Takada T, Kawarada Y, Hirata K, Mayumi T, Yoshida M, Hirota M,
Kimura Y, Takeda K, Isaji S, Koizumi M, Otsuki M, Matsuno S. JPN Guidelines for
the management of acute pancreatitis: epidemiology, etiology, natural history, and
outcome predictors in acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg.
2006;13(1):10-24.
9. Takeda K, Takada T, Kawarada Y, Hirata K, Mayumi T, Yoshida M, Sekimoto M,
Hirota M, Kimura Y, Isaji S, Koizumi M, Otsuki M, Matsuno S. JPN Guidelines for the
management of acute pancreatitis: medical management of acute pancreatitis. J
Hepatobiliary Pancreat Surg. 2006;13(1):42-7.
10. Uhl W, Warshaw A, Imrie C, Bassi C, McKay CJ, Lankisch PG, Carter R, Di Magno E,
Banks PA, Whitcomb DC, Dervenis C, Ulrich CD, Satake K, Ghaneh P, Hartwig
W,Werner J, McEntee G, Neoptolemos JP, Büchler MW; International Association of
Pancreatology. IAP Guidelines for the Surgical Management of Acute Pancreatitis.
Pancreatology. 2002;2(6):565-73.
11. Wu xie-Ning. Guidelines for treatment of severe acute pancreatitis. Hepatobiliry and
Pancreatic diseases international, 1, (3): 446-451; 2002.
12. UK guidelines for the management of acute pancreatitis, Gut 2005;54;1-9
Pancreatite acuta: dati epidemiologici e dati di attività
La ricerca di dati epidemiologici inerenti l’incidenza della pancreatite acuta è stata
effettuata tramite la banca bibliografica PubMed con le seguenti parole chiave:
“Incidence” AND “acute pancreatitis” Limits: published in the last 5 years, Humans, MetaAnalysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Review, English, French, Italian,
Spanish. Sono stati trovati 22 articoli, di cui 5 pertinenti.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
48
Numerosi studi di popolazione hanno analizzato l’incidenza della pancreatite acuta in
diversi paesi occidentali. L’incidenza sembra simile in Inghilterra (23 casi su 100,00
abitanti), in Olanda, Germania e Norvegia (da 16 a 20 casi su 100,00 abitanti); mentre è
più alta nei paesi scandinavi (Svezia e Finlandia) e negli USA (32-44 su 100,00 abitanti).
I diversi tassi d’incidenza si possono spiegare con l’esposizione differente ai fattori di
rischio per lo sviluppo della pancreatite acuta (alcool, farmaci, abitudini alimentari, ecc).
Altre motivazioni possono risiedere in differenti assetti genetici e nel tipo di classificazione
adottata per la definizione della condizione clinica.
L’incidenza della pancreatite acuta sta aumentando in tutto il mondo; proporzionalmente
sta aumentando di più il numero di pancreatiti acute dovute a calcoli. Ciò potrebbe essere
correlato all’incremento del tasso di obesità, riconosciuto quale fattore di rischio per lo
sviluppo di calcolosi. Anche l’età è un fattore di rischio per lo sviluppo di calcoli.
Dall’analisi del tracciato SDO regionale relativo agli anni 2005-2006-2007 emerge che i
ricoveri effettuati in strutture pubbliche aventi una diagnosi di “pancreatite acuta” (cod.
ICD-9-CM: 577.0) nei campi “diagnosi principale” o in quelli delle “diagnosi secondarie”
sono (vedi figura 1):
• 2005: 2046 (1452 diagnosi principale, 594 diagnosi secondaria)
• 2006: 2132 (1485 diagnosi principale, 647 diagnosi secondaria);
• 2007: 2149 (1413 diagnosi principale, 736 diagnosi secondaria).
Figura 1: Casi di pancreatite acuta, anni 2005-07
Casi di Pancreatite Acuta, Anni 2005-07
2500
2000
647
736
1452
1485
1413
2005
2006
2007
n° di casi
594
1500
1000
500
0
PA (ICD-9-CM: 577.0) in Diagnosi principale
PA (ICD-9-CM: 577.0) in Diagnosi secondarie
Relativamente al triennio considerato, tra coloro che presentano la “pancreatite acuta” tra
una delle diagnosi secondarie si evince che circa il 30% delle diagnosi principali è da
ricondursi a problemi di “calcolosi” (Tab. 1). Effettuando una aggregazione sui primi tre
codici di diagnosi principale emerge che circa il 48% è associata a problemi di colelitiasi
(Tab. 2).
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
49
Tabella 1. Diagnosi principali maggiormente rilevate associate a diagnosi
secondaria di “pancreatite acuta”.
CODICE
574.00
DESCRIZIONE
2005 2006 2007 TOT
CALCOLOSI DELLA COLECISTI,CON COLECISTITE ACUTA , SENZA
OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
59
64
64
187
CALCOLOSI DELLA COLECISTI,SENZA COLECISTITE ACUTA,SENZA
OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
54
56
53
163
CALCOLOSI DELLA COLECISTI, CON ALTRA COLECISTITE, SENZA
OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
34
38
38
110
CALCOLOSI DEL DOTTO BILIARE, SENZA COLECISTITE ACUTA ,
CON OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
25
31
38
94
CALCOLOSI DELLA COLECISTI, CON COLECISTITE ACUTA , CON
OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
15
24
27
66
407
434
516
1357
594
647
736 1977
574.20
574.10
574.51
574.01
…
ALTRE DIAGNOSI
TOTALE
Tabella 2. Diagnosi principali (raggruppate sui primi 3 caratteri) associate a
diagnosi secondaria di “pancreatite acuta”.
CODICE
CODICE
574
CODICE
575
CODICE
576
TOTALE
DESCRIZIONE
COLELITIASI
2005 (%)
286 (48.1%)
2006 (%)
328 (50.7%)
2007 (%)
ALTRI DISTURBI DELLA
COLECISTI
ALTRI DISTURBI DELLE VIE
BILIARI
ALTRO
17 (2.9%)
25 (3.9%)
20 (4.5%)
29 (5.4%)
271 (45,6%)
265 (41,0%)
320 (43,5%)
594
647
736
1977
343 (46.8%)
39 (5.0%)
34 (4.6%)
TOT (%)
957(48,4%)
81 (4,1%)
83 (4,2%)
856
(43,3%)
Concentrando l’attenzione sui ricoveri aventi come diagnosi principale “pancreatite acuta”
le diagnosi secondarie (rilevate nel campo SDO “prima diagnosi secondaria”) più frequenti
risultano essere, ancora una volta, relative a problemi di “calcolosi” (Tab. 3). Da notare
che al 22,7% dei ricoveri non è associata alcuna diagnosi secondaria. Effettuando una
aggregazione sui primi tre codici della prima diagnosi secondaria emerge come circa il
29,4% è associata a problemi di colelitiasi (Tab. 4). Infine, estendendo l’analisi a tutti i
campi di diagnosi secondaria, si evince come problemi di colelitiasi siano associati al
34,9% dei ricoveri, problemi di Ipertensione essenziale benigna siano associati al 15,5%
dei ricoveri e problemi di diabete mellito siano associati al 7,9% dei ricoveri (Tab. 4).
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
50
Tabella 3. Diagnosi secondarie (prima D.S.) più frequenti associate a diagnosi
principale di “pancreatite acuta”.
Prima
diagnosi
secondaria
…
574.20
574.00
574.10
401.1
574.51
577.2
250.00
…
Descrizione
200
5
200
6
200
7
NESSUNA DIAGNOSI SECONDARIA
357
307
324
988
22,7
%
149
146
124
419
9,6%
70
92
65
227
5,2%
44
38
54
136
3,1%
39
46
50
135
3,1%
30
43
45
118
2,7%
18
25
23
66
1,5%
26
21
19
66
1,5%
698
754
685
2137
49,1
%
TOTALE 1452 1485 1413
4350
CALCOLOSI DELLA COLECISTI,SENZA COLECISTITE
ACUTA,SENZA OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
CALCOLOSI DELLA COLECISTI,CON COLECISTITE ACUTA
, SENZA OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
CALCOLOSI DELLA COLECISTI, CON ALTRA
COLECISTITE, SENZA OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
IPERTENSIONE ESSENZIALE BENIGNA
CALCOLOSI DEL DOTTO BILIARE, SENZA COLECISTITE
ACUTA , CON OSTRUZIONE DEL DOTTO BILIARE
CISTI E PSEUDOCISTI DEL PANCREAS
DIABETE MELLITO,TIPO II O NON SPECIFICATO,NON
DEFINITO SE SCOMPENSATO,SENZA MENZ. DI COMPLIC.
ALTRE DIAGNOSI
Totale
complessivo
Tabella 4. Diagnosi secondarie (raggruppate sui primi 3 caratteri) più frequenti
associate a diagnosi principale di “pancreatite acuta”.
PRIMA DIAGNOSI
SECONDARIA
CODICE
…
574
401
577
250
576
571
575
414
427
…
200 200 200
5
6
7
DESCRIZIONE
TOT
22,7
988
%
128 29,4
0
%
3,2%
2,9%
2,6%
2,2%
1,6%
TOT
22,7
988
%
150 34,5
1
%
15,5
676
%
175 4,0%
342 7,9%
179 4,1%
161 3,7%
87 2,0%
64 1,5%
186 4,3%
53 1,2%
124 28,5
399 449 392
0
%
145 148 141 435 100
TOTALE
2
5
3
0
%
217 5,0%
393 46,6
2
%
844
4 …
NESSUNA DIAGNOSI SECONDARIA
357
307
324
COLELITIASI
419
449
412
IPERTENSIONE ESSENZIALE
61
62
60
183 4,2%
MALATTIE DEL PANCREAS
DIABETE MELLITO
ALTRI DISTURBI DELLE VIE BILIARI
MALATTIE EPATICA CRONICA E CIRROSI
ALTRI DISTURBI DELLA COLECISTI
ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA
CRONICA
ARITMIE CARDIACHE
42
46
38
29
27
44
41
38
29
24
52
38
39
37
18
138
125
115
95
69
16
24
24
18
18
17
ALTRE DIAGNOSI SECONDARIE
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
TUTTE LE
DIAGNOSI
SECONDA
RIE
51
Focalizzandosi sui casi di pancreatite acuta individuati come sopra descritto, si è cercato di
selezionare quelli di maggiore severità, secondo tre diversi filtri (F):
1. F1: la presenza di diagnosi di shock (cod ICD-9-CM: 78559, 78550), oppure di
setticemia (cod ICD-9-CM: 03849,-2-0-3), oppure la presenza di interventi di
pancreatectomie (cod ICD-9-CM: 5221,-2);
2. F2: passaggio in terapia intensiva;
3. F3: passaggio in medicina d’urgenza (per gli ospedali che ne possiedono una)1.
Dall’applicazione congiunta dei tre filtri si ottengono, nel 2007, 236 (10,1% dei casi di
pancreatite acuta) ricoveri per pancreatite acuta definibile come severa, di cui 8 individuati
solamente dal filtro F1, 72 solamente dal filtro F2, 109 solamente dal filtro F3 e 47 da una
combinazione tra i tre filtri. In figura 2 e 3 si osservano le intersezioni tra i criteri di
severità utilizzati.
Figura 2. Filtri adottati per definire “severa” una pancreatite acuta.
F1: Presenza diagnosi di shock o
setticemia, oppure
presenza di interventi di
pancreatectomie
F2: Passaggio in
Terapia Intensiva
34
72
8
7
3
3
109
F3: Passaggio in Medicina
d’Urgenza
Totale pancreatiti acute definite gravi,
2007: 236
1 Dal momento che il codice ministeriale della Medicina d’Urgenza coincide con quello della Medicina Interna (026) e pertanto non è
possibile identificarla automaticamente tramite il progressivo del reparto presente sul flusso SDO, si sono individuati dalla Nuova
Anagrafe delle Strutture (NAS) della Regione Piemonte le Unità Operative (UO) la cui descrizione contiene le parole
“medicina”&”urgenza”, quindi si è creata una chiave univoca tramite l’unione del codice delle UO così identificate ed il codice
HSP11Bis (identificante la struttura di erogazione) il cui match su analoga chiave costruita sul flusso SDO ha consentito
l’identificazione dei passaggi in Medicina d’Urgenza (uno tra reparto di ammissione, reparti di trasferimento e reparto di dimissione).
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
52
Figura 3. Contributi dei filtri e loro interazioni nell'individuazione delle
Pancreatiti Acute Severe: 2005-07.
Contributi dei filtri e loro interazioni all'individuazione delle Pancreatiti Acute
Severe nel triennio 2005-07
350
TI, MdU
SSP, TI, MdU
300
SSP, MdU
SSP, TI
250
MdU
TI
200
SSP
Dove:
150
TI = terapia
intensiva;
MdU = Medicina
d’urgenza;
SSP = shock,
setticemia o
pancreatectomie
100
50
0
2005
2006
2007
Come si può apprezzare in figura 3, nel 2007 il numero di pancreatiti severe si riduce di un
terzo circa. L’andamento è determinato dalla netta riduzione dei casi di pancreatiti acute
trattate dalle medicine d’urgenza, elemento che evidenzia possibili criticità di questo filtro
per l’individuazione delle pancreatiti severe.
Tabella 5. Mortalità per pancreatite acuta.
2005
PANCREATITI ACUTE
PANCREATITI ACUTE LIEVI
PANCREATITI
ACUTE
SEVERE
PANC.
ACUTE
SEVERE
INDIVIDUATE
TRAMITE
FILTRO F1, SSP (DI CUI
SHOCK)
PANCREATITI
ACUTE
SEVERE
INDIVIDUATE
TRAMITE FILTRO F2,TI
PANCREATITI
ACUTE
SEVERE
INDIVIDUATE
TRAMITE FILTRO F3,MDU
2006
2007
5,33%
3,55%
14,72%
3,94%
2,27%
13,23%
4,89%
2,67%
22,88%
56,67% (72,09%)
44,00% (53,66%)
55,77% (65,79%)2
34,88%
33,72%
38,79%
3,52%
4,76%
8,20%
Interessanti risultano i dati sulla mortalità, pari, nel 2007, al 2,7% (105 su 2149) per le
pancreatiti acute lievi e al 22,9% (54 su 236) per le pancreatiti acute severe (filtro 1,2,3).
In particolare, la mortalità tra le pancreatiti acute severe individuate con il filtro F1 (shock,
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
53
setticemia o pancreatectomie) risulta particolarmente elevata, attestandosi ad un 55,8%2,
mentre è del 38,8% tra le pancreatiti acute severe individuate col filtro F2 (passaggio in
terapia intensiva) e del 8,2% tra quelle individuate con il filtro F3 (passaggio in medicina
d’urgenza) (tabella 5).
Il trend dei dati sulla mortalità richiede ulteriori commenti sul filtro F3 (passaggio in
medicina d’urgenza) quale elemento di severità della pancreatite: è ragionevole supporre
che tra il 2006 ed il 2007 sia intervenuta una qualche variazione dei modelli organizzativi
di presa in carico dei pazienti affetti da pancreatite acuta, infatti, al già richiamato
dimezzamento dei casi trattati da questa disciplina, si accompagna un raddoppio della
mortalità intraospedaliera (dal 4 all’8%). Questo andamento della mortalità sembra
supportare l’interpretazione del ricovero in medicina d’urgenza quale elemento di gravità
ipso facto. Tuttavia si fa notare che la mortalità all’interno del filtro F3 è comunque
decisamente inferiore rispetto a quella registrata per i filtri F1 ed F2. Soprattutto è da
rilevare l’apporto della riduzione dei volumi trattati dalla medicina d’urgenza sulla mortalità
delle pancreatiti acute severe che raddoppia tra il 2005-06 ed il 2007.
In base allo studio di Uomo et al (2007), condotto su 56 centri italiani, distribuiti in modo
omogeneo sul territorio italiano, il 14,2% dei casi di pancreatite acuta è stato definito
come severo (secondo i criteri di Atlanta3). La mortalità tra le pancreatiti acute severe è
del 19,2%, la mortalità delle forme lievi è pari allo 0,4%, mentre la mortalità complessiva
risulta pari al 3,1%. Il confronto con i nostri risultati suggerisce la buona sensibilità dei
criteri creati per l’individuazione delle PA severe attraverso le SDO.
Poiché l’evento “morte” potrebbe essere un indicatore a posteriori della severità di una
pancreatite acuta è emersa la necessità di valutare le caratteristiche del gruppo di 51
deceduti tra i casi di pancreatite acuta individuata come NON severa (tramite il criterio da
noi applicato). La valutazione è stata effettuata secondo tre metodi: 1) analisi della
distribuzione delle giornate di degenza tra i diversi gruppi (pancreatiti acute, pancreatiti
acute severe – in entrambi i casi separatamente per deceduti e non deceduti); 2) analisi
del numero medio di diagnosi tra i diversi gruppi; 3) analisi puntuale (sulle diagnosi di
dimissione) della riconducibilità del decesso alla pancreatite acuta.
2 Particolarmente rilevante ai fini della mortalità risulta la diagnosi di shock. Infatti applicando un filtro con i soli codici ICD-9-CM
78559 e 78550 si individuano 38 casi tra i quali la mortalità è del 65,8%.
3 Si segnala che la letteratura internazionale, sulla base del “Atlanta symposium” e successivi aggiornamenti, è concorde nel definire
la severità della pancreatite acuta sulla base di: presenza di organ failure (insufficienza respiratoria, insufficienza renale, shock);
complicanze locali (necrosi, ascesso, pseudocisti); complicanze sistemiche (sepsi, sindrome da risposta infiammatoria sistemica);
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
54
Figura 4. Distribuzione durata degenza per pancreatiti acute e pancreatiti acute
severe (deceduti e non deceduti)
Distrbuzione giornate di degenza
101,8
50
45
40
GG degenza
35
30
25
20
15
10
5
0
Pancreatite Acuta Lieve,
Deceduti (n=51)
I Percentile
Pancreatite Acuta Lieve,
NON Deceduti (n=1858)
I Quartile
Mediana
Pancreatite Acuta Severa,
NON Deceduti (n=186)
Media
III Quartile
Pancreatite Acuta Severa,
Deceduti (n=54)
IX Percentile
L’analisi della distribuzione delle giornate di degenza (fig. 4) evidenzia come nel gruppo
delle pancreatiti acute “lievi, NON deceduti” la variabilità sia inferiore rispetto agli altri
gruppi: il 50% dei ricoveri compresi tra i 6 ed i 14 giorni e l’80% compresi tra i 4 ed i 21
giorni. La variabilità delle pancreatiti acute severe risulta decisamente più ampia, con il
50% dei ricoveri compresi nell’intervallo 6-22,8 giorni per i NON deceduti e 10-45,3 per i
deceduti. L’andamento dei ricoveri con diagnosi di pancreatite acuta lieve con esito in
decesso sembra più simile alle pancreatiti acute severe: il 50% dei ricoveri, infatti, è
compreso nell’intervallo 2-19 giorni. Da notare che tra il gruppo delle pancreatiti acute lievi
il decesso avviene prima rispetto alle pancreatiti acute severe.
L’analisi del numero medio di diagnosi (tab. 6) evidenzia come nelle SDO dei pazienti
deceduti siano codificate, in media, quasi 1,5 diagnosi in più rispetto a quelle dei NON
deceduti. Nelle SDO dei casi di pancreatiti severe (deceduti e non) si riscontrano circa 0,6
diagnosi in più rispetto alle SDO con diagnosi di pancreatite lieve. Il numero medio di
diagnosi tra le persone decedute con diagnosi di pancreatiti acute lievi e severe risulta
sovrapponibile.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
55
Tabella 6. Numero di diagnosi medie per pancreatiti acute e pancreatiti acute
severe (deceduti e non deceduti).
DATI
N°
PANCREATITE
N° MEDIO DI DIAGNOSI
ACUTA LIEVE
DEV. STANDARD DIAGNOSI
N°
PANCREATITE
N° MEDIO DI DIAGNOSI
ACUTA SEVERA
DEV. STANDARD DIAGNOSI
N°
TOTALE N° MEDIO DI DIAGNOSI
DEV. STANDARD DIAGNOSI
TOTALE
NON DECEDUTO DECEDUTO COMPLESSIVO
1858
51
1909
2,98
4,35
3,02
1,46
1,45
1,48
186
54
240
3,38
4,56
3,64
1,69
1,21
1,66
2044
105
2149
3,01
4,46
3,09
1,49
1,33
1,52
Infine dall’analisi puntuale delle diagnosi principali e secondarie delle persone decedute
con diagnosi di pancreatite acuta lieve si è trovato che in 24 casi la causa del decesso è
potenzialmente riconducibile alla pancreatite acuta – e pertanto sarebbero casi da
considerarsi severi. Per i restanti 27 casi il decesso non sembra collegato con la diagnosi di
pancreatite acuta – e pertanto sembrerebbe corretto continuare a considerarli come casi di
pancreatiti lievi.
Se si accetta questo tipo di valutazione, ne discende che il filtro da noi utilizzato per
l’individuazione dei casi di pancreatite acuta severa sottostimerebbe un 10% di casi
rispetto alla situazione reale. Inoltre, applicando i filtri 1,2,3 cambiano i valori della
mortalità tra i diversi gruppi: aumentano quella delle pancreatiti severe e si dimezza quella
delle pancreatiti lievi. In tab. 7 sono riportati i dati di sintesi tra i valori della letteratura e
quelli riscontrati nel nostro studio (con l’applicazione del filtro 1+2+3 e con la correzione
dei decessi effettuata a posteriori per l’anno 2007).
Tabella 7. Sintesi dei dati relativi alla pancreatite acuta.
PANCREATITE
ACUTA (SEVERA –
LIEVE)
UOMO ET AL
(2007)
SDO 2007
PIEMONTE
SDO 2007
PIEMONTE
CORRETTO4
SDO 2006
PIEMONTE
SDO 2005
PIEMONTE
PREVALENZA
PANCREATITE
SEVERA SUL
TOTALE
MORTALITÀ
PANCREATITE
SEVERA
MORTALITÀ
PANCREATITE
LIEVE
MORTALITÀ
PANCREATITE
ACUTA
1173 (167 - 1006)
14,2%
19,2%
0,4%
3,1%
2149 (236 - 1913)
11,0%
22,9%
2,7%
4,9%
2149 (262 - 1889)
12,2%
30,0%
1,4%
4,9%
2046 (326 - 1720)
15,2%
13,2%
2,3%
4,0%
2132 (325 - 1807)
15,9%
14,7%
3,5%
5,3%
In “Piemonte corretto” si sono inclusi i 24 casi di pancreatite acuta per i quali l’analisi puntuale ha fatto emergere potenziale
causalità tra la pancreatite ed il decesso - ma individuate come lieve dal filtro proposto - tra le pancreatiti severe.
4
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
56
Distribuzione per presidio
Dall’analisi della distribuzione delle pancreatiti acute per presidio di erogazione (tab. 8)
non sembrano emergere chiari poli di attrazione. Infatti, il centro che tratta il maggior
numero di pancreatiti acute è appena al di sopra dell’8% del totale, mentre il 36% delle
stesse è trattata in 40 differenti strutture. Una maggiore tendenza all’emergere di
eventuali poli di attrazione si nota nella distribuzione delle pancreatiti acute severe per
presidio di erogazione (tab. 8-9) con soli 5 presidi in cui la proporzione di ricoveri per
pancreatiti severe è superiore al 20%. Per le pancreatiti severe 6 presidi trattano circa il
63% delle stesse mentre il restante 37% è trattato in 27 differenti presidi.
Tabella 8. Distribuzione dei casi di pancreatite acuta per presidio di erogazione.
Presidio 1
Presidio 2
Presidio 3
Presidio 4
Presidio 5
Presidio 6
Presidio 7
Presidio 8
Presidio 9
Presidio 10
Presidio 11
Presidio 12
Presidio 13
Presidio 14
Presidio 15
Presidio 16
Presidio 17
Presidio 18
Presidio 19
Altri (40 Presidi)
Totale complessivo
Pancreatite
Acuta
173
119
99
85
74
72
69
68
65
63
61
61
60
59
58
56
55
55
50
747
2149
Pancreatite
Pancreatite % Pancreatite
Acuta Lieve
Acuta Severa Acuta Severa
122
51
29,5%
101
18
15,1%
79
20
20,2%
76
9
10,6%
70
4
5,4%
68
4
5,6%
68
1
1,4%
48
20
29,4%
62
3
4,6%
36
27
42,9%
54
7
11,5%
60
1
1,6%
55
5
8,3%
56
3
5,1%
51
7
12,1%
54
2
3,6%
47
8
14,5%
49
6
10,9%
37
13
26,0%
720
27
3,6%
1909
240
11,2%
% Totale
8,1%
5,5%
4,6%
4,0%
3,4%
3,4%
3,2%
3,2%
3,0%
2,9%
2,8%
2,8%
2,8%
2,7%
2,7%
2,6%
2,6%
2,6%
2,3%
34,8%
100,0%
Tabella 9. Distribuzione dei casi di pancreatite acuta severa per presidio di
erogazione.
Presidio 1
Presidio 2
Presidio 3
Presidio 4
Presidio 5
Presidio 6
Altri (27 Presidi)
Totale complessivo
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
Totale
complessivo
51
27
20
20
18
13
87
236
Non deceduto
39
24
18
17
14
13
57
182
Deceduto
Non deceduto
12
3
2
3
4
…
30
54
76,5%
88,9%
90,0%
85,0%
77,8%
100,0%
65,5%
77,1%
Deceduto
23,5%
11,1%
10,0%
15,0%
22,2%
0,0%
34,5%
22,9%
57
I dati sulla mortalità intra-ospedaliera sia per le pancreatiti acute lievi che severe
evidenziano una differenza importante tra i presidi che effettuano più elevati volumi
rispetto a quelli che trattano la pancreatite in modo quasi sporadico (meno di 50 ricoveri
anno), ma che congiuntamente considerati rappresentano una parte importante
dell’assistenza.
Un’indagine più approfondita sui fattori che possono influire sulla mortalità
intraospedaliera è stata condotta utilizzando un modello di regressione logistica multilivello
(ad intercetta casuale)5. Sono state considerate solo le variabili che possano derivare dal
flusso dei dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), prendendo in considerazione
fattori legati al paziente (età, sesso, durata della degenza, peso del DRG, severità della
pancreatine) e caratteristiche del reparto (volume di attività, misurato come numero
medio di ricoveri per pancreatine acuta registrati nei tre anni di osservazione), inseriti nel
modello come effetti fissi; i fattori legati alle caratteristiche del presidio ospedaliero sono
stati inseriti nel modello come effetto casuale. I volumi di attività sono stati misurati a
livello di unità operativa e non a livello di presidio per evitare possibili misclassificazioni
dovute al fatto che all’interno di un presidio con (relativi) alti volumi, può verificarsi che
l’attività sia in realtà parcellizzata in un numero eccessivo di reparti. Per contro,
concentrarsi sui reparti introduce elementi di imprecisione sull’assegnazione alle diverse
unità operative dei ricoveri con uno o più trasferimenti (la scelta, in linea con la
letteratura, è stata di assegnare i ricoveri ai reparti di dimissione). Da notare che questa
imprecisione è limitata per le pancreatiti lievi, dove oltre l’85% dei ricoveri non hanno
trasferimenti, mentre è più elevata per le pancreatiti severe.
La tabella 10 riporta le codifiche utilizzate per la variabili incluse nel modello.
L’unità statistica dell’analisi coincide con il singolo ricovero effettuato nel periodo 20052007. Il software utilizzato per l’analisi è Stata.
Tabella 10. Codifica variabili utilizzate nel modello di regressione logistica.
Variabile
SESSO
ETÀ
DURATA DELLA DEGENZA
PESO DEL DRG
SEVERITA’ DELLA PANCREATITE
VOLUME DI ATTIVITA’ DEL REPARTO DI
RICOVERO
“1”
“0”
“1”
“2”
“3”
“1”
“2”
“3”
“4”
“1”
“0”
“1”
“0”
“1”
“0”
Codifica
SE UOMO;
SE DONNA;
SE ETÀ<60 ANNI;
SE 60<=ETÀ<=74 ANNI;
SE ETÀ>74 ANNI;
SE DEGENZA<=7GG;
SE 7<DEGENZA<=14GG;
SE 14<DEGENZA<=21GG;
SE DEGENZA>21GG;
SE PESO DRG>2;
SE ALTRIMENTI;
SE PANCREATITE ACUTA SEVERA;
ALTRIMENTI;
SE RICOVERI PER PANCREATITE ACUTA ≥30 ANNO;
SE RICOVERI PER PANCREATITE ACUTA < 30 ANNO;
5 Le analisi statistiche sono satate effettuate in collaborazione con gli epidemiologi e gli statistici del CPO Piemonte. In particolare si
ringraziano Carlo Senore, Luca Scaglione e Ileana Baldi.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
58
I risultati dei parametri stimati (Odds Ratio) con la regressione logistica multilivello di cui
in tabella 11 sono da confrontarsi rispetto alla mortalità intra-ospedaliera del ricovero
“base” avente le seguenti caratteristiche: donna con età inferiore ai sessanta anni,
ricoverata per pancreatite lieve in un presidio che effettua meno di trenta ricoveri all’anno,
con degenza inferiore o uguale a sette giorni e peso DRG inferiore a due.
La probabilità di decesso risulta strettamente correlata con l’età del paziente: in modo
particolare gli ultra settantacinquenni presentano un Odds Ratio (OR) rispetto a chi ha
meno di sessanta anni pari a 9,74 (IC: 6,46-14,70). Una durata della degenza superiore a
sette giorni sembra avere un effetto protettivo, ovverosia è ipotizzabile, per le pancreatiti
lievi, che superata una soglia di tempo critica entro la quale il decesso è più probabile, le
cure potrebbero associarsi a una maggiore efficacia. Anche il peso del DRG (superiore a
due) è positivamente e fortemente correlato alla probabilità di decesso.
Si osserva, come atteso, un drastico aumento della probabilità di decesso in caso di
pancreatite severa (OR: 7,82; IC: 5,51-11,09).
Per quanto riguarda l’effetto dei volumi di attività, la mortalità risulta significativamente
più bassa nei reparti che trattano almeno 30 casi l’anno rispetto a quelli con più basso
volume di attività, sia per la pancreatine acuta lieve (OR: 0,44; 95%IC:0,28-0,70) che per
quella severa (OR:0,10; 95%IC: 0,04 – 0,24).
L’effetto delle caratteristiche dell’ospedale spiega una proporzione pari al 9.4% (IC: 4,917,1) della variabilità residua, dopo aver corretto per i fattori associati al paziente a alle
caratteristiche del reparto.
Dal momento che la definizione di pancreatite acuta severa utilizzata per la classificazione
dei ricoveri in questa analisi fa riferimento a parametri in parte clinici ed in parte
organizzativi, per una verifica della stabilità dei risultati è stata condotta una analisi che
tenesse conto di una diversa classificazione della gravità basata sul sistema APR-DRG.
Questo sistema permette di assegnare entro ciascun DRG, un punteggio di gravità e di
rischio ad ogni specifico ricovero. L’analisi è stata eseguita sull’APR-DRG 282, che con
3829 ricoveri rappresenta il 61,14% dei ricoveri inclusi nel precedente modello (la
distribuzione dei DRG assegnati al restante 39% dei casi era troppo dispersa per
permettere altre analisi di dettaglio 6). Sono state quindi eseguite tre diverse regressioni:
una con le stesse variabile del modello già descritto in tabella 11, una aggiungendo a
questo le variabili di severità del sistema APR-DRG ed una aggiungendo a le variabili di
rischio del sistema APR-DRG.
I risultati di questa analisi confermano l’associazione tra elevati volumi di volumi trattati
per reparto e la riduzione del rischio di mortalità intra-ospedaliera che rimane pressoché
invariata nei diversi modelli.
Il secondo APR-DRG per numerosità e il n° 263, che con 762 casi rappresenta il 12,17% della popolazione statistica di partenza,
mentre il terzo è l’APR-DRG 284, che con 464 casi rappresenta il 7,41% della popolazione statistica di partenza
6
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
59
Tabella 11. Regressione Logistica Multilivello: Deceduto = f(Eta; Durata
degenza; Peso DRG>2; Pancreatite severa; UO ad elevati volumi; Sesso;
Pancreatite severa * UO ad elevati volumi).
Variabile
DONNA
UOMO
ETA’ < 60 ANNI
ETÀ 60-74 ANNI
ETÀ>74 ANNI
DEGENZA ≤ 7 GIORNI
DEGENZA 8-14 GIORNI
DEGENZA 15-21 GIORNI
DEGENZA >21 GIORNI
PESO DRG ≤ 2
PESO DRG >2
PANCREATITE ACUTA LIEVE
PANCREATITE ACUTA SEVERA
UO < 30 RICOVERI ANNO e PANCREATITE ACUTA LIEVE
UO ≥30 RICOVERI ANNO e PANCREATITE ACUTA LIEVE
UO < 30 RICOVERI ANNO e PANCREATITE ACUTA SEVERA
UO ≥30 RICOVERI ANNO e PANCREATITE ACUTA SEVERA
Odds Ratio [OR]
1
0.92
1
2.89
9.74
0.267
Intervallo confidenza OR [95%]
0.22
0.52
1
4.19
1
7.82
1
0.44
1
0.10
0.14 – 0.35
0.36 – 0.75
0.70 – 1.20
1.85 – 4.51
6.46 – 14.70
0.184 – 0.385
2.92 – 6.03
5.51 – 11.09
0.28 – 0.70
0.04 – 0.24
ERCP
Colangiopancratografia endoscopica retrogada (ERCP): dati epidemiologici e
dati di attività
Dall’analisi del flusso SDO del 2007, in Piemonte, sono stati rilevati 1.580 ricoveri nei quali
è stata eseguita una ERCP (codice ICD-9-CM 51.10 in uno dei campi Intervento principale
o 1, 2, 3, 4, o 5), di cui 23 eseguite nel privato e 1.557 nel pubblico: di queste, 1.461 sono
state eseguite in regime di ricovero ordinario e 96 in regime di ricovero diurno. Delle 1.557
ERCP eseguite in strutture pubbliche, 173 sono state effettuate in emergenza (123 con
trasporto 118, 50 provenienza DEA). È presente una forte eterogeneità nel numero di
prestazioni effettuate nei diversi presidi ospedalieri (media 29,38 ds 41,05, range 1-201).
Solo in 3 strutture è risultato un numero di prestazioni effettuate superiore a 100, di cui
una sola raggiunge la soglia delle 200 prestazioni.
I dati potrebbero essere sottostimati nel caso in cui non tutte le procedure di ERCP
vengano codificate nello SDO, sia perché la strutturazione della SDO non permette
l’inserimento di più di 6 codici di intervento sia per scarsa attenzione nella compilazione
delle SDO7.
Dall’analisi del tracciato SDO, emerge che nei 2149 ricoveri effettuati con una diagnosi
principale o secondaria di pancreatite acuta, risulta effettuata una ERCP in 201 casi, pari al
9.4% del totale (tab. 13). Il ricorso all’ERCP risulta più frequente nei casi di pancreatite
lieve (9,6%) che in quelli di pancreatite severa (7,5%). I dati di mortalità intraospedaliera
Sono disponibili i dati del 2006 relativi all’indagine trasversale “censimento organizzativo endoscopia digestiva” (dott. Soldati) che
sembrano confermare questa ipotesi.
7
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
60
ed esecuzione di ERCP evidenziano che si verificano 5 decessi tra le 201 ERCP eseguite
(2,5%).
Tabella 12. Pancreatite acuta ed ERCP.
Senza ERCP
Con ERCP
Totale complessivo
Pancreatite lieve
1726
183 (9,6%)
1909
Pancreatite severa Totale complessivo
222
1948
18 (7,5%)
201(9,4%)
240
2149
Analizzando le diagnosi riscontrabili nelle SDO che contengono la prestazione ”ERCP”
(1580 tot), emerge che:
- 239 SDO (15.1%) contengono la diagnosi principale “calcolosi del dotto biliare, senza
colecistite, con ostruzione del dotto biliare” (cod. 574.51);
- 142 SDO (9%) contengono la diagnosi principale “ostruzione del dotto biliare” (cod.
576.2);
- 107 SDO (6.8%) contengono la diagnosi principale “pancreatite acuta” (cod. 57.70).
Aggregando la diagnosi principale sui primi 3 codici dell’ICD-9-CM , possiamo raggruppare
le diagnosi in:
colelitiasi (57.4)
= 738 casi (46.7%)
altri disturbi delle vie biliari (57.6)
= 247 casi (15.6%)
malattie del pancreas (57.7)
= 163 casi (10.3%)
Con i dati a nostra disposizione non è possibile esprimersi sulle complicanze dovute ad
ERCP, infatti non è possibile stabilire chiaramente se la presenza di diagnosi di pancreatite
sia causa o conseguenza dell’intervento. Inoltre, nel caso le complicanze fossero posteriori
al ricovero, non disponendo dei dati anagrafici non è possibile ricostruire i percorsi seguiti
dai pazienti.
Nella tabella 14 vengono presentati i dati relativi alle prestazioni ERCP erogate nell’anno
2007 dalle Aziende sanitarie piemontesi come desumibili dal tracciato SDO (nella prima
colonna è indicata la nuova codifica delle strutture, nella seconda colonna la vecchia
codifica delle strutture). Da notare che alcuni degli erogatori risultano, in realtà,
appoggiarsi ad altre strutture per l’esecuzione dell’ERCP; questo fenomeno, se diffuso,
richiederebbe una diversa valutazione dei volumi misurati secondo il tracciato SDO.
Tabella 13. ERCP per Azienda di erogazione
Denominazione struttura
Presidio 1
Presidio 2
Presidio 3
Presidio 4
Presidio 5
Presidio 6
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
n
n%
201
187
118
89
70
70
n_cum%
12,9%
12,0%
7,6%
5,7%
4,5%
4,5%
24,9%
32,5%
38,2%
42,7%
47,2%
61
Denominazione struttura
Presidio 7
Presidio 8
Presidio 9
Presidio 10
Presidio 11
Altri
TOTALE
n
n%
58
57
49
46
46
566
1557
3,7%
3,7%
3,1%
3,0%
3,0%
36,4%
100,0%
n_cum%
50,9%
54,6%
57,7%
60,7%
63,6%
100,0%
Dal momento che è indicata l’esecuzione di una ERCP in caso di pancreatite acuta con
presenza di diagnosi di calcolosi (cod ICD-9-CM: 574), si è analizzata la situazione del
Piemonte (tab. 15): risultano solo 144 ERCP eseguite sui 845 casi di calcolosi associate a
pancreatite acuta.
Tabella 14. Diagnosi di calcolosi ed esecuzione di ERCP per i casi di pancreatite
acuta.
Senza ERCP
Con ERCP
Totale complessivo
Senza diagnosi di calcolosi
1247
57
1304
Con diagnosi di calcolosi
701
144
845
Totale complessivo
1948
201
2149
Metodo di ricerca della letteratura
La ricerca delle linee guida in merito all’ERCP e dei documenti correlati è stata
effettuata tramite la banca bibliografica PubMed con le seguenti parole chiave:
• "Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Mesh] Limits Practice
Guideline, Guideline, English, French, Italian, Spanish;
• "Quality Indicators, Health Care"[Mesh] AND "Cholangiopancreatography,
Endoscopic Retrograde"[Mesh];
L’utilizzo
delle
parole
chiave
"Reference
Standards"[Mesh]
AND
"Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Mesh] non ha portato a nessun
risultato rilevante.
Sono stati esclusi gli articoli che trattavano esclusivamente di patologia della colecisti
(infiammazione, cancro), o che non avevano l’abstract disponibile.
È stata inoltre, utilizzata la funzione “related article” di PubMed e la rivisitazione della
bibliografia degli articoli reperiti in full text e sono stati individuati altri 2 articoli pertinenti.
In totale sono stati ottenuti 36 articoli di cui 9 pertinenti, inseriti nel paragrafo di
riferimento.
Gli articoli reperiti sono stati classificati secondo il tipo di studio (tipo di pubblicazione)
REVIEW
GUIDELINES
CONSENSUS (DEVELOPMENT) CONFERENCE
MEDICAL POSITION PAPER
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
COSTAMAGNA 2008
LEE 2008, ADLER 2005, BEILENHHOFF 2007, SAGES
2007, JOHANSON 2002
BARON 2006, NIH 2002
FOX 2000
62
La ricerca della relazione volume/esiti è stata effettuata tramite la banca bibliografica
PubMed con le seguenti parole chiave:
• "Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Mesh] AND case volume; no
limits.
Sono stati reperiti 20 articoli, da cui sono poi stati esclusi quelli per cui non si è ottenuto il
full text o non inerenti il nostro quesito; in totale sono stati analizzati 8 articoli.
Gli articoli reperiti sono stati classificati secondo il tipo di studio (tipo di pubblicazione)
REVIEW
STUDIO CASO-CONTROLLO
STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO
COSTAMAGNA 2008
MASCI 2007; FANELL 2002
KAPRAL 2008; SALMINEM
KUMAR 1995; VITTE 2007
2007; DUNDEE 2007;
La ricerca relativa alla curva di apprendimento per l’ERCP è stata effettuata tramite la
banca bibliografica PubMed con le seguenti parole chiave:
• Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Mesh] AND ("Education"[Mesh]
OR "education "[Subheading] OR “training”) No limits: sono stati reperiti 114
articoli, da cui sono stati esclusi quelli per cui non si è ottenuto il full text o non
inerenti il nostro quesito. Sono stati presi in considerazioni articoli pubblicati
dall’anno 2000 sino ad oggi.
• "Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde"[Mesh] AND learning curve; no
limits: 19 articoli sono stati trovati, di cui 7 pertinenti.
Gli articoli reperiti sono stati classificati secondo il tipo di studio (tipo di pubblicazione)
LINEE GUIDA
STUDIO CASO-CONTROLLO
STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO
STUDIO DESCRITTIVO
OPINIONE DI ESPERTI
SAGES 2000, SAGES 2006, AGA 2007,
KAPRAL 2008
WILLIAMS 2006; VERMA 2007; AKARAVIPUTH
2008;
SEDLACK 2003; RAGUNATH 2003; VITALE 2005;
HELLIER 2000; PETERSEN 2002; ASGE 2006;
AGA 2007 ; GARCIA CANO 2007; LEUNG 2008;
ROSENTHAL 2008, GUDA 2008;
Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi, è stata interrogata la banca bibliografica
PubMed con le seguenti parole chiave:
• "Practice
Management,
Medical"[Mesh]
AND
"Cholangiopancreatography,
Endoscopic Retrograde"[Mesh]
• "Practice
Management,
Medical"[Mesh]
AND
"Cholangiopancreatography,
Endoscopic Retrograde"[Mesh]) AND ("Organizations"[Mesh] OR "organization and
administration "[Subheading] OR "Hospital-Physician Joint Ventures"[Mesh] OR
"Management Service Organizations"[Mesh])
Sono stati trovati 2 articoli, senza possibilità di accesso al full text.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
63
Attraverso i “related article” , il database rimanda alle Linee guida dell’American Society for
Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) del 2005 (Johanson et al, 2005), in cui si raccomanda
l’introduzione di specifici indicatori di processo ed outcome per la verifica della qualità di
un centro che svolga ERCP.
Gli articoli reperiti sono stati classificati secondo il tipo di studio (tipo di pubblicazione)
REVIEW
HAMILTON 2002
LINEE GUIDA
ASGE 2005
Linee guida ERCP
L’ASGE ha prodotto una serie di linee guida per valutare la qualità e gli esiti delle
procedure endoscopiche (Johanson 2002, Adler et al 2005).
Johanson et al (2002) propongono una serie di indicatori di qualità per la valutazione della
pratica ERCP (vedi tabella 16)
Tabella 15 ERCP specific quality indicators
Fonte: J.F. Johanson, et al., Quality assessment of ERCP, American Society For
Gastrointestinal Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopi, Volume 56, No. 2,
2002, pag. 167.
Gli autori raccomandano l’utilizzo routinario di questi indicatori per i pazienti sottoposti a
ERCP. Per alcuni parametri (ad esempio la soddisfazione) può essere sufficiente un
campione di pazienti. Per altre aree quale quella demografica, indicazioni di intenti, eventi
non pianificati e successo tecnico, devono essere valutati tutti i pazienti. Il calcolo degli
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
64
indicatori può essere effettuato più facilmente attraverso la progettazione di una banca
dati.
L’ASGE e l’American College of Gastroenterology task force (ACG) hanno proposto una
serie di indicatori che permetterebbero lo sviluppo di certificazione di qualità (Baron 2006).
Gli indicatori proposti riguardano la fase preprocedurale, intraprocedurale e
postprocedurale.
Nella fase preprocedurale è opportuno valutare:
1. l’appropriatezza della prescrizione attraverso la documentazione dell’indicazione, e
nel caso si tratti di una indicazione non standard deve comparire la motivazione,
2. la presenza del consenso informato diretto specialmente alla spiegazione degli
eventi avversi,
3. la valutazione della difficoltà procedurale. Anche se i gradi di difficoltà non sono
ancora stati validati è noto che le procedure con gradi di difficoltà più alti sono
associate a percentuale di successo minore e tassi di complicazioni più elevati. In
generale il I grado di difficoltà (vedi tabella 17) è associato ad un tasso di successo
delle ERCP che va dall’80 al 90%. Gli autori suggeriscono inoltre che gli
endoscopisti con bassi livelli di esperienza non dovrebbero tentare ERCP per casi
con grado di difficoltà 2 o 3.
4. Aderenza alle linee guida per la profilassi antibiotica.
5.
Tabella 16 ERCP Degrees of difficulty
Baron TH, Petersen BT, Mergener K, Chak A, Cohen J, Deal SE, Hoffinan B,
Jacobson BC, Petrini JL, Safdi MA, Faigel DO, Pike IM; ASGE/ACG Taskforce on
Quality in Endoscopy.
Quality indicators for endoscopic retrograde
cholangiopancreatography. Am J Gastroenterol. 2006 Apr;101(4):892-7. pag
894
Nella fase intraprocedurale (che inizia con la somministrazione della sedazione e si
completa con la rimozione dell’endoscopio) gli autori propongono:
1. tasso di incannulazione del dotto desiderato. Report dagli anni ’90 mostrano un
tasso si incannulazione riuscita pari al 95% e che l’obiettivo dei programmi di
addestramento è un tasso di successo di almeno 80%. Gli autori suggeriscono che
un tasso >85% dovrebbe essere raggiungibile dalla maggior parte degli
endoscopisti che effettuano ERCP (Baron 2006, Costamagna 2008). Sono esclusi dal
calcolo i fallimenti dovuti a problemi relativi alla sedazione, precedenti interventi
addominali, anomalie anatomiche, ostruzione del duodeno ed elevato volume di
contenuto gastrico (Baron 2006).
Il successo tecnico, oltre dalla incannulazione riuscita, dipende, ad esempio, anche dal
superamento di restrizioni, estrazione dei calcoli, posizionamento dello stent e dovrebbe
essere ≥85%. Infatti, altri due indicatori proposti sono:
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
65
2. Tasso di successo nell’estrazione del calcolo dal dotto comune. Ci si aspetta un
tasso di successo >85% (Baron 2006, Caddy 2006, Costamagna 2008). Adler et al
(2005) evidenziano come la sensibilità e specificità dell’ERCP nell’evidenziare un
calcolo nel dotto comune sia maggiore dell’95%, che la sfinterectomia e l’estrazione
del calcolo ha successo in più del 95% dei casi con un tasso complessivo di
complicazioni del 5% e di mortalità minore dell’1% in mani esperte.
3. Tasso di successo nel posizionamento dello stent sotto la biforcazione. Un
endoscopista competente dovrebbe essere in grado di posizionare uno stent in una
percentuale compresa tra l’80% ed il 90% dei pazienti trattati (Baron 2006, Adler
2005, Raijman 2003).
Adler et al (2005) riportano il tasso di successo di drenaggio via transpapillare di
pseudocisti del pancreas maggiore del 90%. Il drenaggio transmurale della pseudocisti,
sebbene tecnicamente più difficile, può essere ottenuto in percentuale maggiore
dell’80% in mani esperte.
Nella fase postprocedurale (che va dalla rimozione dell’endoscopio alla dimissione del
paziente) gli indicatori proposti sono:
1. completezza della documentazione. Devono essere indicati elementi quali l’esito
della incannulazione, correlate immagini fluoroscopiche, immagini endoscopiche se
appropriato.
2. Tasso di complicazioni. Il tasso di pancreatiti post ERCP va dall’1% al 7%. Il tasso
di perforazione è meno dell’1%, maggiore in caso di anomalie anatomiche. Il tasso
atteso di sanguinamento a seguito di sfinterectomia è di circa il 2%. Sono, inoltre,
da valutare gli eventi avversi relativi alla sedazione (Baron 2006). In base ai risultati
di una revisione di Costamagna (2008), si considera come minimo standard di
qualità per competenza di un endoscopista un tasso di complicanze minore del
10%.
Il grado di raccomandazione relativo agli indicatori proposti da Baron (2005) sono riassunti
In tabella
Tabella 17 Proposed quality indicators for ERCP
Baron TH, Petersen BT, Mergener K, Chak A, Cohen J, Deal SE, Hoffinan B,
Jacobson BC, Petrini JL, Safdi MA, Faigel DO, Pike IM; ASGE/ACG Taskforce on
Quality in Endoscopy.
Quality indicators for endoscopic retrograde
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
66
cholangiopancreatography. Am J Gastroenterol. 2006 Apr;101(4):892-7. pag
896
Costamagna (2008) propone ulteriori elementi da valutare, comuni a tutte le procedure
endoscopiche, non specificatamente espressi dalla proposta dell’ASGE/ACG. Questi
indicatori comprendono:
• Valutazione della storia clinica del paziente,
• Esame obiettivo,
• Gestione dei farmaci anticoagulanti e antipiastrinici,
• Valutazione dei bisogni del paziente per programmare un’adeguata sedazione,
• Monitoraggio del paziente durante la procedura,
• Somministrazione dei farmaci,
• Tentativi di rianimazione,
• Documentazione fotografica di specifici punti o lesioni,
• Follow-up della patologia,
• Istruzioni al paziente dopo la procedura,
• Comunicazione ad altri medici o chirurghi e
• Valutazione della soddisfazione del paziente attraverso l’utilizzo di questionari.
Bisogna sottolineare che la qualità di una procedura endoscopica, in accordo con l’ASGE,
differisce dall’efficienza. La valutazione di qualità non è un semplice resoconto di tasso di
successi e complicanze, ma include una valutazione globale sulla performance dell’intera
equipe di endoscopia e informazioni riguardo alla soddisfazione del paziente, che dovrebbe
essere valutata con un questionario ad hoc. (Costamagna 2008, Baron, 2006).
Anche la sorveglianza microbiologica è un mezzo importante per la valutazione della
qualità delle procedure di disinfezione. Le linee guida elaborate dalla European Society of
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) e dalla European Society of Gastroenterology and
Endoscopy Nurseys and Associates (ESGENA) si focalizzano sulla gestione qualitativa della
disinfezione degli endoscopi flessibili e si basano sullo standard europeo prEN ISO 15883
(Beilenhoff 2007).
La linea guida si basano sull’opinione di esperti e fornisce informazioni pratiche e consigli
sulla validazione dell’intero processo di disinfezione degli endoscopi flessibili.
Il sistema di qualità per la disinfezione proposto prevede tre parti: test di tipo, effettuati
dal costruttore della macchina; validazione all’atto dell’installazione e test di routine
stabiliti al fine di verificare che le macchine lavorino nei limiti stabiliti per ogni parametro e
provare il buon risultato dell’intero ciclo.
Gli autori individuano una serie di prerequisiti strutturali e ambientali per il servizio:
- Separazione dei locali dedicati all’effettuazione delle procedure delle sale di lavaggio
-
e disinfezione
Separazione tra area sporca e pulita
Informazioni sulla qualità dell’acqua (esempio: durezza e informazioni
microbiologiche)
Sistema di scarico con sifone a U
Sistema di ventilazione delle sale di lavaggio e disinfezione
Sistema di controllo della temperature delle sale di lavaggio e disinfezione
Valvole di intercettazione e filtri per l’acqua fredda
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
67
Sono,
-
-
Valvole di intercettazione e filtri per l’acqua calda
Valvole di intercettazione per l’acqua demineralizzata
Interruttore principale per il generatore di corrente elettrica
Dispositivi per la disinfezione delle mani
Depositi per sostanze chimiche e deposito pulito per stoccaggio strumenti
Requisiti di igiene e sicurezza
inoltre, stati individuati i prerequisiti organizzativi per il servizio:
Istruzioni per lavaggio e disinfezione di ogni singolo dispositivo medico
Analisi del rischio per ogni dispositivo medico riutilizzabile (con riferimento
all’igiene)
Manuali dei dispositivi medici e della washer-disinfector (apparecchiatura di
lavaggio e disinfezione), inclusa la descrizione dell’intera procedura di lavaggio e
disinfezione
Manutenzione e programma di manutenzione per WD
Schede di sicurezza per tutti i composti chimici
Definizione dei carichi di test per la validazione
Definizione della persona responsabile per la validazione
Certificazione del personale (corsi di formazione, certificazione delle competenze)
Piani di pulizia e disinfezione
Compatibilità tra WD, endoscopi e composti chimici
Raccomandazioni in campo pediatrico
Poiché i bambini non sono semplicemente dei piccoli adulti, la pratica endoscopica in
pediatria richiede particolari attenzioni e attrezzature ad hoc. In generale, i centri pediatrici
che offrono un servizio di ERCP incontrano diversi ostacoli quali la carenza degli specialisti
adeguatamente formati, numero insufficiente di pazienti per mantenere la curva di
apprendimento e i costi relativi alla strumentazione (Fox 2000). Se l’endoscopista viene
chiamato ad effettuare un’indagine ad un paziente in età pediatrica è utile la consulenza di
un pediatra o di un gastroenterologo pediatrico, nel caso dell’ERCP è necessario che
l’endoscopista pediatra debba mantenere la curva di apprendimento per la specifica
procedura, cosa non sempre facile a causa dell’esiguo numero di pazienti che si
sottopongono alla stessa (Fox 2000, Lee 2008). L’ASGE ha prodotto delle linee guida
indirizzate alla gestione della pratica endoscopica nei bambini sottolineando la necessità di
porre attenzione, oltre agli aspetti fisiologici, anche agli aspetti psicologici dei piccoli
pazienti e dei loro genitori o accompagnatori (es. consenso informato adatto per l’età).
Poiché il diametro dell’endoscopio per adulti può creare una compressione dei tessuti molli
della trachea può essere necessario l’utilizzo di strumenti di diametro ridotto ma non
sempre è possibile associarvi l’utilizzo degli strumenti operativi. In generale, nella maggior
parte dei bambini di età maggiore di 2-3 anni si può utilizzare un diametro standard.
Un’ulteriore questione riguarda la radioprotezione, in particolare è utile che sia presente
un tecnico radiologo con comprovata esperienza in campo pediatrico e che sia disponibile
il consulente radiologo in caso di presenza di anomalie anatomiche del paziente (Fox
2000). Per quanto riguarda i dispositivi per la gestione delle emergenze, devono essere
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
68
disponibili i presidi di dimensioni appropriate e i farmaci in dosaggio utile per la gestione
delle emergenze nel bambino (Lee 2008).
Relazione volume/esiti ed aspetti organizzativi.
La letteratura internazionale mostra già da tempo (Geenen 1981; Jowell 1996; Meguid,
1998; Vaira, 1989, Birkmeyer 2003; Begg 1998; Dimick 2003) una correlazione
statisticamente significativa tra alto numero di casi trattati presso centri di riferimento per
una determinata procedura chirurgica e outcome di esito migliori, come risulta da
differenti indicatori analizzati (tasso di successo di incannulazione delle vie biliari o
pancreatiche, tasso di complicanze ERCP-correlate, tasso di mortalità ERCP-correlata).
Varadarajulu (2006), Vitte & Morfoisse (2007) hanno dimostrato che si ottengono migliori
esiti in centri ad alto volume di prestazioni rispetto ai centri con basso volume. In
particolare, il primo studio che ha analizzato circa 200mila ERCP in più di 2600 centri, ha
evidenziato una durata della degenza minore (6,9 giorni) nei centri ad alto volume
(>200ERCP/anno) rispetto ai centri a basso volume (<100 ERCP/anno) dove la degenza
media era di 7,8 giorni (differenza statisticamente significativa). Il tasso di insuccesso era
del 4,7% nei centri che effettuavano più di 300 ERCP/anno mentre nei centri dove si
effettuava meno di una ERCP/settimana il tasso era del 6%. Il secondo studio, effettuato
in Francia, ha diviso 28 centri in tre gruppi, in base al numero delle procedure effettuate
durante il periodo di ricerca (gruppo A >100, B 100-200, C >200). È stata riscontrata una
differenza significativa nel tasso di successo di incannulazione a favore dei centri a
maggior volume di procedure. La probabilità di successo terapeutico era maggiore nel
centro ad alto volume e il tasso di complicazioni era significativamente minore.
Uno studio italiano (Masci, 2007) non ha evidenziato differenze tra i 6 centri a basso
volume (<200ERCP/anno) rispetto agli 8 centri ad alto volume relativamente al tasso di
incannulazione e complicazioni. Gli autori evidenziano, invece, come i centri a basso
volume hanno avuto un punteggio maggiore relativamente alle informazioni fornite ai
pazienti.
Wiliams et al (2007) hanno pubblicato un interessante studio sulla qualità dei centri che
effettuano ERCP nel Regno Unito. Hanno valutato in un periodo di 6 mesi, nel 2004 circa il
20% di tutte le ERCP effettuate per un totale di 5264 procedure. L’indagine ha evidenziato
la scarsa qualità dei centri inglesi e in particolare che il 72% delle unità endoscopiche
possedeva una area di ricovero dedicata ma che solo il 16% delle unità possedevano
dispositivi per la rianimazione nella stanza dedicata all’ERCP. All’ 11% dei pazienti non era
stato richiesto il consenso informato, nell’80% delle procedure riviste non era indicato se il
paziente aveva effettuato test della coagulazione, il 23% dei pazienti non era stato
monitorato in modo adeguato. Riguardo alle procedure anestesiologiche, il 20% dei
pazienti ha ricevuto una dose eccessiva di benzodiazepine e il 7,6% dei pazienti ha dovuto
ricevere agenti antagonisti (reversal agent). Anche se il 94% delle procedure sono state
considerate terapeutiche, il 68% sono state associate ad una indicazione inutile, solo il
33% delle ERCP in urgenza sono state considerate appropriate. Gli esiti e i successi
terapeutici sono risultati al di sotto degli standard indicati dalla letteratura. Gli autori
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
69
sostengono che ciò è dovuto principalmente all’elevato numero di apprendisti che
effettuano poche procedure in centri a basso volume di attività.
In merito agli aspetti organizzativi, il documento dell’ASGE (2006) fornisce solo alcune
raccomandazioni in merito al personale da coinvolgere in un intervento di ERCP in regime
di urgenza: oltre all’endoscopista dovrebbero essere presenti un tecnico endoscopista,
infermiere, tecnico radiologo, radiologo, possibilmente un citopatologo, anestesista e staff
di camera del risveglio.
Competenza/curve di apprendimento
L’endoscopista in fase di apprendimento necessita un’ampia supervisione e di esperienza
pratica per sviluppare le capacità tecniche per poter effettuare procedure sicure e efficaci;
gli esiti della procedura, infatti, dipendono in modo critico dall’esperienza dell’endoscopista
(Cohen 2002, Christensen 2004, Suissa 2005).
Numerosi autori (NIH 2002; Adler 2005; Costamagna 2008; Guda 2008; Kapral 2008;
Leung 2008) sottolineano che gli endoscopisti che effettuano ERCP devono avere
un’appropriata formazione e competenza. Sebbene pochi sono gli studi disponibili per
valutare le capacità nell’eseguire una ERCP, la competenza di effettuare un’incannulazione
del dotto biliare non può essere raggiunta routinariamente finché non si effettuano almeno
200 ERCP (Adler 2005).
Mentre un tempo come competenza si indicava la capacità nell’effettuare una profonda
incannulazione di entrambi i dotti e realizzare, in modo sicuro per i pazienti una
sfinterectomia, oggi, il termine competenza include l’abilità nell’effettuare un certo numero
di procedure terapeutiche di difficoltà variabile. L’ASGE ha definito la competenza
diagnostica e terapeutica in ERCP come la capacità di:
1) ottenere l’incannulazione selettiva del dotto desiderato
2) effettuare una sfinterectomia controllata
3) ottenere una decompressione biliare o pancreatica
4) ottenere sufficiente materiale endoscopico, radiografico e di materiale patologico per
formulare un’adeguata diagnosi e programmare un trattamento efficiente.
Inoltre, la competenza richiede la capacità di effettuare alcune manovre quali l’estrazione
di calcoli, il posizionamento di stent e la gestione di eventuali emorragie causate dalla
sfinterectomia.
L’ASGE raccomanda che debbano essere effettuate almeno 100 ERCP prima che possa
essere valutata la competenza (Eisen 2001). Per ottenere l’European Diploma of
Gastroenterology è richiesta un’esperienza di 150 ERCP (Bisschops 2002) e l’Australian
Conjoint Commette for Recognition of Training in Gastrointestinal Endoscopy raccomanda
200 ERCP (Jones 1999).
La revisione della letteratura più recente raccomanda di non avere come riferimento un
numero preciso di ERCP per raggiungere un grado soddisfacente di abilità nell’esecuzione
di ERCP. Si ritiene, piuttosto, di importanza cruciale il raggiungimento costante e continuo
di uno specifico tasso di successo nelle procedure eseguite (Costamagna, 2008). Verma et
al affermano che siano necessarie almeno 350 ERCP in pazienti con papilla normale per
raggiungere una tasso di successo di incannulazione del dotto biliare di circa l’80%.
Questo si discosta molto da altri studi (Akaraviputh T, 2008; Kapral C, 2008) e dalla
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
70
cultura prevalente che ritiene un endoscopista “competente” quando abbia raggiunto le
180-200 ERCP di diversi gradi di difficoltà, sotto supervisione.
Riguardo ai programmi di addestramento, le linee guida sviluppate dalla commissione della
Society of American Gastrointestinal and Endoscopc Surgeon (SAGES) richiedono
l’inclusione di istruzioni pratiche e didattiche relative a 1) strumentazione e accessori, 2)
indicazioni e controindicazioni, 3) tecniche diagnostiche e terapeutiche, 4) uso appropriato
di sedazione cosciente, 5) complicazioni e gestione delle stesse, 6) esiti a breve e lungo
termine. Inoltre, sottolineano l’importanza della pratica e non dell’affidamento solo a
simulatori o modelli animali. Una volta ottenuta la qualifica è fondamentale il
mantenimento delle performance attraverso iniziative di promozione della qualità.
Conclusioni
Per affrontare il quesito relativo all’individuazione di una più efficace organizzazione
dell’attività dei centri diagnostico terapeutici per specifiche patologie, in questo caso per le
patologie pancreatiche, si è provato ad utilizzare il flusso informativo SDO quale fonte
privilegiata.
Per individuare i fattori correlati alla migliore gestione delle cure, abbiamo ritenuto
necessario suddividere i casi di pancreatite in base al grado di severità. A tal fine, si è
proceduto alla creazione di filtri, sulla base delle indicazioni di letteratura, che ci hanno
consentito la suddivisione. La corrispondenza dei nostri dati con quelli del più recente
studio multicentrico svoltosi in 56 centri italiani, per un totale di 1173 pazienti affetti da
pancreatite acuta classificati per severità, conferma la correttezza e la bontà dei filtri
utilizzati.
Si è poi provveduto a mettere in relazione le PA di grado lieve e severo con i presidi di
ricovero: emerge una differenza importante nel rischio di mortalità tra i presidi che
effettuano più elevati volumi di attività rispetto a quelli che trattano la pancreatite in modo
quasi sporadico ma che, congiuntamente considerati, rappresentano una parte importante
dell’assistenza. A fronte della necessità di redigere regole condivise per la razionalizzazione
dei punti di erogazione, in modo da raggiungere i migliori outcome di salute, i risultati di
questa analisi permettono di individuare i centri su cui concentrare l’erogazione delle cure
alle persone affette da pancreatite acuta.
Dall’analisi della letteratura emerge la necessità di un monitoraggio delle attività di un
servizio che effettua ERCP attraverso l’utilizzo di indicatori di qualità. Ciò è mirato ad
aumentare il numero dei successi diagnostico/terapeutici e a ridurre il tasso di
complicazioni. Misure di qualità
internazionalmente accettate sono gli indicatori
dell’ASGE/ACG. Certamente, il monitoraggio della qualità comporta un lavoro aggiuntivo,
spesso non sostenibile in alcuni centri, perciò il processo di raccolta dati dovrebbe essere
agevolato da mezzi informatici.
Migliori esiti si ottengono in centri ad alto volume di prestazioni rispetto a quelli a basso
volume (Varadarajulu 2006, Vitte & Morfoisse 2007).
Le performance delle ERCP potrebbero migliorare indirizzando i casi più difficili ai centri
che effettuano maggiori volumi di procedure (Costamagna 2008).
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
71
Costamagna (2008), inoltre, sottolinea come l’utilizzo appropriato dell’endoscopia ad
ultrasuoni e della colangiografia a RMN sono essenziali per una corretta selezione dei
pazienti, ma queste tecnologie sono raramente disponibili in piccoli ospedali. I casi più
difficili (grado di difficoltà 3-5 secondo Schutz) dovrebbero, quindi essere indirizzati a
centri terziari.
Nonostante ciò, sempre secondo Costamagna, i risultati non giustificano una limitazione
assoluta delle ERCP ai soli centri di riferimento: ad essi devono essere certamente inviati i
casi di maggiore difficoltà tecnica; per i casi di difficoltà tecnica minore, le ERCP possono
essere effettuate anche in altri centri, a condizione che gli operatori abbiano una adeguata
formazione. Secondo l’esperienza del suo centro è necessaria una formazione di almeno
un anno. Le società internazionali richiedono un numero preciso di ERCP effettuate per
ricevere l’attestato di competenza. Costamagna sottolinea, però, l’importanza, al di fuori
del numero di ERCP effettuate, del raggiungimento di uno specifico tasso costante di
successo. Verma (2007) ha evidenziato che per ottenere un tasso di successo di profonda
incannulazione del dotto biliare, stabile, pari all’80% sono necessarie almeno 350
esecuzioni di ERCP con papille anatomicamente normali. Anche il NIH (2002) mette in
evidenza come il numero di procedure effettuate sia un indicatore di capacità tecnica, ma
che tale indicatore deve essere considerato quale proxy del reale tasso di successo.
Dallo studio inglese di Williams et al (2007) emerge che le unità endoscopiche debbano
essere fornite di un’area di ricovero dedicata e di dispositivi per la rianimazione nella
stanza dell’ERCP.
Inoltre, deve essere disponibile uno specifico consenso informato sulle possibili
complicanze della procedura.
Infine, avere a disposizione una squadra di radiologi, infermieri e tecnici endoscopisti
specializzata ha un impatto positivo sugli esiti (NIH 2002).
Bibliografia
1. Adler DG, Baron TH, Davila RE, Egan J, Hirota WK, Leighton JA, Qureshi W, Rajan
E, Zuckerman MJ, Fanelli R, Wheeler-Harbaugh J, Faigel DO; Standards of Practice
Committee of American Society for Gastrointestinal Endoscopy. ASGE guideline:
the role of ERCP in diseases of the biliary tract and the pancreas. Gastrointest
Endosc. 2005 Jul;62(1):1-8.
2. Baron TH, Petersen BT, Mergener K, Chak A, Cohen J, Deal SE, Hoffinan B,
Jacobson BC, Petrini JL, Safdi MA, Faigel DO, Pike IM; ASGE/ACG Taskforce on
Quality in Endoscopy.
Quality indicators for endoscopic retrograde
cholangiopancreatography. Am J Gastroenterol. 2006 Apr;101(4):892-7.
3. Begg CB, Cramer LD, Hoskins WJ, Brennan MF. Impact of hospital volume on
operative mortality for major cancer surgery. JAMA. 1998 Nov 25;280(20):1747-51.
4. Beilenhoff U, Neumann CS, Biering H et al. ESGE/ESGENA guideline for process
validation and routine testing for reprocessing endoscopes in washer-disinfectors,
according to the European standard prENISO 15883 parts 1, 4 and 5. Endoscopy
2007; 39: 85–94.
5. Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE, Goodney PP, Wennberg DE, Lucas FL Surgeon
volume and operative mortality in the United States. N Engl J Med. 2003 Nov
27;349(22):2117-27.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
72
6. Bisschops R, Wilmer A & Tack J. A survey on gastroenterology training in Europe.
Gut 2002; 50:724–729.
7. Bollen TL, van Santvoort HC, Besselink MG, van Leeuwen MS, Horvath KD, Freeny
PC, Gooszen HG; Dutch Acute Pancreatitis Study Group. The Atlanta Classification
of acute pancreatitis revisited.Br J Surg. 2008 Jan;95(1):6-21. Review.
8. Bradley EL 3rd. A clinically based classification system for acute pancreatitis.
Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga,
September 11 through 13, 1992. Arch Surg. 1993 May;128(5):586-90. Review.
9. Caddy GR & Tham TC. Gallstone disease: symptoms, diagnosis and endoscopic
management of common bile duct stones. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006;
20: 1085–1101.
10. Christensen M, Matzen P, Schulze S & Rosenberg J. Complications of ERCP: a
prospective study. Gastrointest Endosc 2004; 60: 721–731.
11. Cohen S, Bacon BR, Berlin JA et al. National institutes of health state-of-the-science
conference statement: ERCP for diagnosis and therapy, January 14–16, 2002.
Gastrointest Endosc 2002; 56: 803–809.
12. Costamagna G, Familiari P, Marchese M. Tringali A. Endoscopic biliopancreatic
investigations and therapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2008;22(5):865-81.
13. Dimick JB, Cowan JA Jr, Chen SL. Emerging approaches for assessing and
improving the quality of surgical care. Curr Surg. 2003 May-Jun;60(3):241-6.
14. Eisen GM, Dominitz JA, Faigel DO et al. Guidelines for advanced endoscopic
training. Gastrointest Endosc 2001; 53: 846–848.
15. Fox VL, Werlin SL, Heyman MB. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography
in children. Subcommittee on Endoscopy and Procedures of the Patient Care
Committee of the North American Society for Pediatric Gastroenterology and
Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000 Mar;30(3):335-42.
16. Geenen JE. Endoscopic sphincterotomy. Indications and complications. Postgrad
Med. 1981 Oct;70(4):235.
17. Johanson JF, Cooper G, Eisen GM, Freeman M, Goldstein JL, Jensen DM, Sahai A,
Schmitt CM, Schoenfeld P; American Society of Gastrointestinal Endoscopy
Outcomes Research Committee.
Quality assessment of ERCP. Endoscopic
retrograde cholangiopacreatography. Gastrointest Endosc. 2002 Aug;56(2):165-9.
18. Jones DB & Chapuis P. What is adequate training and competence in
gastrointestinal endoscopy? Med J Aust 1999; 170: 274–276.
19. Jowell PS, Baillie J, Branch MS, Affronti J, Browning CL, Bute BP. Quantitative
assessment of procedural competence. A prospective study of training in
endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Ann Intern Med. 1996 Dec
15;125(12):983-9.
20. Lee KK, Anderson MA, Baron TH, Banerjee S, Cash BD, Dominitz JA, Gan SI,
Harrison ME, Ikenberry SO, Jagannath SB, Lichtenstein D, Shen B, Fanelli RD, Van
Guilder T ASGE STANDARDS OF PRACTICE COMMITTEE.
Modifications in
endoscopic practice for pediatric patients. Gastrointest Endosc. 2008 Jan;67(1):1-9.
21. Masci E, Minoli G, Rossi M et al. Prospective multicenter quality assessment of
endotherapy of biliary stones: does center volume matter? Endoscopy 2007; 39:
1076–1081.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
73
22. Meguid
A,
Scheeres
DE,
Mellinger
JD.
Endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography in a general surgery training program. Am Surg. 1998
Jul;64(7):622-5; discussion 625-6.
23. NIH
state-of-the-science
statement
on
endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography (ERCP) for diagnosis and therapy. NIH Consens State Sci
Statements 2002;19:1-26.
24. Schutz SM & Abbott RM. Grading ERCPs by degree of difficulty: a new concept to
produce more meaningful outcome data. Gastrointest Endosc 2000; 51: 535–539.
25. Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons, Guidelines for training in
diagnostic and therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
Surg Endosc (2007) 21: 1010–1011
26. Suissa A, Yassin K, Lavy A et al. Outcome and early complications of ERCP: a
prospective single center study. Hepatogastroenterology 2005; 52: 352–355.
27. Vaira D, D'Anna L, Ainley C, Dowsett J, Williams S, Baillie J, Cairns S, Croker J,
Salmon P, Cotton P, et al. Endoscopic sphincterotomy in 1000 consecutive patients.
Lancet. 1989 Aug 19;2(8660):431-4.
28. Varadarajulu S, Kilgore ML, Wilcox CM & Eloubeidi MA. Relationship among hospital
ERCP volume, length of stay, and technical outcomes. Gastrointest Endosc 2006;
64: 338–347.
29. Verma D, Gostout CJ, Petersen BT et al. Establishing a true assessment of
endoscopic competence in ERCP during training and beyond: a single-operator
learning curve for deep biliary cannulation in patients with native papillary anatomy.
Gastrointest Endosc 2007; 65: 394–400.
30. Vitte
RL
&
Morfoisse
JJ.
Evaluation
of
endoscopic
retrograde
cholangiopancreatography procedures performed in general hospitals in France.
Gastroenterol Clin Biol 2007; 31: 740–749.
31. Williams EJ, Taylor S, Fairclough P et al. Are we meeting the standards set for
endoscopy? Results of a large-scale prospective survey of endoscopic retrograde
cholangio-pancreatograph practice. Gut 2007; 56: 821–829.
32. C. Kapral, C. Duller, F.Wewalka, E. Kerstan, W. Vogel, F. Schreiber. Case volume
and outcome of endoscopic retrograde cholangiopancreatography: results of a
nationwide Austrian benchmarking project. Endoscopy 2008; 40: 625-630
33. UK guidelines for the management of acute pancreatitis, Gut 2005;54;1-9
34. Uomo G, Pezzilli R, Gabbrielli A, Castoldi L, Zerbi A, Frulloni L, De Rai P, Cavallini G,
Di Carlo V; ProInf-AISP Study Group. Diagnostic assessment and outcome of acute
pancreatitis in Italy: results of a prospective multicentre study. ProInf-AISP:
Progetto informatizzato pancreatite acuta, Associazione Italiana Studio Pancreas,
phase II. Dig Liver Dis. 2007 Sep;39(9):829-37.
A.Re.S.S. Piemonte
PDTA pancreatite acuta
74