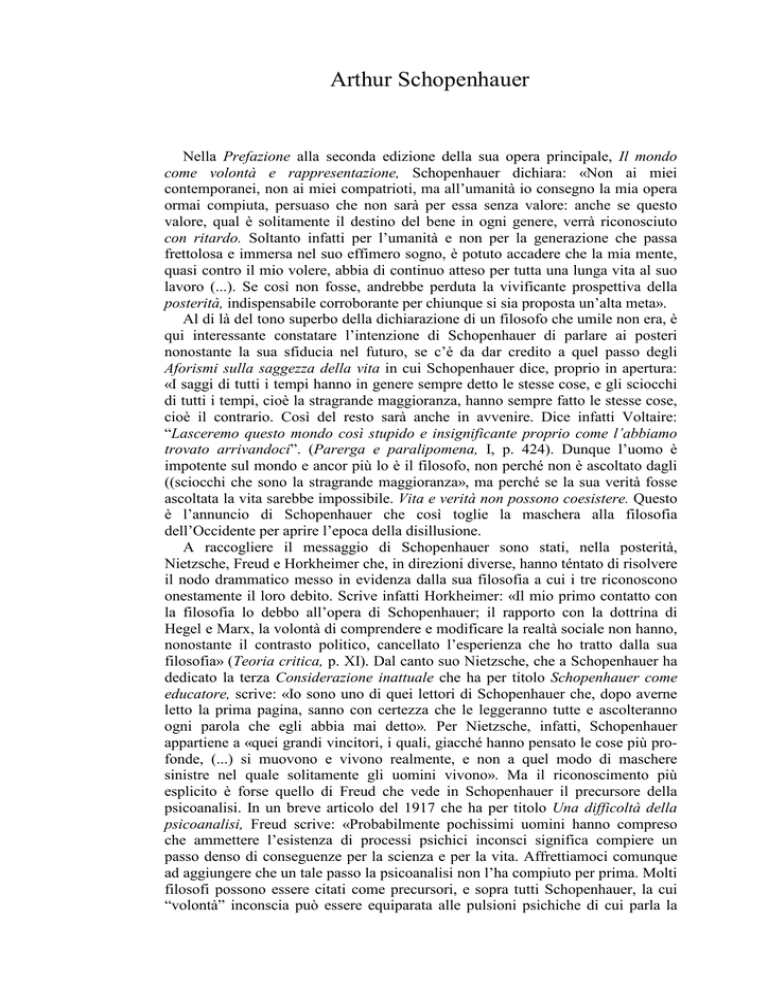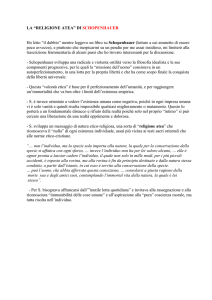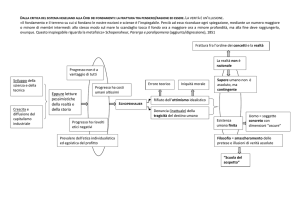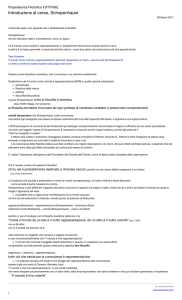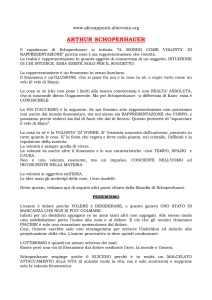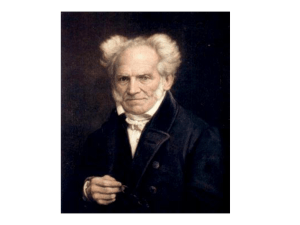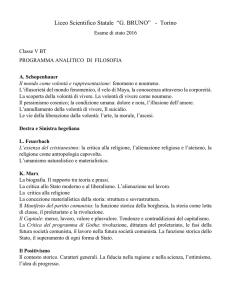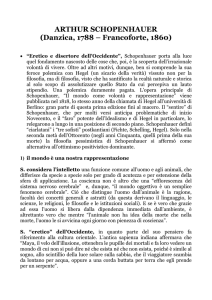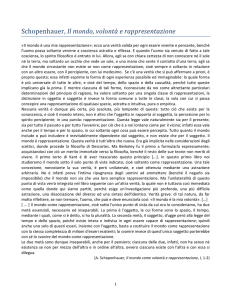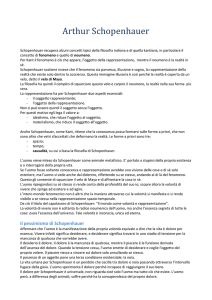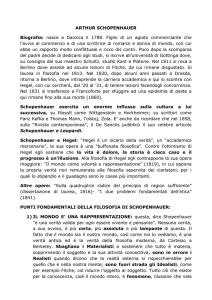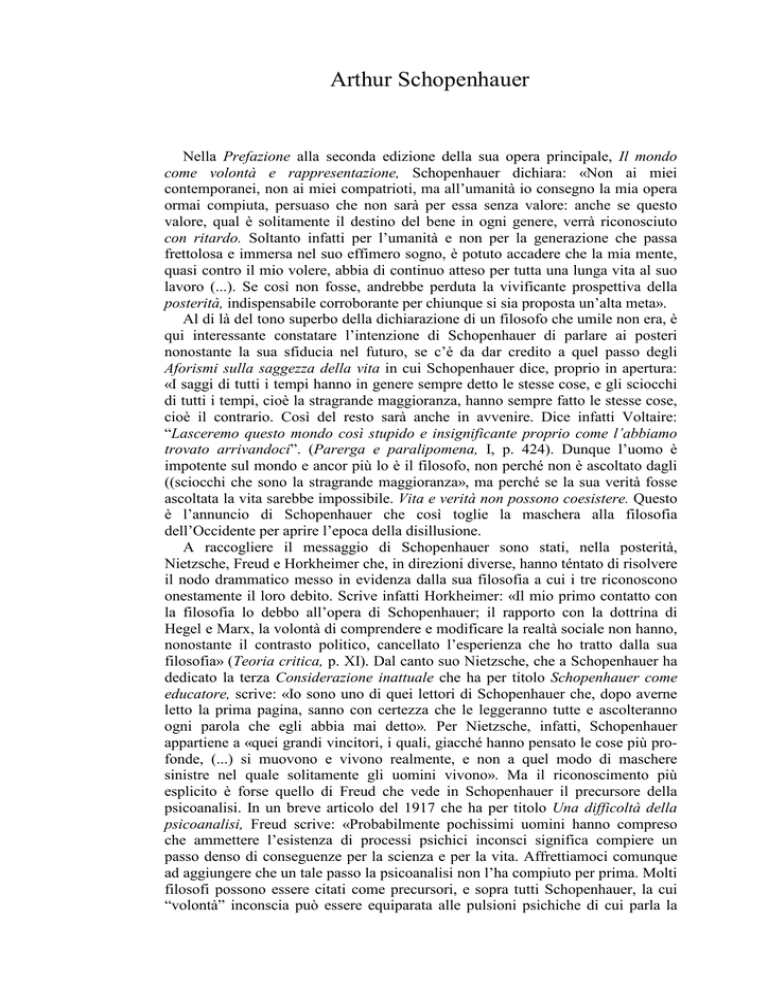
Arthur Schopenhauer
Nella Prefazione alla seconda edizione della sua opera principale, Il mondo
come volontà e rappresentazione, Schopenhauer dichiara: «Non ai miei
contemporanei, non ai miei compatrioti, ma all’umanità io consegno la mia opera
ormai compiuta, persuaso che non sarà per essa senza valore: anche se questo
valore, qual è solitamente il destino del bene in ogni genere, verrà riconosciuto
con ritardo. Soltanto infatti per l’umanità e non per la generazione che passa
frettolosa e immersa nel suo effimero sogno, è potuto accadere che la mia mente,
quasi contro il mio volere, abbia di continuo atteso per tutta una lunga vita al suo
lavoro (...). Se così non fosse, andrebbe perduta la vivificante prospettiva della
posterità, indispensabile corroborante per chiunque si sia proposta un’alta meta».
Al di là del tono superbo della dichiarazione di un filosofo che umile non era, è
qui interessante constatare l’intenzione di Schopenhauer di parlare ai posteri
nonostante la sua sfiducia nel futuro, se c’è da dar credito a quel passo degli
Aforismi sulla saggezza della vita in cui Schopenhauer dice, proprio in apertura:
«I saggi di tutti i tempi hanno in genere sempre detto le stesse cose, e gli sciocchi
di tutti i tempi, cioè la stragrande maggioranza, hanno sempre fatto le stesse cose,
cioè il contrario. Così del resto sarà anche in avvenire. Dice infatti Voltaire:
“Lasceremo questo mondo così stupido e insignificante proprio come l’abbiamo
trovato arrivandoci”. (Parerga e paralipomena, I, p. 424). Dunque l’uomo è
impotente sul mondo e ancor più lo è il filosofo, non perché non è ascoltato dagli
((sciocchi che sono la stragrande maggioranza», ma perché se la sua verità fosse
ascoltata la vita sarebbe impossibile. Vita e verità non possono coesistere. Questo
è l’annuncio di Schopenhauer che così toglie la maschera alla filosofia
dell’Occidente per aprire l’epoca della disillusione.
A raccogliere il messaggio di Schopenhauer sono stati, nella posterità,
Nietzsche, Freud e Horkheimer che, in direzioni diverse, hanno téntato di risolvere
il nodo drammatico messo in evidenza dalla sua filosofia a cui i tre riconoscono
onestamente il loro debito. Scrive infatti Horkheimer: «Il mio primo contatto con
la filosofia lo debbo all’opera di Schopenhauer; il rapporto con la dottrina di
Hegel e Marx, la volontà di comprendere e modificare la realtà sociale non hanno,
nonostante il contrasto politico, cancellato l’esperienza che ho tratto dalla sua
filosofia» (Teoria critica, p. XI). Dal canto suo Nietzsche, che a Schopenhauer ha
dedicato la terza Considerazione inattuale che ha per titolo Schopenhauer come
educatore, scrive: «Io sono uno di quei lettori di Schopenhauer che, dopo averne
letto la prima pagina, sanno con certezza che le leggeranno tutte e ascolteranno
ogni parola che egli abbia mai detto». Per Nietzsche, infatti, Schopenhauer
appartiene a «quei grandi vincitori, i quali, giacché hanno pensato le cose più profonde, (...) si muovono e vivono realmente, e non a quel modo di maschere
sinistre nel quale solitamente gli uomini vivono». Ma il riconoscimento più
esplicito è forse quello di Freud che vede in Schopenhauer il precursore della
psicoanalisi. In un breve articolo del 1917 che ha per titolo Una difficoltà della
psicoanalisi, Freud scrive: «Probabilmente pochissimi uomini hanno compreso
che ammettere l’esistenza di processi psichici inconsci significa compiere un
passo denso di conseguenze per la scienza e per la vita. Affrettiamoci comunque
ad aggiungere che un tale passo la psicoanalisi non l’ha compiuto per prima. Molti
filosofi possono essere citati come precursori, e sopra tutti Schopenhauer, la cui
“volontà” inconscia può essere equiparata alle pulsioni psichiche di cui parla la
psicoanalisi. Si tratta del resto dello stesso pensatore che, con enfasi
indimenticabile, ha anche rammentato agli uomini l’importanza misconosciuta
delle loro aspirazioni sessuali. La psicoanalisi ha quest’unico vantaggio: che non
si limita ad affermare astrattamente i due principi, tanto penosi per il narcisismo,
dell’importanza della sessualità e dell’inconsapevolezza della vita psichica, ma li
dimostra mediante un materiale che riguarda personalmente ogni singolo
individuo, costringendolo a prendere posizione di fronte a questi problemi. Ma
appunto per questo essa attira su di sé quell’avversione e quelle resistenze che di
fronte al gran nome del filosofo non osavano manifestarsi».
La posterità, a cui Schopenhauer aveva indirizzato la sua opera, non è stata
prodiga solo di riconoscimenti, ma anche di attacchi di cui, forse, il più tagliente è
quello di Croce che nella Filosofia della pratica così si esprime:«Chi può resistere
alla filosofica trivialità degli Aforismi sulla saggezza della vita di Arturo
Schopenhauer? Franca la spesa di aprire un libro per apprendervi che i beni si
dividono in personali, di ricchezza e di immaginazione o riputazione; e che i primi
(la buona salute o il temperamento gaio) hanno preminenza sugli altri? Non si
impara di più, con maggior rapidità ed efficacia da proverbi sul genere di
quello:“Uomo allegro,- Dio l’aiuta”?».
Con questo intervento Croce rinnova la polemica che aveva opposto
Schopenhauer alla filosofia idealistica e, in particolare, a Hegel che, nei Parerga e
paralipomena (I, pp. 141-142), Schopenhauer così descrive: «Hegel, uomo che
perseguiva, e per di più senza successo, degli scopi politici, spacciato in tutto e per
tutto come un grande filosofo, un ciarlatano piatto, privo di spirito, nauseante,
disgustoso, ignorante, il quale con una sfrontatezza e un’assurdità senza pari,
scarabocchiò tutto quello che dai suoi seguaci mercenari fu strombazzato come
sapienza immortale (e tale infatti venne considerato dagli sciocchi), facendo
nascere un coro unanime di ammirazione, quale mai era stato inteso prima. Il
vasto influsso spirituale, estorto da un siffatto uomo, ha avuto come conseguenza
la corruzione intellettuale di tutta una generazione erudita. Gli ammiratori di
quella pseudo-filosofia vanno incontro al disprezzo della posterità».
Al di là dell’insulto, l’accenno, che ritorna, alla posterità lascia intendere che
Schopenhauer non fa giudicare la sua filosofia dal suo tempo, ma da quel tempo
futuro che avrà la possibilità di rendersi conto che la verità assoluta, alla cui
ricerca s’è sempre mossa la filosofia da Platone a Hegel, è in realtà la
rappresentazione che l’uomo s’è dato per trovare una ragione sufficiente per
vivere. Noi, infatti, non siamo gli autori della nostra vita, ma siamo vissuti, senza
senso e senza scopo, da quella più universale volontà di vita che, dal mondo
vegetale, attraverso quello animale, fino al mondo umano, non vuole altro che la
propria riproduzione. Riflettendo su questa intuizione di Schopenhauer, la
posterità, nelle figure di Nietzsche, di Freud e di Horkheimer, ha parlato di
tragico, di inconscio e di ragione strumentale con cui la volontà di vita, nella sua
assoluta irrazionalità, tesse la rete dell’inganno per gli individui che pensano di
realizzare quei fini che in realtà sono solo i mezzi con cui la specie si conserva. Per
smascherare questo inganno, Schopenhauer ripercorre la storia del pensiero
occidentale la cui filosofia ha potuto prodursi come discorso veritativo solo
rimuovendo il corpo e la cieca pulsionalità che lo abita. Ciò che ne è nato non è la
verità del mondo, come la filosofia ha sempre preteso di enunciare, ma la
rappresentazione che l’anima s’è fatta del mondo, dopo essersi separata dal corpo
e dalla sua pulsionalità. Come frutto di una rimozione, la verità dell’anima è
dunque un inganno e, nei Frammenti sulla storia della filosofia, Schopenhauer ne
narra l’origine e la storia.
Schopenhauer e la filosofia dell’Occidente
La nozione di verità, di cui da sempre si occupa la filosofia, ha un atto di
nascita, e uno sviluppo storico, che per Schopenhauer è intimamente connesso al
concetto di anima, le cui variazioni di significato nel corso della storia decidono il
senso che di volta in volta viene ad assumere la parola “verità”. Seguire questo
sviluppo è essenziale per chi intende smascherare la pretesa validità atemporale di
ciò che si è costituito temporalmente, e soprattutto per chi, come Schopenhauer,
oppone al risolvimento hegeliano della storia nell’idea il dissolvimento dell’idea
nella sua storia.
Ora, nei Frammenti sulla storia della filosofia, Schopenhauer coglie in Platone
non solo l’atto di nascita della verità, ma l’intima connessione tra il carattere
assoluto della verità e il carattere immortale dell’anima. Evidenziare questa
connessione è essenziale perché le sorti dell’anima nel corso della storia si
riveleranno decisive per le sorti della verità.
Scrive Schopenhauer: «In Platone troviamo in qualche modo l’origine di una
falsa dianoiologia, che si introduce con una segreta intenzione metafisica,
tendendo ad una psicologia razionale ed alla connessa dottrina dell’immortalità.
La medesima si è più tardi rivelata una dottrina ingannevole dalla vita
tenacissima, prolungando la sua esistenza attraverso tutta la filosofia antica,
medioevale e moderna sino a che Kant, lo stritolatore, la colpì infine al capo. La
dottrina di cui intendo parlare è il razionalismo della teoria della conoscenza con
intenzione finale metafisica. Essa, brevemente, può così riassumersi. La parte
conoscitiva in noi è una sostanza immateriale, fondamentalmente diversa dal
corpo, chiamata anima: il corpo per contro è un impedimento alla conoscenza.
Ogni conoscenza ottenuta quindi attraverso la mediazione del corpo è
ingannevole: l’unica vera, giusta e sicura è quella libera e lontana da ogni sensibilità (e quindi da ogni intuizione), in altre parole il pensiero puro, cioè l’operare
unicamente con concetti astratti. Tutto ciò è compiuto dall’anima con i suoi propri
mezzi: la situazione migliore si verificherà dunque quando essa si sarà separata
dal corpo, e noi saremo morti. Cose di questo genere sono dunque messe dalla
dianoiologia a disposizione della psicologia razionale, a vantaggio della sua
dottrina dell’immortalità. Questa dottrina, quale la riassumo ora, si trova espressa
in forma dettagliata e chiara nel capitolo 10 del Pedone» (Parerga, L p.72).
In realtà in Platone si intrecciano due tradizioni: una legata ai riti misterici, a
cui Platone era stato iniziato in Egitto da Sechenuf, e di cui parla con linguaggio
mitologico nel Fedro e nel Convito che sono i dialoghi dedicati alla divina follia,
all’Eros, ad Apollo e Dioniso, al caos e al cosmo, all’origine degli dei e degli
uomini. E questa l’anima della tradizione orfica commista alla tradizione
sciamanica e alla nascente medicina della scuola di Cos che, nella sua pratica
terapeutica, aveva accolto la tradizione di Asclepio, che curava nel sonno tramite
il sogno. E l’anima dei lirici e dei primi tragici che ad Eleusi la rappresentavano in
drama.
Ma a quest’anima, che oggi potremmo dire di natura psicologica, Platone
affianca quell’anima, propriamente filosofica, che è la capacità di astrarre dalla
molteplicità del sensibile per potersi esprimere nell’unità dell’idea. Dove infatti
non c’è unità, non c’è sapere. Non c’è sapere quando parlo dell’acqua del fiume,
dell’acqua del mare, dell’acqua dello stagno, ma quando colgo ciò che queste
acque hanno in comune: oggi diremmo H20, Platone diceva l’essenza dell’acqua o
idea.
Queste idee sono in “cielo” perché in terra non è dato vedere l’essenza
dell’acqua del fiume, del mare, dello stagno. Il sapere veritativo allora nasce solo
se l’anima distoglie lo sguardo dalla dispersione in cui giacciono le cose sensibili
per volgerlo a quell’espressione della loro unità che è l’essenza o idea. Di ciò che
è irriducibile ad unità, come ad esempio i nostri corpi, non c’è sapere, e dove non
c’è sapere c’è follia: la «follia del corpo» dice Platone nel Fedone (67 a). Una
volta separata dal corpo, l’anima, come luogo della verità, incomincia a pensarsi
per sé e a guadagnare quell’autosufficienza che costituirà uno dei filoni
determinanti dell’antropologia occidentale dove l’uomo, pensato come anima, si
sviluppa sotto il segno dell’interiorità, e dove la felicità non coincide più con la
fruizione della propria corporeità nel tempo, ma è spostata alla fine della vita
terrena in un logos eterno, trascendente e soprattutto indifferente rispetto al fluire
della storia.
L’uomo, che in Omero era aperto al mondo attraverso i piaceri, i desideri, le
passioni e i dolori del corpo, con Platone si ritira dal mondo per rivolgersi alla
propria anima che diventa ad un tempo il luogo della verità contro l’inganno dei
sensi e il luogo dell’identità dell’Io contro la forza dissolvente delle passioni.
Scrive infatti Platone: «Coloro che amano il sapere, sanno bene che la filosofia,
prendendo a educare l’anima, si adopera per liberarla dal corpo (...) e la esorta a
raccogliersi e a restringersi tutta sola in se stessa e a non fidare in nient’altro che
in se stessa, qualunque sia l’essere che ella voglia da se medesima penetrare nella
sua essenza immutabile» (Pedone, 83 a-b).
Non essendoci verità che nell’anima, l’anima deve star sola con se stessa;
l’ascesi che ne scaturisce, e che, come vedremo, sarà un motivo fondamentale
nella filosofia di Schopenhauer, è un rivolgersi alla propria interiorità per
guadagnare in profondità. La profondità è il massimamente distante dal mondo e il
massimamente vicino alla verità. Tra mondo e verità corre ormai l’abisso, lo
stesso che corre tra verità e felicità, nel senso che diventa possibile una vita
ospitata dalla verità, ma senza felicità e una felicità senza vita, ossia nell’altro
mondo.
Questo motivo platonico sarà ripreso dalla religione cristiana che, come luogo
eminente della cultura dell’anima, diventa base dell’elaborazione
dell’antropologia occidentale. Quando la tradizione agostiniana dice che amare
mundum non est cognoscere Deum, o che in interiore ho-mine habitat veritas,
ribadisce il nesso platonico interiorità = verità, ma soprattutto prepara il senso
della filosofia moderna che, da Cartesio a Schopenhauer, non fa che dire: il mondo
è una rappresentazione dell’anima. Che altro significa cogito ergo sum se non che
nell’interiorità del pensiero sono da ricercare le leggi per la comprensione del
mondo?
A Schopenhauer non sfugge questo passaggio e perciò scrive: «Cartesio è
considerato a buon diritto il padre della filosofia, anzitutto ed in generale perché
ha avviato la ragione a reggersi sulle proprie gambe» (Parerga, I, p.l9).
La continuità con Platone sta nel principio che la verità è nell’interiorità
dell’anima, nella ragione che si regge solo “sulle proprie gambe”; la differenza è
che Platone riteneva che le idee o essenze ultime delle cose, che l’anima rinveniva
restando sola con se stessa, riproducevano l’oggettività dell’essere stesso, mentre
Cartesio, pur ribadendo che tutto ciò che esiste, esiste solo come affezione
dell’anima, ritiene che le idee, che il cogito trova in se stesso, non ci danno
l’oggettività del mondo, ma la sua rappresentazione soggettiva che solo la certezza
di un Dio non ingannevole rende identica alla situazione oggettiva.
Cartesio, scrive Schopenhauer, «fu tutto preso dalla verità che noi siamo prima
di ogni altra cosa limitati dalla nostra propria coscienza e che il mondo ci è dato
soltanto come rap presentazione: con il famoso “dubito, cogito ergo sum” egli
volle porre in rilievo l’unica certezza della coscienza soggettiva, in contrasto alla
problematicità di tutto il resto, ed esprimere la grande verità che l’unica cosa
realmente e incondizionatamente data è l’autocoscienza. A rigore, il suo celebre
principio equivale al mio punto di partenza: “il mondo è la mia rappresentazione”.
L’unica differenza sta nel fatto che egli pone in rilievo l’immediatezza del
soggetto, ed io la mediatezza dell’oggetto. Le due proposizioni esprimono la
medesima cosa da due lati, sono il rovescio l’una dell’altra. (...) Certamente da
allora si è ripetuta innumerevoli volte la sua frase, avendo soltanto sentore della
sua importanza, e non avendo una chiara comprensione del suo vero senso e del
suo scopo. Egli dunque scoprì l’abisso che separa il soggettivo, o ideale,
dall’oggettivo, o reale, ed espresse questa sua tesi nel dubbio sull’esistenza del
mondo esterno: senonché con il suo misero espediente per uscirne — affermando
cioè che il buon Dio non ci vorrà certo ingannare — egli mostrò quanto fosse
profondo e difficile a risolversi il problema. Nel frattempo, attraverso di lui,
questo scrupolo era entrato nella filosofia e doveva continuare ad agire come
elemento perturbatore, sino a che non fosse definitivamente eliminato» (Parerga,
I, pp. 20-21).
Dall’anima di Platone al cogito di Cartesio il sapere e la verità si esprimono nel
regime dell’interiorità the risolve il mondo in una sua rappresentazione. L’anima
diventa legislativa, detta cioè le leggi della rappresentazione del mondo. In
proposito Kant è chiarissimo. Nella Prefazione alla seconda edizione della Critica
della Ragion pura (1787) scrive che Galilei e Torricelli «compresero che la
ragione vede solo ciò che lei stessa produce secondo il proprio disegno, e che, con
principi dei suoi giudizi secondo leggi immutabili, deve essa entrare innanzi e
costringere la natura a rispondere alle sue domande: e non lasciarsi guidare da lei,
per dir così con le redini, perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e
senza un disegno prestabilito, non metterebbero capo a una legge necessaria, che
pure la ragione cerca e di cui ha bisogno. E necessario dunque che la ragione si
presenti alla natura avendo in una mano i principi, secondo i quali soltanto è
possibile che fenomeni concordanti abbiano valore di legge, e nell’altra
l’esperimento, che essa ha immaginato secondo questi principi: per venire bensì
istruita da lei, ma non in qualità di scolaro che stia a sentire tutto ciò che piaccia al
maestro, sebbene di giudice, che costringa i testimoni a rispondere alle domande
che egli loro rivolge».
La funzione legislativa della ragione moderna ribadisce il motivo platonico
secondo cui è l’anima, “tutta raccolta in se stessa”, a dire com’è il mondo, è
l’interiorità a fornire il principio d’ordine dell’esteriorità che, fuori da questo ordine, nel suo in sé, rimane inconoscibile. L’inconoscibilità del noumeno kantiano,
della “cosa in sé”, cioè al di là delle categorie con cui il pensiero se la
rappresenta, è per Schopenhauer la conferma che da Platone a Kant, quindi per
tutto l’arco della storia d’Occidente, il mondo è una rappresentazione dell’anima,
e l’anima è la rappresentazione del mondo.
Il mondo come rappresentazione
L’opera principale di Schopenhauer — Il mondo come volontà e
rappresentazione — inizia così: «“Il mondo è una mia rappresentazione”:ecco una
verità valida per ogni essere vivente e pensante, benché l’uomo possa soltanto venirne a coscienza astratta e riflessa. E quando l’uomo sia venuto di fatto a tale
coscienza, lo spirito filosofico è entrato in lui. Allora, egli sa con chiara certezza
di non conoscere né il sole né la terra, ma soltanto un occhio che vede un sole, e
una mano che sente il contatto d’una terra; egli sa che il mondo circostante non
esiste se non come rappresentazione, cioè sempre e soltanto in relazione con un
altro essere, con il percipiente, con lui medesimo. Se c’è una verità che si può
affermare a priori, è proprio questa; essa infatti esprime la forma di ogni esperienza possibile ed immaginabile: la quale forma è più universale di tutte le altre, e
cioè del tempo, dello spazio e della causalità, perché tutte queste implicano già la
prima» .
Se il mondo è una mia rappresentazione, il criterio di verità sarà da rintracciare
nel regime della mente. Per questo Cartesio scrive un Discorso sul metodo e le
Regulae ad directionem ingenii; per questo Kant, nella Critica della Ragion pura,
prende in esame le condizioni della pensabilità in generale e le elenca dopo averle
distinte in intuizioni e categorie; per questo Schopenhauer indaga Sulla
quadruplice radice del principio di ragion sufficiente per descrivere la
legislazione con cui l’intelletto costruisce la rappresentazione del mondo. «Non è
vero —scrive infatti Schopenhauer — che il mondo, già bell’e pronto, debba
semplicemente entrare nella testa attraverso i sensi e le porte dei loro organi. I
sensi, infatti, non forniscono che la materia prima, che l’intelletto, per mezzo delle
semplici forme date, cioè spazio, tempo e causalità, elabora immediatamente
nell’intuizione oggettiva di un mondo di corpi regolati da leggi. La nostra
intuizione quotidiana empirica è dunque un’intuizione intellettuale».
Che significa tutto questo? Significa che conoscere continua ad essere, come
aveva detto Platone, un evento dell’anima che si raccoglie in se stessa, ma mentre
per Platone raccogliersi significava ritirarsi dal mondo e dal corpo, quindi passare
dall’esteriorità all’interiorità, con Cartesio — e da Cartesio in poi — il mondo e
il corpo, in quanto rappresentazioni dell’anima, sono inclusi e contenuti
nell’anima, che in tal modo diventa il limite estremo, l’assoluta esteriorità rispetto
ai corpi e agli eventi del mondo che essa include.
Se infatti il mondo, come dice Schopenhauer, «non è lì bell’e pronto per entrare
nella nostra testa», ma è «posto dalle leggi dell’intelletto» e, in quanto così posto,
è saputo, allora è l’anima a creare il mondo come noi lo conosciamo, e il mondo è
il suo sogno.
«Tratteremo dunque — scrive Schopenhauer —l’universo come pura
rappresentazione, come oggetto per il soggetto; e, al pari di ogni altro oggetto
reale, considereremo anche il nostro corpo, unico nostro mezzo per l’intuizione
del mondo, soltanto dal punto di vista della conoscibilità, rispetto alla quale non è
che rappresentazione» (Il mondo, § 6).
Quando l’anima era un’interiorità che si ritirava dal mondo, era possibile
distinguere lo stato di veglia, proprio della condizione filosofica in grado di
raggiungere con l’anima l’essenza delle cose, dallo stato di sogno in cui giacevano
quanti, fidandosi solo dei sensi corporei, non erano in grado di sollevarsi dal
mondo delle apparenze sensibili. E, nella Repubblica (476 c), proprio alla
metafora del sogno ricorre Platone per distinguere i filosofi «che sono in condizione di veglia» dai filodoxoi «che vivono come in un sogno, perché confondono
l’apparenza con la realtà». Ma ora, con l’esteriorizzazione dell’interiorità
dell’anima, non c’è più un mondo che sia esterno all’anima, e quindi non c’è più
una realtà rispetto a cui poter distinguere la condizione di veglia dalla condizione
di sogno.
I]ipotesi kantiana secondo cui «il rapporto delle rappresentazioni fra loro
secondo la legge della causalità distingue la vita dal sogno» non persuade
Schopenhauer perché anche i singoli elementi del sogno si connettono secondo il
principio di ragione in tutte le sue forme, e questa connessione non si rompe che
tra la vita e il sogno o tra un sogno e l’altro. Quindi la risposta di Kant non
ammette che quest’unica interpretazione: il sogno lungo (la vita) ha in sé una connessione costante secondo il principio di ragione, però non la possiede con i sogni
brevi, nonostante ciascuno di essi abbia in sé la stessa connessione: in questo
modo è dunque rotto il ponte tra i sogni delle due classi, e tale è appunto il
carattere che li distingue (...). I sogni si distinguono dunque dalla vita reale in
quanto non rientrano nella continuità dell’esperienza che ininterrottamente vi
circola: e tale differenza è ben indicata dal risveglio. Ma se questa connessione
dell’esperienza appartiene già, come sua forma, alla vita reale, anche il sogno
possiede la sua connessione. Se per giudicare le cose noi ci poniamo in un punto
di vista estraneo e alla vita e al sogno, nella loro essenza noi non riusciamo a
trovare un carattere distintivo netto, e allora dobbiamo concordare con i poeti che
la vita non è che un lungo sogno» (Il mondo, § 6).
Questa concessione «poetica» abolisce quell’antica distinzione tra desti e
dormienti che la filosofia ha inaugurato fin dal suo primo sorgere, quando, con
Eraclito, avvertiva: «Non bisogna agire e parlare come nel sonno» (fr. 10); e
ancora: «i desti hanno un mondo in comune, mentre nel sonno ognuno si apparta
in un mondo privato» (fr. 12). La filosofia nasce per superare questi mondi privati
e porre le basi di un discorso comune (koinòn), perciò Eraclito può dire: «Si deve
seguire ciò che è comune. Ma benché comune sia questo Logos che io insegno, i
molti vivono come se avessero un proprio pensiero privato» (fr. 5).
Proseguendo sulla via indicata da Eraclito, Platone formula i codici
grammaticali e gli statuti logici del discorso comune o, come lo chiama Platone,
epistemico. Il discorso, infatti, nelle mani dei sacerdoti, dei poeti, dei retori, dei
sofisti, corre il rischio della sovrabbondanza, dell’ambiguità, dell’equivoco e
insieme dell’inconcludenza; Platone, con la sua magistrale e gigantesca
costruzione che punta all’unità del molteplice, lo sottrae a questo rischio e lo
instaura come «scientifico». Le «idee» di Platone sono la prima grande macchina
con cui la ragione si organizza, guadagna certezza di sé, e, nel suo esercizio, si
autocertifica. La prima forma di autocertificazione è l’esclusione della follia. Folli
sono tutti quei discorsi che non danno ragione alle regole della ragione, la cui
capacità di dominio si trasforma dapprima in rappresentazione di un ordine
necessario e, col suo progressivo estendersi, in rappresentazione dell’ordine come
tale.
Platone era convinto che quest’ordine, che l’anima aveva scoperto,
corrispondesse all’ordine effettivo delle cose, e perciò chi perveniva a
quest’ordine (il filosofo) era desto rispetto ai molti (i filodoxoi) che, non
pervenendovi, erano simili ai dormienti. Ma quando Cartesio avverte che l’ordine
dell’essere è stabilito dal cogito, cioè dal pensiero umano, il mondo diventa una
rappresentazione di questo pensiero, e la distinzione tra i desti e i dormienti si
capovolge, nel senso che i dormienti sono coloro che ancora non sanno che
l’ordine del mondo è l’ordine che la ragione umana ha dato al mondo. Nel suo «in
sé» il mondo resta sconosciuto e la ragione umana resta confinata nell’ordine che
essa stessa ha dato al mondo, resta confinata quindi nella sua rappresentazione.
«Nessuna verità — scrive Schopenhauer — è dunque più certa, più assoluta, più
lampante di questa: tutto ciò che esiste per la conoscenza, e cioè il mondo intero,
non è altro che l’oggetto in rapporto al soggetto, la percezione per lo spirito percipiente; in una parola: rappresentazione. Questa legge vale naturalmente sia per il
presente, sia per tutto il passato e per tutto l’avvenire; per ciò che è a noi lontano
come per il vicino; infatti essa vale anche per il tempo e per lo spazio in cui
soltanto ogni cosa può essere percepita. Tutto quanto il mondo include o può in-
cludere è inevitabilmente dipendente dal soggetto, e non esiste che per il soggetto.
Il mondo è rappresentazione» (Il mondo, § 1).
La rappresentazione è ordinata da quelle connessioni che il principio di ragione
instaura. Conoscere è connettere, è comporre nessi; il fondamento di questa
connessione, e quindi della conoscenza, non è nelle cose, come ritenevano gli
antichi, ma nel soggetto che le istituisce. E come nella metafora teologica non si
dà mondo prima della creazione, così per Schopenhauer non si dà mondo prima
della legislazione della ragione che, attraverso le sue leggi (tempo, spazio,
causalità, le forme a priori in cui si articola il principio di ragione), crea il mondo
che, in quanto accessibile solo attraverso le leggi della ragione, coincide con
queste leggi.
Se il mondo coincide con le leggi della ragione che l’hanno istituito,
l’istituzione non ha in sé alcuna ragione e, come tale, è un atto arbitrario. Alle
spalle della ragione e del mondo che si rappresenta c’è allora una volontà assoluta
e istitutiva che, venendo prima della ragione, è cieca pulsione: der Wille als blinde
Trieb, dice Schopenhauer (Il mondo, § 21). Rispetto alla volontà come cieca
pulsione, il soggetto, finora descritto come creatore del mondo, appare solo una
misera preda. Così la cieca pulsione infrange il sogno del mondo: «La cosa
rappresentata e la sua rappresentazione hanno lo stesso significato, ma sono anche
soltanto la cosa rappresentata e non la cosa in se stessa: quest’ultima è sempre
volontà, sotto qualsiasi aspetto essa possa apparire nella rappresentazione» (Parerga, I, pag. 41).
Il corpo e la cieca pulsione
La ragione ha costruito se stessa prima come verità (Platone) e poi come
rappresentazione del mondo (Cartesio), percorrendo l’itinerario platonico che,
attraverso la separazione dal corpo, ha condotto alla progressiva interiorizzazione
dell’anima e alla sua completa autonomia. I testi in proposito sono espliciti:
«Sembra ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a
questa considerazione, e cioè: fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra
anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo
adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità [...]. Pertanto, nel
tempo in cui siamo, in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere
quanto meno avremo relazioni col corpo e comunione con esso, se non nella
stretta misura in cui vi sia imprescindibile necessità, e non ci lasceremo
contaminare dalla natura del corpo, ma dal corpo ci manterremo puri fino a che
Iddio stesso non ci avrà scelto da esso. E così, liberati dalla follia del corpo, come
è verosimile, ci troveremo con esseri puri come noi e conosceremo, nella purezza
della nostra anima, tutto ciò che è puro: questo io penso è la verità» (Fedone, 66
a). Dal canto suo Cartesio, nelle Meditazioni metafisiche, ribadisce: «Ma che cosa
sono io? Una cosa che pensa. E che cos’è una cosa che pensa? E una cosa che
dubita, che concepisce, che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che
immagina anche, e che sente [...] e siccome ora so che noi non concepiamo i corpi
se non per mezzo della facoltà di intendere che è in noi, e non per
l’immaginazione, né per i sensi; e che non li concepiamo per il fatto che li
vediamo o li tocchiamo, ma solamente per il fatto che li concepiamo per mezzo
del pensiero, io conosco evidentemente che non v’è nulla che mi sia più facile a
conoscere del mio spirito».
Da Platone in poi, quindi per l’intero arco della storia della filosofia, la ragione
ha potuto costruire se stessa e ha potuto legiferare, prima in termini di verità, poi
in termini di rappresentazione, solo rimuovendo il corpo e risolvendolo in
quell’idea di corpo che la ragione, e i saperi da essa promulgati, andavano di volta
in volta descrivendo.
Negato nel suo in sé, il corpo è divenuto una semplice superficie di scrittura
atta a ricevere il testo visibile dell’ordine che la ragione andava dispiegando. Ma
sotto quest’ordine l’inseità corporea, come bene aveva visto Platone, continua a
costituire la massima obiezione all’autonomia della ragione, lo scoglio contro cuj
la sua verità o la sua rappresentazione si infrange. Parlare del corpo significa
allora sprigionare la follia, quella follia per contenere la quale Platone aveva dato
avvio all’edificio della ragione, costruendolo sulla separazione dell’anima dal
corpo.
A Schopenhauer non sfugge la mossa platonica e, contro la verità o la
rappresentazione del mondo costruita da «una testa d’angelo alata senza corpo»,
solleva lo spessore della corporeità disgregante l’ordine della ragione. «In realtà
— scrive Schopenhauer — sarebbe impossibile trovare il significato di questo,
mondo che ci sta dinnanzi come rappresentazione, oppure comprendere il suo
passaggio da semplice rappresentazione del soggetto conoscente a qualcosa
d’altro e di più, se il filosofo stesso non fosse qualcosa di più che un puro soggetto
conoscente (una testa d’angelo alata, senza corpo). Ma il filosofo ha la sua radice
nel mondo; ci si trova come individuo, e cioè la sua conoscenza, condizione e
fulcro del mondo come rappresentazione, è necessariamente condizionata dal
corpo, le cui affezioni, come abbiam fatto vedere, porgono all’intelletto il suo
punto di partenza per l’intuizione del mondo medesimo. Per il soggetto puramente
conoscitivo il corpo è una rappresentazione come un’altra, un oggetto fra altri
oggetti, i suoi movimenti e le sue azioni non sono per lui, sotto questo punto di
vista, nulla di diverso dalle modificazioni di qualsiasi altro oggetto intuitivo [...].
Ora le cose non stanno punto così; anzi al contrario: è l’individuo, il soggetto
conoscente, quello che dà la parola dell’enigma; e questa si chiama volontà:
Questa parola, questa sola, offre al soggetto la chiave della propria esistenza
fenomenica; gliene rivela il significato, e gli mostra il meccanismo interiore che
anima il suo essere, il suo fare, i suoi movimenti. Al soggetto conoscente che deve
la sua individuazione all’identità con il proprio corpo, esso corpo è dato in due
maniere affatto diverse: da un lato come rappresentazione intuitiva dell’intelletto,
come oggetto fra oggetti, sottostante alle loro leggi; ma insieme, dall’altro lato, è
dato come qualcosa di immediatamente conosciuto da ciascuno, e che viene
designato col nome di volontà» (Il mondo, § la).
L’irruzione della volontà, di cui le pulsioni del corpo sono l’evidente
manifestazione, spezza l’«egoismo teorico» in cui si è arroccata la filosofia e
contro il quale non c’è un argomento che tenga, ma solo una cura.
La ragione, infatti, ha sempre ragione di tutti gli argomenti che nascono nel suo
ambito, perché qui vigono le sue regole che regolano appunto l’esclusione del
corpo, della volontà e delle pulsioni.
Per questo, scrive Schopenhauer, «l’egoismo teorico non si potrà mai confutare
con argomenti [...]. Come convinzione seria non potrebbe incontrarsi che in un
manicomio, e allora per confutarlo non occorrono più argomenti, ma è necessaria
una cura. Non ne terremo dunque più conto» (Il mondo, § 19).
Nata dall’esclusione del corpo, la ragione non può ospitare l’obiezione del
corpo, e perciò, prosegue Schopenhauer: «Noi che cerchiamo di estendere per
mezzo della filosofia i limiti della nostra conoscenza, non riguarderemo l’argomento a noi opposto dall’egoismo teorico se non come un piccolo forte di
frontiera; inespugnabile, ma la cui guarnigione non può far mai una sortita, sicché
si può passare oltre lasciandocelo alle spalle senza pericolo» (Il mondo, § 19).
Passare oltre non significa solo lasciare alle spalle, ma abitare uno spazio che
ridefinisce la ragione e il suo altro. In questo spazio la ragione appare come il
tentativo di razionalizzare ciò che razionale non è, perché è pura volontà di vita,
cieca pulsione a essere, a crescere, a proliferare: «La volontà, così come la
troviamo nel nostro intimo, non scaturisce dalla conoscenza, come pretendeva
finora la filosofia, e non è della conoscenza una semplice modificazione, una cosa
secondaria, dunque, derivata, determinata dal cervello come la conoscenza; la
volontà è il prius della conoscenza, il nucleo del nostro essere, è quella forza
originaria che crea e conserva il corpo animale, del quale compie tutte le funzioni
consapevoli e inconsapevoli: in ciò consiste il primo passo della conoscenza
essenziale della mia metafisica» (Il mondo, §23).
I passi successivi mostreranno quindi che «la volontà che, nella natura priva di
conoscenza, si mostra come forza naturale; un gradino più in alto come forza
vitale; nell’uomo e nell’animale, poi, ottiene il nome di volontà» (Parerga, Il, §
63).
Con questi rapidi passaggi Schopenhauer riporta il senso dell’essere, a cui la
filosofia si è applicata fin dal suo nascere, all’insensatezza del divenire, dove è
possibile rintracciare l’antico significato della parola essere che, come physis, non
vuol dire verità, ma semplicemente vita che da sé sboccia e scaturisce
dispiegandosi nei suoi aspetti multiformi e non preordinati. Sottraendo all’essere il
suo sostanziale divenire e immobilizzandolo nei suoi aspetti (éidos), e nelle sue
forme, la filosofia ha potuto ordinario con le sue idee e così padroneggiarlo. Ma
questo dominio tradisce una volontà; il suo ordine è un ordinamento e la ragione
che lo presiede è una semplice razionalizzazione. La verità che la filosofia ha
riconosciuto nell’immobilizzazione dell’essere è una maschera che il divenire
della vita manda in frantumi.
Dunque tra vita e verità non c’è conciliazione, ma solo l’effetto della maschera
il cui crollo riapre l’insanabile dissidio che si annoda intorno al soggetto della
vita: siamo noi a vivere o siamo vissuti da una vita che ci trascende? La seconda
ipotesi è l’abbattimento del soggetto e la riduzione della sua ragione e del suo
ordine a illusioni per vivere. La verità che ci anima è, infatti, la verità che noi
abbiamo prodotto per difenderci da quella volontà che, come cieca pulsione, ci
abita prima dei nostri pensieri e delle nostre illusorie ragioni. Lo spazio di gioco
non è «logico», non è tra la verità e l’uomo, ma è«bio-logico» perché si gioca tra
la vita, nel senso animale e vegetale della parola, e l’uomo con le sue produzioni
di verità, per cui più appropriata delle metafore filosofiche è la metafora di Paolo
di Tarso: «Non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te» (Lettera ai
Romani, 11,18).
Comprendiamo a questo punto il titolo dell’opera principale di Schopenhauer:
Il mondo come volontà e rappresentazione. La rappresentazione è il
mascheramento razionale della volontà. Ciò che appare come ragionevole è semplicemente volontaristico. La ragione è inganno perché fa apparire come ordine
deliberatamente conquistato ciò che è semplicemente espressione di
un’insopprimibile volontà di vita. Scoprirlo è smascherare la ragione, è
retrocedere alle sue spalle, onde scorgervi il fondamento irrazionale che la
promuove e che, a inganno avvenuto, ricompare in quelle domande che chiedono
il senso dell’agire, dell’operare, del lavorare, del darsi da fare in generale; il senso
di quel trovarsi così costituiti come volontà volente che, nel possesso delle cose,
esprime la propria volontà di vita. La ragione non cessa mai di offrire «buone
ragioni» per vivere, nasconde il tragico sotteso al non-senso della volontà di vita,
e così facendo la difende dalla tentazione sempre incombente che ne determi-
nerebbe l’estinzione per il riconoscimento avvenuto.
Il dolore universale e le vie di liberazione
Contro la tesi di Leibniz, che questo è il migliore dei mondi possibili,
Schopenhauer afferma recisamente che non solo questo è il peggiore, ma, se
appena fosse ancora un poco peggio, non potrebbe esistere. L’ottimismo, dice
Schopenhauer ripetendo a suo modo una tesi di Hume, non è che «l’autoelogio
ingiustificato del creatore del mondo, cioè della volontà di vita, la quale compiacentemente si specchia nella sua opera» (Il mondo, § 46); ma dal punto di vista
dell’individuo la vita non è che una perpetua oscillazione tra il dolore e la noia. Da
un lato, infatti, volere significa desiderare, e il desiderio implica l’assenza di ciò
che si desidera, quindi il dolore; d’altro lato, se il desiderio dovesse estinguersi,
non rimarrebbe che la noia, per cui di sette giorni della settimana sei appartengono
alla fatica e al bisogno, il settimo alla noia.
«Già nella natura incosciente — scrive Schopenhauer — costatiamo che la sua
essenza è una costante aspirazione senza scopo e senza posa; nel bruto e
nell’uomo, questa verità si rende manifesta in modo ancor più eloquente. Volere è
aspirare, questa è la loro essenza; una sete inestinguibile. Ogni volere si fonda su
di un bisogno, su di una mancanza, su di un dolore: quindi è in origine e per
essenza votato al dolore.
Ma supponiamo per un momento che alla volontà venisse a mancare un
oggetto, che una troppo facile soddisfazione venisse a spegnere ogni motivo di
desiderio, subito la volontà cadrebbe nel vuoto spaventoso della noia; la sua
esistenza, la sua essenza, le diverrebbero un peso insopportabile. Dunque la sua
vita oscilla, come un pendolo, fra il dolore e la noia, suoi due costitutivi essenziali.
Donde lo stranissimo fatto che gli uomini, dopo ricacciati nell’inferno dolori e
supplizi, non trovarono che restasse per il cielo niente all’infuori della noia» (Il
mondo, § 57).
Dal dolore universale non si esce con il suicidio, perché chi si uccide non nega
la volontà di vita, ma solo quella particolare condizione di vita in cui egli si trova.
Col suo gesto il suicida esprime proprio il contrario di ciò che vorrebbe esprimere;
egli infatti si uccide perché ama la vita e considera intollerabile solo la situazione
in cui è venuto a trovarsi. Anche nel suicidio, quindi, ciò che si celebra è
l’indistruttibile volontà di vivere.
Dal dolore non si esce neppure con un comportamento morale, perché là dove
tutto è regolato dalla volontà irrazionale, dove non c’è un «regno dei fini» come
riteneva Kant, o un piano predisposto dall’«astuzia della ragione» come pensava
Hegel, non c’è agire a cui si possa dare uno scopo o imporre un dovere. Anzi una
morale fondata sul «dovere» come voleva Kant sconta già all’interno quella che
per Hegel è la sua «miseria», perché non dice ciò che gli uomini fanno, ma ciò che
devono fare. La sua «innocenza» tradisce la sua inefficacia, la sua scarsa aderenza
alla realtà e alla condotta effettiva dell’uomo.
Nell’attacco all’imperativo categorico che prevede il dovere per il dovere,
Schopenhauer è con Hegel, ma a Hegel si contrappone violentemente quando si
tratta di stabilire la nuova direzione dell’atteggiamento etico. L’etica hegeliana,
che pretende di intervenire nella storia «alla sua altezza», appare a Schopenhauer
come un nuovo mascheramento dell’effettivo comportamento umano, e la sintesi
dialettica un nuovo ritrovato della ragione per mascherare le effettive motivazioni
che provengono dai bisogni della natura umana. I bisogni determinano la «ragion
pratica» i cui ideali permangono nella misura in cui soddisfano i bisogni; la
morale, infatti, non si impone da sé, ma solo se manifestamente o nascostamente
soddisfa la relazione motivazione-bisogno che è alla base di ogni agire.
Supporre che l’agire possa realizzare la propria soddisfazione significa
presupporre la capacità da parte dell’agire di trasformare la struttura metafisica
dell’essere, quindi la capacità da parte dell’uomo di disporre della propria
«radice». Siccome ciò è impossibile, ogni discorso relativo alla libertà dell’agire e
alla razionalità del comportamento etico si giustifica solo nel misconoscimento di
questa impossibilità. L’agire non è libero e non ha alcun fine, ma soddisfa solo il
bisogno infinito che lo sostanzia e che lo pone in essere sul piano dell’apparenza,
dove la ragione interviene, con le sue «ragioni sufficienti», nel tentativo di
giustificarlo e di dargli un senso più o meno ultimo. Da questo ingannevole
tentativo nascono le morali, gli ideali e i valori che la ragione impone come
doveroso realizzare. Dalla comprensione dell’insignificanza dell’agire, dall’aver
colto il suo significato strumentale e non finalistico, dalla sua assenza di senso, in
quanto mera esecuzione di una necessità, nasce quell’ideale di rinuncia e di ascesi
che per Schopenhauer è l’unico in grado di liberare l’uomo dal mondo.
La rinuncia non vuole la vita, ovvero quella trama di bisogni e soddisfazioni
che la ragione presenta come motivazioni e fini, disinserisce da quell’irrazionalità
dell’agire che non ha alcun senso, quindi dall’inganno e dalla volontà di
perpetrarlo. Chi non cerca più soddisfazioni è soddisfatto.
I nuovi concetti morali vengono quindi dedotti da questo nuovo punto di vista
che ai motivi sostituisce i quietivi, alla voluntas la noluntas che si sottrae a ogni
azione nel mondo perché torna solo a vantaggio della volontà di vita incurante
degli individui.
La prima via di liberazione indicata da Schopenhauer è la simpatia, che non
costituisce il legame dialettico, intramondano e storico, ma esattamente l’opposto;
essa rappresenta infatti il patire insieme (sim-patia, Mit-leid), l’annullamento di
qualsiasi interesse per il riconoscimento avvenuto dell’equivalenza del mondo del
bisogno e del dolore, dell’impotenza dell’agire, dell’inganno delle ragioni che lo
motivano. Una volta conosciuto nella volontà irrazionale l’esse che determina i
fenomeni della vita, non si produce più alcun inter-esse.
La simpatia non va confusa con l’amore che per Schopenhauer è la più
raffinata espressione dell’egoismo e della brama di possesso. La simpatia è
piuttosto partecipazione dell’uomo al dolore del mondo, per l’avvenuto
riconoscimento dell’identità della propria sorte con la sorte di tutti gli esseri
viventi. Il precetto regolativo della simpatia è quello indiano tat tvam asi = ciò sei
tu. In ogni essere del mondo, infatti, si rispecchia lo stesso dolore.
Partendo dal presupposto che «nessun oggetto della volontà, una volta
conseguito, può dare appagamento durevole, che più non muti; ma assomiglia solo
all’elemosina che, gettata al mendico, prolunga oggi la sua vita per continuare
domani il suo tormento» (Il mondo, § 38), Schopenhauer vede nella
contemplazione estetica, in quanto sguardo disinteressato al possesso della cosa, la
seconda via di liberazione dal giogo della volontà irrazionale e dalla trama del suo
inganno. L’arte, infatti, gioca col mondo; il suo operare non rispetta le regole della
ragione, non persegue valori né scopi, rompe la trama, è accadimento senza
sequenza. Tra le varie espressioni dell’arte, la più elevata è considerata la tragedia,
nella quale meglio si rivela l’intimo dissidio e la lotta della volontà con se stessa.
«Il dolore senza nome, l’affanno dell’umanità, il trionfo della perfidia, la schernevole signoria del caso, e il fatale precipizio dei giusti e degli innocenti vengono
dalla tragedia presentati in piena luce, e si ha così un significante indizio della
natura del mondo e dell’essere» (Il mondo, § 51).
Ma la liberazione dell’arte è temporanea e parziale. Più che una via d’uscita dal
giogo della volontà di vita è solo un conforto alla vita stessa. La via di liberazione
totale è perciò l’ascesi, dove la volontà non afferma più la propria essenza, ma la
rinnega: «L’ascesi è l’orrore dell’uomo per l’essere di cui è espressione il suo proprio fenomeno, per la volontà di vivere, per il nocciolo e l’essenza di un mondo
riconosciuto pieno di dolore» (Il mondo, § 68).
L’asceta cessa di volere la vita e perciò pratica la castità perfetta che libera
dalla prima e fondamentale manifestazione della volontà di vita che è l’impulso
alla generazione. Per Schopenhauer questo impulso domina tutte le forme
dell’amore sessuale che, per quanto elevato possa essere, è sempre sotto la spinta
degli interessi e delle esigenze della generazione. La scelta individuale dell’amore
non è mai individuale, perché è sempre della specie e nell’interesse della specie
che suscita innamoramenti e passioni per la sua continuità e prosperità. In ogni
rapporto, anche il più elevato, tra individui di sesso diverso non c’è per
Schopenhauer che «la mediazione del genio della specie sull’individuo possibile
mediante i due e sulla combinazione delle loro qualità» (Il mondo, § 44).
Astenersi da ogni pratica sessuale e più ampiamente da ogni soddisfazione —
perché si è riconosciuto che «nulla nel mondo esterno possiede valore» (Sul
fondamento della morale, p. 221) — rende perfetto il consumo del mondo che,
invece, risorge da ogni parziale consumazione compiuta dalla volontà che di
continuo promuove bisogni e soddisfazioni parziali. La continuità del processo
indica che ogni consumo puntuale non soddisfa, per cui si rinuncia alla
soddisfazione contingente e puntuale per raggiungere la soddisfazione totale, non
come calcolo utilitaristico, e quindi come nuovo prodotto della ragione calcolante,
ma come oltrepassamento della volontà, in quanto consumo parziale del mondo.
L’ascesi è la consumazione totale, come insignificanza del mondo non più
inseguito. Il nulla a cui si perviene è nulla per quanti cercano soddisfazioni nel
mondo, ma è pienezza per chi rinuncia all’idea di soddisfazione, dopo aver riconosciuto il nulla del mondo e aver rinunciato alla volontà ad esso. Qui è la
positività della rinuncia. Per coglierla è necessario un pensiero differente da quello
espresso dalla ragione occidentale che ha posto la sua realizzazione nel mondo; è
necessario un pensiero che sia in grado di cogliere l’aspetto positivo nella
nullificazione del mondo e il valore dell’agire in quell’agire che, consumandolo,
lo vanifica. Un simile pensiero è stato chiamato in Oriente avvicinamento al
Nirvana. Esso consiste nella radicale rinuncia alle soddisfazioni del mondo, nella
padronanza raggiunta nella sua nullificazione, nel disinter-esse che anima chi è
giunto al riconoscimento dell’insensatezza del suo esse. «Questo è per noi —
scrive Schopenhauer alla conclusione della sua opera — l’unico mezzo per
dissipare la lugubre impressione del nulla; di quel nulla che si delinea quale meta
finale in uno sfondo di là della santità e della virtù, e che temiamo come i fanciulli
temono le tenebre. Meglio così, che non illudere il nostro terrore, come fanno gli
indiani, i quali si appagano di miti e di parole vuote di senso, come ad esempio
l’assorbimento nel Brahma, o il Nirvana dei buddisti. Lo riconosciamo
francamente: per coloro che sono ancora animati dal volere, ciò che resta dopo la
totale soppressione della volontà è il vero e assoluto nulla. Ma, viceversa, per
coloro in cui la volontà si è convertita e soppressa, questo mondo così reale, con
tutti i suoi soli e le sue vie lattee, questo, propriamente questo, è il nulla» (Il
mondo, § 71).
Umberto Galimberti