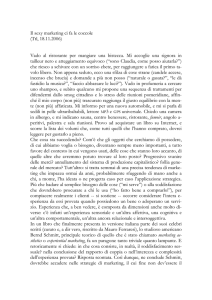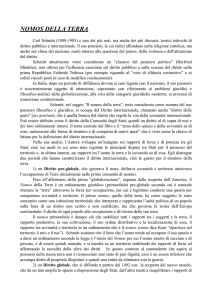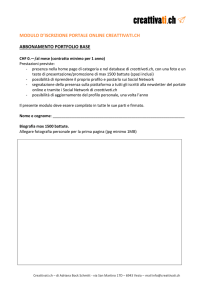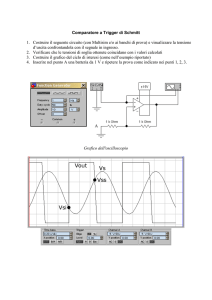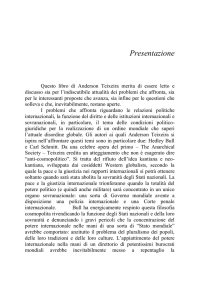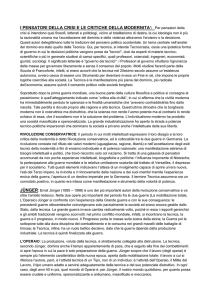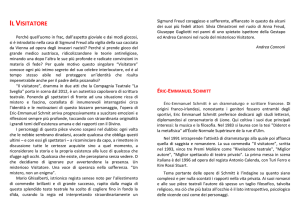Orientarsi dopo l’11 settembre:
dalla «instabilità semantica» alla genealogia della politica.
Alcune note su Carl Schmitt
Maurizio Guerri
«Tutto questo, e ciò che era stato e ciò che seguì
si svolse in un tal viluppo di rapidità, che passato,
presente e futuro parvero un attimo solo».1
1. Se volessimo rispondere in modo estremamente sintetico alla domanda quale è l’esigenza
fondamentale espressa da Jacques Derrida nel dialogo con Giovanna Borradori, potremmo dire che
l’idea fondamentale del filosofo francese è che l’evento dell’11 settembre richiede una risposta
filosofica radicale. Tale risposta apre però immediatamente a ulteriori interrogativi: che cosa
significa essere radicali, dare risposte filosofiche radicali? E ancora, è possibile nell’accelerando del
terrore e della sua spettacolarizzazione trovare la serenità per articolare ancora qualche parola
sensata? Nel suo intervento Derrida sostiene che è possibile e necessaria una risposta filosofica che
«rimetta in questione, nei fondamenti, i presupposti concettuali più essenziali del discorso
filosofico».2 E questo, spiega ancora Derrida significherebbe risvegliarsi dal «sonno dogmatico»,3
ovvero da quel complessivo adagiarsi del pensiero che fa sì che i filosofi si lascino trascinare
nell’uso di luoghi comuni che sono sfruttati incessantemente dal giornalismo e dalle
amministrazioni governative e che danno sempre e comunque per implicito e scontanto il
significato di «guerra» e «pace», di «democrazia» e «terrorismo». Ma per Derrida se vogliamo
cercare di comprendere l’evento dell’11 settembre dobbiamo abbandonare la tranquillizzante e
diffusissima convinzione che in queste parole vi sia qualcosa di scontato. Alcune minoritarie ma
assai significative voci nel dibattito che è seguito all’11 settembre hanno evidenziato, per esempio,
che il significato della parola «terrorismo», come quello di tante altre «nozioni giuridiche di
importanza cruciale» è poco chiaro, ma che nonostante in tali nozioni molto vi sia molto di «oscuro,
dogmatico o pre-critico», ciò «non impedisce ai poteri cosiddetti legittimi di servirsene quando
sembra loro opportuno».4
Dare una risposta radicale in senso filosofico davanti a Ground Zero significa in prima istanza
risvegliarsi da questo sonno dogmatico, da questa pseudofilosofia da un lato presa continuamente
dagli specialismi e persa nel funzionamento della macchina burocratica, dall’altra politicamente
inattiva, in ogni caso appiattita sui luoghi comuni dell’informazione e dell’amministrazione dei
mercati e delle genti, fino al punto di diventare ininfluente e insignificante anche per chi la pratica.
Il tentativo di Derrida è quello di fare un passo indietro e risalire alla domanda: che cosa significano
parole come «guerra» e «pace», «democrazia» e «terrorismo»? In che misura tali nozioni
rappresentano l’una la contrapposizione dell’altra? È proprio vero che là dove regna la pace non si
dà la guerra e che l’eliminazione del terrorismo passa per la diffusione planetaria della democrazia?
1
H. Melville, Benito Cereno, tr. it. di C. Pavese, Einaudi, Torino 1940-1994, p. 89.
J. Derrida, Autoimmunità, suicidi reali e simbolici, in G. Borradori (a c. di), Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen
Habermas e Jacques Derrida, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 108.
3
Ibid.
4
Ivi, p. 111.
2
Uno dei modi attraverso cui è possibile affrontare questo compito è confrontarsi con una
riflessione che inizi da quella che Derrida definisce una «lettura critica»5 di Carl Schmitt. Derrida
intende il termine critica in modo etimologico, riferendosi al suo senso di decisione: in un’epoca di
«instabilità semantica», di «irriducibile sconvolgimento della frontiera tra i concetti, di indecisione
dello stesso concetto di confine»,6 ovvero in un epoca caratterizzata dalla oscurità delle nozioni
occidentali di diritto e politica, bisogna tornare a decidere filosoficamente che cosa diritto e politica
sono. Ma questo è possibile solo cercando di capire a quali azioni le parole del diritto e della
politica si rapportino operativamente, ricostruendo il senso effettivo del discorso giuridico e
politico.
Quello che è un breve accenno di Derrida al pensiero di Carl Schmitt si rivela gravido di
conseguenze per il ragionamento del filosofo francese: possiamo ritrovare un senso nella confusione
concettuale o addirittura nella strumentalizzazione ideologica che caratterizzano il discorso
giuridico e politico del nostro tempo rivolgendoci criticamente al pensiero di Carl Schmitt.
L’eredità teorica di Schmitt, dunque, come una sorta di bussola che permette al filosofo che naviga
nelle tumultuose acque della globalizzazione di provare a riorientarsi. Bisogna allora cercare di
seguire la preziosa indicazione di Derrida e provare a comprendere come il pensiero di Schmitt
debba essere assunto, come sia possibile confrontarsi in modo attivo e fertile con la sua filosofia per
poter avvicinarci a una comprensione di quelle parole, «guerra» e «pace», «democrazia» e
«terrorismo», così spesso utilizzate e il cui senso ci appare sempre più poco chiaro, ambiguo,
oscuro. Attraverso questo tipo di confronto con il pensiero di Carl Schmitt è possibile andare con
Schmitt, oltre Schmitt. Questa decisione di andare oltre si rende necessaria – lascia intendere
Derrida – perché l’attacco alle Twin towers così come il war on terrorism dichiarato dal presidente
Bush non corrisponde in senso stretto a nessuna delle forme di conduzione della guerra descritte da
Schmitt. Eppure nonostante ciò il pensiero di Schmitt è considerato come un punto di partenza
imprescindibile per chiunque cerchi quella che Derrida chiama una «rifondazione del giuridicopolitico» e «attraverso di essa» una più generale «mutazione concettuale, semantica, lessicale e
retorica allo stesso tempo».7 Nel confronto a distanza con Jürgen Habermas appare chiaro, del resto,
che per Derrida la filosofia non può essere, come per il filosofo francofortese, semplice strumento
neutrale e obiettivo mediante cui l’uomo può intervenire in modo terapeutico sulla malattia
dell’Occidente, bensì la filosofia stessa non può che portare sul proprio volto i segni di quella
patologia da cui la modernità occidentale sarebbe afflitta. Anzi è proprio da qui che occorre iniziare.
2. Carl Schmitt (1888-1985) studiò alle università di Strasburgo, e Monaco (dove fu allievo di Max
Weber) e insegnò a Greifswald, Bonn e Berlino. Attivo politicamente negli ambienti reazionari
della Germania weimariana, accrebbe il proprio prestigio politico e accademico durante il
nazionalsocialismo dal quale ricevette incarichi ufficiali fino ad arrivare a essere il costituzionalista
più importante e influente. Ebbe intensi contatti con Ernst Jünger e Martin Heidegger. Alla fine
della Seconda guerra fu arrestato dalle truppe di occupazione alleate, venne incarcerato per tredici
mesi tra il 1945 e il 1946 e nuovamente arrestato nel 1947. Nel corso del secondo arresto fu
processato a Norimberga e costretto a difendersi dall’infamante accusa di crimini di guerra dalle
5
Ibid.
Ivi, p. 113.
7
Ibid
6
quali fu infine assolto.8 Dal 1947 si ritirò in quella che Schmitt amava definire la «sicurezza del
silenzio» nel piccolo villaggio natale dedito alla quiete degli studi.
Chiunque volesse cercare un ripensamento di carattere autobiografico da parte di Carl Schmitt
sul proprio rapporto con il nazionalsocialismo non troverà nulla; le parole scritte nella cella tra il
1945 e il 1947 sono una pietra tombale posta sulla questione:
Uno studioso che osserva dalla visuale storica vede se stesso entro la cornice e tra i flutti delle forze e
delle potenze storiche, Chiesa, Stato, partito, classe, professione e generazione. Un giurista che ha
educato se stesso e molti altri all’oggettività, evita gli egotismi psicologici. La propensione alle
confessioni e alle professioni di fede letterarie mi è un po’ interdetta da brutti esempi quali Jean-Jacques
Rousseau e il povero August Strindberg. Come esperto di diritto costituzionale, ho tuttavia in
costitutionalibus un compagno di destino assai interessante che in tema di confessioni personali e di
professioni di fede ha fatto cose stupefacenti, parlo del protagonista della dottrina liberale, Benjamin
Constant. [...] Ma nemmeno il suo esempio potrebbe indurmi a confessioni letterarie. Chi vuole
confessarsi, esca e vada dal parroco.9
Uno dei rari accenni di carattere autobiografico che ancora Schmitt si concede dopo la caduta
del nazismo è quello in cui il giurista tedesco paragona la propria condizione durante il regime
hitleriano a quella di Benito Cereno di Melville:10 un capitano in ostaggio dei passeggeri della
propria nave, costretto a fingere per aver salva la vita. Un’affermazione che apre a enormi
interrogativi: in che modo e fino a che punto è colpevole colui che obbedisce agli ordini di un
dittatore? In che senso Schmitt fu ostaggio del regime? Almeno qualche breve considerazione si
rende necessaria: diventare docente di diritto a Berlino e presidente dell’Associazione dei giuristi
tedeschi nello Stato nazionalsocialista, significa probabilmente qualcosa di più che aver
semplicemente eseguito degli ordini e aver cercato di assecondare il regime per aver salva la vita.
Forse più che essersi trovato nella situazione dell’ostaggio, Schmitt come tanti altri intellettuali
tedeschi tentò tragicamente di cavalcare la tigre nazionalsocialista contribuendo in modo attivo alla
costruzione e al funzionamento della più terrificante macchina statale di morte che l’Occidente
moderno abbia prodotto. Il rapporto o la collusione di filosofi e scrittori con i regimi dittatoriali
desta sempre interrogativi di grande rilevanza e del resto almeno dai tempi del viaggio di Platone
alla corte di Dionisio II di Siracusa la filosofia deve costantemente confrontarsi con il potere
politico, al punto che storicamente il senso della dottrina di un filosofo non può non prendere forma
anche in una particolare azione politica. Ripercorrendo la vicenda di Schmitt non possiamo che
riformulare gli inquietanti interrogativi che da sempre toccano il rapporto tra la teoria filosofica e le
decisioni politiche del suo autore: in che misura un grande pensiero può essere messo in discussione
in seguito alla adesione del suo autore a un regime dittatoriale? Fino a che punto l’adesione più o
meno convinta e spontanea a un movimento come il nazionalsocialismo da parte di un grande
8
Sono ora disponibili i testi degli interrogatori condotti da Robert Kempner e le autodifese di Schmitt: C. Schmitt,
Risposte a Norimberga, a c. di H. Quaritsch, tr. it. di F. Ferraresi, Laterza, Roma-Bari 2006.
9
C. Schmitt, Ex Captivitate Salus, tr. it. di C. Mainoldi, Adelphi, Milano 1987, pp. 78-79.
10
Carl Schmitt paragona la propria condizione a quella di Benito Cereno già nel 1941, come è testimoniato dal diario di
Ernst Jünger: «Parigi, 18 ottobre 1941. [...] Conversazione su una delle controversie scientifico-letterarie della nostra
epoca. Carl Schmitt si paragonò al capitano bianco dominato da schiavi negri del Benito Cereno di Melville, e citò poi il
detto: Non possum scribere contra eum qui potest me proscribere». (E. Jünger, Irradiazioni. Diario 1941-1945, tr. it. di
H. Furst, Guanda, Parma 1993, p. 44). Per la ricostruzione del rapporto tra Jünger e Schmitt è fondamentale il carteggio:
E. Jünger, C. Schmitt, Briefwechsel. 1930-1983, hrsg. H. Kiesel, Klett-Cotta, Stoccarda 1999.
filosofo o giurista può essere considerato come un semplice errore di valutazione che non inficia il
valore stesso della sua dottrina? Non è questa la sede per affrontare esaurientemente tale questione
cui tuttavia occorreva necessariamente almeno fare cenno, perché come ha osservato Carlo Sini a
proposito del coinvolgimento di Heidegger nella politica nazionalsocialista «pensieri elevati che
conducono a errori abissali non debbono essere messi esclusivamente sul conto delle circostanze
dell’umana fallibilità, ma debbono invece venire essi stessi almeno sospettati di una loro fatale
influenza su quegli errori».11
Un fatto importante e altrettanto degno di essere considerato, al pari dell’innegabile rapporto
tra Schmitt e il nazismo è l’ampia e profonda influenza del pensiero schmittiano su tanti autori
molto spesso legati a una azione politica radicalmente differente; basti ricordare solo qualche nome:
Walter Benjamin, Alexandre Kojève, Leo Strauss, Jakob Taubes, Michel Foucault oltre che Jacques
Derrida (si pensi, per esempio, a un testo come Politiques de l’amitié).12 Ancora oggi gli scritti di
Carl Schmitt sono sicuramente uno dei punti di riferimento teorico fondamentale sia per la teoria
del diritto internazionale che per la filosofia politica in generale.
Ma per quale ragione Schmitt è così importante e in che modo la sua rilevanza nella filosofia
politica, per certi versi, come mostra la riflessione di Derrida, tende ad accrescersi? Per quale
motivo Derrida si riferisce a Schmitt come a una possibilità per il pensiero filosofico oggi, perché
Derrida si rivolge agli scritti del giurista tedesco come all’inizio di un riorientamento del pensiero
nel suo complesso?
Per molti aspetti Schmitt incarna per la filosofia politica e per il diritto contemporaneo
qualcosa di analogo a ciò che Nietzsche ha rappresentato per il pensiero filosofico nel suo
complesso a partire dalla fine del XIX secolo. Come Nietzsche introduce una prospettiva
genealogica volta a decostruire le superstiziose ideologie morali, così Schmitt introduce nell’ambito
dei concetti politici del liberalismo e nella dottrina del diritto una prospettiva genealogica tale da
arrivare a mostrare effettivamente (ovvero operativamente) come tali concetti sono sorti, in che
modo esercitano il loro potere e come necessariamente sono giunti o giungeranno al loro tramonto.
Per usare una immagine nietzschiana potremmo dire che la filosofia politica di Carl Schmitt
rappresenta l’«acido nitrico» dei valori politici del liberalismo: a contatto con esso la loro funzione
ideologica si disvela, il valore di quei valori si dissolve e ciò che ne rimane è la loro genealogia, la
nuda struttura attraverso cui hanno potuto esercitare il loro potere.
3. Schmitt, dunque, sarebbe importante per Derrida e per noi oggi proprio in quanto genealogista
del diritto e della politica liberale. Occorre pertanto fare un minimo di chiarezza intorno al
significato della parola genealogia e dobbiamo allora rivolgerci necessariamente al pensiero di
Friedrich Nietzsche.
Nietzsche, come è noto, scrive le cristalline dissertazioni di cui si compone Zur Genealogie
der Moral in poche settimane nell’estate del 1887. Il tema in oggetto è appunto la genealogia della
morale. Si tratta essenzialmente di mettere a fuoco la seguente domanda: come emergono
11
C. Sini, Prefazione, in H. Ott, Martin Heidegger: sentieri biografici, tr. it. di F. Cassinari, SugarCo, Milano 1988, pp.
IV-V. Per affrontare il complesso rapporto di Heidegger con il nazismo è fondamentale il testo che raccoglie scritti,
interviste di Heidegger e riflessioni di filosofi e scrittori sul tema: M. Heidegger, Risposta. A colloquio con Martin
Heidegger, Guida, Napoli 1992.
12
Cfr. J. Deridda, Politiche dell’amicizia, tr. it. di G. Chiurazzi, Cortina, Milano 1995, soprattutto pp. 103-200. Un
importante accenno alla distinzione schmittiana «amico-nemico» in J. Derrida, Donare la morte, tr. it. di L. Berta, Jaca
Book, Milano 2002, pp. 132 e sgg. Alcune fondamentali considerazioni sul rapporto tra Deridda e Schmitt in C. Galli,
Genealogia della politca. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 751 e sgg.
(entstehen) nella storia del pensiero occidentale i concetti morali e, soprattutto, una volta che sono
sorti come arrivano a imporsi come valori? Nietzsche affronta questa domanda ricostruendo la
storia in senso genealogico delle parole «buono/malvagio», «colpa e cattiva coscienza» e «ideali
ascetici» che rappresentano rispettivamente i temi delle tre dissertazioni di cui si compone
Genealogia della morale.
Che cosa scopre Nietzsche? Scopre qualcosa di inquietante per la filosofia occidentale, ovvero
che se noi guardiamo in profondità strappando il velo ideologico dei valori morali, se noi non diamo
per scontato ciò che solitamente affidiamo al senso comune ovvero alla superstizione e al
pregiudizio, scopriamo che tutto ciò che il pensiero occidentale considera da sempre come sacro,
puro, limpido, ideale, in breve ciò che che si considera «valore morale» è in realtà profano, impuro,
torbido e concreto. Soprattutto i valori morali non sono, o meglio il loro essere non consiste
nient’altro che nel loro divenire. Dunque non divenire contro essere, ma essere ovvero divenire. Se i
valori sono in quanto divengono allora comprendere l’essenza dei valori consiste nel comprendere
la loro storia.
In questo senso possiamo dire che il vero come il buono sono relativi e in particolare sono una
finzione (nel senso etimologico di «plasmazione») umana. Se vogliamo capire che cosa i valori
morali sono, il che per Nietzsche equivale a comprendere come i valori operano (wirken), dobbiamo
accostarci a essi «in senso extramorale». Questo significa in primo luogo non stare ad ascoltare le
favole che essi ci raccontano – in primo luogo il loro auto-rappresentarsi come assoluti –, ma
ricostruire la loro storia per noi, attraverso il loro operare, mediante il modo secondo cui hanno dato
– e in alcuni casi continuano a dare – forma al mondo. La ricerca di Nietzsche, in breve, risponde a
una «nuova esigenza»:
Enunciamola questa nuova esigenza: abbiamo bisogno di una critica dei valori morali di cominciare a
porre una buona volta in questione il valore stesso di questi valori – e a tale scopo è necessaria una
conoscenza delle condizioni e delle circostanze in cui sono attecchiti, poste le quali si sono andati
sviluppando e modificando [...], non essendo esistita fino a oggi una tale conoscenza e non essendo stata
neppure soltanto desiderata. Si è preso il valore di questi «valori» come dato, come risultante di fatto,
come trascendente ogni messa in questione [...].13
Per Nietzsche non è più tempo per gli uomini di continuare a credere alla rappresentazione
che i valori danno di sé stessi, come se fossero verbo divino, principi trascendenti ogni messa in
questione. In Zur Genealogie der Moral Nietzsche si getta in una ricerca genealogica che lo porta a
dissodare il terreno della morale per portare alla luce le radici di quei concetti che si impongono
come valori. E quali sono queste radici?
Nella formazione dei valori morali non è in gioco alcun principio ideale e nemmeno materiale
il che significa che non esistono concetti o ideali eterni a cui la morale si ispiri, e nemmeno l’utilità
13
F. Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, tr. it. di F. Masini, Adelphi, Milano 1968-1984, pp. 8-9.
Della vastissima letteratura secondaria su Nietzsche mi limito a segnalare gli studi fondamentali a cui si è fatto maggior
riferimento nel presente saggio: F. Moiso, Morfologia e filosofia, in Annuario filosofico, 8, 1992, Mursia, Milano 1992;
S. Natoli, Nietzsche e la «Dialettica del tragico», in Id. Ermeneutica e genealogia. Filosofia e metodo in Nietzsche,
Heidegger, Foucault, Feltrinelli, Milano 1988; Id., Nietzsche retore e filosofo, in Teatro filosofico; Gli scenari del
sapere tra linguaggio e storia, Feltrinelli, Milano 1991; A. Orsucci, Genealogia della morale. Introduzione alla lettura,
Carocci, Roma 2001.
darwinianamente intesa può essere sensatamente assunto come un principio che domina nello
sviluppo dei valori morali.
Ma se né un principio ideale né un principio materiale possono essere considerati come
l’origine (Ursprung) dei valori morali, come questi valori morali sono sorti? Nietzsche osserva che
l’emergenza (Entstehung)14 delle nozioni di bene e male coincide con la storia di un gruppo di
uomini che si auto-definisce «buono», che decide di definirsi tale in base a una determinata
superiorità di potenza, estendendo l’esercizio di questa potenza ad ambiti sempre più ampi della
vita. Buono è colui che esercita e riconosce la propria potenza e quella dei propri simili e che
conseguentemente definisce il diverso, il nemico come «malvagio» con la conseguente fondazione
dell’idea di male.
Una particolare e contingente forma di potenza – nel caso specifico esaminato da Nietzsche la
preminenza in ambito bellico – si traduce in potere politico che a sua volta si ipostatizza in
superiorità spirituale fino alla creazione dell’ideale morale in sé. Dietro l’emergenza dei valori
morali c’è dunque l’esercizio di potere in uno specifico ambito che viene usato retoricamente fino a
imporsi come valore ideale, nel caso che interessa a Nietzsche come valore morale in sé:
Sono stati [...] gli stessi «buoni» vale a dire i nobili, i potenti, gli uomini di condizione superiore e di
elevato sentire ad aver avvertito e determinato se stessi e le loro azioni come buoni, cioè di prim’ordine, e
in contrasto a tutto quanto è ignobile e d’ignobile sentire, volgare e plebeo.15
Esemplare a questo proposito è la ricostruzione nietzschiana del termine latino bonus (da
ricollegare a bellum) che viene fatto derivare dall’arcaico duonus che è collegato a sua volta da
duellum. Il senso originario di bonus è da ricondurre alla auto-designazione della casta eroicocavalleresca: bonus è l’«uomo della disputa della disunione, come guerriero».16 Bonus è il modo in
cui la stirpe dei signori e dei conquistatori guerrieri decide di riconoscersi e di definirsi, perché
esercita la propria forza e il proprio potere distinguendosi dal malus. In sintesi: la storia del valore
del
bene
può
essere
originariamente
fatta
risalire
all’equazione
17
«buono=nobile=potente=bello=felice=caro agli dei».
La bontà morale, la nobiltà non sono niente altro che la trasformazione in senso ideale
dell’esercizio pratico della potenza in ambito bellico, la quale poi si amplia attraverso l’azione
politica e si consolida idealmente mediante l’istituzione del valore morale. La nascita di un valore
morale è dunque da ricondurre a un contingente rapporto di forza che viene retoricamente utilizzato
come valore assoluto, come valore in sé fino all’occultamento dell’Entstehung effettiva del
concetto.
La storia dei valori morali è dunque quanto di più concreto ci si possa immaginare: Nietzsche,
si è visto, parla esplicitamente della «bontà morale» come della «trasformazione in senso ideale
dell’esercizio pratico della potenza in ambito bellico». La metabasis eis allo genos che permette
all’esercizio pratico della potenza bellica di arrivare a istituirsi come valore assoluto è una creazione
retorica, dunque un fatto di carattere linguistico che si innesta su un azione amplificandone e
14
Particolarmente attento a queste scelte linguistiche di Nietzsche nella Genealogia della morale è Michel Foucault
nello studio Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., Microfisica del potere. Interventi politici, tr. it. G. Procacci e P.
Pasquino, Einaudi, Torino 1977, pp. 30 e sgg.
15
F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., p. 15
16
Ivi, p. 19
17
Ivi, p. 23.
mutandone il senso. Nell’emergenza dei concetti morali il linguaggio non è semplice strumento di
comunicazione, supporto materiale per contenuti spirituali prodotti altrove, bensì il linguaggio deve
essere concepito come la carne stessa dei valori, al tempo stesso anima e corpo dei valori. La
separazione dell’«io sono buono» dal «tu sei malvagio» (quello che Nietzsche chiama il Pathos der
Distanz) e i successivi passaggi retorici di questa distinzione fino all’istituzione del valore assoluto,
accade e si trasforma sempre all’interno della lingua. L’imporsi dei concetti morali in quanto valori
è un evento di carattere linguistico, una questione di metamorfosi delle parole.
Il pathos della nobiltà e della distanza [...] il perdurante e dominante sentimento fondamentale e totale di
una superiore schiatta egemonica in rapporto a una schiatta inferiore, a un «sotto» – è questa l’origine
dell’opposizione tra «buono» e «cattivo». (Il diritto signorile di imporre nomi si estende così lontano che
ci si potrebbe permettere di concepire l’origine stessa del linguaggio come un’estrinsecazione di potenza
da parte di coloro che esercitano il dominio: costoro dicono «questo è questo», costoro impongono con
una parola il suggello definitivo a ogni cosa e a ogni evento e in tal modo, per così dire, se ne
appropriano).18
Dunque, per noi oggi, parlare sensatamente di valori morali significa parlare della genesi dei
valori morali, la quale a sua volta è un episodio della storia della lingua. L’«imporre nomi» è infatti
il gesto originario del linguaggio e la nascita di un linguaggio è l’«estrinsecazione di potenza» da
parte di chi si trova nella condizione di esercitare il dominio. I valori morali sono costitutivamente
azioni linguistiche, ma la lingua a sua volta non risponde in alcun modo a criteri logici, non mira
alla Verità, né tanto meno risponde a universali ideali morali, perché è la lingua che crea le verità e
le morali attraverso il diritto di coniare nomi e di stabilire funzioni e ordinamenti la cui emergenza e
la cui storia effettiva è in primo luogo da ricondurre sempre a una storia di tipo linguistico: la
lingua, dunque, è più antica della morale.
A questo punto appare chiaro che chiunque intenda comprendere la wirkliche Historie (da
tradurre come la «storia effettiva», ma anche come «storia operativa», wirklich rimanda tanto a
Wirkung «effetto» quanto a Werk «opera») dei valori morali dovrà seguirne la metamorfosi
all’interno della lingua, perché i valori morali non sono altro che parole su cui si è impresso il senso
delle forme storiche attraverso l’esercizio di contingenti rapporti di forza i quali sono stati
cancellati o meglio sono stati retoricamente assunti come valori assoluti e dunque di di essi si è
occultata l’emergenza concreta. Per Nietzsche la lingua, anzi, meglio, le diverse lingue non sono
niente altro che la modalità diveniente eppure sempre conclusa attraverso cui gli uomini danno
forma al mondo, e in cui, dunque, si esprime effettivamente il tipo di rapporto che esiste tra l’uomo
e le cose, come si desume da un passo di Su verità e menzogna in senso extramorale:
Le diverse lingue, poste l’una accanto all’altra, mostrano che nelle parole non ha mai importanza la verità,
né un’espressione adeguata. In caso contrario non esisterebbero infatti così tante lingue. La «cosa in sé»
(la verità pura e priva di conseguenze consisterebbe appunto in ciò) è d’altronde del tutto inafferrabile per
colui che costruisce il linguaggio, e non è affatto degna per lui di essere ricercata. Egli designa soltanto le
relazioni delle cose con gli uomini e ricorre all’aiuto delle più ardite metafore per esprimere tali relazioni.
Uno stimolo nervoso, trasferito anzitutto in un’immagine: prima metafora. L’immagine è poi plasmata in
18
Ivi, p. 15. Una ripresa dell’«imporre nomi» come gesto iniziale del linguaggio in O. Spengler, L’uomo e la tecnica.
Contributo a una filosofia della vita, tr. it. di G. Gurisatti, Guanda, Parma 1992, pp. 57 e sgg.
un suono: seconda metafora. Ogni volta si ha un cambiamento completo della sfera, un passaggio a una
sfera del tutto differente e nuova.19
Non la verità, non l’adaequatio intellectus et rei sono ciò che domina teleologicamente il
processo linguistico. La lingua è poiesis retorica che esprime «le relazioni delle cose con gli
uomini». Questo passaggio da una metafora all’altra, questo continuo processo di traduzione da una
sfera della vita all’altra è ciò che accade anche nella formazione dei concetti morali. Per i valori
morali vale ciò che Nietzsche scrive a proposito di ogni tipo di verità in rapporto alla sua origine
linguistica:
Il trascurare ciò che vi è di individuale e di reale ci fornisce il concetto, allo stesso modo che ci fornisce la
forma, mentre la natura non conosce invece nessuna forma e nessun concetto e quindi neppure alcun
genere, ma soltanto una X, per noi inattingibile e indefinibile. [...] Che cos’è dunque la verità? Un mobile
esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state
potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo uso
sembrano a un popolo solide, canoniche, vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la
natura illusoria, sono metafore che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la
cui immagine si è consumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come
monete.20
Ogni tipo di verità ha una propria storia particolare, nasce come figura retorica volta ad
esprimere una particolare relazione umana che attraverso un potenziamento poetico finisce per
essere assunta come Verità solida e vincolante di cui si è resa irriconoscibile la natura poetica,
immaginifica, illusoria. Compito del genealogista è quello di risalire alla emergenza (Entstehung)
della illusione, cercare di riconoscere sul metallo della moneta le tracce dell’immagine che vi era
stata impressa, ormai divenuta pressoché irriconoscibile.
A proposito della prospettiva genealogica nietzschiana Salvatore Natoli ha scritto: «Da un
punto di vista genealogico, non è tanto l’adeguazione tra la forma ideale e il supposto riferimento
reale a dare conto della verità, ma la verità coincide con il campo di effettualità dell’idea stessa».21
Quindi la verità genealogica non mira all’«accertamento storico di una genesi», bensì tenta di
ricostruire la «genesi del punto di vista che vuole accertare».22 Qui sta la differenza tra la
storiografia classica e il metodo genealogico: la storiografia mira a una rappresentazione adeguata
di una supposta realtà, arretrando nel passato alla ricerca dell’origine (Ursprung), del reale inizio.
Comprendere genealogicamente significa descrivere le modalità attraverso cui una determinata idea
è stata storicamente efficace.
Perché la prospettiva genealogica sia possibile è necessario che lo sguardo dell’osservatore
appartenga a quella fase di una Kultur denominata da Nietzsche Zeitalter des Vergleichens l’«età
del confronto»23 in cui tutto appare «divenuto» e ogni forma, staccata dalla tradizione vivente
19
F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, in Id. La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e scritti
1870-1873, tr. it. di G. Colli, Adelphi, Milano 1973-1991, p. 231.
20
Ivi, p. 233.
21
S. Natoli, Nietzsche retore e filosofo, in Id., Teatro filosofico. Gli scenari del sapere tra linguaggio e storia,
Feltrinelli, Milano 1991, p. 102.
22
Ivi, p. 103.
23
F. Nietzsche, Umano troppo umano, tr. it. di S. Giametta, Adelphi, Milano 1965-1979, vol. I, a. 23, p. 32 (tr. it.
modificata).
diventa riproducibile e comparabile. In questa condizione qualsivoglia fenomeno non è più
riconducibile a una radice fissa, a una origine reale:
Non vogliono capire che l’uomo è divenuto e che anche la facoltà di conoscere è divenuta; mentre alcuni
di loro si fanno addirittura fabbricare, da questa facoltà di conoscere l’intero mondo. [...] Tutta la teologia
è basata sul fatto che dell’uomo degli ultimi quattro millenni si parla come di un uomo eterno, al quale
tendono naturalmente dalla loro origine tutte le cose del mondo. Ma tutto è divenuto; non ci sono fatti
eterni: così come non ci sono verità assolute. Per conseguenza il filosofare storico è d’ora in poi
necessario e con esso la virtù della modestia.24
La genealogia è quel particolare sguardo di tipo storico che si impone quando le forme
culturali divengono tutte comparabili: ciò rende non più credibile un pensiero che si fondi sulla
scissione tra mutevolezza del fenomeno e stabilità della cosa in sé, sull’adaequatio intellectus et rei.
Non è più possibile ricondurre le cose alla loro Origine. Michel Foucault in Nietzsche, la
genealogia e la storia (1971) mette in evidenza un aspetto fondamentale della prospettiva
genealogica:
Ponendo il presente all’origine (Ursprung), la metafisica fa credere al lavoro oscuro d’una destinazione
che cercherebbe di farsi strada fin dal primo momento. La genenalogia, al contrario, [puntando lo sguardo
sulla Entstehung] ristabilisce i diversi sistemi di asservimento: non la potenza anticipatrice d’un senso, ma
il gioco casuale delle dominazioni.25
Non un’origine vera, non una «destinazione» di tipo teleologico o escatologico regge il
processo storico, ma la vicenda «casuale» della lotta, il gioco dei rapporti di dominazione. Se per la
storiografia classica l’origine sta nell’inizio materiale, nel passato oggettivo, per la genealogia
l’inizio è spostato nel presente, nel senso che l’atto conoscitivo assume su di sé e prende sul serio
fino in fondo la condizione di illimitata riproducibilità e comparabilità dei fenomeni.
Ricapitolando, vediamo quali sono gli elementi fondamentali della prospettiva genealogica di
Nietzsche: la forma (il valore morale, nel caso considerato da Nietzsche) che subisce metamorfosi e
si trasforma è nel suo divenire (essere e divenire coincidono) e in particolare per quanto concerne i
concetti di bene e male morale (Gut und Böse) la forma può essere compresa nella
Entstehungsgeschichte des Denkens la «storia della emergenza del pensiero»26 e si configura come
decisione e interpretazione dello spettro semantico dei termini, come genealogia semantica del
linguaggio. In altri termini, dire che cosa bene e male sono, significa essere in grado di dire come
queste forme divengono, cioè che cosa significano operativamente: io posso fare ciò ripercorrendo
la Begriffs-Verwandlung la «metamorfosi concettuale» che è depositata nel processo di continua
deformazione del significato delle parole.
Evidentemente non è per noi rilevante la correttezza delle analisi di Nietzsche relative alla
storia delle parole Gut e Böse, ma rilevantissimo è il lascito filosofico di questo gesto: è eliminata la
contrapposizione apriori aposteriori e forma contenuto; Nietzsche afferma che la storia dei concetti
consiste di un puro divenire di configurazioni linguistiche che sono dotate di contenuto e non
24
Ivi, vol. I, a. 2, p. 16.
M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Id., Microfisica del potere, cit., p. 38.
26
F. Nietzsche, Umano troppo umano, cit., vol. I, a. 16, p. 27 (tr. it. modificata).
25
riconducibili a un Grund ultimo e che esse sono solo comparabili in quanto divenienti. In
conclusione le forze che sono in gioco nella storia non obbediscono né a una destinazione di
carattere spirituale, né ad una meccanica leggibile scientificamente, ma piuttosto alla casualità del
conflitto, con il risultato che la parte vittoriosa sarà portatrice di un sapere che è letteralmente un
prendere posizione, l’esercizio di una forma di potere e con ciò un’imposizione di un sistema di
valori.
4. Schmitt scopre qualcosa di altrettanto «urtante all’orecchio» – per dirla con le parole di Nietzsche
– a proposito della genealogia della politica. Tutte le nozioni del diritto e della politica osservate
secondo una prospettiva genealogica non costituiscono dei valori né rinviano a ideali universali, ma
appaiono come concetti che emergono sul terreno di contingenti rapporti di forza. Che Schmitt
interpreti in modo genealogico le principali nozioni del pensiero politico e giuridico è ben visibile, a
partire proprio da uno dei suoi saggi più importanti e noti Der Begriff des “Politischen” (1927).27 In
questo scritto tanto sintetico quanto denso e problematico per lo stesso autore – al punto da essere
sottoposto a numerose revisioni e riformulazioni fino al 1963 –, la parola politica die Politik viene
ricondotta al neutro di un aggettivo politisch. Con ciò Schmitt intende affermare che dietro a ciò che
sono le forme storicamente determinate della politica non vi sono sostanze rette da principi razionali
o materiali, ma rapporti di forze in continua metamorfosi. Il politico, oltre a questo divenire di
storicamente determinati rapporti di forza è nulla. Il politico non è retto da alcuna sostanza
razionale o da ragioni di carattere ideale o utilitaristico, ma è qualcosa di contingente e concreto che
per essere compreso deve poter venir ricondotto genealogicamente alla propria storia effettuale.
Analogamente alla prospetiva genealogica sviluppata in ambito morale da Nietzsche, anche per
Schmitt abbiamo bisogno primariamente di interrogarci sulle parole della politica e del diritto,
perché in esse sono stratificate le modalità secondo le quali si sono formate e trasformate le idee e i
valori della politica e del diritto. La prospettiva genealogica mostra come l’universalità e il
fondamento dei concetti della politica e del diritto sono annullati, ridotti a visione particolare,
riportati alla loro rispettiva emergenza sul terreno dei concreti rapporti di forza.
Nella nuova prefazione del 1963 al Concetto di politico Schmitt osserva che rispetto agli anni
in cui il saggio è stato scritto, continua ad aumentare la distanza tra «l’impiego ufficiale dei concetti
classici» nel campo del diritto internazionale e la «realtà effettiva» degli scopi e dei metodi verso
cui sono rivolti. Uno dei problemi fondamentali, come scrive Schmitt, è che i «nuovi tipi e metodi
di guerra contemporanea costringono a una continua riflessione sul fenomeno delle ostilità».28
L’esigenza di condurre questa «continua riflessione intorno al fenomeno delle nuove ostilità» in
modo genealogico è comprensibile nella consapevolezza schmittiana della sempre maggiore frattura
che si apre tra l’«impiego ufficiale dei concetti classici» della politica e del diritto e i fenomeni che
mediante essi sono descritti. Ciò che accade operativamente nella politica a partire dai rapporti tra
nazioni quell’ambito della vita dello Stato che era regolamentato dallo jus publicum Europaeum con
lo scoppio della Prima guerra mondiale sembra fuoriuscire dalle forme descritte dalle regole del
diritto internazionale e diviene incontrollabile e imprevedibile per la dottrina del diritto.
27
Sul complesso rapporto tra Schmitt e Nietzsche si vedano in primo luogo le illuminanti riflessioni di Carlo Galli,
Genealogia della politica, cit., pp. 123 e sgg.
28
C. Schmitt, Il concetto di “politico”, in Id., Le categorie del “politico”. Scritti di teoria politica, a c. di G. Miglio e P.
Schiera, tr. it. di P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, p. p. 99.
Ma che cos’è il politico per Schmitt? Secondo Schmitt la scienza della politica e la scienza del
diritto fondano la definizione della politica su un circolo vizioso: «In generale», scrive Schmitt,
«“politico” viene assimilato, in una maniera o nell’altra, a “statale” o quanto meno viene riferito
allo Stato. Allora lo Stato appare qualcosa di politico, ma il politico come qualcosa di statale: si
tratta manifestamente di un circolo vizioso».29 Le scienze che si occupano della politica tendono a
dare per presupposto e scontato «in modo non problematico uno Stato già esistente, nel cui ambito
si muovono»30 e a elaborare concetti e definizioni settoriali, senza mai poter porre in questione la
nozione di Stato, né tanto meno quella di politico. Tutte le definizioni settoriali rispondono ai
problemi del lavoro giuridico, ma non mirano mai «a definizioni generali del “politico”».31 Per
Schmitt è possibile «raggiungere una definizione concettuale del “politico” solo mediante la
scoperta e la fissazione delle categorie specificamente politiche».32 Per comprendere ciò che è il
“politico” bisogna arrivare a «qualche distinzione di fondo alla quale può essere ricondotto tutto
l’agire politico in senso specifico».33 Così come, per esempio, «sul piano morale le distinzioni di
fondo» sono rappresentate nella coppia «buono cattivo» e sul piano estetico da quelle di «bello e
brutto», su quello economico da «utile e dannoso oppure redditizio e non redditizio», sul piano
politico la distinzione fondamentale è quella tra Freund (amico) e Feind (nemico): «La specifica
distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici, è la distinzione di
amico [Freund] e nemico [Feind]. Essa offre una definizione concettuale, cioè un criterio, non una
definizione esaustiva o una spiegazione del contenuto».34
Occorre non lasciarsi ingannare dalle intenzione apparentemente essenzialistica di Schmitt.
Come ha osservato Carlo Galli, infatti, è importante sottolineare che «attraverso il “politico”
Schmitt non vuole determinare l’essenza della politica, dato che [...] nel “politico” c’è piuttosto la
scoperta della mancanza di essenza – e quindi di stabilità – di ogni ambito della vita associata».35 E
in effetti, continua Galli,
è alla modernità che la teorizzazione del “politico” di fatto si riferisce. [...] Proprio il fatto che non ci sia
una definizione dell’amico, in Schmitt, e che il punto di partenza dell’argomentazione sia il nemico,
significa appunto questo, che nel “politico” si pensano non le gerarchie e i rapporti politici personali
premoderni (le “amicizie”) ma la disordinata uguaglianza moderna (l’inimicizia) e la Herrschaft
impersonale ma al contempo decisionistica che ne è resa necessaria; insomma, che il “politico” implica la
fine della politica “ben fondata” (e in ciò è all’origine del Moderno).36
Che l’intento essenzialistico in Schmitt sia solo apparente lo si può comprendere dalle parole
che abbiamo citato in apertura di questo paragrafo: la domanda che cos’è il politico muove dalla
consapevolezza della insanbile frattura tra teoria politica e prassi della guerra, dell’abisso che si è
aperto tra «impiego ufficiale dei concetti classici» e il «fenomeno delle nuove ostilità». Come in
Nietzsche l’Entstehung della conoscenza genealogica in ambito morale è costituito dalla non
credibilità per noi oggi della eternità e stabilità dei valori morali imposta dalla illimitata
29
Ivi, p. 102.
Ivi, p. 103.
31
Ivi, p. 105.
32
Ivi, p. 108.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 742.
36
Ibid.
30
riproducibilità degli stili, analogamente per Schmitt la genealogia della politica inizia con la
consapevolezza della effettiva crisi delle istituzioni giuridiche e dei concetti fondamentali della
politica liberale nel loro complesso. Questa crisi si mostra indubbiamente su un piano storicopolitico (l’ordine normativo razionale e trasparente sfocia nella catastrofe della Prima guerra
mondiale, la gloriosa via verso il progresso si converte nella distruttività bellica della tecnica
moderna, l’illuminata spazialità politica moderna conduce nell’inferno della trincea), ma anche su
un piano logico-teorico (la scarsa tenuta o il tracollo delle categorie giuridiche e politiche classiche
nel tentativo di razionalizzare ciò che accade nella effettiva esperienza dei rapporti intra-statali e
inter-statali). L’atteggiamento di Schmitt dinanzi all’offuscarsi o al cedimento delle istituzioni
chiare e distinte dell’Europa (la distinzione tra Stato e società, tra pubblico e privato, tra diritto e
politica, tra pace e guerra e la fuoriscita del fenomeno bellico da quella che lo jus publicum
Europaeum definiva come guerre en forme) è profondamente diverso da quello di un Hans Kelsen:
il giurista austriaco muove, come Schmitt, dalla constatazione della irrisolvibile spaccatura che
separa politica statuale e spazialità la quale determina una crisi di sovranità politica; tuttavia tale
crisi lungi dal rappresentare il tramonto della politica moderna, segna uno passaggio di carattere
evolutivo verso la costruzione di un «universalismo giuridico post-statuale, indifferente allo spazio
empirico, che espressamente richiama l’ideale, ora reso “scientifico”, della civitas maxima di
Kant».37
Per Schmitt invece, come ha osservato Galli, il politico deve essere pensato come un «lato
dell’origine»:
in quanto è un “concreto” vuoto di sostanza ma carico di energia eccezionale, il “politico” è
l’immediatezza dell’eccezione. E quindi il politico nega originariamente non solo la politica “ben
fondata” premoderna, ma anche l’artificio statuale moderno, la mediazione razionale, rispetto alla quale si
costituisce come una sorta di “stato di natura” [...] mai pienamente superabile in un ordine artificiale.38
Come si legge in Teoria del partigiano (1963) – che costituisce come recita il sottotitolo una
Integrazione al concetto del Politico – il politico «non è l’inimicizia pura e semplice, bensì la
distinzione fra amico e nemico, e il presupporre l’amico e il nemico».39 Ovvero: la storia della
politica moderna è retta dalla metamorfosi del processo di auto-identificazione di una collettività
mediante il conflitto tra amico e nemico. La storia del politico è costituita dalla trasformazione del
senso del conflitto amico-nemico su cui si fonda la capacità di una collettività di riconoscersi in
quanto tale. In questo senso il politico da una parte non può essere inteso come mero caos
distruttivo, «inimicizia» che tutto divora, d’altra parte il formarsi della collettività di «amici»
avviene attraverso l’esclusione di ciò che si definiscono come «nemici». L’identità del Noi è
fondata sulla esclusione dell’Altro. Il «nemico» deve essere allontanato all’esterno o neutralizzato
all’interno della collettività. Quella «“tranquillità, sicurezza e ordine”»40 che sono il «presupposto
perché le norme giuridiche possano aver vigore» e su cui dunque poggia la vita «normale»41 di una
37
C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, Il Mulino, Bologna 2001, p. 121. Sul rapporto tra spazialità
politica e universalismo giuridico post-statuale cfr. soprattutto H. Kelsen, Il problema della sovranità, tr. it. di A.
Carrino, Giuffrè, Milano 1989.
38
C. Galli, Genealogia della politica, cit., pp. 743-44.
39
C. Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico, Adelphi, Milano 2005, p. 127.
40
C. Schmitt, Il concetto di “politico”, in Id., Le categorie del “politico”, cit., p. 130.
41
Ibid.
collettività organizzata in Stato, emerge dal conflitto: il Noi esiste solo in virtù del riconoscimento,
della separazione e della esclusione dell’Altro. Come ha osservato Galli, attraverso il politico
«Schmitt vuole superare l’identità tautologica del moderno razionalismo politico: il “nemico” in
verità è l’Altro in noi, è la nostra stessa esistenza nel suo lato tragico e al contempo energetico;
l’Estraneo è il Prossimo, ovvero, per usare le parole di Rilke, “Feindschaft ist uns das Nächste”».42
L’idea liberale di politica, la concezione borghese di sicurezza sono decostruite e destituite di
fondamento: l’identità politica esiste solo mediante l’identificazione di un nemico e
successivamente alla sua esclusione. Noi ci siamo politicamente perché abbiamo escluso l’Altro. La
nostra stessa identità dunque deriva dall’esclusione, poggia continuamente sulla figura di ciò che è
stato definito come nemico. L’ordine giuridico-politico (l’amicizia) non viene fondato sul
trasparente riferirsi a sé della collettività, ma è una deriva del conflitto.
La formazione statale non è originariamente una costruzione astratta, l’esito della Vermittlung
razionale e sempre presente a se stessa, ma è costitutivamente emersa dalla concreta decisione e
separazione conflittuale fra amico e nemico. La vita normale della collettività statale si basa certo
sulla neutralizzazione del conflitto attraverso l’organizzazione e l’ordinamento dello Stato, ma tale
neutralizzazione non è mai stata né potrebbe essere assoluta, proprio perché il politico per emergere
concretamente deve aprire il conflitto e da esso trarre continuamente energia. Questa condizione di
tragicità irrisolvibile su cui la vita del politico si basa è allo stesso tempo il limite della formazione
politica statale, ma anche l’unica dimensione possibile della sua esistenza. «L’amicizia – l’ordine –
che pure è originariamente prevista da Schmitt a costituire il politico», scrive Galli, «non è dunque
il quieto riposare in sé dell’oggettivo riferirsi a sé del soggetto collettivo, ma è percorsa dall’ostilità:
amicizia e ostilità sono due modi della medesima immediatezza – dell’eccezione e della
contingenza –. E la decisione e l’esclusione, che li uniscono e al contempo li dividono, mostrano
come si coappartengono proprio mentre si respingono».43 Dunque l’ordine del diritto non ha bisogno
di diritto per essere ciò che è, il che equivale a dire che la universalità dei concetti giuridico-politici
vive della contingenza dei rapporti di forza che ne ha decretato la nascita.
Un ulteriore elemento tragico su cui il diritto poggia e di cui continuamente si alimenta è
individuato da Schmitt nella «sovranità» e nella sua relazione costitutiva con l’«eccezione». Anzi,
potremmo dire meglio che parlando della sovranità e dell’eccezione non ci troviamo di fronte a
un’altra separazione tragica oltre a quella della esclusione o del conflitto come emergenza del
conflitto, perché come ha osservato Giorgio Agamben, l’«eccezione» non è che «una specie
dell’esclusione»,44 di quel tipo di conflitto che abbiamo visto segnare l’emergenza del rapporto
amico-nemico come gesto iniziale del “politico”. Schmitt nello scritto Politische Theologie, Vier
Kapitel zur Lehre der Souveranität (1922-1934) osserva che «una giurisprudenza orientata alle
questioni della vita di ogni giorno e degli affari ordinari non ha alcun interesse al concetto di
sovranità. Per essa è normale solo ciò che è conoscibile e tutto il resto è “disordine”».45 Il tema
centrale del saggio schmittiano è invece proprio la «sovranità», da intendersi secondo la frase con
42
C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 750. La citazione del verso rilkiano è tratta dalla Quarta Elegia (R. M.
Rilke, «Quarta Elegia», in Id. Elegie Duinesi, tr. it. di E. De Portu e I. De Portu, Einaudi, Torino 1978, vv. 9-11): «Uns
aber, wo wir Eines meinen, ganz, | ist schon des andern Aufwand fühlbar. Feindschaft | ist uns das Nächste». «Ma noi,
quando intendiamo una cosa, e null’altro, | l’altro già lo avvertiamo, e sensibilmente. L’inimicizia | ci è prossima più di
ogni altra cosa.» (tr. it. modificata).
43
C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 751.
44
G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995-2005, p. 21.
45
C. Schmitt, Teologia politica, in Id., Le categorie del “politico”, cit., p. 38
cui si apre lo scritto: «Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione [Ausnahmezustand]».46 La
questione che Schmitt si pone da un punto di vista giuridico è la seguente: esiste l’istituto giuridico
dello «stato d’eccezione» o del «caso d’eccezione» che a differenza di altri casi estremi come la
guerra esterna e lo stato d’assedio interno non sono né prevedibili né preventivamente
regolamentabili, il che, quando correttamente interpretata, comporta, come scrive Galli, «la
sospensione o l’abrogazione dell’ordinamento giuridico, mentre lo Stato come energia politica
ovvero come sovranità, continua a sussistere in virtù del proprio “diritto di autoconservazione”».47
La eccezionalità dello stato di eccezione consiste nel fatto che tale stato «è ancora qualcosa di
diverso dall’anarchia e dal caos», infatti «dal punto di vista giuridico esiste ancora in esso un
ordinamento, anche se non si tratta più di un ordinamento giuridico. L’esistenza dello Stato
dimostra qui un’indubbia superiorità sulla validità della norma giuridica».48 Ora tutta la questione è
cruciale nel pensiero schmittiano per comprendere l’emergenza stessa dell’ordinamento giuridico e
la provenienza dell’autorità statale rimanendo comunque in un ambito «accessibile alla conoscenza
giuridica»:49
L’eccezione è ciò che non è riconducibile; essa si sottrae all’ipotesi generale, ma nello stesso tempo rende
palese in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione. [...] La norma ha
bisogno di una situazione media omogenea. Questa normalità
di fatto non è semplicemente un
«presupposto esterno» che il giurista può ignorare; essa riguarda invece direttamente la sua efficacia
immanente. Non esiste nessuna norma che sia applicabile a un caos. Prima deve essere stabilito l’ordine:
solo allora ha un senso l’ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui
che decide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero. Ogni diritto è «diritto
applicabile a una situazione» Il sovrano crea e garantisce la situazione come un tutto nella sua totalità.
Egli ha il monopolio della decisione ultima. In ciò sta l’essenza della sovranità statale, che quindi
propriamente non dev’essere definita giuridicamente come monopolio della sanzione o del potere, ma
come monopolio della decisione [...]. Il caso d’eccezione rende palese nel modo più chiaro l’essenza
dell’autorità statale.50
Schmitt afferma che lo stato d’eccezione in virtù della propria eccezionalità mostra
l’emergenza della «situazione normale». Infatti sovrano è colui che in base a un determinato
ordinamento giuridico ha il potere di dichiarare lo stato d’eccezione e di sospendere il normale
funzionamento dell’ordinamento giuridico; in questo senso, scrive Schmitt, il sovrano «sta al di
fuori dell’ordinamento giuridico e tuttavia appartiene a esso, perché spetta a lui decidere se la
costituzione in toto possa essere sospesa»51 L’emergere della sovranità sta dunque nella decisione
sul caso eccezionale. Ma questo significa che nel suo complesso l’ordinamento è a completa
disposizione di chi decide al punto che il sovrano non è semplicemente il rappresentante superiore
di un ordinamento, ma il suo stesso creatore. La forma giuridica e l’ordine giuridico sono creati da
chi detiene la sovranità, ovvero da chi decide sul caso d’eccezione: dunque l’ordine trae vita dal
disordine, la norma generale è generata dall’eccezione. Non solo: questo «agire abissale» – come è
46
Ivi, p. 33.
C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 335.
48
C. Schmitt, Teologia politica, in Id. Le categorie del “politico”, cit., p. 39.
49
Ibid.
50
Ivi, pp. 39-40.
51
Ivi, p. 34.
47
stato definito da Galli – del creatore (del sovrano), non si dà solo inizialmente, ma «anzi il disordine
e l’eccezione restano, all’interno dell’ordine, come potenzialità sempre presenti».52 Anzi: «il
permanere indeterminante del disordine e della contingenza – della crisi – all’interno dell’ordine
esige e rende necessaria la sovranità che è quindi la funzione attraverso la quale un ordine
contingente si determina e si autointerpreta».53 L’ordine è un sistema razionale e ordinato, ma che
poggia continuamente sull’assenza di razionalità e di ordine, tragicamente esposto all’eccezione, al
Nulla della propria emergenza. La sovranità in quanto eccezione alimenta di continuo la macchina
razionale del diritto, pur non avendo alcun fondamento razionale.
Agamben ha osservato che spesso nel pensiero contemporaneo è stato osservato come
l’ordinamento giuridico-politico «abbia la struttura di una inclusione di ciò che è, insieme, respinto
fuori».54 A tal proposito Agamben ricorda alcuni passi esemplari di Deleuze di Blanchot e di
Foucault.55 Ma tuttavia bisogna sottolineare la peculiarità della struttura della sovranità nella lettura
schmittiana:
Ciò che è fuori viene qui incluso non semplicemente attraverso un’interdizione o internamento, ma
sospendendo la validità dell’ordinamento, lasciando cioè, che esso si ritiri dall’eccezione, l’abbandoni.
Non è l’eccezione che si sottrae alla regola, ma la regola che, sospendendosi, dà luogo all’eccezione e
soltanto in questo modo si costituisce come regola, mantenendosi in relazione con quella. Il particolare
“vigore” della legge consiste in questa capacità di mantenersi in relazione con una esteriorità. Chiamiamo
relazione di eccezione questa forma estrema della relazione che include qualcosa unicamente attraverso la
sua esclusione».56
Non solo l’emergere della legge ma lo stesso normale vigore della legge, il suo regolare
funzionamento dipende dalla sospensione della legge interna alla legge stessa, sospensione che è
sempre operativa attraverso quel peculiare tipo di relazione che è la relazione di eccezione. In
questo senso l’eccezione sovrana è, scrive Agamben
la localizzazione (Ortung) fondamentale, che non si limita a distinguere ciò che è dentro e ciò che è fuori,
la situazione normale e il caos, ma traccia fra di essi una soglia (lo stato di eccezione) a partire dal quale
interno ed esterno entrano in quelle complesse relazioni topologiche che rendono possibile la validità
dell’ordinamento. L’ordinamento dello spazio, in cui consiste per Schmitt, il Nomos sovrano, non è
pertanto, solo «presa della terra» (Landnahme), fissazione di un ordine giuridico (Ordnung) e territoriale
(Ortung), ma innanzitutto «presa del fuori», eccezione (Ausnahme).57
L’ordine politico emerge dal conflitto e pur neutralizzandolo lo conserva in sé tanto che il
gesto sovrano per eccellenza non consiste nel creare le norme finalizzate alla pace e all’ordine, ma
nel sospendere quello stesso sistema normativo, con una decisione che svela come la presenza
dell’eccezione (ovvero dell’anormalità e del conflitto) sia interna e connaturata all’ordine stesso. La
politica e il diritto non sono mai razionale esclusione del conflitto, sia la politica che il diritto dal
52
C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 339
Ibid.
54
G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 22
55
Cfr. ivi, pp. 22 e sgg.
56
G. Agamben, Homo sacer, cit., p. 22
57
Ivi, p. 23.
53
conflitto sorgono e del conflitto vivono. La politica nel suo complesso non è solo ordine e norma in
funzione della pace, ma anzi fin dall’inizio emerge come atto conflittuale, quale coappartenersi
inscindibile di pace e guerra. È la perenne possibilità del conflitto che con la sua decisione il
sovrano (sia esso un singolo o una collettività) di volta in volta rende attuale sia all’esterno
dell’ordine statale che all’interno.
Ora credo si possa almeno iniziare a comprendere per quale ragione il pensiero di Schmitt
rappresenti per Derrida un momento di riflessione decisivo e ineludibile per il suo pensiero e per
chiunque intenda interrogarsi oggi sulla questione della guerra: il conflitto e la guerra non sono
errori o malattie che insidiano dall’esterno l’illuminata e pacifica costruzione politica del mondo
occidentale, ma sono contenuti fin dall’inizio all’interno di ogni ordinamento politico e giuridico. In
particolare Schmitt cerca di mostrare come la moderna neutralizzazione politico-giuridica della
guerra sia sempre stata parziale e incompleta e che non possa che essere così. La patologia che
affligge l’Occidente non è una malattia che colpisce dall’esterno la sana costituzione
dell’Occidente, ma viene dal suo stesso interno, è un elemento costitutivo della organizzazione
giuridico-statale; potremmo dire, semplificando con un paradosso, che è la natura particolare di
questa malattia che ha reso possibile per secoli la vita sana dell’Occidente. La crisi che ha colpito
l’organizzazione giuridico-politica dell’Occidente e che percorre ora l’intero globo occidentalizzato
nel suo complesso è ciò che ha permesso allo stesso Occidente per lungo tempo la sua vita statale
illuminata, regolamentata, civile. Ma allora se questa è la genealogia della politica occidentale ha
ancora senso parlare della dimensione globale della violenza come di una “patologia”?
5. La storia dello jus publicum Europaeum è la storia concreta della «regolamentazione e una
relativizzazione dell’ostilità»58 e «ogni relativizzazione delle ostilità costituisce un grosso progresso
in senso umanitario»,59 ma tale progresso dalla Prima guerra mondiale l’Occidente se lo è lasciato
alle spalle.
Schmitt in Der Nomos der Erde (1950) e in Land und Meer (1942-1954) ricostruisce questo
frangente della vita politica moderna mostrando come il sistema degli Stati dello jus publicum
Europaeum rese possibile una limitazione della guerra non in virtù di un astratto universalismo
razionalistico o di un libero accordo fra i contraenti del “contratto sociale”, ma grazie a concrete
condizioni strutturali, a contingenti rapporti di potere, dei quali occore ricordare ora almeno gli
elementi più importanti: la scoperta degli spazi liberi delle Americhe e la loro conquista da parte
delle potenze coloniali, l’equilibrio fra potenze di terra e mare, fra continente e Inghilterra. Di qui
una serie di regolamentazioni (la differenza fra guerra terrestre e marittima, fra guerra in Europa e
nelle colonie) che permise al continente europeo la conquista politica del pianeta e la diffusione
globale del suo sistema tecnico ed economico. Con estrema chiarezza Schmitt scrive:
La comparsa di spazi liberi immensi e la conquista territoriale di un nuovo mondo resero possibile un
nuovo diritto internazionale europeo a struttura interstatale. Nell’epoca interstatale del diritto
internazionale, che va datata tra il secolo XVI e la fine del XIX, si conseguì un reale progresso: quello di
circoscrivere e di limitare la guerra europea. Questo grande successo non può essere spiegato né con le
formule della guerra giusta tramandate dal Medioevo, né con concetti di diritto romano. Esso si verificò
solo perché si realizzò un nuovo ordinamento spaziale concreto, un equilibrio tra gli Stati territoriali del
58
59
C. Schmitt, Il concetto di politico, in Id. Le categorie del “politico”, cit., p. 92
Ibid.
continente europeo in correlazione con l’impero marittimo britannico, avente sullo sfondo immensi spazi
liberi. Con lo svilupparsi sul territorio europeo di parecchieformazioni di potere territorialmente compatte
e dotate di governo, di amministrazione centrale e di confini stabili, furono trovati i portatori adeguati di
un nuovo jus gentium. Grazie al concreto ordinamento spaziale dello Stato territoriale il suolo europeo
acquisì uno specifico status di diritto internazionale, valido tanto in se stesso, quanto in rapporto a tutti i
territori non europei d’oltremare. Fu così reso possibile per un periodo di tre secoli un diritto
internazionale comune non più ecclesiastico o feudale, ma appunto statale. 60
In un altro passo fondamentale del Nomos della Terra che vale la pena citare per intero,
Schmitt si sofferma sinteticamente su uno degli aspetti fondamentali della nascita dello jus
publicum Europaeum:
La separazione di terraferma e mare libero è la caratteristica specifica fondamentale dello jus publicum
Europaeum. Questo ordinamento spaziale trae origine essenzialmente non già da conquiste intraeuropee o
da mutamenti territoriali, ma dalla conquista europea di un nuovo mondo europeo, connessa alla
conquista del mare libero operata dall’Inghilterra. Spazi liberi immensi, apparentemente illimitati resero
possibile e ressero il diritto interno dell’ordinamento interstatale europeo. [...] Per il nomos della terra
emergono in quest’epoca le seguenti distinzioni e suddivisioni: 1) distinzione tra la superficie della
terraferma e quella del mare libero, importante ai fini della distinzione tra guerra terrestre e guerra
marittima, a ognuna delle quali corrisponde un proprio concetto di nemico, guerra, preda; 2) entro la
superficie della terraferma: distinzione tra il suolo degli Stati europei (territorio statale in senso proprio) e
il suolo dei possedimenti d’oltremare (territorio coloniale), importante ai fini della distinzione tra guerra
europea e guerra coloniale. La limitazione della guerra ottenuta per la guerra terrestre europea, si riferisce
solo alle guerre interstatali condotte sul suolo europeo o su un suolo a esso equiparato.61
L’emergenza dello Stato razionale occidentale non può essere concepita come l’evoluzione
diretta della tradizione giuridica romana o delle formule della guerra giusta di tipo medievale. Alla
base della costruzione statale moderna sta un «nuovo ordinamento spaziale» che Schmitt definisce
esplicitamente «concreto». Lo Stato occidentale a partire dal XVI secolo diventa il nucleo di un
nuovo jus gentium in base al quale si decise anche il destino dei grandi spazi americani e del mare.
La limitazione della guerra entro i confini europei deriva da questa situazione concreta, e funzionale
a questa situazione concreta deve essere visto il nuovo diritto internazionale secondo il quale la
guerra non si invoca più justa causa (cioè secondo un principio morale) né si utilizza come
strumento divino contro gli eretici e gli infedeli, ma ormai del tutto deteologicizzata come il resto
della vita pubblica è dichiarata contro uno justus hostis (dunque, in base a un concetto formale) e
condotta secondo regole determinate e condivise tra i contendenti. Nasce la guerre en forme ovvero
un modo di condurre la guerra in cui il nemico «cessa di costituire qualcosa che “deve essere
annientato”»:62
60
C. Schmitt, Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello «jus publicum Europaeum», tr. it. di E. Castrucci,
Adelphi, Milano 1991, p. 163.
61
Ivi, pp. 223-24.
62
Ivi, p. 166.
Un ordinamento internazionale che si fonda sulla liquidazione della guerra civile e che limita la guerra
trasformandola in un duello europeo tra Stati, si legittima di fatto come ambito di relativa razionalità.
L’uguaglianza dei sovrano fa sì che questi siano fra di loro partner bellici equiparati e tiene lontano i
metodi della guerra di annientamento.63
Il fatto che la guerra sia stata limitata – si badi bene non in toto, ma esclusivamente sul suolo
europeo – entro confini giuridici razionali e condivisi fino ad assumere l’andamento di un duello
confinato entro norme limitate e definite a cui tutte le entità statali europee si sentono costrette e
onorate a tener fede, permette contemporaneamente di intraprendere guerre brutali nel “nuovo”
mondo in quanto terra non ordinata secondo i principi dello Stato moderno. Oltre alla guerra civile
anche la guerra coloniale rimane estranea alla regolamentazione dello jus publicum Europaeum.
La «relativa razionalità» che ha caratterizzato i rapporti internazionali tra gli Stati europei dal
XVI secolo, tramonta alla fine del XIX: le caratteristiche dei conflitti tendono a non rispettare più
quelle che per alcuni secoli erano state assunte come norme inviolabili della guerra tra gli Stati: non
considerare i prigionieri di guerra come «l’oggetto di una punizione, di una vendetta o di una
cattura di ostaggi»,64 trattare la proprietà privata «non più direttamente come bottino di guerra»,65
rispettare le nazioni neutrali e concludere, al termine delle ostilità «trattati di pace con ovvie
clausole di amnistia».66 Come all’origine dello jus publicum Europaeum abbiamo visto essere
presente un concreto ordinamento spaziale, così il suo tramonto è segnato da una altrettanto
concreta «rivoluzione spaziale». Una importanza decisiva nello svuotamento di senso dello jus
publicum Europaeum ha ricoperto secondo Schmitt l’ampliamento del teatro di guerra al cielo. Con
la nascita del volo meccanico e con l’istituzione della aeronautica oltre alla terra e al mare la guerra
conquista un ulteriore elemento, l’aria, con un effetto «rivoluzionario» tale che, come si legge in
Land und Meer (1942), è possibile definire l’aeronautica nel complesso come «arma spaziale»:
«L’effetto di rivoluzione spaziale che ne deriva, infatti, è particolarmente forte, immediato,
manifesto».67 Per Schmitt non si tratta di un mero aumento quantitativo dei luoghi deputati agli
scontri armati, quanto piuttosto di una conquista di un nuovo elemento che esprime l’avvenuta
trasformazione dell’idea di guerra in quanto tale. In particolare l’ingresso sulla scena del volo
aerero militare muta anche l’idea di guerra terrestre e marittima, fino a dissolvere i confini della
guerre en forme. La guerra aerea riporta concretamente sulla scena europea l’idea della «guerra di
annientamento»:
Il bombardamento aereo ha [...] il significato e il fine esclusivo dell’annientamento. La guerra aerea
autonoma – che non è una guerra che si aggiunge alle armi e ai metodi della guerra terrestre o marittima
finora conosciuta, bensì un tipo di guerra completamente nuovo – si distingue da quei due altri tipi di
guerra soprattutto per il fatto che essa non è affatto una guerra di preda, ma una pura guerra di
annientamento.68
63
Ibid.
Ivi, p. 411
65
Ibid.
66
Ibid.
67
C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Adelphi, Milano 2002, p. 107. Su questo tema cfr.
anche C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., pp. 417-29.
68
C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., p. 423.
64
Certamente anche la guerra terrestre può essere condotta come guerra di annientamento, ma
storicamente l’emergere e l’affermarsi dello jus publicum Europaeum mostra come di fatto la
guerra terrestre e l’occupazione bellica siano potute diventare un istituto giuridico del diritto
internazionale, al punto che the mutual relation between protection and obedience nella guerra
terrestre in forma ha caratterizzato normalmente i rapporti tra l’esercito occupante e la popolazione
del territorio occupato :
Nella misura in cui l’esercito occupante salvaguarda l’ordine pubblico e protegge la popolazione del
territorio occupato, la popolazione è tenuta per parte sua all’obbedienza nei confronti della forza
d’occupazione. Risulta qui evidente il nesso immediato tra protezione e obbedienza. Esso poggia su un
chiaro legame spaziale che si instaura tra una forza d’occupazione effettivamente presente e la
popolazione del territorio occupato. La potenza terrestre occupante può avere programmi e intenzioni
diversi: essa può incorporare la terra occupata, annetterla o utilizzarla come materia di scambio o come
garanzia; può assimilare oppure sfruttare la popolazione. Sempre, anche quando vengono presi degli
ostaggi, rimane configurabile una connessione tra protezione e obbedienza e continua a essere data –
almeno all’epoca del diritto internazionale europeo – una qualche relazione positiva sul suolo europeo tra
il suolo stesso e i suoi abitanti.69
Questo rapporto tra protezione e obbedienza come anche il «rapporto tra tipo di guerra e
preda» sono di principio esclusi nella riorganizzazione spaziale successiva alla nascita della «guerra
aerea autonoma»:
La guerra aerea autonoma elimina il nesso tra il potere che usa la forza e la popolazione che dalla forza è
colpita in grado assai più alto di quanto avvenga nel caso di un blocco nel corso della guerra marittima.
Nel bombardamento aereo la mancanza di relazioni tra il belligerante e il territorio, congiuntamente alla
popolazione nemica che in esso si trova, diventa assoluta; qui non è rimasta nemmeno più l’ombra della
connessione tra protezione e obbedienza. [...] L’aereo arriva volando e getta le sue bombe, oppure attacca
scendendo a volo radente e quindi riprende quota: in entrambi i casi adempie alla sua funzione di
annientamento e abbandona quindi immediatamente al suo destino (vale a dire: alle sue autorità statali) il
territorio bombardato, con le persone e le cose che vi si trovano.70
La guerre mondiali segnano il crollo dell’ordinamento spaziale che aveva reso possibile la
regolamentazione della guerra. In particolare l’estensione su scala planetaria della sovranità statale
resa possibile dal processo di decolonizzazione iniziato alla fine della Seconda guerra mondiale
comporta l’impossibilità di continuare a tenere in forma quel fragile orientamento ordinativo dello
spazio mondiale che aveva reso possibile la regolamentazione della guerra e la “pacifica” politica
europea europea nel suo complesso. Come ha osservato Galli «che estesasi universalmente, la
sovranità dello Stato non sia più in grado di determinare un orientamento ordinativo degli spazi
mondiali ma sia solo “tecnica” è dimostrato per Schmitt dal fatto che le forze universalistiche e
“marittime” – il liberalismo, l’economia capitalistica, la tecnica – prendono il sopravvento»71
69
Ivi, p. 425
Ivi, pp. 428-29.
71
C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, Il Mulino, Bologna 2001, p. 118.
70
annullando tutte quelle separazioni ed esclusioni interno ed esterno, terra europea, mare, colonie,
nemico e criminale di cui l’ordinamento politico moderno viveva.
6. L’esigenza derridiana di rivolgersi a Carl Schmitt è comprensibile nella misura in cui all’interno
della dimensione globale della politica e della guerra ci troviamo in una situazione caratterizzata dal
«caos concettuale»; siamo finiti in una «zona di turbolenza aleatoria propria del linguaggio pubblico
o politico» che impone al pensiero filosofico di «riconoscere le strategie e i rapporti di forza».72 In
questo quadro critico della politica in cui il significato di parole come «pace», «guerra»,
«terrorismo», «democrazia» appare consumato dal senso comune e dagli usi strumentali, Derrida
vede una possibilità per il pianeta globalizzato nella «rifondazione, se così la si può chiamare, del
giuridico politico» e con essa «una mutazione concettuale, semantica, retorica allo stesso tempo».73
Ma tale rifondazione non può avere inizio se non ritessendo il vocabolario della politica occidentale
attraverso una comprensione genealogica – nella direzione di Schmitt appunto – delle modalità
mediante le quali l’ordinamento statale moderno si è dissolto nelle trincee della Prima guerra
mondiale, producendo un’esplosione sempre più generealizzata e incontrollabile della violenza
bellica. La comprensione genealogica risponde all’esigenza di tornare imparare a vedere e a parlare
fuori dalle contrapposizioni ideologiche e abbandonando i vuoti stereotipi nel tentativo di dar forma
a nuovi concetti. È all’interno di questa cornice che anche l’evento dell’11 settembre deve essere
inserito: non tanto evento epocale, punto di svolta, ma fenomeno che con il suo nudo terrore ben
visibile e ben comprensibile dagli occhi occidentali, esprime la portata della violenza globale,
incontenibile dalle vecchie categorie della politica europea.
In questo contesto la schmittiana genealogia della politica, come scrive Galli, non è né
una apologia della guerra, né l’affermazione della semplice coincidenza di guerra e politica; è la scoperta
che ogni ordine politico è reso possibile da un disordine e sul conflitto che dunque porta in sé fin dalla
propria emergenza, come atto costitutivo, della presenza costitutiva della guerra (come possibilità)
all’interno della pace, della precarietà delle chiare distinzioni di cui si è nutrita la politica moderna, delle
opacità che ineriscono la ragione, della contingenza di ogni ordine, dell’instabilità dello Stato, la cui
neutralità è in realtà impossibile, perché nata e orientata da un conflitto mai del tutto giuridificabile.74
Con la fine della guerre en forme la dimensione dell’annientamento diventa coessenziale
all’esercizio della guerra stessa. In questo vuoto di dominio sulla guerra, nell’impossibilità di
produrre spazio politico e identità attraverso l’azione violenta, lo scenario normale che si prospetta
è quello di una diffusione planetaria di conflitti irregolari in cui figure ed eventi irregolari ed
eccezionali tendono ad assumere sempre più la funzione normale di scontri regolari. In quello che
Alain Joxe definisce come il «caos imperiale»,75 assistiamo alla quotidiana «riduzione degli “altri” a
entità politicamente nulla» il che comporta, come ha scritto Alessandro Dal Lago, «la
trasformazione della guerra in polizia-pulizia su scala globale in cui non esiste più riconoscimento
del nemico».76 Uno dei pericoli più grandi del processo di normalizzazione della guerra funzionale
al «sistema-lavoro», della normalità e della quotidianità della violenza che circola incessantemente
72
J. Derrida, Autoimmunità, suicidi reali e simbolici, in G. Borradori (a c. di), Filosofia del terrore. p. 113.
Ibid.
74
C. Galli (a c. di), Guerra, Laterza, Roma-Bari 2005, p. XXVI.
75
A. Joxe, L’impero del caos. Guerra e pace nel nuovo disordine mondiale (2002), Sansoni, Milano 2004, p. 33.
76
A. Dal Lago, Polizia globale. Guerra e conflitti dopo l’11 settembre, ombre corte, Verona 2003, pp. 37-38.
73
e in modo sottile e spesso impercettibile viene dalla ideologica criminalizzazione di chi è
considerato nemico, dal ridurre il cosiddetto nemico a materiale di scarto da eliminare. Nella
ricostruzione del processo che conduce alla dimensione planetaria della guerra, il terrore e
l’annientamento appaiono quali elementi essenziali e non come minaccia esterna alla
trasformazione della democrazia occidentale in democrazia planetaria.77 In questo senso tutta quella
sequela di statiche contrapposizioni tra valori occidentali e fanatismo orientale, tra democrazia dei
paesi civilizzati e tirannia dei “popoli fondamentalisti” si presenta come una di quelle forme di
consapevole o inconsapevole produzione ideologica del nemico, che denuncia comunque la propria
cecità dinanzi alla genealogia della dimensione globale della violenza e dimostra l’assenza di
comprensione della portata intrinsecamente imperialistica di quella che Ernst Jünger già negli anni
Trenta aveva definito come «democrazia della morte». La costruzione dello spazio planetario si è
realizzato e continua a realizzarsi come imposizione dell’uniformità della disciplina della tecnica e
del lavoro attraverso la distruzione sistematica di ciò che rimane delle altre forme culturali, ma
proprio in questa opera di annullamento dell’altro, la razionalità europea tende a estraniarsi rispetto
alla propria provenienza, a occultare la propria radice tragica e conflittuale. Alla democrazia
occidentale accade qualcosa di analogo a ciò che secondo Nietzsche78 decretò la morte della tragedia
antica: come il dramma tragico svuotato della forza aorgica, divenuto incapace di parlare la lingua
straniera di Dioniso non può che rispecchiarsi in se stesso fino ad assumere le sembianze e gli
atteggiamenti della «scimmia di Ercole», così l’abbandono, anzi l’annullamento sistematico
dell’altro da parte della tirannia dei valori democratici muta l’essenza della democrazia occidentale
che è ora, per dirla con Nietzsche, «dialettica sofistica», democrazia «imitata e mascherata» proprio
come agli occhi di Nietzsche apparve il dramma euripideo.
La portata di questa mutazione è massimamente visibile fissando lo sguardo su quella «logica
della forza»79 che emerge nell’esecuzione politica dell’imperativo democratico «rendere l’altro
uguale a noi». Come ha scritto in modo lapidario Guido Davide Neri: «Mai come nell’attuale
“pedagogia delle bombe” si manifesta la verità del detto che proprio “il medium è il messaggio”.»80
Nell’uso della guerra come via per una cosiddetta “civilizzazione democratica” si svela l’essenza
della versione contemporanea della democrazia occidentale, nonché il destino nichilistico del suo
progetto. Parlano di noi oggi le immagini con cui si chiude lo scritto di Jünger Die totale
Mobilmachung: in quei «luoghi» nei quali «la maschera umanitaria è quasi cancellata» ciò che
rimane della «rete» planetaria intrecciata dalla Mobilitazione totale è «un feticismo della macchina
mezzo grottesco e mezzo barbarico»,81 lo svanire del «sogno della libertà» stritolato «come nella
ferrea morsa di una tenaglia»:82
77
Sul terrorismo come modus operandi che mira non all’eleminazione precisa dei soldati avversari, ma
all’annientamento generalizzato del nemico e del suo ambiente e sulla sua nascita nello scenario della guerre en forme
tra Stati cfr. P. Sloterdijk, Schäume, Suhrkamp, Francoforte s. M. 2004. Sulla dimensione nichilistica della guerra
contemporanea S. Markus, H. Münkler, W. Röcke (a cura di), Schlachtfelder. Codierung von Gewalt in medialen
Wandel, Akademie Verlag, Berlino 2003.
78
«Che cosa volevi, empio Euripide, quando cercasti di costringere ancora una volta questo morente a servirti? Morì fra
le tue braccia violente, e allora sentisti il bisogno di un mito imitato, mascherato, che come la scimmia di Ercole sapeva
ormai soltanto adornarsi con l’antica pompa. E come per te moriva il mito, moriva per te anche il genio della musica:
per quanto tu saccheggiassi con avide mani tutti i giardini della musica, anche così giungesti solo a una musica imitata e
mascherata. E poiché avevi abbandonato Dioniso, anche Apollo abbandonò te». (F. Nietzsche, La nascita della tragedia
(1876), Adelphi, Milano 1972-1977, p. 74.
79
G. D. Neri, Sulla guerra, in Il sensibile, la storia, l’arte, cit. p. 294.
80
Ibid.
81
E. Jünger, La mobilitazione totale, in Id., Foglie e pietre, cit., 134.
82
Ivi, p. 135.
«È uno spettacolo grandioso e terribile vedere i movimenti delle masse sempre più omologati, su cui lo
spirito del mondo getta la sua rete. Ciascuno di questi movimenti non fa che rendere la presa più stretta e
più implacabile, e qui agiscono forme di costrizione che sono più forti della tortura: così forti che l’uomo
le saluta con giubilo».83
Sviluppando specialmente la riflessione sulla metamorfosi della guerra di Ernst Jünger e di
Carl Schmitt, Carlo Galli osserva che l’essenza della «guerra globale» è quella di «non essere una
Terza guerra mondiale» e «di non essere neppure una guerra dei mondi (del mondo islamico contro
il mondo cristiano), quanto piuttosto la manifestazione del fatto che la globalizzazione è un mondo
di guerra».84 In questo senso la incessante cupa proliferazione di fronti avversi che si delineano sulla
base della contrapposizione di ideologie, religioni e valori non dà forma a «identità politiche intese
come fattori di ordine politico, ma solo a immagini fantasmatiche in reciproca immediata
negazione».85 «La guerra», scrive Jünger nel 1959, «non viene circonfusa dalla luce di un affinato
incivilimento che ne segni l’inutilità: essa piuttosto si disgrega, divenendo uno strumento ottuso
imprevedibile, e perfino suicida, della politica, un vicolo cieco».86 Proprio nel superamento di questo
deserto fantasmatico e ideologico consiste il primo passo per ritessere le trame di un ethos
occidentale in grado di essere fedele al senso della propria provenienza culturale e all’altezza della
comprensione del destino di quella globalizzazione che nella implicazione mondiale della storia
europea ha la propria ragione e che non può certo essere «lasciata alle spalle come un’uniforme
dismessa».87 Un ethos che si realizza praticando quella che Jünger ha definito una «nuova scienza»,
oggi la più fertile e la più felice di tutte, «la dottrina della libertà umana di fronte alle nuove forme
che ha assunto la violenza».88
83
Ibid.
C. Galli, Guerra globale, cit., p. 55. Su questi temi si vedano anche le riflessioni di A. Dal Lago, Polizia globale.
Guerra e conflitti dopo l’11 settembre, cit. e Id. La guerra-mondo, in «Conflitti globali», 1, marzo 2005. Ma cfr. anche:
D. Zolo, Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale, Einaudi, Torino 2000; S. Palidda, Polizia postmoderna.
Etnografia del nuovo controllo sociale, Feltrinelli, Milano 2000; S. Vaccaro, Globalizzazione e diritti umani, Mimesis,
Milano 2004; G. Buonaiuti, A. Simoncini (a cura di), La catastrofe e il parassita, Mimesis, Milano 2004; L. Bonanate,
La politica internazionale tra terrorismo e guerra, Laterza, Roma-Bari, 2004.
85
C. Galli, Guerra globale, cit., p. 36.
86
E. Jünger, MdT, p. 93.
87
G. D. Neri, L’Europa dal fondo del suo declino, in Id., Il sensibile, la storia, l’arte, cit., p. 271.
88
E. Jünger, Trattato del ribelle, cit., p. 24.
84