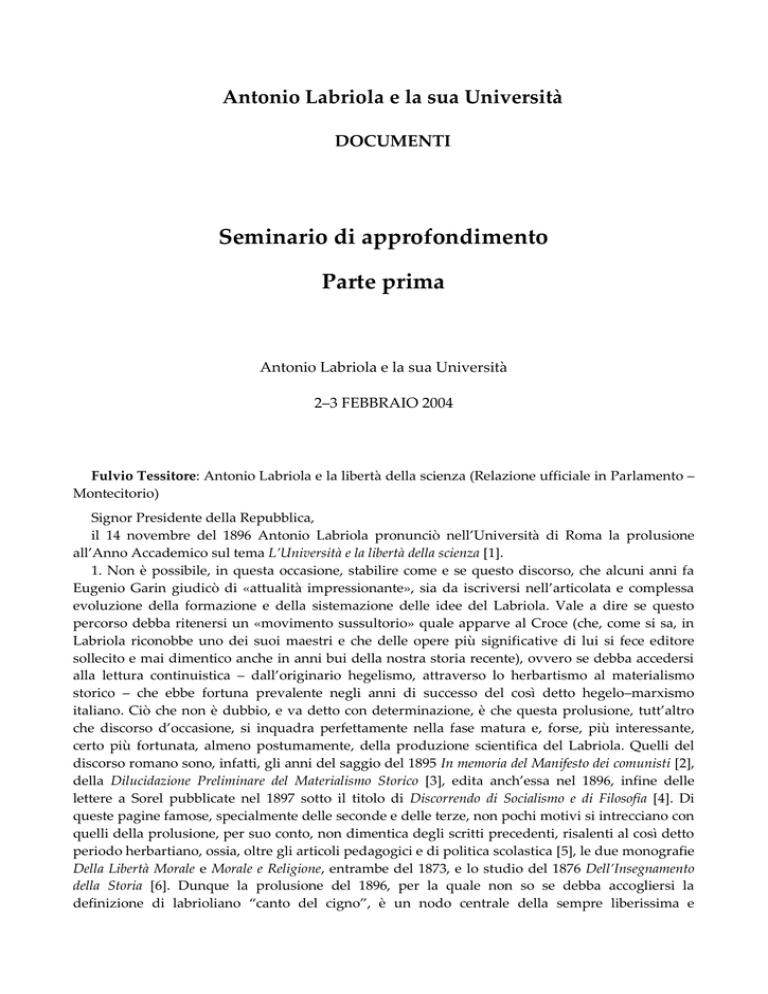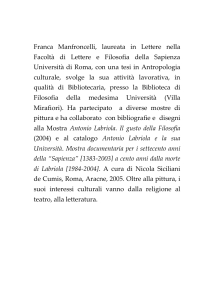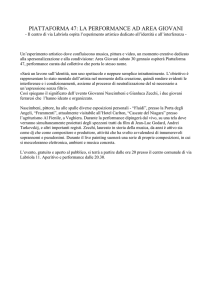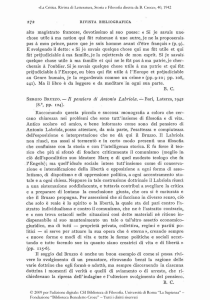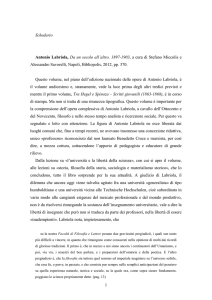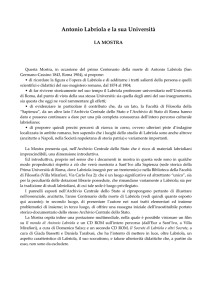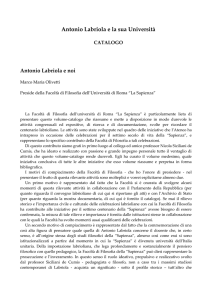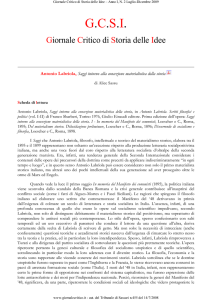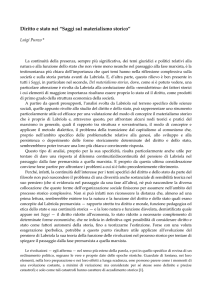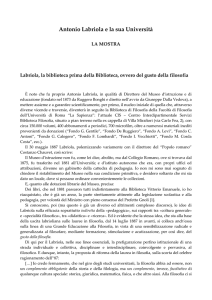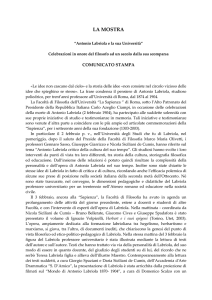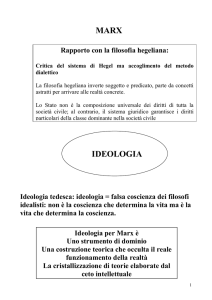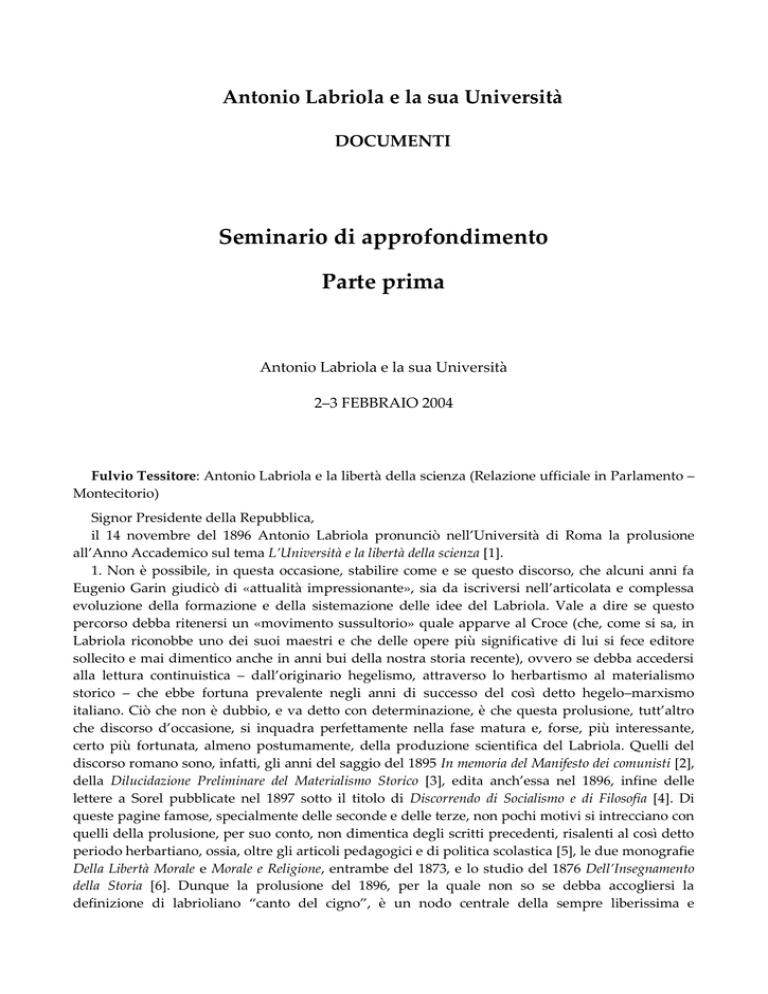
Antonio Labriola e la sua Università
DOCUMENTI
Seminario di approfondimento
Parte prima
Antonio Labriola e la sua Università
2–3 FEBBRAIO 2004
Fulvio Tessitore: Antonio Labriola e la libertà della scienza (Relazione ufficiale in Parlamento –
Montecitorio)
Signor Presidente della Repubblica,
il 14 novembre del 1896 Antonio Labriola pronunciò nell’Università di Roma la prolusione
all’Anno Accademico sul tema L’Università e la libertà della scienza [1].
1. Non è possibile, in questa occasione, stabilire come e se questo discorso, che alcuni anni fa
Eugenio Garin giudicò di «attualità impressionante», sia da iscriversi nell’articolata e complessa
evoluzione della formazione e della sistemazione delle idee del Labriola. Vale a dire se questo
percorso debba ritenersi un «movimento sussultorio» quale apparve al Croce (che, come si sa, in
Labriola riconobbe uno dei suoi maestri e che delle opere più significative di lui si fece editore
sollecito e mai dimentico anche in anni bui della nostra storia recente), ovvero se debba accedersi
alla lettura continuistica – dall’originario hegelismo, attraverso lo herbartismo al materialismo
storico – che ebbe fortuna prevalente negli anni di successo del così detto hegelo–marxismo
italiano. Ciò che non è dubbio, e va detto con determinazione, è che questa prolusione, tutt’altro
che discorso d’occasione, si inquadra perfettamente nella fase matura e, forse, più interessante,
certo più fortunata, almeno postumamente, della produzione scientifica del Labriola. Quelli del
discorso romano sono, infatti, gli anni del saggio del 1895 In memoria del Manifesto dei comunisti [2],
della Dilucidazione Preliminare del Materialismo Storico [3], edita anch’essa nel 1896, infine delle
lettere a Sorel pubblicate nel 1897 sotto il titolo di Discorrendo di Socialismo e di Filosofia [4]. Di
queste pagine famose, specialmente delle seconde e delle terze, non pochi motivi si intrecciano con
quelli della prolusione, per suo conto, non dimentica degli scritti precedenti, risalenti al così detto
periodo herbartiano, ossia, oltre gli articoli pedagogici e di politica scolastica [5], le due monografie
Della Libertà Morale e Morale e Religione, entrambe del 1873, e lo studio del 1876 Dell’Insegnamento
della Storia [6]. Dunque la prolusione del 1896, per la quale non so se debba accogliersi la
definizione di labrioliano “canto del cigno”, è un nodo centrale della sempre liberissima e
autonoma filosofia del Cassinese, così che, esaminandola partitamente, sia pure con la concisione
qui imposta da questa solenne occasione celebrativa, può scaturirne, se chi parla ne sarà capace, un
profilo di questa importante figura della nostra cultura filosofica e politica Otto–Novecentesca.
2. Al di là della scorrevolezza oratoria il discorso è complesso nel suo articolato intreccio
tematico. Un primo nucleo di argomentazioni è rivolto a delineare, senza enfasi e non senza
sarcasmi, le virtù e i vizi dell’Università della «Nuova Italia». Labriola non esita parlare di «gran
magagna della nostra Università» [7], quando riflette su quello che gli appare la «promiscuità
dell’insegnare e dell’esaminare», che si risolve in danno perché, innaturalmente, spacca il nesso
didattica – ricerca nell’ossessione dell’esame, che non è «attestazione di capacità scientifica» ma
solo documento utile al fine della professione. Le conseguenze sono ben più gravi di quanto possa
apparire: il Professore si abitua a vedere negli studenti soltanto dei candidati agli esami e gli
studenti si considerano soltanto degli esaminandi, desiderosi di superare la prova il più
rapidamente e sbrigativamente possibile. L'incidenza sulla struttura è pesante, costringendo, ad
esempio, il docente a non curare il corso monografico ma quello «enciclopedico» (come lo chiama
Labriola riferendosi a quello che noi chiamiamo corso “generale” o “istituzionale”), obbligando le
Facoltà a chiudersi in «antiquate muraglie cinesi» [8] concentrate nella difesa dei confini
disciplinari, contro l'interazione tra i saperi positivi. Perciò la riforma delle Facoltà è urgente, «è
per ora la sola riforma urgente a completare il nostro ordinamento», «e passo sopra all’eventuale
sparizione di parecchie Università» [9], aggiunge Labriola, con antiveggenza destinata a clamorose
smentite e, tuttavia, testimonianza della sua lucida capacità di salire dalle patologie minute e
contingenti alle ragioni di merito e di principio. Lo mostra ciò che egli ricava dalla rilevazione
delle condizioni critiche. S’impoverisce il professore, risultato soltanto l’erede del «letterato
italiano» dell’età della decadenza nazionale, della quale Labriola, l’anno prima, nel saggio In
Memoria del Manifesto dei Comunisti aveva lucidamente individuato ragioni e modalità, quando
aveva parlato di uno «Stato Moderno in una società quasi esclusivamente agricola e in gran parte
di vecchia agricoltura» [10], così da creare «un sentimento di universale disagio» che da «la
generale coscienza della incongruenza di tutto e di ogni cosa». Insomma un clima, come scrive, con
feroce sarcasmo, al suo maestro Bertrando Spaventa, il 3 novembre 1873, in cui si respira «un’aria
che incretinisce. Per respirare un po’ liberamente m’adatterò a conversare con la mia padrona di
casa, con una sarta e con una stiratrice, che discutono con più buon senso che non si faccia
all’Università o a casa del Mamiani» [11], ossia l’allora famoso e potente professore Terenzo
Mamiani Della Rovere.
Se si dovesse continuare così, dirà impietosamente nel 1897 in Discorrendo di Socialismo e
Filosofia, i Professori, come i Preti, risulteranno «categorie […] superflue».
E però il discorso non può esaurirsi nella rilevazione di sì fatte deficienze pur serie, perché,
osserva, con determinato e motivato orgoglio, Labriola «l’Università nostra è nuovamente vitale»
[12]. Le ragioni sono molteplici e vanno ricordate. In particolare Labriola insiste su alcuni fattori
importanti. In primo luogo «ai Professori italiani è premuto soprattutto, in quest’ultimo trentennio,
di rimettersi al passo con gli scienziati degli altri Paesi» e «lo sforzo ha in buona parte ottenuto il
desiderato effetto. I prodotti della scienza italiana sono rientrati nella circolazione internazionale»
[13], consentendo di vedere il superamento dell’antica decadenza consacrata dalle fortune del
«letterato» contro lo «scienziato». Ed anche sul piano strutturale le cose son cambiate e cambiate in
bene. Ormai «l’Università italiana sfida il paragone di tutte le altre» e lo fa grazie
all’«incondizionata pubblicità dell'insegnamento» [14], che significa affermazione della funzione
sociale e civile della ricerca e della esperienza scientifica, che si sviluppano, si mantengono e
prosperano «in tale pubblico istituto per vie naturali e con modi affatto spontanei, lo dicano o non
lo dicano le leggi; ed è anzi bene che non lo dicano» [15]. Certo, osserva con coraggio il marxista
Labriola, «l’Università non avrà mai l'ufficio di farsi organo ed istrumento della cultura popolare».
A ciò dovranno servire – non certamente sganciate dall’istruzione superiore – la scuola Media e la
scuola Elementare a cui lo Stato deve provvedere con attenta sollecitazione. Ma «l’Università
nostra» è «così accessibile, tanto comunicativa ed in principio tanto democratica», che è «cosa della
quale non possiamo che lodarci» [16]. Ormai, ed è un’altra constatazione lucidamente sferzante,
noi, e con noi le nostre Università, «siamo lontani dalla tirannia regia o papale, come dalla
prepotenza comunale» [17] (e non so se ciò possa ripetersi anche oggi).
Qual è la ragione di questa rinnovata vitalità delle Università, dopo secoli di decadenza e
nonostante il persistere di patologie, che richiedono repliche rigorose accanto a provvedimenti
severi? La risposta, che porta al nucleo centrale del discorso di Labriola, merita una preliminare
precisazione in cui riluce la sorprendente attualità del discorso che sto commentando, così come
mi pare che emerga anche dalle altre cose già dette. Labriola rileva che «negli ultimi tempi» la
«critica» dell’Università, «s’è fatta [...] senza dubbio, assai viva nel pubblico» ed è cosa positiva se
non scadesse nel sentito dire di fustigatori tanto ignari quanto improvvisati. «C’è toccato di
leggerne e di sentirne d’ogni genere e d’ogni colore negli ultimi anni. Nei giornali quotidiani e nei
discorsi parlamentari c’è accaduto più volte di sentirci oggetto di una critica, che spesso fu poco
benevola, e quasi mai parve rivolta all’intento di fornire a noi nuovi lumi e cognizioni nuove. Noi,
colpevoli dei frequenti tumulti studenteschi; – noi, cagione di danno alla società, perché
produciamo troppi professionisti, che nella lotta della vita forman poi un forte contingente
nell’esercito degli spostati; – noi, pericolosi, come quelli che abusiamo, chi sa mai come, della
libertà dell’insegnare: e così via, da non finirla! Non dirò che sia giunto il tempo di mettersi in su le
difese, come se fossimo minacciati da grave ed imminente pericolo; ma dirò francamente, che i
Professori hanno il grave torto di abbandonare la discussione sulle cose universitarie all’arbitrio
degli incompetenti, e di non reagire contro gli erronei giudizi con la forza e con l’autorità della
propria esperienza collettiva» [18]. Non si poteva dir meglio ieri, non si potrebbe dir meglio oggi. E
c’è ne per tutti, anche per il potere politico (ne voglio cedere al gusto non mio della
decontestualizzazione e osservare come ciò che sto per leggere sembra il brano di un nostro
discorso di oggi e, ahimè, forse persino di domani). Ma ecco Labriola. «Venga una buona volta alla
Camera a discutere utilmente delle urgenti riforme universitarie. Abolisca, se ciò è ragionevole,
parecchie Università, cambi l’ordine degli studi, muti i rapporti degli esami con le professioni,
rinnovi fin dal fondo i metodi della nomina e della carriera dei Professori». E non si fermi se non,
come deve, dinanzi ad un solo, «incontrastabile principio: non c’è modo di stabilire limiti
preconcetti o assegnati allo sviluppo dell’attività scientifica». [19] «Nessuna prescrizione deve
ricordare ai Professori, che la scienza reca in se stessa i limiti naturali della libertà dell’insegnare –
aggiunge con accenti desanctisiani Labriola –, perché ne può essere materia di deliberazione per
chi l’apprende, ne lascia a chi insegna campo all’arbitrio. Chi dice scienza, dice tendenza materiale
ad eliminare il dominio delle pure opinioni» [20]. Serve ricordare che siamo nel 1896? Ma andiamo
avanti.
Ciò che legittima l’orgoglioso insorgere contro ingiuste accuse, è il riconoscimento, netto e
schietto, della realtà delle cose, con le sue luci e le sue ombre, ma è soprattutto la capacità di non
fermarsi all’apparire a danno dell’essere, alla corteccia a scapito del nocciolo. Non è perciò un caso
che, l’anno dopo, nella lettera del 2 luglio 1897 a Sorel di Discorrendo di Socialismo e di Filosofia [21],
Labriola lamenti le Università divenute «allevamenti artificiali del sapere», che significa
tradimento della scienza e tradimento della funzione sociale e civile delle Università.
Che il richiamo non sia occasionale concessione alla retorica di un discorso d’occasione lo
mostra il riferimento di questo punto ad una affermazione nevralgica della prolusione romana,
opportunamente rivolto ai giovani, che suscitò le polemiche e le proteste dei ben pensanti.
A proposito di una borghesia capitalistica e colonialistica, interessata vanamente a scaricare
fuori di sé le ragioni della propria crisi (e Labriola si riferiva alla piaga dell’emigrazione dei
lavoratori delle braccia e del cervello), il filosofo marxista diceva: «L’Italia ha bisogno di progredire
materialmente, moralmente, intellettualmente. Io spero che voi [giovani] vedrete un’Italia, nella
quale l’atavistico assetto della cultura dei campi sarà soppiantato dalla introduzione delle
macchine e dalle larghe applicazione della chimica; e che vediate strappate ai corsi superiori dei
fiumi, e forse alle onde del mare e dai venti, la forza generatrice dell’elettricità». «Io mi auguro che
voi vedrete spariti dall’Italia gli analfabeti, e con essi gli uomini che non son cittadini, e le plebi che
non son popolo» [22]. E, tuttavia, anche qui il discorso non si compiaceva di un’astratta e polemica
soluzione ideologica, che lo avrebbe impoverito. Non si tratta, infatti, di «monopolizzare» la
scienza per questo o quel fine e tanto meno auspicare l’accumulo di tutta la «cultura» e di tutto «il
pensiero» in una «ipertrofica Università» [23]. Tanto meno si tratta di rivendicare ruoli demiurgici
ai docenti, pur «orgogliosi della superiorità di condizione morale» in cui si trovano rispetto a
quando «le libertà furono privilegi» e bisognava «piegare dinanzi ai capricci dei mecenati, o alle
prepotenze dei protettori e dei grandi» [24].
Ancora una volta, una lettera di Discorrendo di Socialismo e di Filosofia [25] fa eco e chiarisce, con
lucidità antiveggente una non diversa convinzione che Max Weber avrebbe dichiarato, con non
minore coraggio, nel 1917, nel gran discorso su La Scienza come vocazione. «Il tempo dei profeti è
trapassato». «Giova forse di ricordare ai Professori – aveva detto nella prolusione romana –, che
essi non devono confondere l’attività loro con quella dell'apostolo, del propagandista e
dell’agitatore; e che il tenore e lo stile delle trattazioni didattiche non hanno niente di comune con
ciò che si addice al pubblicista, all’avvocato, all’oratore?» [26] «Ora, presentemente, non è lecito di
essere utopisti, se non ai soli imbecilli. L’utopia degli imbecilli, o è cosa ridicola, o è dilettanza di
letterati». Ancora «i letterati» contro gli scienziati! Ora è tempo, aggiunge Labriola con piena
cognizione di causa, di scienza e di realtà, è tempo della scienza di realtà. E qui il discorso si fa
ulteriormente complesso nella sua rigorosa e chiarissima, lineare forza argomentativa.
3. Che cosa è la scienza, qual è il senso, il significato, il valore, la funzione della scienza
nell’Italia che lavora alla propria modernizzazione, alla rivoluzione civile e alla rivoluzione
industriale? Esistono pochi dubbi nell’individuare la risposta di Labriola, resa perentoriamente in
una pagina per altri versi difficile fin ad essere ambigua su cui bisognerà tornare. «Tutto il
conoscibile può essere conosciuto; e tutto il conoscibile sarà, all’infinito, realmente conosciuto; e al
di là del conoscibile, a noi, nel campo della conoscenza, non importa nulla di null’altro». «Per il
materialismo storico il divenire, ossia l’evoluzione è […] reale, anzi è la realtà stessa; come è reale il
lavoro, che è il prodursi dell’uomo, che ascende dalla immediatezza del vivere (animale) alla
libertà perfetta». Insomma la scienza come lavoro, la scienza «che è lavoro», ha detto la prolusione
romana [27] e «il lavoro non è improvvisazione». Esso fonda il (e su) «il sapere» che è «un bisogno,
che empiricamente si produce si raffina, si perfeziona, si corrobora di mezzi e di tecniche, come
ogni altro bisogno» [28]. Ne va dei rapporti tra scienza e filosofia, ma, prima ancora, della idea
stessa del filosofare. Su ciò la prolusione romana ha affermazioni perentorie, di non poca rilevanza.
Netta è la consapevolezza di ciò che è cambiato nella concezione della filosofia, la quale non è più,
«quel sommo ed imperiale magistero sull’universo scibile, che essa fu, o parve, in passato, e che
consiste pur sempre nelle semplici anticipazioni del pensiero su quell’esperienza naturale, storica e
sociale, sulla quale ora, come sopra sicuro fondamento, poggiano le scienze propriamente dette»
[29]. L’anno prima, in una lettera del giugno del 1897 di Discorrendo di Socialismo e di Filosofia, si
rigetta la «caccia all’universale filosofia», [30] che è la succedanea, come dice una lettera di un mese
prima, della «metafisica» della quale «è piena tutta la storia», «in quanto essa è la immaturità di
una mente non ancora scaltrita dall’autocritica, e non rafforzata dall’esperienza» [31]. La
dichiarazione di avere ormai in uggia «la filosofia sistematica» [32] si richiama proprio al discorso
romano del 1896, nel quale è dato leggere ancora il radicale rifiuto di «quella filosofia, che avrebbe
da abbracciare, come in bella prospettiva, e per via di definizioni e di categorie, la totalità del reale
– tutte le forme del sapere» [33]. Ma il punto è: esiste questa totalità e che cosa è il pensiero? Le
lettere a Sorel rispondono senza lasciare adito a dubbio, pur quando aprono altri problemi la cui
determinazione, come si vedrà di qui a poco, non è lasciata inevasa. «I termini del pensiero» non
sono «cose ed entità fisse», ma «funzioni» [34], dice il Labriola marxista non dimentico dello
herbartismo e del kantismo non neokantiano ma appunto herbartiano. Vale a dire si tratta di
procedere, di prendere atto e di capire «la perfetta immedesimazione della filosofia, ossia del
pensiero criticamente consapevole, con la materia del saputo, ossia la completa eliminazione del
divario tradizionale tra scienza e filosofia» [35]. Con accenti vichiani, Labriola precisa che «il
problema della conoscenza – quale è posta dal materialismo storico – trova soluzione quando, in
opposizione ad una filosofia che è la scienza metafisica dell'essere in sé delle cose» [36], riconosce
non esserci «limitazione fissa, né a priori né a posteriori, alla conoscibilità, perché nell’indefinito
processo del lavoro, che è esperienza, e dell’esperienza che è lavoro, gli uomini conoscono tutto ciò
che fa bisogno e che è utile di conoscere» [37]. Però questo processo di acquisizione continua,
questo continuo passaggio dal conoscibile al conosciuto, non si assolutizza in una «filosofia
universale», perché ha in sé, nel suo essere funzione (si potrebbe dire, determinazione delle leggi di
costruzione e di acquisizione della realtà) il limite dato dalla consapevolezza «che non si può
pensare se non quello che possiamo sperimentare, in lato senso, noi stessi» [38]. «Il pensiero cessa
dall’essere un presupposto, o un’anticipazione paradigmatica delle cose, anzi diventa concreto,
perché cresce con le cose, a intelligenza delle quali viene progressivamente concrescendo» [39].
A questo punto la questione da affrontare è quella del metodo (ma in senso per dir così non
finalisticamente metodologistico) di questo funzionale processo del pensiero, «di cui non possiamo
renderci conto se non pensando in atto» [40]. E tuttavia, prima ancora (in senso ovviamente
cronologico e non logico) va posto il problema della precisa cognizione della «risoluzione» del
processo del pensiero nell’«esame specificato di tutti i fondamentali problemi delle singole scienze»
[41]. Le singole scienze! Ecco il punto centrale della riflessione di Labriola. La filosofia come scienza
del conosciuto non è interessata «allo sviluppo di una novella sistematica filosofica», che non può
non risultare «una filologia in cambio della filosofia, come è accaduto ai neo – kantiani» [42], dice,
sprezzantemente, Labriola, che pur conosce il significato della filologia come scienza storica, da lui
studiata sulle tracce di Boeck e di Droysen [43]. Qui «filologia» sta per memoria del passato contro
la costruzione del presente e reale, affidato al lavoro degli uomini, che non sono le incarnazioni o i
portatori dello Spirito del Mondo. «Ogni atto di pensiero è uno sforzo, cioè un lavoro nuovo»,
afferma solennemente Labriola [44], il quale sa – come scrive in una pagina importante Del
Materialismo Storico [45] –, che «le idee non cascano dal cielo». Tutto ciò significa – ed è l'approdo e
la fondazione labrioliana del materialismo storico – che la filosofia in quanto scienza, cognizione
delle scienze particolari in cui si risolve la sua nuova funzione, non può che essere storica, un
risultato del lavoro poggiato sul pluralismo dei «fattori» espressi dalle «diverse discipline [...] ora
per noi tutte indispensabili, quando si voglia ricostruire qualunque parte dei tempi passati» [46] e,
attraverso «la mutazione delle idee, arrivare fino alla creazione dei nuovi metodi di concezione»,
riflettenti «l’esperienza di una nuova vita» [47]. Siamo dinanzi al metodo che «è la forma del
pensiero, che concepisce le cose non in quanto sono (factum, specie fissa, categorie etc.), ma in
quanto divengono: e che perciò esso stesso, come pensiero, deve essere atto di movimento» [48]. In
altri termini, il senso labrioliano del divenire costruendo della filosofia come scienza di realtà è
tanto marcato da non ritenere sufficiente a manifestarlo l’espressione (hegeliana e marxiana) di
metodo dialettico. Labriola preferisce parlare di «metodo genetico» che lascia impregiudicato –
come scrive – «la natura empirica di ciascuna particolare formazione» [49]. In tal modo «la parola
Wissenschaft ha un senso più intimo, più complesso, più organico, che non la famosa Science dei
positivisti». Insistendo ed approfondendo questa concezione anche il termine antitetico al metodo
dialettico, ossia il metodo metafisico, viene chiarito così da non consentire confusione. Nella lettera
del giugno 1894, che sto seguendo in parallelo con i saggi del 1895–97 tanto connessi, Labriola non
risparmia critiche e pesanti giudizi ironici e cattivi sulla parola metafisica e sul concetto che essa
esprime s’è fatto sempre grande confusione, tanto che forse lo stesso Aristotele – ritenutone il
fondatore – l’avrebbe rifiutata «per le sue ricerche, così da altri designati», dice Labriola. In ogni
caso è indispensabile «non dar ragione a quel cretino del Signor Spencer, che facendo della cattiva
metafisica senza saperlo (i primi principi!), lui hegeliano, anzi pseudo–hegeliano senza genialità,
lui inventore di metafisica che vorrebbe parere concetti, gracida contro la metafisica». Allo stesso
modo non si rischia di confondere il positivismo col positivo, ossia col positivamente acquisito
«nella interminabile nuova esperienza sociale e naturale» [50]. Bisogna evitare che «col pretesto
dell’anti metafisico, ora Darwin, il positivismo, Spencer, la sociologia, il socialismo, eccetera ecc,
diventino tutta una cosa nel cervello demimondano dei lettori di rivista» [51]. Queste disgiunzioni
consentono di capire che «sotto il nome di logica, di dialettica va inteso naturalmente tutta la
metodica speciale delle scienze particolari» [52], dice Labriola, tornando ad insistere sulla idea di
«scienze particolari», che sono storiche, il prodotto della storia e le manifestazioni dello storico
lavoro degli uomini.
S’apre in tal modo un altro fronte del discorso, che mena diritto alla libertà della scienza.
4. Al fine di comprendere il significato della storia secondo Labriola non può essere trascurato
un tema che si affianca all’or ora ricordata rivendicazione dei saperi positivi e della loro
interazione rispetto a presunte scienze e filosofie generali; un motivo di certo acutissimo,
modernissimo ed esperto dai temi della più originale filosofia contemporanea a Labriola ma non
dominante in quegli anni, e penso a Dilthey e allo storicismo critico delle diltheyane
Einzelwissenschaften.
Labriola insiste, come s’è visto, sulla pluralità delle «discipline analitiche» e però sostiene che
queste, le quali «illustrano i fatti che si svolgono nella storia» [53], hanno finito per imporre
l’esigenza di una «unificazione dei processi storici». Non si tratta, come Labriola dice poco oltre
[54], di fare appello a «una generica sociologia» o a «una generica filosofia dello stato, del diritto e
della storia», quando si raggiunge, la «interpretazione integrale» della cose umane attraverso il
«ritrovamento delle leggi storico sociali» (verrebbe voglia di dire una anticipata histoire à part
entière). Certo qui (e non solo qui, come tra poco si vedrà) si insinua il vizio della fiducia
nell’avvento di una nuova società senza «antitesi» e senza classi, che ripropone lo spettro dello
hegeliano Spirito assoluto della Storia, del quale secondo Croce e secondo Labriola il materialismo
storico ha costituito l’opposizione e la salvazione. E però l’esigenza dell’unità è vista come
unificazione e non ricognizione di totalità data. Non si tratta più, vale ripeterlo, d’una scienza
generale da esplicare ed effettuare (direi hegelianamente nella propria esauriente Wirklichkeit, ma
d’una scienza unitaria da costruire per individuare e rafforzare la comprensione storica della
pluralità dei fattori storici, i quali, dice acutamente Labriola, indicano «qualcosa che è molto meno
della verità, ma che è molto più del semplice errore» [55]. Ciò che conta è che il percorso non va
dal concetto alla cosa, alle cose della vita, ma al contrario. La storia, in quanto ambito conoscitivo
della «filosofia della praxis», è «filosofia immanente alle cose su cui filosofeggia, dalla vita al
pensiero, e non già dal pensiero alla vita, ecco il processo idealistico. Dal lavoro che è un conoscere
operando, al conoscere come astratta teoria: e non da questo a quella» [56].
Ne conseguono affermazioni importanti: la storia non è «una illustrata catena» di eventi
linearmente connessi [57]. «La storia è il fatto dell’uomo», l’opposto di ogni forma di fatalismo,
anche quello camuffato della lotta per l’esistenza. La circostanzialità della storia esprime e rafforza
l’opera dell’uomo nella natura non quella della natura sull’uomo. L’esigenza di «naturalizzare la
storia», che «può dare occasione ad equivoci, va avvertita come la critica di ogni veduta ideologica,
che parta dalla idea di un presupposto della storia, fino al punto di mettere in dubbio perfino il
razionalismo, intendendosi sotto tal nome il preconcetto, che le cose nella loro esistenza ed
esperienza rispondano ad un norma, ad un ideale, ad una stregua, ad un fine in modo esplicito o
implicito che sia». «Tutto ciò che è accaduto nella storia è opera dell’uomo» e l’opera e l’attività
umana «non è sempre la medesima cosa, nel corso della storia con la volontà che operi a disegno,
con piani preconcetti»; «ossia non è una e medesima cosa con la ragione ragionante» [58].
L’essenziale della storia «consiste […] nei momenti critici» [59]. Il che induce Labriola a negare il
determinismo della lotta per l’esistenza in quanto negazione dell’opera sempre nuova del lavoro,
salvo ad accertarlo tale determinismo se significa ricerca della «spiegazione storica» ossia
l’individuazione dei criteri regolatori della volontà umana contro gli automatismi della naturalità
[60]. Con implicita ripresa di idee ed espressioni hegeliane, Labriola rifiuta, a chiarimento di
quanto or ora ricordato, la sostituzione della sociologia alla storia (come non sarebbe sempre
accaduto dopo di lui in ritornanti riflessioni sul rapporto tra storia e scienze sociali), perché per lui
non si tratta «di separare l’accidente dalla sostanza, la parvenza dalla realtà, il fenomeno dal
nocciolo intrinseco [...]; ma di spiegare l’intreccio e il complesso, per l’appunto in quanto è
intreccio e complesso» [61]. La storia in quanto scienza di realtà non è divenuta la filosofia di sì
fatta scienza, perché qui la realtà significa Realität, ossia qualcosa che non si esaurisce nella propria
effettualità ( Wirklichkeit ), ma è conoscenza di qualcosa di potenziale, di possibile, affidata alla
volontà degli uomini operanti verso un mondo libero, sempre più libero. Si tratta, insomma, «della
storia e non dello scheletro suo». Ne discende che anche il progresso non «implica se non la
nozione di cose empiriche circostanziata» in quanto l’uomo è in grado «di valutare il passato e di
prevedere, ossia di intravedere, in un certo senso e in una certa misura, l’avvenire» [62]. In
sostanza va riconosciuta la «relatività del progresso» di fronte agli «impedimenti all’uniformità del
divenire umano» (a loro volta assai problematici e non riportabili a ragioni naturali quali la razza o
le differenze geografiche [63]. Il chiarimento viene dalla radicale affermazione che «il tempo
storico non è corso uniforme per tutti gli uomini». «Il tempo come astratta misura di cronologia, e
le generazioni succedenti in termini approssimativi di anni, non danno criterio ne recano
indicazione di legge o di processo» [64].
Ne è conferma l’opera di «astrazione» che lo storico compie di necessità per orientarsi tra i
molteplici infiniti avvenimenti. Attraverso questa azione (che è poi la selezione che consente la
comprensione) lo storico «prescinde da molti e svariati precedenti e presupposti», «spezza e
scompone» l’intricata tela «degli eventi». In tal modo (e Labriola sembra anticipare pur
confusamente i tipi weberiani) lo storico trascorre dagli avvenimenti ai «fattori» che «si originano
nella mente, per via dell’astrazione, della generalizzazione degli aspetti immediati del monumento
apparente» [65], ricavando anch’essi da questo processo un criterio, perché essi, «concorrenti» ed
«isolati» per via della suddetta astrazione non vadano mai visti «operare ciascuno per sé» [66], e,
d’altra parte, la loro pluralità – che è il proprium della realtà storica – non vada scambiata con
disordine e irrazionalità, al fine di mostrare quanto, effettivamente siano «indispensabili» per noi a
capire, «qualunque parte dei tempi passati» [67], condizione della comprensione dei tempi
presenti e dei tempi futuri. «Su questa linea di pensiero, certo assai complessa e qui solo
abbozzata, Labriola va tanto innanzi da lasciare osservare che, certamente non immemore dei
primi scritti sulla storia del suo giovane amico Benedetto Croce, quasi anticipa la tesi – e crociana e
gentiliana – della contemporaneità della storia, quando nel saggio Del Materialismo Storico, fa
appello, per difendere il lavoro dello storico, a «quella fonte immediata che sta più in là dei
documenti propriamente detti, e che prima di esprimersi e di fissarsi in questi, consiste nell'animo
e nella forma di consapevolezza, nella quale gli operatori resero conto a se dei motivi dell’opera
propria» [68]. Si tratta di qualcosa d’assai vicina alla Frage droiseniana (una fonte di Croce ma
anche del Labriola dei Problemi della Filosofia della Storia del 1887) [69], con la differenza, almeno
rispetto alla prima formulazione crociana e alla definitiva formulazione gentiliana della filosofia
della storia, che per Labriola l’interesse dello storico non si esaurisce nella conoscenza del fatto,
solo così inteso come fatto storico tra gli infiniti avvenimenti, ma si compone nel fare nell’azione,
nella costruzione della realtà delle cose tanto da giustificare persino il progresso e però solo come
postuma razionalizzazione [70] di quanto è accaduto, perché opera dell’uomo e non di un fato, o
destino che supera, governa e domina gli uomini e la loro volontà, quae fertur in incognitum.
L’appello al futuro riporta al significato labrioliano di scienza in grado di fondare il senso della
storia, della scienza della storia.
La scienza non può distaccarsi (e non si distacca) dalla «circostanzialità della vita» e, aggiunge
Labriola, dalla «formazione pedagogica del carattere», dove pedagogia è da intendersi nel senso
classico della paideia ossia la regola delle «inclinazioni», degli «abiti», delle «consuetudini», dei
«consigli», dei «giudizi», delle «valutazioni» degli uomini [71], in una parola significa la morale
della vita, che non può divaricarsi dalla conoscenza, che è la regola della scienza. In tal modo
Labriola poneva da conto l’analisi formale della logica e sceglieva il realismo del nesso
desanctisiano scienza–vita, e recuperava, contro il concettismo della morale astratta di presunte
regole valide per ogni tempo senza cadere nella casistica, l’etica dell’agore, che si risolve, come egli
scriveva, «nello studio storico delle condizioni oggettive e soggettive del come la morale si
sviluppi, o trovi impedimento a svilupparsi». Solo in ciò, ossia entro questi termini, «ha valore
l’enunciato, che la morale è correspettiva alle situazioni sociali, e ossia, in ultima analisi, alle
condizioni economiche» [72]. «A qualche cretino soltanto – aveva detto poco prima – può essere
passato per il capo di dire che la morale individua di ciascun uomo sia rigorosamente
proporzionale alla sua individua situazione economica. Ciò è non solo empiricamente falso, ma è
intrinsecamente irrazionale». L’etica della vita, vale a dire la realtà della vita, raccoglie ed esprime
il complesso dei «fattori», nel senso labrioliano di funzioni creative, che depurano l’immediatezza
delle passioni qual è manifestata dalla poesia, dal mito, dalla religione. L’etica è la faticosa scoperta
e la difficile conquista della vita libera dall’ignorantia che è sempre in agguato dietro la imaginatio
[73]. E ciò si consegue attraverso «lo sviluppo normale delle attitudini», l’age quod agis della «vita
quotidiana» nella quale la storicità della vita realizza la propria inerenza alla complessità dei
processi di sviluppo storico garantito dalle «mutazioni sostanziali» e non dalle astrazioni
metafisiche. Ed è questo il processo che fonda il futuro, il quale è garantito soltanto se filosofia e
storia, conoscenza e prassi, pensiero e azioni possono fidare sulla libertà della scienza cioè dalla
conoscenza della realtà. E qui il circolo delle idee di Labriola si chiude in una superba
rivendicazione del ruolo del sapere nella sua insostituibile funzione sociale e civile. Sentiamo le
sue parole per concludere e per ricordare, oggi, a cent’anni dalla morte, l’opera scientifica di
Antonio Labriola forse non ancora perenta nella sua inestinguibile fonte di educazione alla libertà.
«Se c’è chi abbia bisogno di vivere fin d’ora nel futuro, come da sentirlo e da provarlo su la propria
pelle; e, papeggiando in nome delle idee, voglia investire dei loro diritti e doveri i componenti della
società dell’avvenire – s’accomodi pure. Permetta [però] a me [...] di esprimere la speranza, che
quei del futuro, non trasumanati tanto da non essere più comparabili a noi del presente, serbino
tanto della gaia dialettica del ridere, da farsi beffe umoristicamente dei profeti dell'oggi» [74].
«Ora, quando la intelligenza è tanto progredita da aver vinto gl’incantesimi della imaginatio e della
ignorantia, i quali legano le sorti così poveramente prosaiche dell’ovvia vita cotidiana alle
(fantasticate) forze trascendenti, non è più alla suggestione generica dell’ottimismo o del
pessimismo che si tenga dietro. L’animo si volge al (prosaico) studio dei mezzi occorrenti a
raggiungere, non quell’ente favoloso che dicesi la felicità, ma lo sviluppo normale delle attitudini;
le quali, date le favorevoli condizioni sociali e naturali, fanno si che la vita trovi se stessa la ragione
dell’esser suo e della esplicazione sua. È qui il cominciamento di quella saggezza che solo può
giustificare la etichetta dell’homo sapiens» [75]. Vale a dire che la libertà del conoscere garantisce la
vita, perché questa non è fondata da qualcosa o da qualcuno ma si autofonda grazie all’agire
responsabile dell’uomo individuo, degli uomini associati, che, vichianamente, fanno la storia e la
conoscono.
Credo sia questa l’ultima parola di Labriola, che, in tal modo, mostrava di avvertire, pur
embrionalmente, i termini costitutivi della società contemporanea comprensibile solo se si sappia
seguire la drammatica dialettica i cui poli sono Carlo Marx e Max Weber, l’uno così presente in
Labriola, l’altro del tutto ignorato eppure presentito dalla sua intelligenza critica libera e
spregiudicata [76].
Seminario di approfondimento nella Facoltà di Filosofia
Gennaro Sasso: Do la parola al professor Olivetti che porterà il saluto della Facoltà di Filosofia,
della quale è il Preside.
Marco Maria Olivetti: Sono molto lieto di portare il saluto della Facoltà di Filosofia. Sono
onorato che questo convegno abbia luogo proprio in questa Facoltà per le seguenti ragioni.
La prima è che, come ognuno di noi ha potuto vedere sul programma, il convegno ha avuto
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Siamo grati al Presidente Ciampi che, anche in
questo caso, ha mostrato la sua sensibilità e il suo apprezzamento non soltanto per le questioni
universitarie, come ognuno di noi sa seguendo le cronache di questi giorni, ma anche per il ruolo
universitario e civile della filosofia. Proprio poco tempo fa il Presidente aveva ricevuto alcuni di
noi – il professor Sasso, il professor Siciliani e altri rappresentanti della Facoltà romana di Filosofia
– mostrando di apprezzare l’importanza di questa Facoltà nell’ambito della vita culturale e civile
del paese. Il Patronato concesso per il convegno labrioliano è, dunque, la conferma dell’attenzione
con cui il Presidente Ciampi segue la nostra attività.
La seconda ragione è che la Facoltà di Filosofia è onorata di appartenere alla istituzione in cui, a
suo tempo, Antonio Labriola esercitò il suo Alto Magistero. Si tratta, quindi, di un convegno su un
pensatore non solo importante e significativo, ma che appartiene anche ai padri fondatori, ai numi
tutelari della Facoltà di Filosofia dell’Università “La Sapienza”.
Labriola venne ad insegnare alla “Sapienza” nel 1874, quindi esattamente centotrenta anni fa.
Egli insegnava Filosofia Morale, Pedagogia e credo che, successivamente, abbia insegnato anche
Filosofia della Storia. Qualche anno dopo, nel ‘77, divenne il direttore del Museo dell’Istruzione e
dell’Educazione, che è il nucleo originario della biblioteca di filosofia. Poi il Museo, voluto da
Angelo Bonghi fu trasformato con Credaro in Scuola di Pedagogia. Successivamente, con Gentile,
si passò alla Scuola di Filosofia, poi all’Istituto di Filosofia. In seguito ci fu la
dipartimentarizzazione e, infine, è stata creata la Facoltà di Filosofia, della quale, dunque, Labriola
è, in qualche modo, all’origine.
Per questo motivo trovo molto efficace il titolo che è stato dato a questo convegno: “Antonio
Labriola e la sua Università”. La sua Università non soltanto in un senso ampio, cioè la sua idea di
Università, quell’idea su cui Labriola scrisse delle pagine altissime e memorabili su L’università e la
libertà della scienza. La sua Università intesa anche come questa Università, che oggi si chiama
Università di Roma “La Sapienza”, con la sua istituzione filosofica, poiché significativo è stato il
suo ruolo culturale e istituzionale all’interno della filosofia romana.
L'amico e collega Siciliani si è dato da fare anche per raccordare questa iniziativa con le
celebrazioni del settecentesimo anniversario della “Sapienza”. Atto, questo, non solo estrinseco,
ma sostanziale. La cosa è ancora in marcia, ma siamo grati a Siciliani della sua attività. Il
programma rivela la sua impronta culturale, anche nel modo stesso in cui è concepito. Siciliani,
infatti, non è solo lo studioso di Labriola che tutti noi conosciamo. Egli organizza anche il
“Laboratorio Labriola” della cui attività avremo più di un saggio nel corso del convegno.
Ringrazio tutti i presenti e i relatori. Devo inoltre comunicare che, purtroppo, i colleghi
Cotroneo e Giarrizzo non possono essere presenti fisicamente per motivi di salute. Giarrizzo ha
mandato la sua relazione che sarà letta dal collega Punzo. Il professore e collega Visalberghi
cercherà di essere presente domani. Oggi non è particolarmente in forma, ma gli siamo grati di
prendere in considerazione la partecipazione per la giornata di domani. Devo anche trasmettere ai
presenti il saluto al convegno e l’augurio di buon lavoro da parte dei colleghi Francesco Adorno,
Giovanni Mastroianni, Pierluigi Pietrobelli, Maurizio Torrini ed Enza Colicchi. Credo di aver detto
tutto quello che mi competeva. Rinnovo il saluto della Facoltà.
Girolamo Cotroneo: Labriola e Croce.
Uno degli avvenimenti più importanti nella storia della nostra cultura filosofica degli ultimi
anni dell’Ottocento è certamente l’incontro, sia sul piano personale che su quello filosofico, tra
Antonio Labriola e Benedetto Croce; o, forse meglio, l’incontro di Benedetto Croce con Antonio
Labriola. Seguendo infatti la discussione intercorsa tra di loro, soprattutto sulla base delle lettere
indirizzate a Croce da Labriola, avendo quest’ultimo soltanto una volta discusso pubblicamente
con Croce, non si può non giungere alla conclusione che le osservazioni di Croce non ebbero
praticamente influenza alcuna sul pensiero di Antonio Labriola, ove invece non si può certo
sostenere il contrario [77].
Dall’incontro di Croce con il suo maestro riconosciuto [78], discesero, infatti, due indirizzi
culturali la cui incidenza sulla filosofia e sulla vita politica italiana del Novecento non fu certo
poca: innanzi tutto uno storicismo – quello di Croce, ovviamente – che superò l’originaria matrice
idealistica inserendo in essa aspetti del pensiero filosofico – il “momento pratico” dello spirito, ad
esempio, che tanto scandalizzava un hegeliano ortodosso come Sebastiano Maturi e che lasciava
perplesso Giovanni Gentile [79] – fino ad allora praticamente esclusi dall’indagine teoretica. L’altro
fenomeno riguarda la parte che questa filosofia, questo storicismo, ebbe più o meno direttamente,
nell’evoluzione del marxismo italiano – che certo non morì con Antonio Labriola – quale si
presentò nella nostra cultura, e dove ebbe parte determinante il pensiero di Antonio Gramsci,
tutt’altro che insensibile agli argomenti filosofici di Benedetto Croce.
Tra le tante pagine che Gramsci ha dedicato a quest’ultimo, se ne incontra una dove si legge che
«l’identità di filosofia e storia è immanente nel materialismo storico», ma che questa era
diventata, nella concezione del Croce ben altra cosa da quella che è immanente nel materialismo storico:
esempio gli ultimi scritti di storia etico–politica del Croce stesso. La proposizione che il proletariato è l’erede
della filosofia classica tedesca contiene appunto l’identità tra filosofia e storia; così come la proposizione che
i filosofi hanno finora solo spiegato il mondo e che ormai si tratta di trasformarlo. [80]
L’idea che nel materialismo storico filosofia e storia fossero di fatto congiunte, anche se in
maniera del tutto diversa da quella in cui le congiungeva Croce [81], è un’idea che Gramsci
potrebbe avere ricavato, per così dire, a posteriori, sarebbe a dire dopo la lettura e l'intelligenza del
pensiero di Croce, più che direttamente attraverso quello di Marx. Comunque sia, queste
affermazioni, così come gli argomenti successivi, dove Gramsci segnalava quali, a suo parere,
erano i limiti della visione crociana dell’identità di storia e filosofia, potrebbero anche non
interessare in maniera particolare questa relazione, se non fossero precedute da una domanda: «Ha
preso il Croce», si chiedeva Gramsci, «l’abbrivo dalla filosofia della praxis di Antonio Labriola?»
[82]. Una risposta qui non è data, in quanto la domanda era chiaramente retorica. In altra
occasione, infatti, Gramsci, dopo avere detto che dallo studio del pensiero di Marx, Croce era
giunto «alla conclusione che non si può parlare di un Marx filosofo e quindi di una filosofia
marxista, perché ciò che Marx si proponeva era appunto di “capovolgere” non tanto la filosofia di
Hegel, quanto la filosofia in genere, di sostituire il filosofare con l’attività pratica, ecc.»; dopo avere
detto questo, dunque, osservava «che lo stesso Croce nel volume Materialismo storico ecc., in una
nota riconosce esplicitamente come giustificata l’esigenza di costruire sul marxismo una “filosofia
della praxis” posta da Antonio Labriola» [83], e che, sotto l’influenza, appunto, di quest’ultimo
aveva «ritradotto in linguaggio speculativo le acquisizioni progressive della filosofia della praxis e
in questa ritraduzione è il meglio del suo pensiero» [84].
Che Gramsci ritenesse tutt’altro che privo di importanza l'incontro tra Labriola e Croce, lo
provano ancora diverse pagine dei Quaderni: dopo avere detto, ad esempio, in polemica con un
certo modo di leggere la filosofia di Marx, che questa «ha avuto per tramite la filosofia idealistica,
ciò che ai marxisti legati essenzialmente alla particolare corrente di cultura dell’ultimo quarto del
secolo scorso (positivismo, scientismo) pare un controsenso», così proseguiva:
Per questo mi pare da rivalutare la posizione di Antonio Labriola. Perché? Il marxismo ha subito una
doppia revisione, cioè ha dato luogo a una doppia combinazione. Da un lato alcuni suoi elementi,
esplicitamente o implicitamente, sono stati assorbito da alcune correnti idealistiche (Croce, Sorel, Bergson
ecc., i pragmatisti ecc.); dall’altra i marxisti “ufficiali”, preoccupati di trovare una “filosofia” che contenesse il
marxismo, l’hanno trovata nelle derivazioni moderne del materialismo filosofico volgare o anche in correnti
idealistiche come il Kantismo (Max Adler). Il Labriola si distingue dagli uni e dagli altri con la sua
affermazione che il marxismo stesso è una filosofia indipendente e originale. [85]
A questo aggiungeva:
Per gli idealisti: vedere quali elementi del marxismo sono stati assorbiti “esplicitamente”, cioè
confessatamente. Per esempio, il materialismo storico come canone empirico di ricerca storica del Croce, che
ha introdotto questo suo concetto nella cultura moderna […]. Ma la parte più difficile e delicata è la ricerca
degli assorbimenti “impliciti”, non confessati, avvenuto perché, appunto, il marxismo è stato un momento
della cultura, un’atmosfera diffusa, che ha modificato i vecchi modi di pensare per azioni e reazioni non
apparenti o non immediate. Lo studio del Sorel può dare molti indizi a questo proposito. Bisognerebbe però
studiare specialmente la filosofia del Bergson e il pragmatismo per vedere in quanto certe loro posizioni
sarebbero inconcepibili senza l’anello storico del marxismo; così per il Croce e Gentile ecc. [86]
Per la verità, proprio l’idea di Croce, qui accolta da Gramsci, del materialismo storico come
“canone empirico di ricerca storica”, era stato uno dei motivi di forte dissenso con Labriola. In una
lettera che porta la data del 28 febbraio 1898, gli contestava «l’erronea opinione che il materialismo
è soltanto un nuovo canone di ricerca storica. Ma cosa vuol dire canone?», chiedeva: «Un metodo
di frugare nei libri, o un metodo di concezione? E se è questo non è forse una Weltanschauung?
Via», concludeva, «per aumentare il numero dei fogli di carta stampata che si chiamano storie, non
valeva la pena di far tanto rumore» [87].
A quali considerazioni di Croce Labriola qui si riferisse è fin troppo facile comprendere: nel
primo dei suoi saggi su Marx e il marxismo, Sulla forma scientifica del materialismo storico del maggio
1896, il cui scopo, scriveva Croce, era non già una sua personale indagine sulla dottrina di Marx e
di Engels, ma «soltanto di sottoporre ai colleghi alcune poche osservazioni intorno ad essa,
prendendola nella forma in cui si presenta in un libro recentissimo del professor Antonio Labriola
dell’Università di Roma» [88]; nel primo di quei saggi, dicevo, Croce giungeva alla nota
conclusione che «il materialismo storico non è, e non può essere, una nuova filosofia della storia,
né un nuovo metodo, ma è, e dev’essere, proprio questo: una somma di nuovi dati, di nuove
esperienze, che entrano nella coscienza dello storico» [89]. Questo argomento, che svalutava il
marxismo come “filosofia”, divenne oggetto di una discussione piuttosto vivace tra Croce e
Gentile, il quale si mostrava anch’egli, come Labriola, contrario alla riduzione del marxismo a
“critica”, “storia”, politica”; e alle sue obiezioni Croce così replicava:
Come già vi accennai, credo che l’interpretare il Marx dichiarando secondarie le sue vedute metafisiche,
non possa dirsi un procedimento comodo, ma giustificato; giacché è per lo meno tanto giustificato quanto
l’inverso, e forse più. Appercepirlo come critico della società presente e come storico di essa e come politico del
movimento proletario, è prender Marx in ciò che forma la parte veramente notevole della sua attività. La
filosofia è un condimento, e non è un buon condimento, del suo pensiero. [90]
Prima di proseguire il discorso sulle conseguenze filosofiche dell’incontro tra Labriola e Croce,
vorrei però indugiare su un particolare momento dei loro rapporti personali; e vorrei farlo
muovendo da una pagina piena di amarezza dei Taccuini di lavoro di Benedetto Croce, iniziati nel
1906, «per invigilare me stesso» [91] e diventati nel tempo un vero e proprio diario: «Mi pare»,
scriveva il 13 novembre del 1943, «di essere fallito finora in ogni mia azione politica, e mi torna il
dubbio, che ha regnato sempre in me, circa le mie attitudini politiche: dubbio che, giovane e
adulto, mi tenne lontano da quella forma di attività e tutto dedito agli studii» [92].
Quando Croce accenna ai dubbi che anche da giovane aveva avuto sulle proprie capacità
politiche, pensava quasi certamente alla discussione con Antonio Labriola, il quale, facendogli
conoscere il pensiero di Marx aveva di nuovo “accesa” la sua mente. Da allora per qualche tempo,
scriveva, «non potei più distogliermi da quei pensieri e problemi, che si radicavano e allargavano il
mio spirito»; pensieri e problemi, proseguiva, che «mi scossero tutto e suscitarono in me per la
prima volta un sembiante di appassionamento politico» [93]. Ma, come sappiamo,
«quell’appassionamento politico e quella fede non durarono» [94]; e Labriola se ne rese conto
abbastanza presto [95]. Questo lo irritò fino al punto di rivolgere a Croce qualche giudizio non
proprio lusinghiero sulla sua stessa persona, sul suo modo di essere: «Per tutte queste vedute
incomplete, immature o erroneo tu mi hai l’aria di un epicureo che mediti su le forme del pensiero,
ignaro della vita» [96]. Non era certo un giudizio benevolo, come non lo era quello contenuto nella
lettera di qualche mese dopo, precisamente del 6 maggio 1898, una lettera scritta, gli diceva
Labriola, «non per cominciare una discussione, ma per chiuderle tutte»; una lettera nella quale
indirizzava a Croce queste durissime parole:
Caro Croce, quanto sei terribilmente napoletano, ossia animale extra – e antipolitico: quanto sei
noiosamente letterato che nella carta stampata non vedi né gli uomini né le cose. Ed anche per questa
questione faccio punto una volta per sempre. Sono seccato anch’io di vedere che tu non vuoi capire, che
passando per socialista e per marxista, quello che scrivi non vale come semplice carta stampata, secondo il
senso dei letterati. E che altro devo dirti per spiegarmi – o non vuoi intendere? [97]
Il giorno successivo Croce replicando «con calma alla […] lettera senza calma» del suo maestro,
gli diceva:
E ci siamo intesi anche per la caratteristica che mi date di letterato. Non ho fatto mai nulla per autorizzare
la gente a credermi un uomo politico o un ispiratore politico. Vivo a Napoli, in un ambiente pessimo per la
politica. Anche se ci avessi inclinazione, io qui non sarei che uno sconclusionato che si dimena nel vuoto.
Lasciatemi, dunque, fare il letterato: almeno per ora, che non trovo di meglio da fare. Faccio questo mestiere
con fini onesti – ed è già qualche cosa, fra tanti che lo fanno per fini disonesti. [98]
Questa discussione non incise per nulla sui rapporti personali tra Labriola e Croce, che
durarono amichevoli fino al 1904, l’anno della morte di Labriola. Basta per tutto ricordare la
lettera, che merita di venire riportata per intero, che quest’ultimo indirizzava a Croce l’8 maggio
1898, quindi subito dopo avere ricevuto la lettera sopra citata:
Caro Benedetto, mentre in Italia si sta facendo come la prova generale della rivoluzione, credo sarebbe
quasi ridicolo occuparsi di Marx, Sorel ed altri simili accidenti: Come però ho la manìa di volerti bene, (– e
soffro della manìa di tutti gl’innamorati, d’indispettirsi con l’oggetto amato –) e checché tu faccia non posso
a meno d’interessarmi di te (– col debito rispetto d’ora innanzi della tua vita arciprivatissima –) così non
posso resistere alla tentazione di mandarti (con preghiera di rimandarmela) una lettera del Bonnet (al quale
io avevo semplicemente chiesto se Sorel fosse ammattito), lettera piena di curiosi particolari: e te la mando
perché tu veda come dietro alla carta stampata ci sian sempre… tante altre cose. / E basta di ciò. [99]
Come si vede, nonostante l’affetto che traspare da queste parole, Labriola non rinunciava a far
sapere a Croce che dietro la “carta stampata” ci sono sempre gli uomini e le cose. A tutto questo,
però, si deve aggiungere che Labriola non aveva fatto molto per indurre Croce a occuparsi di
politica attiva, finendo invece, indirettamente, con il favorire il disinteresse originario, naturale
quasi, del suo giovane amico, visti i giudizi che esprimeva sulla politica italiana, in particolare sul
socialismo e i socialisti. Lo confermano alcuni passaggi delle lettere indirizzate a Croce, quale, ad
esempio, quella del dicembre 1896, dove diceva di non trovare «nessuna ragione di [farsi]
compagno di un certo nuovo numero di avventurieri. Noi», proseguiva, «non siamo usciti dal
Bakuninismo, e il socialismo italiano è ancora fatto dagli spostati, dagli avventurieri,
dagl’imbroglioni e dagli snobisti»; [100] o quella dell’aprile 1897, dove si legge questa durissima
invettiva:
Tutti questi socialisti non vanno misurati alla stregua della causa del proletariato (che in Italia non esiste
come forza politica) né dell’ideale che ignorano, e quindi non conoscono, ma a quello dei loro piccoli affari,
mistificati di frase ideo–socialistica. Visti da vicino non sono… che dei piccoli affari: Ma appunto perché
pigliano questa veste sono degni di sputi in faccia. Che cosa ha reso spregevoli i preti… forse le qualità che
hanno comuni con gli altri uomini… o la dissonanza loro con l’ideale che immerdano?. [101]
E infine quella del novembre del medesimo anno, dove così liquidava il socialismo italiano:
«Tutto questo insieme di cose», scriveva,
che in Italia si chiama il socialismo diventa poco per volta una maffia, una camorra, una compagnia di
avventurieri, una banda di buontemponi, una manomissione di senso comune. […] Quando tu vorrai
conoscere in forma perfetta il paradigma di tali persone, io ti manderò la relazione (rarissima!) di Marx su la
cacciata di Bakunin dalla Internazionale (Aja). Lì imparerai tutto. [102]
Ho insistito a lungo su questi temi: la delusione per il “disimpegno” di Croce dalla politica e il
giudizio sul socialismo italiano, che quel “disimpegno” non poteva non favorire, anche se, è fin
troppo ovvio dirlo, non è stato certo quest’ultimo fattore, ma il rifiuto di vedere nel marxismo una
filosofia in senso forte, a indurre Croce a distaccarsi «intellettualmente dal Labriola che non sapeva
perdonarmi certe conclusioni che io traevo dalla sue premesse», come scriveva nella sua
autobiografia [103]; ho insistito su questi temi, dicevo, perché le repliche private di Labriola agli
argomenti (e atteggiamenti pratici) di Croce, sono certamente più efficaci e significative delle non
moltissime pagine dedicate da Labriola a Croce nei suoi lavori scientifici. E qui vorrei ricordare un
particolare non irrilevante. Nonostante Labriola sia stato un filosofo nel senso pieno della parola, e
a suo modo originale e innovativo, più che la stessa “filosofia della prassi” privilegiava la “prassi
politica” come tale. Merita al proposito di venire ricordata una sua lettera (“riservata”, si legge
nell'intestazione) dell’aprile 1886 indirizzata a Giosuè Carducci, dove annunciava al “caro collega”
di una probabile sua prossima candidatura nel secondo collegio di Perugia, e di avere già scritto
«gli appunti del futuro programma che vedranno la luce», proseguiva, «quando ai miei amici
parrà opportuno. Sono come la traccia dei discorsi che farei alla vigilia delle elezioni»; ma dove la
cosa più importante è la proposizione successiva: «Lascio stare il passato, e non faccio il filosofo»
[104]. O ancora, la lettera a Croce del settembre 1897, dove scriveva: «Si vede che quel Sorel è uno
di quegli uomini che vorrebbero salvare il mondo con una dottrina filosofica, e non si rassegna al
qui poterit capere capiat» [105].
Ma torniamo alle repliche di Labriola alle obiezioni di Croce, cominciando da una lettera del
marzo 1898, dove Labriola anticipava il tema di quella del maggio successivo, quando avrebbe
“gratificato” Croce con l’epiteto di “letterato”. «In tutti i tuoi scritti», gli diceva,
fino a due anni fa, che non mi mossero mai, né a passionato dissenso, né ad entusiastico assenso, io ho scorto
ed ammirato il divenire della tua coltura extra–accademica, nei cui saggi ho notato un solo difetto comune, un
certo che di scolorito e di troppo occasionale, un vero pregio comune, l’amore disinteressato della ricerca.
[…] Ora per la prima volta hai pigliato dei veri granchi a secco, esagerando per facilità d’ingegno, le doti
dell’acuta osservazione sopra cose le quali esigono altro lavoro di prolungata meditazione, di quella che non
convenga e basti per la critica storico–letteraria. [106]
I “granchi a secco” di cui qui diceva Labriola [107], dovrebbero riguardare, come del resto
confermano diversi documenti, le considerazioni sviluppate da Croce nel saggio apparso sul finire
del 1897, dal titolo Per l’interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo, al quale, come
vedremo, Labriola replicò pubblicamente sul finire di quello stesso anno. Ma è probabile che
Labriola si riferisse anche a qualche considerazione di Croce nella lettera (a noi sconosciuta, come
quasi tutte le altre) alla quale faceva riferimento [108], che doveva essere quella, di cui ho già avuto
occasione di dire, in cui Croce replicava all’accusa di non avere capito che il marxismo non era un
“canone di ricerca storica”, e nella quale per la prima volta gli aveva dato dell’“epicureo” [109];
una lettera che, diceva polemicamente a Croce, «se non fosse tua io potrei chiamarla quasi
scortese» [110].
Perché insisto su questo aspetto della discussione tra i due filosofi? Perché ci fa comprendere
che Labriola – nonostante scrivesse di non subordinare la sua amicizia verso le persone, e
soprattutto quella verso Croce, al suo giudizio sulle loro opinioni [111] – in realtà era piuttosto
insofferente di fronte alle obiezioni di Croce che giudicava “esterne” al problema del materialismo
storico, e di natura, appunto, letteraria: «Ma vuoi persuaderti», gli aveva scritto nella lettera alla
quale Croce sembra abbia risposto in maniera “quasi scortese”,
che quella teoria del valore–lavoro ha una portata più larga di ciò che importi alla corrente economica, come
spiegazione terra–terra dei fattarelli di tutti i giorni? Tu pigli il lavoro come una cosa esterna rispetto al tuo
pacifico ozio di epicureo contemplante – e quindi non puoi intendere perché la teoria del valore–lavoro
abbia rivoluzionato tutta la concezione della vita e della storia, in quanto l’economia è la scienza
dell’ordinamento della produzione». [112]
Insistere su questo aspetto delle critiche di Labriola, sul fatto che Croce affrontasse il marxismo
da un punto di vista intellettualistico, e non vedesse quello studio di per sé un impegno etico–
politico, potrebbe essere, a questo punto, superfluo. Diventa quindi di maggiore interesse
ricordare che alle obiezioni “filosofiche” rivolte da Croce al marxismo, più che direttamente a
Labriola, quest’ultimo – nonostante gli avesse in un primo momento detto che non essendo il
saggio al quale in questa occasione replicava, il già ricordato Per l’interpretazione e la critica di alcuni
concetti del marxismo , «né una critica né una recensione del [suo] libercolo», per cui non aveva il
dovere di rispondergli pubblicamente [113] – avrebbe risposto “pubblicamente” nel Post–scriptum
all’edizione francese di una delle sua opere più note, Discorrendo di socialismo e di filosofia, che porta
la data del 10 settembre 1898, quindi posteriore di qualche mese alla loro polemica epistolare, che
aveva avuto i momenti di maggiore tensione tra il marzo e il maggio di quello stesso anno, subito
dopo la comparsa (febbraio–marzo 1898) sul “Devenir social” della versione francese della
“Memoria” prima ricordata.
La critica di Labriola riguardava soprattutto quella che in quel testo Croce chiamava
l’“economia pura”. Marx ed Engels, aveva infatti scritto, hanno affermato che l’economia – quella
da loro “coltivata” – era una scienza storica: le loro indagini tuttavia, proseguiva, «non sono
storiche, ma ipotetiche e astratte, ossia teoriche. Di conseguenza, visto che la legge del valore da
essi assunto è la legge particolare dall’astratta società lavoratrice», l’economia marxistica «non è la
scienza economica generale» e «il valore – lavoro non è il concetto generale del valore» [114].
Abbiamo incontrato le obiezioni di Labriola a quest’ultima affermazione di Croce nella lettera
che gli aveva indirizzato il 28 febbraio del 1898. Qui, nel Post–scriptum, contestava duramente,
come prima ho detto, il concetto di “economia pura” che seguiva le considerazioni precedenti.
Scriveva:
Accanto, dunque, alla ricerca marxista può, anzi deve vivere e prosperare una scienza economica
generale, che stabilisca un concetto del valore, deducendolo da principi affatto diversi e più comprensivi di
quelli particolari del Marx. E se gli economisti puri, chiusi nella loro specialità, hanno mostrato una sorta di
gretta repulsione intellettuale verso le ricerche del Marx, i marxisti, a loro volta, hanno a torto disconosciuto
un ordine di ricerche ad essi estranee, dichiarandole ora oziose ora addirittura assurde. [115]
La replica di Labriola era qui molto più dura e severa di quando si rivolgeva personalmente a
Croce. Da dove Croce – si chiedeva – «trae la persuasione, che oltre alle varie economie succedutesi
nella storia […] ci sia poi una economia pura, che da sola dà luce e indirizzo a tutti questi casi o,
diciamo meglio, a tutte queste forme di prosaica esperienza?». E che cosa mai sarebbe, proseguiva,
questa economia “pura”? Forse
un animale in sé , oltre a tutti gli animali visibili ed ostensibili? E che cosa dovrebbe mai contenere cotesta
economia dell’uomo superistorico e supersociale, che finisce per essere più noioso dei superuomini della
letteratura e della filosofia? Forse la nuda dottrina dei bisogni e degli appetiti, data la sola natura ambiente,
ma senza esperienza di lavoro, senza istrumenti, e senza correlazioni precise, o di comunanza, o di società?».
[116]
Labriola non poteva sapere – e del resto non lo sapeva ancora nemmeno Croce – che questa
economia “pura” era, in caligine, quella che sarebbe stata una delle due forme dello “spirito
pratico”, la cui genesi risale certamente a queste discussioni. Le parole di Labriola diventavano
però ancora più “pesanti” quando portava il discorso sul terreno, diciamo così, filosofico,
mettendo in discussione il retroterra teoretico – o quello che riteneva fosse il retroterra teoretico:
Labriola non usa la parola “metafisica”, ma ci va molto vicino – di Croce. Dopo avere citato il
passaggio in cui quest’ultimo imputava a Marx di non avere stabilito «con metodica esposizione,
come i fatti apparentemente più diversi del mondo economico siano retti in ultimo da una
medesima legge» che «attraversa organizzazioni varie, senza mutare se stessa» [117], scriveva:
Qui Marx, se pure avesse voglia di rispondere, non saprebbe che cosa rispondere. Qui Marx non c’entra
più. E non si tratta nemmen più delle generalizzazioni [...] che pur sempre rientrano nei processi leciti di
astrazione e d’isolazione proprii ad ogni scienza, che partendo dalla base empirica tenti la via dei principii.
Qui ci troviamo in presenza di una legge economica, che a guisa di un quasi–ente attraversa misteriosamente le
varie fasi della storia, perché non s’abbiano a scucire. Questo è il puro possibile, che è poi l’impossibile. […]
Qui si tratta di riaffacciare delle difficoltà nella concezione preliminare di ogni problema scientifico, per le
quali rimangono fuori della comprensibilità, non solo Marx, ma tre quarte del pensiero contemporaneo. [118]
Le proposizioni successive sono una sprezzante liquidazione della tesi di Croce, trasferita, per
la verità piuttosto arbitrariamente, dalla sfera economica alla conoscenza generale: «La logichetta
formale, di felice memoria», scriveva, diventa nella visione di Croce «l’arbitro del sapere».
Teniamoci pure, proseguiva,
al testo, che in passato ebbe tanta diffusione in Francia, il Port–Royal. Si parta da un concetto della massima
estensione e del minimo contenuto, e per incremento di meccanica notazione si arrivi ad un concetto di
minima estensione e di massimo contenuto. E se ci capita poi tra le mani un processo reale, il passaggio, per
es. dall’invertebrato al vertebrato, o dal comunismo primitivo alla proprietà privata del suolo, […] invece di
fermarsi in tali atti, come in casi di epigenesi faticosamente e realiter accaduta, scriveremo in un concetto già
bello e preconcepito, per via di un facile metodo di notazione, prima un A, poi un a, poi un a1, poi un a2, poi
un a3, e così via: – e tutta sarà bello e fatto. E mi pare che basti di ciò. [119]
Come prima ho ricordato, il Post–scriptum porta la data del 10 settembre 1898. Quasi
contemporaneamente Labriola scriveva a Croce informandolo di quanto stava per essere
pubblicato, che, gli diceva, «riguarda proprio te»; e proseguiva dicendogli che quanto aveva
scritto, forse non gli avrebbe fatto piacere, «ma io memore dell’amicus Plato , con quel che segue,
non so che farci se andrai in collera» [120]. Come in quasi tutti gli altri casi non sappiamo in che
termini Croce abbia risposto a Labriola; sappiamo però che qualche giorno dopo Labriola così gli
scriveva: «Non t’immaginare che io abbia scritto delle impertinenze contro di te, e che abbia voluto
premunirmi contro l’effetto che le mie parole possono produrre in te. Io avrei voluto soltanto non
trovarmi mai nella necessità di criticare in pubblico ciò che scrivi. Perciò ti parlai di scrupolo filosofico».
Dopo avergli rimproverato di continuare a non volere intendere «che uno che sia fatto come me possa
essere intellettualmente offeso da certi ragionamenti», così proseguiva:
Dunque io non voglio farti, né socialista, né marxista, né il diavolo a quattro. Non voglio persuaderti di
nulla. Voglio solo difendermi – per lo meno dall’equivoco. Non si può essere buoni amici senza essere
collaboratori in un ordine d’idee? Una sola cosa mi permetto d’osservarti […] e questa cosa posso dirtela
perché va fuori del campo del socialismo, del marxismo e simili, e anzi rientra nelle mie mansioni ordinarie
di professore (che avranno spero ancora autorità sopra di te) ed è: che ti liberi dalla smania di ragionare dal
di fuori su i concetti, come se fossero cosette. I concetti bisogna concepirli rispetto ad un ordine determinato di
cose, come funzioni vive ». [121]
Ancora una volta Labriola rivolgeva a Croce l’accusa che gli aveva rivolto nella primavera di
quell’anno, di non essere, cioè, coinvolto in prima persona e fino in fondo nella sua ricerca
filosofico–politica, che conduceva senza pathos, senza passione. In ogni modo, nonostante quella
lettera si concludesse in tono, per così dire, conciliante, visto che Labriola diceva a Croce di non
avere inteso fare «una polemica contro tutta la [sua] Memoria», ma soltanto di avere «notato i
concetti che fanno a calci col marxismo» [122]; nonostante questo, dunque, Croce nella sua risposta
deve avergli ancora obiettato, sia pure senza spirito polemico, qualcosa, se la lettera che Labriola
gli indirizzò il 15 ottobre 1898 così cominciava: «Caro Benedetto, ti ringrazio della tua affettuosa
lettera. Io non ho mai negato il valore della logica formale, come istrumento didattico – ma non è
istrumento di ricerca, e non è teoria della conoscenza» [123].
Da questo momento in poi, tra Croce e Labriola lis finita est. La corrispondenza successiva vede
ancora Labriola discorrere con Croce di filosofia, di marxismo, con toni sereni e pacati, talvolta con
ironico distacco rispetto agli argomenti che pure li avevano divisi [124]. Come ho detto, all’inizio
questa discussione con il suo maestro – che Croce ha raccontato minuziosamente nel già ricordato
lungo saggio del 1937, dal titolo, per la verità poco felice, Come nacque e come morì il marxismo teorico
in Italia; questa discussione, dicevo, non è certa passata senza lasciare traccia non soltanto su Croce
ma sull’intera cultura italiana del Novecento: la quale deve ad entrambi qualcosa.
Luigi Punzo: Ho avuto dal comitato scientifico l’incarico di leggere la relazione del professor
Giarrizzo. Ho accettato con molto piacere soprattutto perché, pur se in questo momento mi trovo
ad essere esterno alla Facoltà, continuo a sentirmi di casa e quindi desidero dare questa ulteriore
testimonianza.
Giuseppe Giarrizzo: Labriola: la critica della società e della politica
Non v’ha storico della crisi italiana di fine Ottocento che non abbia incorporato nel proprio testo
giudizi e sentenze di Antonio Labriola (1843–1904), riguardassero la società la politica la cultura
contemporanee. Non è detto che ciò abbia contribuito ad una miglior comprensione della sua
critica “per frammenti”, che fu originale e acuta, della società e della politica. Seguirò quindi un
metodo diverso, e muoverò dalla fine, da quella estate del 1901 in cui Labriola avvia la redazione
di Da un secolo all’altro [125].
Labriola vuol districare “il grande intrigo della storia”, vale a dire «tutta la somma degli
impedimenti, pei quali, nel secolo decimonono, liberalismo, democrazia e principio nazionale
hanno subito così vari, così frequenti e così potenti arresti». Torna alla divisione tra l’Oriente
passivo e l’Occidente attivo: «La posizione attiva è sempre tenuta, alla fin delle fini e nel
tutt'insieme, dai neogermani e dai neo–latini: e ci troviamo perciò rimandati alla lunga tradizione
della civiltà mediterranea antica, continuatasi nella unità cattolica del Medioevo». Il principio di
nazionalità che ha trionfato in Italia e in Germania ha lasciato fuori greci, bulgari, serbi, rumeni; “la
infelice dilacerata Polonia”, i finlandesi ed “i mezzo dispersi armeni”: e la dinamica politica ha
sfidato la logica di quel principio. «Tutto cotesto assetto politico degli stati, che par fatto apposta
per muovere, come muove, alle incessanti proteste i caldi amatori del diritto di natura, della logica
e della giustizia, non sussisterebbe un sol giorno se la compagine interiore delle società che offrono
la materia su la quale si esercita l'arte di stato non fosse per se stessa piena di contrasti, e di
continuo sommossa dal perdurare e dall’intrecciarsi di tali contrasti». Accentuate e spesso
irreducibili differenze psicologiche sono fra rurali e cittadini, fra gli operai industriali e le “infinite
forme di artigianato”: da tali differenziazioni consegue la difficoltà a formarsi – «nel seno di una
società, che non è più giuridicamente gerarchica, ma che è di fatto multiformemente articolata» –
salvo che nei casi ai violente e repentine scosse, quella umanitaria opinione pubblica senza della quale
la democrazia non può sussistere. Da qui la violenza e la corruzione, nella Francia di Napoleone
III, nell’Inghilterra che reprime il cartismo, nella Germania ove Bismarck acclima ai mezzi
costituzionali il moto socialistico.
Due altri fatti confermano l’intralcio che “il complicato intrigo politico” ha opposto nel secolo
XIX al moto ascensivo della democrazia: l’assenza di una “vera cultura popolare” e il risorgere del
misticismo (e del cattolicismo) in un tempo che aveva conosciuto la crescita strepitosa della scienza
e della tecnica. Ne usciremo? La risposta (positiva) di Labriola va registrata nella compiuta
articolazione, perché è sulla persuasione del diritto a progredire che egli fonda la precedente
enumerazione dei contrasti: «per la prima volta gli uomini sentono che essi stessi fanno la storia
per entro alla collettività organizzata. L’intelligenza umana fra i civili d’Europa che tengono il
governo del mondo, è venuta per la prima volta in contatto coi viventi in tutte le regioni dell’orbe
terracqueo, e s’è resa conto dei modi d’esistenza di molte generazioni di nostri antenati [126]. La
consapevolezza dell’esser nostro s’è venuta come rinforzando, avvalorando, moltiplicando, Per la
veduta così allargatasi su i molteplici precedenti del nostro vivere attuale, la certezza dell’aver
progredito, l’aspettazione del progredire e la necessità del dover progredire han finito per
raccogliersi in una persuasione che ha sicurtà di fede. In questa sicurtà s’impernia un nuovo, più
profondo e più ampio senso di comunanza umana, che determina in molti ciò che può oramai dirsi
l’etica del socialismo, cioè il postulato della solidarietà contrapposto all’assioma della
concorrenza».
La nettezza dell’argomento impressiona: al pari del principio di nazionalità, l’assioma liberale
della concorrenza che ha diviso i popoli tra attivi e passivi è superato ormai dall'etica del
socialismo, vale a dire dal postulato della solidarietà – che nasce dal maturare della persuasione
del diritto a progredire in certezza dell’aver progredito. Donde l’attesa del progredire e la necessità
del dover progredire. Lo scenario mondiale ci consegna una teoria degli stadi, che illumina il
nostro passato e consegna al tempo stesso ai popoli passivi il viatico solidale della civiltà!
Il testo, l’incompiuto quarto saggio sul materialismo storico, è quasi un testamento. Perciò
riassume, con miglior respiro dell’ultimo corso universitario, l’intera parabola della riflessione
politica di Labriola, una riflessione che copre quarant’anni e s’iscrive nel quadro di una ricerca
coerente di filosofia della storia. Il cui “carattere originario” riceve evidenza fin dalla prima
formazione di quegli che si definirà “socialista teorico”: vi si assume la nazionalità compiuta come
presupposto della storica “missione di civiltà e di progresso” di uno Stato europeo dell’Occidente
(ne restano fuori la Russia e l’Austria imperiale). A questa missione Dio (o la Provvidenza) chiama
i popoli attivi che esercitano il loro ufficio provvidenziale in favore dei popoli passivi: ed a tal fine è
legittimo che li conquistino e li assoggettino alla forza del loro dominio, in attesa che maturi anche
in loro il seme organico della nazionalità e li aggreghi – in una prospettiva di universale progresso
– alla società dei popoli attivi.
E però la conversione di Labriola al socialismo, documentata fin troppo riccamente per gli anni
‘80, e che metterà capo al dialogo impegnato con la filosofia dello Herbart e di Steinthal, è maturata
in questi anni Settanta da una critica del liberalismo alle prese con la “questione sociale”, come
critica della borghesia e della società borghese, nel confronto tra la Germania di Bismarck e l’Italia
della Destra al tramonto. La società borghese della Germania si configura come una società
capitalista, un prototipo per leggere e misurare il ritardo della borghesia italiana post–
risorgimentale e per definire la modernità auspicata nei termini del neo–liberalismo tra Spaventa e
Bonghi, diretto a fondare una nuova Destra su una borghesia matura. Era stata la via di fuga
all’inizio degli anni ‘70 con cui Labriola si apprestava a rivedere lo schema spaventiano della
“circolazione delle idee”. Non sarà più quest’ultima a decidere della nazione–guida al progresso
civile, bensì il grado di maturità e compiutezza delle borghesie nazionali: in questa fase, il
trentenne Labriola si riconosce nel manipolo di intellettuali della Destra come Pasquale Villari e
Leopoldo Franchetti, che con diverse ascendenze si erano posti nel decennio alla ricerca della
“borghesia introvabile”, il legato singolare di un Risorgimento incompiuto. Per tutti loro la fine
politica della Destra e l’avvento della Sinistra sono l’esito politico di una borghesia immatura: ne
deriva l'obbligo del “nuovo liberalismo” di farsi carico (e Labriola è dall’inizio parte di questa
riflessione e di quel progetto) della maturazione di questa borghesia cui s’affida il compito di
compiere il Risorgimento e di risolvere in una prospettiva democratica la incombente questione
sociale.
La teoria “stadiale”, che Labriola fa propria, conosce – come si è visto – correzioni attraverso un
percorso fatto di contrasti, e condizionato inoltre dalle opposizioni tra popoli attivi e popoli
passivi. Il modello più avanzato di società è diventata per lui già negli anni ‘70 la società industriale
tedesca, cui corrisponderà un movimento socialista consapevole. La guerra franco–prussiana e il
modello della Germania guglielmina sono stati il contesto in cui Labriola venne saggiando la sua
critica della borghesia italiana e del liberalismo nazionale. Come far sì che l’Italia “Stato
nazionale”, diventando un paese liberal–democratico attraverso la maturazione d’una borghesia
capitalistica, si iscriva senza pentimenti nella schiera dei popoli attivi “per la civiltà e il
progresso”? È la concitata riflessione, l’esame del nesso borghesia/capitalismo a portare Labriola a
Marx che non è solo (come per l’Italia neo–liberale) un critico dei limiti della società borghese, ma
piuttosto il profeta della socialdemocrazia, vale a dire il portatore vigoroso d’una filosofia della
storia post–hegeliana che annuncia il trapasso “rivoluzionario” dall’esausto liberalismo alla “vera”
democrazia. A soggetto politico di questa rivoluzione non basta più quindi una borghesia liberale
matura (quale sognavano, in Germania e fuori, intellettuali e politici del fronte antibismarckiano),
bensì la prole nuova del capitalismo, il proletariato.
Germania docet! Quella società è qui, come nel resto dell’Europa, una società “borghese” a tasso
variabile di sviluppo: ma quali sono – a parte Marx e Engels, e poi Kautsky – le fonti della sua
rappresentazione della società tedesca? Confesso di non saperlo, e non conosco studi adeguati che
pur gioverebbero. Labriola non scommette più su un’evoluzione della società tedesca verso il
nazional–liberalismo, qual è suggerita dal sostanziale positivismo degli scienziati e dei politici
tedeschi, in un conflitto tra individualismo e collettivismo, tra psicologia individuale acquisitiva e
psicologia sociale “solidaristica”. Ma sono stati lo scontro parlamentare con Bismarck, l’atteso
sbocco democratico del processo in Germania a costituire la lezione utile per sbloccare l’impasse
politico dell’Italia tra Minghetti e Depretis.
E la “politica” della Germania guglielmina è altresì lo sfondo del suo giudizio sulla politica
europea: il caso italiano viene comunque misurato sul caso tedesco, mentre le alternative inglese e
francese (spagnola?) seguono un percorso che lo interessa per talune affinità e le molte divergenze,
non certo in quanto tale. È significativo che il caso italiano (società e politica) sia da Labriola
esaminato e giudicato in periodici socialisti tedeschi, con occhi tedeschi. Ai lettori del
“Sozialdemokrat” vorrà dare (giugno 1890) un breve schizzo della situazione economica e sociale
italiana, partendo dal presupposto che la cultura sociale degli italiani è arretrata. «L’Italia si trova
da alcuni anni nel momento storico del grande esercizio industriale ed agricolo appena incipiente,
e la politica del governo [..] sta necessariamente sotto l’influsso del capitalismo che ora si comincia
a formare. Diverse circostanze peggiorano ancora la situazione delle cose. Il capitalismo dipese per
lungo tempo e dipende anche ora dall’estero, sicché lo sfruttamento è doppiamente oppressivo e
doppiamente sensibile. La posizione politica dell’Italia di fronte alle potenze straniere ha condotto
ad un militarismo folle, che sta in vivo contrasto alla capacità di produzione economica del paese.
Le esagerate spese per l’esercito e per la flotta hanno reso la miseria economica del paese non solo
più grande, ma [..] lo pongono in una grande insicurezza finanziaria. Ora solo si forma
naturalmente e quasi impercettibilmente con l’abile utilizzazione della situazione finanziaria la
borghesia schiettamente moderna, per la quale il patriottismo e la politica parlamentare non sono
che buoni affari e opportuni campi di sfruttamento».
L’incipiente capitalismo, una borghesia non ancora moderna (in conseguenza della grande
insicurezza finanziaria) spiegano il lento processo della socialdemocrazia italiana ad uscire “dalla
indeterminatezza del radicalismo dottrinale” per entrare in campo con la formazione di un partito
operaio cosciente “con spirito di classe chiaro e intero”. Il Congresso di Roma (11–14 maggio ‘90)
ha provato ad elaborare un buon programma: ma a prevenire le illusioni stanno, contro la
combattività di settori operai, la crisi finanziaria prodotta dalla speculazione edilizia ed il
socialismo di Stato (“l’atteggiarsi del governo a somministratore di lavoro”, di lavori pubblici per
fronteggiare la questione sociale). E in uno scritto del 2 agosto ’90, sullo stesso periodico, Labriola
criticava l’illusione (Bakunin) “che una rivoluzione sociale verrebbe inevitabilmente e
immediatamente dopo la politica”, e del socialismo si pensava “come di un nuovo atto della
rivoluzione liberale”. Egli disegnava per contro il corso reale delle cose italiane: «Invece dei
volontari, si ha ora un sistema di esercito molto oppressivo, fatto sul modello tedesco. La
monarchia, fortemente collegata con le potenze conservative, si consolida all’interno con l’abile
maneggio del governo parlamentare, e con l’apparente democratizzazione. Il bilancio dello Stato si
è raddoppiato, e la grande borghesia è in continua formazione. La voce dell’opposizione
parlamentare, fatte poche eccezioni, si è quasi spenta innanzi al Crispi, diventato dittatore di sua
propria scelta. Mentre la povertà dei proletari cresce, e con la povertà l’emigrazione e il
malcontento, si sciupano in Africa milioni sopra milioni a vantaggio degli allevatori di schiavi di
nuovo modello. I mazziniani non sono più che cospiratori, e molti di essi sono diventati socialisti
temperati. La promessa rivoluzione non è venuta, e molti dei primi socialisti, senza l’uso di leggi
eccezionali, e solo con la cavillosa applicazione del diritto comune hanno dovuto e devono espiare
nel manicomio, nell’ergastolo, e in esilio il delitto del loro idealismo frettoloso. L’odio dei piccoli e
grossi borghesi contro la massa dei proletari inquieti si è aggravato, per abuso delle influenze di
patronato burocratico, municipale e parlamentare a vantaggio appunto della borghesia. Tutto ciò
colpisce tanto più ora che da anni è al timone la Sinistra, un tempo rivoluzionaria. L’insegna
storica del suo avvento consiste davvero nel fatto, che essa venne al governo per impedire
l’esercizio delle ferrovie da parte dello Stato!».
Ma il socialismo di Stato, gestito dal re e da Crispi, scompagina tuttora ogni tentativo di dare
consistenza ad un partito operaio: e poco appresso, collegandolo con l’insidioso diritto al lavoro ,
Labriola lo dirà facile istrumento di Cesarismo! E nel ‘91 – a commento del suo essere “socialista
teorico” – chiariva che in Italia le dottrine socialiste non erano più di una «anticipazione ideologica
sul moto vivo del proletariato, che lento ed incoerente confò da noi, non vi trova ne scorta, ne
guida, ne consiglio». Peraltro sarà “il corso naturale delle cose” a decidere del successo o
dell’insuccesso del socialismo e del Partito operaio che lo attua; ed hanno ragione quanti reputano
falliti gli sforzi di Labriola per contribuire alla formazione in Italia del partito socialdemocratico:
«Cotesti tentativi, da chiunque vengono, falliscono non solo per le persecuzioni poliziesche, ma
perché urtano nella presente condizione antagonistica degli interessi degli operai, i quali interessi
non sono ancora agguagliati dalla uniforme pressione del capitalismo. Ne la massa dei lavoratori
ha in sé gli elementi di cultura che concorrono per affermare il nesso e il senso dell’attuale vita
economica». «Mentre i capitalisti e il governo, che di quelli è il naturale alleato, dispongono di tutti
i mezzi atti a fornire completa orientazione sullo stato delle cose all’interno e all’estero, gli sforzi
degli operai più avanzati urtano in infinite difficoltà procedenti da interessi o locali, o di
consorteria. Tutto ciò toglie alle tendenze socialistiche quella unità e coerenza di moto e di azione,
che sole possono per via d’esperienza portar poi poco per volta alla formazione di un partito». È in
siffatto contesto che Labriola affronta la questione della emigrazione: essa, come il socialismo di
Stato, rallenta la proletarizzazione; e perciò («se pure l’Italia non è destinata a sparire dal numero
delle nazioni capaci di rappresentare la storia e il progresso») Labriola intravvede nel colonialismo
un modo di tenere ‘in patria’ l’intero esercito di riserva [127].
Questi trapassi Labriola li visse come un’illuminazione crescente. Se già all'inizio degli anni ‘80
individuava nel trasformismo “alla Depretis” l’inciampo che la politica oppone alla maturità della
borghesia, e al capitalismo in sviluppo. Donde la scelta “radicale” e l’attenzione rivolta ai
repubblicani di sinistra, e agli oppositori di Sinistra della politica del Depretis. Fino all’implosione
della metà degli anni ‘80, quando – prima dell’ultimo Ministero Depretis (1887) – la Pentarchia gli
si rivelava per insufficienza di progetto e per interne contraddizioni un’arma spuntata. La
“scoperta” di Engels e della vicenda socialdemocratica prende perciò il carattere spasmodico della
liberazione: l’obiettivo rimane quello originario, assicurare al popolo italiano il ruolo di popolo
attivo ed all’Italia la missione di civiltà e progresso per l’umanità. Ma l’antico quesito torna con
ritmo ossessivo: ci sono nella nuova Italia le condizioni per uno sviluppo economico che veda la
città “conquistare” la sua campagna, e l’industria ridare senso e significato “moderni” agli antichi
conati? A che serve riscoprire il comunismo medievale, nell’Italia comunale del Due e del
Trecento, nell’Italia studiata negli anni ‘80 e ‘90 dal Villari e dalla sua scuola? Solo a raffinare con la
storia l’analisi del rapporto tra politica e società in trasformazione, che dal 1885 egli vede come
decisivo per il radicarsi del socialismo (ideologia e partito) nell’Italia in crisi.
Non così per la Socialdemocrazia tedesca, che nel centenario della Rivoluzione francese può in
quello storico evento cogliere la fine dell’era della rivoluzione liberale, perché inaugura
consapevolmente la storia nuova (al Congresso di Halle, 28 settembre 1890), che interpreta il fato
della storia! «Mai più il moto proletario si disperderà per lenta esaustione come ai tempi del
Cartismo; mai più i proletari correranno dietro alle vane promesse delle fazioni politiche, perché
queste, levate su dal favore popolare, preparino per loro le amare delusioni parigine del giugno
1848; mai più chiederanno ai governi borghesi quello insidioso diritto al lavoro, che è così facile
istrumento di Cesarismo; mai più cederanno alle lusinghe di consorterie politiche e di potenti
demagoghi». Il riferimento costante e comparato alla Germania “matura” ed all’Italia “immatura”
consente di chiarire il processo attraverso cui la storia nuova del socialismo procede: essa avanza
“per vie nazionali”, che mettono capo ad una società pienamente capitalistica; il capitalismo
esercita una pressione uniforme sugli interessi degli operai e trasforma la reazione spontanea in
ricerca dei modi associativi per esplicare consapevolmente la lotta di classe. Per questa via una
nazione entra nel numero delle nazioni attive capaci di rappresentare la storia e il progresso, cioè
di una nazione attiva che attraverso l’Internazionale può associarsi alle altre nazioni attive, e
portare la democrazia sociale al trionfo sul liberalismo [128].
È una filosofia della storia, in cui permangono tratti del modello hegeliano–spaventiano ove la
nazione è chiamata alla missione di impersonare il progresso: qui però non sono più le idee a
circolare, assicurando un livello cui le perdenti debbono riferirsi. Quel che all’Italia mancava e di
cui aveva un bisogno urgente era quindi un partito socialdemocratico come lo aveva fatto la
Germania: lo scopo domina pensiero ed azione di Labriola fin dai secondi anni ‘80. La missione
della Germania e dell’Italia, e con esse di Francia Inghilterra e Spagna è diventata ora, per questa
via, realizzabile col socialismo e nel socialismo: urge perciò rimuovere le condizioni, materiali e
culturali, che ostacolano la diffusione del marxismo, che sono peraltro le stesse che vi fanno
ostacolo alla creazione di un partito socialdemocratico. La Francia aveva chiuso (si è visto) col 1789
l’era del liberalismo borghese: stenta per ragioni proprie (che nel carteggio con Sorel Labriola
prova ad analizzare) a proceder nello sviluppo capitalistico, e nella formazione d’una vera
democrazia: la penetrazione del marxismo la salverà! Più indietro la Spagna traversata da
incoerenti conati riformistici che ne frenano l’evoluzione. E lo stesso vale per l’Inghilterra
“coloniale”.
E l’Italia? La tenuta dell’artigianato, ed il socialismo di Stato bloccano la proletarizzazione della
forza lavoro: e senza il passaggio dalla rivolta spontanea alla consapevole lotta di classe che si fa
attraverso il partito socialdemocratico si resta fermi al palo con conseguenze disastrose per
l’eventuale progresso del paese che esce dal novero degli attivi e della civiltà. Questo, detto per la
società, vale quindi anche per la politica? Al centro si era posta la netta condanna del trasformismo
“alla Depretis”, e l’attenzione breve per la Pentarchia: quando però nel 1887 Crispi e Zanardelli
accettano di entrare nell’ultimo Ministero Depretis e Alfredo Baccarini sceglie di restarne fuori,
Labriola ne trae occasione (Roma 14 novembre 1887) [129] per ridefinire il “governo parlamentare”
(«La lotta contro il trasformismo fu giusta e legittima precisamente perché regolata dal bisogno di
ristabilire la retta opinione del governo parlamentare»): «Il governo parlamentare non può
funzionare praticamente ed utilmente, se l’iniziativa politica, che gli deve essere esclusivamente e
chiaramente riservata, non è circoscritta e limitata dalla responsabilità di tutti gli atti del potere
esecutivo, che abbiano attinenza con gli interessi dei cittadini. Finché il novanta per cento della vita
pubblica [...] non sarà sottratto alla mutazione dei partiti nel governo, perché solo il dieci per cento rimanga
argomento di lotta e di dissenso, non si riuscirà mai ad impedire che la massa degli interessati alla vita
pubblica non si affolli intorno al potere: alcuni per farsi vedere, altri per imporsi col numero, e tutti
concordi nell’affogare la voce di chi comanda, e con la voce il pensiero, in un applauso
infinitamente prolungato. A cotesto sentimento di giustizia e di alta opportunità politica vogliono
essere conformate le nostre opinioni circa l’ordinamento della sicurezza pubblica, e dei poteri
giudiziari, e circa i limiti della responsabilità dei pubblici funzionari [...]. Lavoro ingrato per chi
debba vincere il vecchio pregiudizio liberale della gran garanzia che offrono i voti parlamentari di
piena ed incondizionata fiducia; il che di fatti a volte si risolve in insidia, a volte in burletta,
potendo tornar comodo assai spesso ai ministri, che col voto favorevole su l’indirizzo generale
politico si mandi loro buona anche l’offesa dei diritti e degli interessi e tornando non sempre
incomodo ai deputati di risolvere col si che danno, se non gli affari propri di loro, quelli almeno
spettanti agli elettori. Risolversi per la politica di partito, evitando gli scogli della partigianeria,
ecco il porro et unum della questione».
Labriola teme che si consolidi “un governo arbitrario ammantellato di apparenze
parlamentari”: «Finché non sarà lecito di agitarsi e di agitare politicamente, senza danno dei più
elementati interessi propri e d’altrui, e finché coloro che occupano gli stalli di Montecitorio non
saranno rappresentanti veri e propri degli interessi generali della nazione, invece di essere
elementi fissi e numerati nel quadro organico della gerarchia dello Stato, il paese [...] non saprà
nulla dei benefici reali della libertà, e la vantata democrazia delle istituzioni rimarrà in perpetuo
una figura retorica». La prova del vero carattere “politico” del governo parlamentare sarà data dai
rapporti Stato–Chiesa (la Chiesa, «come interna allo Stato, non può sottrarsi ai nostri interessi di
diritto e di amministrazione»: urge «limitare l’azione didattica del clero a quello soltanto che gli
occorre per reclutare i suoi mèmbri, e sciogliere la parrocchia dai suoi vincoli territoriali per ridurla
in libera e legale associazione, che amministri da sé i fondi necessari al culto») e dalla “politica
sociale” che deve assumer l’obbligo dell’assistenza per quanti siano inabili al lavoro. Ma anche
dalle garanzie della libera ricerca nell’Università (novembre 1896). «Perché all'Università la scienza
libera ci arrivi bisogna che la società sia di tale assetto da produrne gli incentivi e le condizioni
d’esistenza. Coteste condizioni sono ora tali da permettere alla scienza di svolgersi fuori della
cerchia dell’insegnamento in innumerevoli funzioni sociali. L’Università insomma, come è ora, è essa
stessa un riflesso ed un risultato della vita sociale. Per ciò appunto i professori han cessato di essere
una casta. L’opera nostra è tutta al giorno d’oggi nel lavoro, che non è un semplice attributo dei
singoli cervelli nostri, ma è quello che si fa, si produce e si sviluppa per entro alla cooperazione di
tanti discutitori e critici, ed emuli, e concorrenti. Anche questo lavoro è fondato, come tutti gli altri,
su la secolare accumulazione delle energie, e sull’esercizio della cooperazione sociale. Anche noi
professori, con tutto quello che noi facciamo, noi siam vissuti dalla storia; che è la sola e reale
signora di noi uomini tutti».
La Storia che è pur fatta dagli uomini associati è ormai, nell’ultima visione profetica, una
garante del progresso della civiltà e dell’umanità. Il secolo XIX aveva con la rivoluzione delle
nazionalità esaurito il tempo del liberalismo e della borghesia maturi: aveva diviso l’umanità in
popoli attivi e passivi, ma la legittimità dell’azione dei primi era assicurata solo dall’ufficio di
promuovere a democrazia (e non più a mera libertà formale) i popoli passivi. Questo compito di
solidarietà spettava al socialismo, l’etica dell’umanità futura che promuoveva la politica a impegno
collettivo di promozione umana, rimuovendo e non difendendo gli ostacoli che contrastassero alla
diffusione della civiltà e della cultura. La filosofia della storia era cresciuta a profezia, se la Storia
non era ridotta a sogno utopico bensì a garante del disegno religioso di un’umanità al tempo stesso
solidale e progredita. Il secolo XX sarebbe stato il secolo del socialismo dispiegato dei popoli ormai
tutti attivi: e il millennio era il testamento astorico del grande analista. Toccherà a Croce
“sistemare” Labriola, pensiero e azione, entro il sontuoso sudario del realismo politico: il socialista
teorico era liberato del tormentoso circolo di pensiero ed azione. E consegnato alla politica
machiavellica con un procedimento che sarebbe piaciuto a Gramsci, non certo al “paradossale”
Labriola. Ma forse dovremo rileggere con Labriola quella crisi a cavallo dei secoli, di cui egli aveva
voluto farsi interprete per suggerire un modo definitivo di superarla: e restituendo coerenza ai
frammenti, comprenderemo meglio lui ed il tempo tragico che fu suo.
Gennaro Sasso: Abbiamo ascoltato la relazione del professor Giarrizzo, densa come sempre.
Sarebbe bello che Giarrizzo fosse qui per discuterne con lui, ma ci sarà certamente un’altra
occasione.
In questo momento io mi trovo in difficoltà perché a metà convegno debbo dire qualche parola
introduttiva – circostanza, questa, abbastanza curiosa. Questi centenari, queste ricorrenze, sono in
realtà decise dal calendario, poi accadono quando accadono, talvolta in momenti propizi, talvolta
anche in momenti inerti. Non so se questo momento sia particolarmente propizio a un
ripensamento delle varie questioni che il pensiero di Labriola pone. Certo, se dovessi giudicare
dalle cose così come appaiono, direi di no. Infatti, un momento così depresso dal punto di vista
culturale, dal punto di vista politico, aggiungerei anche dal punto di vista morale – ma vorrei
astenermi dal fare del moralismo – raramente mi è capitato di vederlo nel corso della mia vita, che
ormai tanto breve non è stata. Tuttavia, poiché sono sicuro che bisogna avere anche un certo
ottimismo, credo che questa circostanza centenaria possa essere sfruttata dalle persone di buona
volontà per un ripensamento di molte questioni. Essenzialmente, direi, per un ripensamento del
marxismo.
È vero che, come insegnano gli specialisti di Labriola, forse ci sono anche altri momenti, nel suo
svolgimento intellettuale, che meriterebbero di essere rimessi in questione. Ad esempio,
bisognerebbe rivedere più da vicino, anche seguendo le indicazioni che furono date molti anni fa
da Giuseppe Berti, il rapporto complesso, problematico, in certi momenti anche abbastanza
tumultuoso, che Labriola intrattenne con lo hegelismo napoletano. Fu certamente un rapporto
importante, perché attraverso lo hegelismo napoletano Labriola prese contatto con Hegel,
pensatore fondamentale per un corretto e profondo ripensamento della filosofia e del pensiero di
Marx.
Tuttavia, credo sia soprattutto il marxismo che meriterebbe adesso, attraverso Labriola – e non
soltanto attraverso Labriola – di essere ripensato, anche perché mi sembra che nella riflessione
marxiana e marxista di Labriola ci siano molte delle questioni che il secolo XX ha elaborato nel suo
corso. Si consideri, ad esempio, la dicotomia trovata più volte all’interno del pensiero di Labriola,
una dicotomia non risolta, tormentosa tra il marxismo interpretato, semplificando, come un
metodo per la interpretazione della storia – come un metodo particolarmente elaborato, un metodo
che era anche il prodotto finale, per così dire, più completo dell'intero sviluppo della storia – e il
marxismo interpretato, viceversa, come una filosofia della storia che non possedesse la chiave
fondamentale semplicemente per intendere il passato e il presente ma anche per intendere quello
che sarebbe accaduto. Ebbene, questa dicotomia ha dato luogo, anche nel periodo in cui Labriola
era vivo, per esempio, all’incipiente contrasto tra l’interpretazione di due giovani, che allora erano
alle prime armi, ma già abbastanza promettenti anche nell’interpretazione del marxismo, cioè di
Benedetto Croce e Giovanni Gentile.
Penso che su questi problemi occorrerebbe forse di nuovo riprendere la consuetudine di
riflettere, perché non credo che quello che è stato grossolanamente definito il “tramonto delle
ideologie” serva effettivamente da criterio per intendere ciò di cui dobbiamo occuparci e ciò di cui
non dobbiamo occuparci. Sono convinto, quindi, che in questo momento di autentica e profonda
crisi delle certezze ideologiche – che riguarda non semplicemente il marxismo, ma anche molte
altre forme del pensare politico contemporaneo – una riflessione profonda sul marxismo, e su
Labriola, che ne contiene in sé tante parti e tanti momenti, sia effettivamente auspicabile.
A me non resta da dire altro. Dunque, per adesso, annunciando che all’assenza del professor
Giarrizzo si è unita, purtroppo, quella del professor Cotroneo, vorrei dare la parola all’amico e
professore Siciliani de Cumis che svolgerà la sua relazione.
[1] A. Labriola, L’Università e la libertà della scienza, a cura di B. Croce, Milano–Napoli, Ricciardi,
1968, che ristampa la prima edizione, Roma, Loescher, 1897 (di qui in poi, L’Università). Qui e in
seguito preferiamo seguire le edizioni procurate da Croce, sia perché le successive non hanno
apportato significative variazioni, sia per un atto di omaggio a chi ha reso possibile la conoscenza
di Labriola, subendo in seguito ingiustificati e settari attacchi, giacché nessuno, in Italia e fuori, ha
fatto per Labriola ciò che ha fatto Croce. La prolusione ha ricevuto nuove ristampe nel 1961, nel
1970 e nel 1973. L’ultima si deve a Nicola D’Antuono (Lanciano, Itinerari, 1998, con ampio
commento). Le vicende della prolusione romana (dalla sua composizione alle polemiche
successive), sono ricostruibili attraverso le Lettere di Labriola a Benedetto Croce (Napoli, 1975) a
partire da quella del 23–4–1896 (ivi, pp. 108–109), in cui si annuncia l’incarico ricevuto, attraverso
quelle del 6–6–96 (ivi, pp. 125–126) e del 11–9–96 (ivi, p. 150) a quasi tutte quelle successive alla
lettura della prolusione e fino alla fine del 1896 (ivi, pp. 154–192), quasi interamente dedicate alle
polemiche suscitate e ai fastidi che ebbe il Labriola. Si veda, in particolare la lettera senza data (ma
del 27–11; ivi, pp. 159–162).
[2] I ed., Roma, Loescher, 1895. Qui si cita da La concezione materialistica della storia, a cura di B.
Croce, Bari, Laterza, 1938. Più recenti edizioni sono curate da A. Guerra e V. Gerratana (Saggi sul
materialismo storico, Roma, Editori Riuniti, 1964) e da E. Garin (Bari, Laterza, 1965).
[3] I ed., Roma, Loescher, 1896. Poi in La concezione materialistica della storia, cit., e nelle cit.
edizioni successive.
[4] I ed., Roma, Loescher, 1898. Qui si cita dall’edizione a cura di B. Croce (Bari, Laterza, 1938).
Anch’esso ripubblicato nelle cit. ed. Guerra–Gerratana, e Garin.
[5] Cfr. A. Labriola, Scritti di pedagogia e di politica scolastica, a cura di D. Bertoni Jovine, Roma,
Editori Riuniti, 1961.
[6] Tutte e tre le monografie si trovano ristampate nel vol. III delle Opere di A. Labriola, a cura
di L. Dal Pane (Milano, Feltrinelli, 1962), col titolo Ricerche sul problema della libertà e altri scritti di
filosofia e di pedagogia (1870–1883), che oggi va seguito per l’accuratezza dell’edizione.
[7] A. Labriola, L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 20.
[8] Ivi, p. 21.
[9] Ivi, p. 22.
[10] Id., La concezione materialistica della storia, cit., p. 55–56. D’ora in poi si cita in CMS.
[11] Id., Epistolario 1861–1890, vol. I, a cura di V. Gerratana e A. Santucci, Roma, Editori Riuniti,
1983, p. 44.
[12] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 14.
[13] Ibidem.
[14] Ivi, p. 17.
[15] Ivi, p. 23.
[16] Ivi, p. 17.
[17] Ivi, p. 25.
[18] Ivi, pp. 13–14.
[19] Ivi, p. 32.
[20] Ivi, p. 33.
[21] Id., Discorrendo di Socialismo e di Filosofia, a cura di B. Croce, Bari, Laterza, 1939, III ed., p.
116. D’ora in poi si cita con DSF.
[22] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 39.
[23] Ibidem.
[24] Ivi, p. 40.
[25] DSF, pp. 155–156.
[26] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 10.
[27] Ivi, p. 38.
[28] DSF, p. 83.
[29] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 10.
[30] DSF, p. 90.
[31] Ivi, p. 66.
[32] Ivi, p. 90.
[33] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 10.
[34] DSF, pp. 64–65.
[35] Ivi, p. 71.
[36] Cfr., ivi, p. 63.
[37] Ivi, p. 95.
[38] Ivi, p. 63.
[39] Ivi, p. 61.
[40] Ivi, p. 143.
[41] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 9 e cfr. p. 18.
[42] Ivi, pp. 11–12.
[43] Si veda questa prolusione romana del 28 febbraio 1887 in A. Labriola, Scritti filosofici e
politici, a cura di F. Sbarberi, Torino, Einaudi, 1973, vol. I, pp. 5–32. Su di essa cfr. S. Poggi (Antonio
Labriola. Herbartismo e scienza dello spirito alle origini del marxismo italiano, Milano, Longanesi, 1978) e
quanto ne dico in alcune pagine riunite ora in Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, vol.
III, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1977, pp. 386 e sgg.
[44] DSF, p. 54.
[45] CMS, p. 184.
[46] Ivi, p. 179.
[47] Ivi, p. 184.
[48] Id., Epistolario 1890–1885, cit., vol. II, p. 492: lettera a Engels del 13–6–1894.
[49] Ivi, p. 493.
[50] Id., L’Università e la libertà della scienza, cit., p. 12.
[51] Id., Epistolario, vol. II, cit., p. 493.
[52] Ivi, p. 494.
[53] CMS, p. 178.
[54] Ivi, pp. 184–185.
[55] Ivi, p. 179.
[56] DSF, p. 56.
[57] Ivi, pp. 166 e sgg.
[58] CMS, pp. 153–155.
[59] Ivi, p. 158.
[60] Cfr., p. 156–157.
[61] Ivi, pp. 247–248.
[62] Ivi, p. 156.
[63] Ivi, p. 167.
[64] Ivi, p. 165.
[65] Ivi, pp. 171 e 175.
[66] Ivi, pp. 176–177.
[67] Ivi, p. 179.
[68] Ivi, p. 141.
[69] Si veda la già cit. Prolusione in Scritti filosofici, cit., vol. I, p. 11.
[70] Cfr., CMS, pp. 165 e sgg.
[71] Ivi, p. 228.
[72] Ivi, pp. 231–232.
[73] Ivi, pp. 234–235. Sull’etica di Labriola si veda M. Corsi, A. Labriola e l’interpretazione della
storia, Napoli, Morano, 1963, pp. 164 e sgg.
[74] DSF, pp. 156–157.
[75] Ivi, p. 103.
[76] La pagina conclusiva fa riferimento alla classica interpretazione proposta da K. Löwith nel
saggio Max Weber e Karl Marx (1932) ora in Critica dell’esistenza storica, tr. it. di A. L. Künkler
Giavotto, Napoli, Morano, 1967, pp. 9–110 a cui ricorro per confermare alcune suggestioni di
lettura che ho suggerito qua e là in questo mio scritto a testimonianza dell’acuta lettura labrioliana
di Marx in relazione agli sviluppi novecenteschi delle sue dottrine. Credo in tal modo di aver
anch’io rifiutata la lettura di Labriola come di un marginale studioso di Marx. Aggiungo che tutto
lo studio italiano del marxismo di fine Ottocento (ad iniziare dalle interpretazioni di Croce e di
Gentile) va rivisto ormai lontano dalle pregiudiziali ideologiche, che hanno aduggiato le letture
più colte ed originali e smarrito lungo sentieri interrotti quelle astrattamente teoretiche. Sul
Labriola vanno sempre visti L. Dal Pane, Antonio Labriola. La vita e il pensiero, Roma, Edizioni
Roma, 1934, gli scritti di E. Garin e V. Gerratana premessi alle loro citate edizioni del Labriola, e i
seguenti volumi: N. Siciliani de Cumis, Studi su Labriola, Urbino, Argalìa, 1976; S. Poggi,
Introduzione a Labriola, Bari, Laterza, 1983, B. Centi, Antonio Labriola dalla filosofia di Herbart al
materialismo storico, Bari, Dedalo, 1984. Una rassegna di studi recenti può ricavarsi dal volume
collettaneo Antonio Labriola filosofo e politico, a cura di L. Punzo, Milano, Guerini, 1996, cui va
aggiunto G. Orsello, Antonio Labriola, Milano, LED, 2003.
[77] «Nelle indagini che hanno per oggetto la formazione spirituale del Croce», ha scritto Luigi
Dal Pane, «il Labriola occupa un posto molto significativo. E anche il Croce della maturità ebbe
sobbalzi che ricordano le sue esperienze giovanili. […] Ma le sorti della fama del Labriola, ebbero,
nel fatto di essere stato maestro del Croce, un impulso di grande portata. Mentre cresceva e si
allargava l'importanza del Croce si ricordava e si faceva attenzione anche al Labriola». L. Dal Pane,
Antonio Labriola nella politica e nella cultura italiana, Torino, Einaudi, 1975, p. 455.
[78] Ancora nel 1937 Croce definiva Labriola il «mio vecchio maestro dell’Università di Roma, al
quale», proseguiva. sono «rimasto legato e per gratitudine di quello che da lui avevo appreso e per
quello che sempre apprendevo dalla sua conversazione». B. Croce, Come nacque e come morì il
marxismo teorico in Italia, in Id., Materialismo storico ed economia marxistica, Bari–Roma, Laterza, 1973,
p. 253.
[79] Il 22 settembre del 1908, Sebastiano Maturi scriveva, a proposito del lavoro filosofico di
Croce, a Giovanni Gentile: «Ma, caro Giovanni, cosa pensi tu di tutta questa nuova filosofia del
nostro amico? Ma è filosofia?! È processo filosofico codesto? […] Ma riflettiamoci un po’: è bene
lasciar correre così? Tu mi hai sempre assicurato dei tuoi sforzi e delle tue incessanti fatiche per
fargli entrare in capo quella mentalità che noi abbiamo sempre presente in tutto. Ma in verità
questa presenza io non la trovo mai nella sua maniera d filosofare». Gentile gli rispondeva: «Delle
cose del Croce che vuoi che ti dica? Tu sai il mio pensiero, e puoi indovinare quello che approvo e
quello che disapprovo negli scritti del nostro amico. […] Ora vado almanaccando un certo articolo
a proposito del prossimo libro che egli pubblicherà col titolo Filosofia della pratica (da me scorso già
nel manoscritto). E lo pubblicherò se mi riuscirà di farlo che non paia una critica di concetti
fondamentali, e sia intanto, quello che dev’essere, una designazione dei limiti tra il vero e il non
vero del suo pensiero». Carteggio Gentile–Maturi, a cura di A. Schinaia, Firenze, Sansoni, 1987, pp.
273 e 278. Su questo tema mi permetto rinviare al mio Un idealismo “anomalo”, in Questioni crociane e
post–crociane, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, pp. 59–83.
[80] A. Gramsci, Quaderni del carcere , a cura di V. Gerratana, 4 voll., Torino, Einaudi, 1975, vol. I,
p. 1241.
[81] Cfr. B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, a cura di C. Farnetti, nota al testo G. Sasso,
Ed. Nazionale delle opere di Benedetto Croce, Napoli, Bibliopolis, 1996, pp. 223–235.
[82] A Gramsci, Quaderni del Carcere, cit., vol. I, p. 1241.
[83] A Gramsci, Quaderni del Carcere, cit., vol. II, p. 1060.
[84] Ivi, p. 1271.
[85] A Gramsci, Quaderni del Carcere, cit., vol. I, pp. 421–422.
[86] Ivi, p. 422.
[87] A. Labriola, Lettere a Benedetto Croce 1885–1904, a cura di L. Croce, Napoli, Istituto Italiano
per gli Studi Storici, 1975, p. 266.
[88] B. Croce, Sulla forma scientifica del materialismo storico , in Id., Materialismo storico ed economia
marxistica, cit., p.1. Lo scritto di Labriola qui oggetto dell’analisi di Croce era Del materialismo
storico, dilucidazioni preliminari, Roma, Loescher, 1896. Croce rinviava anche alla seconda edizione
del saggio, In memoria del “Manifesto dei comunisti”, apparsa l’anno precedente preso il medesimo
editore.
[89] B. Croce, Sulla forma scientifica del materialismo storico, cit., p. 9. Sull’argomento, N. Bobbio,
Profilo ideologica del Novecento italiano, Torino, Einaudi,1986, p. 16.
[90] A. Labriola, Lettere a Giovanni Gentile, a cura di A. Croce, introduzione di G. Sasso, Milano,
Mondadori, 1981, p. 57.
[91] Cfr. G. Sasso, Per invigilare me stesso. I taccuini di lavoro di Benedetto Croce, Bologna, Il Mulino,
1989.
[92] B. Croce, Taccuini di lavoro 1937–1943, Napoli, Arte Tipografica, 1987, p. 473. «Né»,
aggiungeva «mi feci illusioni di averle acquistate quando partecipai come ministro al governo del
Giolitti, perché allora amministrai con cura e devozione la cosa pubblica, come avevo fatto in
incarichi minori affidatimi in passato; né quando condussi in Italia l’opposizione degli intellettuali
contro il fascismo, perché questa opposizione era non direttamente politica ma anzitutto morale»
(ibidem).
[93] Id., Contributo alla critica di me stesso, a cura di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1989, pp. 33 e
34.
[94] Ivi, p. 35. Nel già ricordato saggio del 1937, Croce scriveva che quando ebbe ricevuto lo
scritto di Labriola, In memoria del Manifesto dei comunisti, «lo lessi e lo rilessi, la mente mi si riempì
di visioni e di concetti per me nuovi», per cui «preso dal sentimento di una rivelazione che si
apriva al mio spirito ansioso, non posi tempo in mezzo e mi cacciai tutto nello studio del Marx e
degli economisti e dei comunisti moderni e antichi, studio che dovevo proseguire intensamente,
per oltre due anni». Tuttavia, proseguiva, se mi era facile contentare Labriola «svolgendo una
metodica critica del Loira, o eseguendo ricerche storici copra questo o quel comunista, non mi era,
nonché facile, possibile di corrispondere alle maggiori speranze che egli aveva in me riposte». La
verità, diceva ancora, «è che io era preso da una passione taciturna e tenace per la ricerca
scientifica, indirizzata a risolvere alcuni problemi, che erano nel fondo del mio essere e che
faticosamente venivo traendo fuori e schiarendo a me stesso», per cui non poteva «sentire il
socialismo, e la politica in generale, al modo stesso in cui li sentiva un uomo di predominante
passione e disposizione politica; e, in questo riguardo tendevo a starmene in disparte, sebbene non
impartecipe». Da qui la conclusione: «Il materialismo storico mi si dimostrò doppiamente fallace e
come materialismo e come concezione del corso storico secondo un disegno predeterminato,
variante della hegeliana filosofia della storia. Ma, d’altra parte, lo vedevo nascere da una così
cocente esperienza storica, da una visione così penetrante della gran parte che l’economia ha nelle
umane vicende, che non ero disposto a passarvi accanto con la sufficienza di chi, dimostrato
l’errore di una dottrina, reputa di essersi sbrigato di tutto l’altro che la dottrina contiene e
dell’esigenza che l’ha fatta sorgere». B. Croce, Come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia,
cit., pp. 254, 255–256, 273, 274, 275.
[95] Ha scritto Luigi Del Pane che «Labriola aveva creduto ad un certo momento di farsi una
scuola, fidando soprattutto sulle forze intellettuali e morali del giovane Croce, che si distingueva
per l’eccellenza delle sue doti di ricercatore e di filosofo. […] Ma ben presto lo scolaro aveva
scavalcato il maestro e si era posto a intaccare le basi stesse della dottrina». L. Dal Pane, Antonio
Labriola nella politica e nella cultura italiana, cit., p. 431.
[96] A. Labriola, Lettere a Benedetto Croce, cit., p. 266.
[97] Ivi, p. 278. Merita di essere ricordata la lettera di Labriola a Sorel del 15 settembre 1897
dove diceva: «Se m’abbandonassi […] all’estro della conversazione, chi sa dove andrei a finire! – le
lettere diventerebbero una letteratura. Di ciò voi non mi sareste grato; per quanto potesse
allietarsene il signor Croce, il quale vorrebbe mettere in tutti il suo istinto di prolificazione
letteraria. Lui fa un curioso contrasto con le dolci abitudini di questa dolce Napoli, nella quale gli
uomini – come i Lotofagi che ogni altro cibi aveano in dispregio – vivono immersi nel solo
presente, e par che, proprio in cospetto della statua di G.B. Vico, allegramente faccian le fiche alla
filosofia della storia». A. Labriola, Discorrendo di socialismo e di filosofia, a cura di R. Finelli, Roma,
Ediesse, 1997, p. 243.
[98] A. Labriola, Lettere a Benedetto Croce, cit., p. 279. Nel volume citato sono inserite, oltre questa
indicata, altre quattro lettere di Croce (ivi, pp. 37, 45 e 46). Come si legge in apertura del volume,
sono “minute di risposte” conservate dallo stesso Croce (ivi, p. VIII).
[99] Ivi, pp. 279–280.
[100] Ivi, p. 186.
[101] Ivi, p. 207.
[102] Ivi, p. 231.
[103] B. Croce, Contributo alla critica di me stesso, cit., p. 35.
[104] A. Labriola, Carteggio, a cura di S. Miccolis, 3 voll., Napoli, Bibliopolis, 2002, vol. II (1881–
1889), p. 328.
[105] Id., Lettere a Benedetto Croce, cit., p. 220.
[106] Ivi, p. 268.
[107] Nel seguito della lettera gli chiedeva perché si ostinasse «a credere che Marx non abbia
spiegato a sé ed agli altri la sua posizione rispetto al pensiero contemporaneo, per il solo fatto che
non ha recitato la sua veduta in un serie di proposizioni confessionali, e come ti possa passare per
il capo che la morale kantiana che fu già profligata e persiflé dal codino Herbart, si regga ancora in
piedi per il tuo beneplacito». E proseguiva: «Tu disputi solo con te stesso e solo per sapere in che
posto della tua coltura tu debba collocare il marxismo. Mi spiego meglio ora: tu, cioè, non adduci
un ordine di fatti (salvo le sagaci osservazioni che fai sul quasi–insuccesso della politica marxista)
che stiano ad argomento obbiettivo della insufficienza di quella determinata dottrina, ma confronti
soltanto libri a libri, vedute a vedute, opinioni ad opinioni». Ivi, p. 269.
[108] «Io non voglio più tornare», scriveva Labriola a Croce nella medesima lettera, «né sul tuo
opuscolo né su la tua ultima lettera, per fermarmi nelle minuzie» (ibidem).
[109] «C’è una profonda differenza», scriveva ancora Labriola, «dal considerare la scienza e la
filosofia come Aufgabe, come missione, come Lebens– und Weltanschauung, al considerarla come
semplice passatempo di intellettualismo – e qui hai preso un quiproquo, su ciò che io dicevo
dell’epicureismo» (ibidem).
[110] A. Labriola, Lettere a Benedetto Croce, cit., p. 267. «Non ho mai creduto», gli diceva ancora,
«che tu ti fossi buttato al socialismo o avessi abbracciato il Marxismo, e ho riso sempre di cuore di
quelli che attribuivano a me questa tua conversione, che io non ho fatto mai nulla per produrla,
anzi ho creduto da tre anni in qua, come credo tuttora, che tu abbia cercato in questi nuovi studii
soltanto un complemento razionale alla tua cultura storico–critica–letteraria». Ivi, p. 267. Nel
dicembre del 1896 però, contestando i comportamenti di alcune figure della cultura dell’epoca in
qualche modo legate al “socialismo”, gli aveva scritto: «Noi mi pare che abbiamo qualcosa di
meglio da fare, per diffondere il socialismo scientifico: e poi verranno quelli che siano atti a farne
uso». Ivi, p. 185.
[111] Ivi, p. 267.
[112] Ivi, p. 266.
[113] Ivi, p. 269.
[114] B. Croce, Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo, in Materialismo
storico ed economia marxistica , cit., p. 67. In precedenza, dopo avere osservato che dopo tutte le
astrazioni di Marx sulle varie fasi dello sviluppo economico, non rimaneva nient’altro che «la
società economica in quanto società lavoratrice», aggiungeva: «La qual cosa è diversa dai lavoratori ed
operai nella nostra società capitalista, che sono una classe ossia un frammento di società
economica, e non già la società economica generica ed astratta, produttrice di ben aumentabili col
lavoro». Ivi, p. 62 e n. 1.
[115] Ivi, pp. 67–68.
[116] A. Labriola, Discorrendo di socialismo e di filosofia, cit., p. 156.
[117] Ivi, p. 159. Cfr. B. Croce, Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo, cit., p.
55.
[118] A. Labriola, Discorrendo di socialismo e di filosofia, cit., pp. 159–160.
[119] Ivi, p. 160.
[120] «Io non potevo tacere», proseguiva, «per tre ragioni – la prima è che il tuo scritto è
apparso in francese, ed ha l’aria di essere, mentre non è, un commento al mio saggio – in secondo
luogo perché il Sorel, quando mi onorava delle sue infinite proposte, fra le altre cose mi propose
che io mettessi quel tuo scritto quale introduzione al mio […] – in terzo luogo perché il Bernstein,
che non legge l'italiano mi chiese se la tua memoria io l’accettavo nei concetti fondamentali». A.
Labriola, Lettere a Benedetto Croce, cit., p. 301.
[121] Ivi, p. 303.
[122] Ibidem – Mi permetto segnalare il mio, Un intellettuale napoletano di fronte a Marx: Benedetto
Croce, in Il marxismo e la cultura meridionale, a cura di P. Di Giovanni, Palermo, Palumbo, 1984, pp.
9–31.
[123] A. Labriola, Lettere a Benedetto Croce, cit., p. 304.
[124] Porto come esempio la lettera di Labriola del 29 dicembre 1998: «Caro benedetto, procurati
il fascicolo XXXVII – del 18 Decembre – del Roma, Rivista parlamentare (alias crispina) che contiene
un articolo su l’agonia del marxismo di un preteso Linderer (da Berlino) il quale mi puzza le cento
miglia lontano d’italiano puro sangue, apologista dissimulato del Loria. Fra le altre cose dice: “Uno
studioso italiano, Benedetto Croce, che finora pareva chiuso nella rigida armatura marxista cerca
spiegare limitandoli i teoremi del Capitale”. Piano piano diventerai un ex–membro della Lega dei
Comunisti». Ivi, p. 320.
[125] A. Labriola, Scritti filosofici e politici, a cura di F. Sbarberi, Torino, Einaudi, 1973 , pp. 820–
57. Il brano del testo è alle pp. 826–31. «Parlando di un secolo decimonono [...], noi sappiamo
dunque di occuparci dell’ultima e della più ampia e dispiegata fase dell’evo borghese» (ivi, p. 841).
[126] «il cresciuto e sempre crescente raffinamento della ricerca economica, giuridica,
etnografica, e antropologica, per non dire della geografia, della statistica, della linguistica e della
mitologia e così di seguito, ci permettono di vedere in sempre nuove e sempre più ricche
prospettive e con più particolari contorni i diversi popoli e i diversi stati, non più distanziati da noi
dalle semplici date cronologiche, ma dai momenti di una evoluzione, che qui troviamo spezzata, lì
più dispiegata, e che poco per volta spezziamo» (ivi, p. 840).
[127] L’impero turco (A. Labriola, Scritti filosofici e politici, cit., pp. 911–13: febbraio 1897): se
vitali le nazioni debbono emanciparsi. Ma laddove «non v’è popoli che sian capaci di vera e
propria autonomia politica», deve esplicarsi «l’influenza del capitale, del commercio e
dell’industria europea, come a modo di conquista. In questa gara conquistatrice, che è sempre
legittima là dove non sono nazionalità vitali, la parte che tocca all’Italia è indicata da tutte le
ragioni della opportunità e della difesa [...]. Non brontolino i socialisti: anzi mettano sicuro il piede
sulla terraferma della politica. Noi abbiamo bisogno di terreno coloniale, e la Tripolitania è a ciò
indicatissima. Pensino che duecentomila proletari all’anno emigrano dall’Italia, senza indirizzo e
senza difese, e ricordino che non ci può essere progresso nel proletariato, là dove la borghesia è
incapace di progredire». Nella nota intervista a Torre “sulla questione di Tripoli” (aprile 1902),
Labriola da un lato espone le ragioni dell’impresa libica, dall’altro osserva: «la nostra immaturità
come nazione si rivela appunto in questo, che noi non possiamo predisporre la politica ad effetti di
lunga scadenza. Viviamo troppo del giorno per giorno, e crediamo che le grandi potenze mondiali,
le quali si sono imposessate, o delle grandi fonti naturali della produzione, o dei punti decisivi
geografici del commercio, abbiano soltanto vinto una specie di terno al lotto!» (962).
[128] Una variante è il caso polacco (A. Labriola, Scritti filosofici e politici, cit., pp. 864–67: Roma
10. V. 1896): «Per l’imputridimento della vostra vecchia aristocrazia, e data la posizione e l’animo
servile della vostra borghesia, i soli proletari sono capaci di emancipare la Polonia [...]. Gli operai
polacchi, e quelli della Polonia russa in ispecie, han percorso un buon tratto di via nello sviluppo
del socialismo: e trovandosi trasportati, per il rapido sviluppo della grande industria, nelle
condizioni di vita che son proprie dell’Europa occidentale, s’incontrano in difficoltà più gravi che
non sian quelle in cui versano i proletari di qualunque altro paese». Qui lo sviluppo della grande
industria ha creato un proletariato consapevole, che non dovrà aspettare una borghesia moderna
per farsi carico dello sviluppo “nazionale”: e però assume al tempo stesso l’emancipazione politica
e quella sociale!
[129] A. Labriola, Scritti politici 1886–1904, Roma–Bari, Laterza, 1970, pp. 113–20.