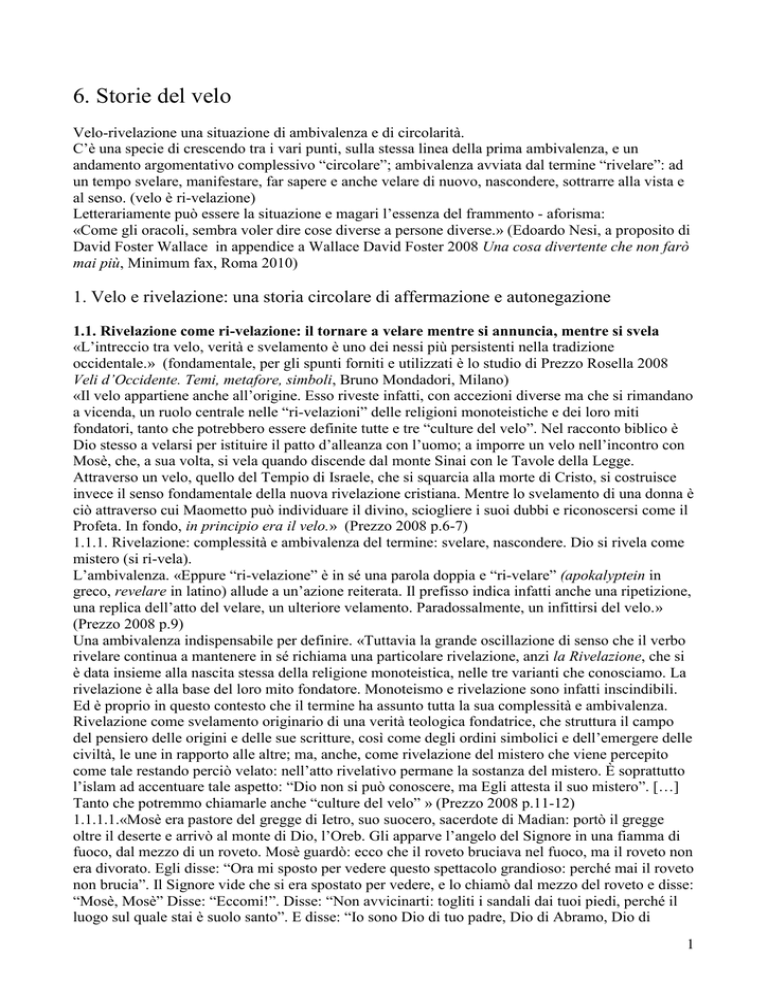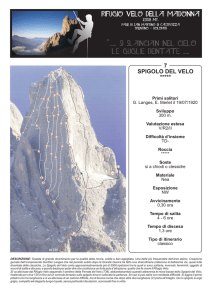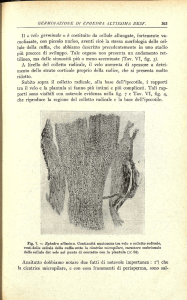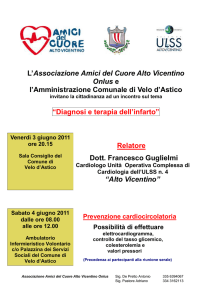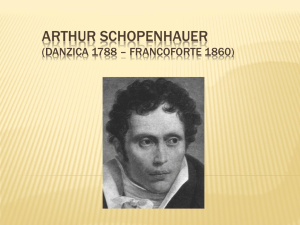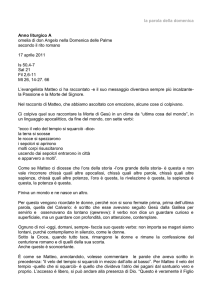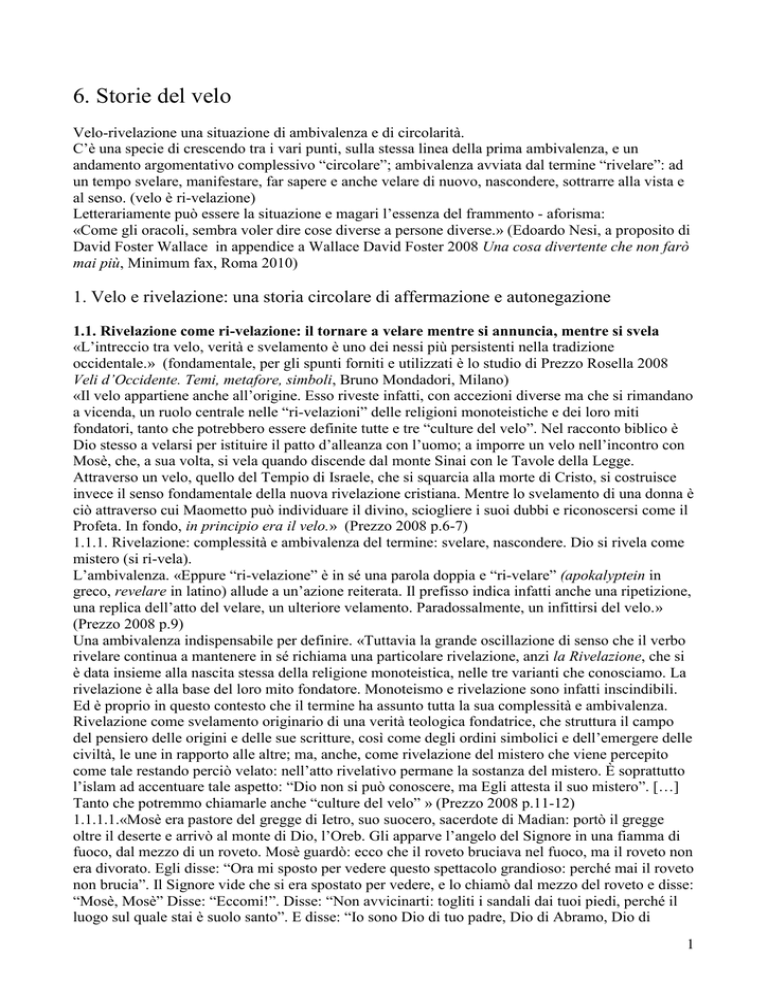
6. Storie del velo
Velo-rivelazione una situazione di ambivalenza e di circolarità.
C’è una specie di crescendo tra i vari punti, sulla stessa linea della prima ambivalenza, e un
andamento argomentativo complessivo “circolare”; ambivalenza avviata dal termine “rivelare”: ad
un tempo svelare, manifestare, far sapere e anche velare di nuovo, nascondere, sottrarre alla vista e
al senso. (velo è ri-velazione)
Letterariamente può essere la situazione e magari l’essenza del frammento - aforisma:
«Come gli oracoli, sembra voler dire cose diverse a persone diverse.» (Edoardo Nesi, a proposito di
David Foster Wallace in appendice a Wallace David Foster 2008 Una cosa divertente che non farò
mai più, Minimum fax, Roma 2010)
1. Velo e rivelazione: una storia circolare di affermazione e autonegazione
1.1. Rivelazione come ri-velazione: il tornare a velare mentre si annuncia, mentre si svela
«L’intreccio tra velo, verità e svelamento è uno dei nessi più persistenti nella tradizione
occidentale.» (fondamentale, per gli spunti forniti e utilizzati è lo studio di Prezzo Rosella 2008
Veli d’Occidente. Temi, metafore, simboli, Bruno Mondadori, Milano)
«Il velo appartiene anche all’origine. Esso riveste infatti, con accezioni diverse ma che si rimandano
a vicenda, un ruolo centrale nelle “ri-velazioni” delle religioni monoteistiche e dei loro miti
fondatori, tanto che potrebbero essere definite tutte e tre “culture del velo”. Nel racconto biblico è
Dio stesso a velarsi per istituire il patto d’alleanza con l’uomo; a imporre un velo nell’incontro con
Mosè, che, a sua volta, si vela quando discende dal monte Sinai con le Tavole della Legge.
Attraverso un velo, quello del Tempio di Israele, che si squarcia alla morte di Cristo, si costruisce
invece il senso fondamentale della nuova rivelazione cristiana. Mentre lo svelamento di una donna è
ciò attraverso cui Maometto può individuare il divino, sciogliere i suoi dubbi e riconoscersi come il
Profeta. In fondo, in principio era il velo.» (Prezzo 2008 p.6-7)
1.1.1. Rivelazione: complessità e ambivalenza del termine: svelare, nascondere. Dio si rivela come
mistero (si ri-vela).
L’ambivalenza. «Eppure “ri-velazione” è in sé una parola doppia e “ri-velare” (apokalyptein in
greco, revelare in latino) allude a un’azione reiterata. Il prefisso indica infatti anche una ripetizione,
una replica dell’atto del velare, un ulteriore velamento. Paradossalmente, un infittirsi del velo.»
(Prezzo 2008 p.9)
Una ambivalenza indispensabile per definire. «Tuttavia la grande oscillazione di senso che il verbo
rivelare continua a mantenere in sé richiama una particolare rivelazione, anzi la Rivelazione, che si
è data insieme alla nascita stessa della religione monoteistica, nelle tre varianti che conosciamo. La
rivelazione è alla base del loro mito fondatore. Monoteismo e rivelazione sono infatti inscindibili.
Ed è proprio in questo contesto che il termine ha assunto tutta la sua complessità e ambivalenza.
Rivelazione come svelamento originario di una verità teologica fondatrice, che struttura il campo
del pensiero delle origini e delle sue scritture, così come degli ordini simbolici e dell’emergere delle
civiltà, le une in rapporto alle altre; ma, anche, come rivelazione del mistero che viene percepito
come tale restando perciò velato: nell’atto rivelativo permane la sostanza del mistero. È soprattutto
l’islam ad accentuare tale aspetto: “Dio non si può conoscere, ma Egli attesta il suo mistero”. […]
Tanto che potremmo chiamarle anche “culture del velo” » (Prezzo 2008 p.11-12)
1.1.1.1.«Mosè era pastore del gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian: portò il gregge
oltre il deserte e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. Gli apparve l’angelo del Signore in una fiamma di
fuoco, dal mezzo di un roveto. Mosè guardò: ecco che il roveto bruciava nel fuoco, ma il roveto non
era divorato. Egli disse: “Ora mi sposto per vedere questo spettacolo grandioso: perché mai il roveto
non brucia”. Il Signore vide che si era spostato per vedere, e lo chiamò dal mezzo del roveto e disse:
“Mosè, Mosè” Disse: “Eccomi!”. Disse: “Non avvicinarti: togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il
luogo sul quale stai è suolo santo”. E disse: “Io sono Dio di tuo padre, Dio di Abramo, Dio di
1
Isacco, Dio di Giacobbe”. Mosè allora si velò la faccia per il timore che il suo sguardo si fissasse su
Dio.» (Esodo 3,1-6)
1.1.1.2. «Il Signore disse a Mosè: “Anche questa cosa che mi hai detto farò, perché hai trovato
grazia ai miei occhi e ti conosco per nome”. Gli disse: “Fammi dunque vedere la tua gloria”.
Rispose: “Io farò passare tutto il mio splendore davanti a te e pronuncerò davanti a te il nome del
Signore. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà”. E aggiunse: “Non puoi vedere
il mio volto, perché l’uomo non può vedermi e vivere”. Il Signore disse: “Ecco un luogo vicino a
me: ti terrai sulla roccia. Quando passerà la mia gloria, ti metterò nella fenditura della roccia e ti
coprirò con la mia mano fino a quando sarò passato; poi ritirerò la mia mano e mi vedrai di dorso
(di dietro); ma il mio volto non si vedrà”». (Esodo 33, 18-23)
1.1.1.3. «Adesso vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a
faccia» (Paolo, 1 Corinti 13,12)
Conclusione provvisoria. L’annuncio della rivelazione costituisce, nei libri delle religioni rivelate,
un evidente e ricorrente ossimoro: la rivelazione è rivelazione del mistero di Dio, che resta mistero
non svelato; è annunciato come mistero, velato nell’annuncio. Se dunque la rivelazione è l’uscita
del divino dal silenzio essa coincide anche con la consegna di una parola-mistero, non svelata nel
suo rivelarsi; a maggior ragione se tale parola viene poi presentata come indiscutibile dogma che
rende muti, al suo cospetto, i soggetti parlanti.
1.1.2. Rivelazione essenza della relazione. Ri-velazione: la distanza dell’altro che si rivela, si rivela
come altro, quindi manifestandosi si vela, appare come mistero, non noto.
[una lettura antropologica della teologia biblica].
«Ma che cosa, qui, si vela e si rivela o, meglio, si vela rivelandosi? »(Prezzo 2008 p.13) «Ciò
potrebbe suggerirci, al di là del testo sacro, che lo sguardo portato sull’altro corre sempre il rischio
di chiudersi in un moto di appropriazione. Laddove l’incontro impone di rispettare la parte nascosta
di ciascuno, al fine di evitare la presa di possesso che espone alla fusione e alla morte. Si tratta
allora di instaurare una distanza grazie alla quale lo scambio può aver luogo. Una distanza che offre
a ciascuno protezione, sicurezza e libertà di azione e movimento, permettendo «un processo di
differenziazione e di individuazione». Il pudore interverrebbe così a mettere un limite alla
possibilità di vedere l’altro nella sua nudità. E dato che il corpo è sempre erotico, desiderabile e
desiderante, “avere accesso a tale desiderio richiede la creazione di un velo, che ne moduli gli effetti
sull’altro e lo renda sopportabile”» (Prezzo 2008 p.14-15).
«Si aprirono allora gli occhi di ambedue e conobbero di essere nudi; perciò cucirono delle foglie di
fico e se ne fecero delle cinture» (Genesi 3,7)
1.1.3. Nella parola rivelata (della ri-velazione) l’ambivalenza della parola stessa: rivelazione e
parola..
[ancora per una lettura antropologica della teologia sia biblica che razionale]
Se il termine rivelazione è compreso quando se ne mette in risalto la ricorrente ambiguità (un
manifestarsi, svelarsi, che assume le forme del ri-velamento), la stessa parola rivelata è contagiata e
si caratterizza per questa ambiguità e dunque assume i tratti del mistero; ma, andando ben oltre, è la
parola in sé (non solo quella consegnata alla sacralità di una rivelazione divina) ad essere il luogo di
quella ambiguità: un dire che nasconde, un parlare che si realizza in quanto prende forma, in quanto
riveste percezioni, emozioni, sentimenti con parole che esprimono ma contemporaneamente
rivestono quelle esperienze che solo in quanto dotate di forme possono apparire, ma, così, di
conseguenza, svelarsi velate, manifestarsi in forza della forma, della velatura; non possono, del
resto, manifestarsi senza forma, senza velatura.
“La parola ha il compito di fare di questa distanza, che essa non abolisce né riduce ma che anzi
mantiene, abitandovi, «il luogo dell’intendersi”» (Prezzo 2008 p.17).
1.2 Velum scissum. “Et ecce velum templi scissum est” (Mt 27,51) e il vuoto nel velare e
rivelare.
2
Veli del tempio: veli che indicano e segnalano la presenza, ma la segnalano velandola,
nascondendola.
«… il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo» (Mt 27,51): lo squarciarsi del velo, svela
il vuoto, annuncia e segnala l’assenza.
«Forse il velo assume l’importanza cruciale di nascondere proprio questo: «uno spazio vuoto,
niente», niente da vedere. Il tabernacolo ebreo era fatto di bende, di panni di tessuto, di veli, e
quando si toglieva il velo non c’era infatti che uno «spazio vuoto». La religione riserva nel segreto
del tabernacolo un Dio nascosto, mentre gli ornamenti sacerdotali ne proclamano la presenza. Ma
non è che una presenza-assenza. Bisogna cogliervi il segno visibile di un soggetto che non esiste
che per l’Altro.» (Prezzo 2008 p.19-20).
1.2.1. Secondo il pensiero biblico ebraico (“sotto l’antica Alleanza” per il cristianesimo) «il Tempio
è il luogo per eccellenza del sacrificio e del culto. In esso due veli svolgono una funzione
imprescindibile. Un primo velo, una tenda, copriva l’entrata dello spazio santo delimitandolo da
quello profano; un altro separava il santuario dal santuario dei santuari, laddove era presente il
Tabernacolo, l’Arca dell’Alleanza con le tavole della Legge. A questa parte più sacra, nella quale
era custodito il mistero divino, nessuno poteva avere accesso, pena la morte. Solo il sommo
sacerdote vi penetrava con il sangue dell’agnello sacrificale una sola volta all’anno, in occasione del
“Giorno dell’espiazione”, per implorare la misericordia divina per sé e il proprio popolo. È la festa
di Kippur, il cui significato, dal verbo ebraico lekapper, è “coprire, rivestire, celarsi, nascondersi”.
Si tratta di un rituale per avvicinarsi proprio al dio che non può essere visto in faccia.» (Prezzo 2008
p.20; e vedi Selz Monique 2003 Il pudore. Un luogo di libertà, Einaudi, Torino 2005 p.119)
1.2.2. Nella nuova Alleanza, proclamata dal Vangelo. «È questo il velo che, secondo gli
Evangelisti, si squarcia «dall’alto in basso» alla morte di Cristo. Tale evento è accompagnato da un
terremoto e da uno spettacolare sconvolgimento della natura che ne sottolinea l’importanza epocale.
1.2.2.1. Caricato di forte valenza simbolica, il «velum scissum» indica il momento della verità
disvelata: la morte di Cristo ci rende direttamente accessibile la grazia di Dio, prefigurata dall’Arca
dell’Alleanza.
1.2.2.2. Ma proprio per questo lo spazio chiuso del tempio che la ospitava non avrebbe più ragione
d’essere, rimanendo solo un luogo buio e vuoto. Il tempo della religione sacra che separava gli
uomini da Dio sarebbe ormai concluso e un’altra era si inaugura, quella del Verbo incarnato. Il Dio
non è più quello lontano, che non si mostra, bensì quello che si è fatto carne.» (Prezzo 2008 p.2021)
1.2.2.3. «Cristo muore chiamando Dio ma egli non viene, lo ha abbandonato. Il velo (la tenda) del
Tempio di Dio, che nascondeva Yahvè in un santuario di oscurità e silenzio assoluto, si è lacerato
lasciando aperta la porta al mistero. Dio è ormai fuori, in quel corpo nudo che muore sulla croce.
Non si occulta più nel tempio chiuso, separato, inaccessibile, al di là del doppio velo teso, ma si
manifesta per sempre nella carne e nel sangue di Cristo. Questo uomo nudo che si sacrifica per
amore degli uomini, senza alcun velo che ne celi il corpo, è presenza stessa di Dio.» (Prezzo 2008
p.22)
1.2.2.4. Lo squarciarsi del velo del tempio evidenzia il vuoto: il divino-mistero è uno spazio vuoto.
2. la scoperta (svelare) attraverso il velo (ri-velare) della metafora
2.01. la direzione generale dello svelare rivelare. La funzione del velo, come è chiarita dalla
ambiguità produttiva presente nel termine “rivelazione” (ri-velazione) diventa la chiave per
comprendere la natura delle produzioni culturali. Nel mettere in evidenza attraverso forme variate i
settori della realtà di cui si occupano svolgono un compito di rivelazione. Svelano la realtà
mostrandocene aspetti e forme, quelle forme sono rivestimenti o veli che ri-velano quella stessa
realtà. Tutto il gioco della produzione culturale secondo aree di senso è consegnato a questa
dinamica continua dello svelare rivelando.
3
2.02. L’inizio del mostrare, la scoperta, è attuato attraverso una traslazione di parola e di sguardi. A
partire da una postazione già acquisita, si indica e si scopre un nuovo, finora ignoto, ora designato e
indicato con termini a disposizione che diventano metafora. Valga come esempio quella che viene
talvolta presentata come la prima e più feconda metafora della storia della filosofia e della scienza:
«Pitagora fu il primo a chiamare cosmo la sfera delle cose tutte, per l’ordine che esiste in essa.» 21.
AËT. II 1, 1 [Dox. 327]. Leggere matematicamente la realtà significa considerarla ordinata; viene
trasferito così alla realtà un termine nato in sede politica come progetto sociale; l’ordine, attribuito
alla natura come metafora, ne diventa poi una definizione: il mondo è cosmo.
2.1. Il gesto della metafora. Il gesto della metafora si configura come un atto per ricoprire un
vuoto, un’assenza, un disorientamento e un buio con il velo di un termine, di un’immagine, di un
concetto presi a prestito da ambiti già noti e trasferiti “misericordiosamente” allo scopo di
tamponare il vuoto, lo smarrimento o rendere possibile un nuovo percorso esplorativo. In questo
caso è dunque un velo che indica e svela; un velo che dando forma permette l’emergere di una
realtà finora ignota. La pietas di questo velare è tanto fondamentale e radicata che è possibile
sostenere, con Nietzsche, che l’intero linguaggio e conseguentemente il suo uso abituale risulta da
una circolazione continua di metafore (di tropi, variazioni, figure retoriche) e da una loro
sedimentazione.
2.1.1. una presentazione elementare e prima di metafora dalla Poetica di Aristotele: «La metafora
consiste nel trasferire ad un oggetto il nome che è proprio di un altro: e questo trasferimento
avviene o dal genere alla specie, o dalla specie al genere, o da specie a specie, o per analogia. […]
si ha poi la metafora per analogia quando, di quattro termini, il secondo, B, sta al primo, A, nello
steso rapporto che il quarto, D, sta al terzo, C; poiché allora, invece del secondo termine, B, si potrà
usare il quarto, D, oppure invece del quarto, D, si potrà usare il secondo. […] la “vecchiezza” (B) è
con la “vita” (A) nello stesso rapporto che la “sera” (D) è col “giorno” (C); perciò si potrà dire che
la “sera” (D) è la “vecchiezza del giorno” (B+C), oppure, come disse Empedocle, e anche si potrà
dire che la “vecchiezza” (B) è la “sera della vita”.» (Aristotele, Poetica 1457b9, 16 ss)
[come ricordi: “ed è subito sera” (sera – vita) (Quasimodo), gomitolo di strade, camice di neve,
polverosi specchi dell’estate, prima che il mattino canti (Ungaretti)… da Skàrmeta – Neruda “ritto
come un palo”, inchiodato come una lancia”, “più quieto di un gatto di porcellana” …
2.1.2. effetti emotivi e comprensivi della metafora, resi in metafora (o, nella metafora il circolo
ermeneutico della totalità)
Da: Skàrmeta Antonio 1985 Il postino di Neruda, Garzanti, Milano 1994 p. 18
Pablo Neruda ha appena recitato una poesia al postino Mario Jiménez , che osserva:
«Strano».
«“Strano”. Sei un critico severo!».
«No, don Pablo. Non è la poesia che è strana. Strano è come io mi sentivo mentre lei recitava la
poesia».
«Mio caro Mario, vedi di svegliarti un po’, perché non posso passare tutta la mattina ad ascoltare le
tue chiacchiere».
«Come posso spiegarmi? Quando lei recitava la poesia, le parole andavano di qua e di là».
«Come il mare, allora!».
«Sì, ecco, si muovevano come il mare».
«E questo è il ritmo».
«E mi sentivo strano, perché con tutto quel movimento mi veniva il mal di mare».
«Il mal di mare».
«Certo! Ero come una barca cullata dalle sue parole».
Le palpebre del poeta si scollarono lentamente. «Come una barca cullata dalle mie parole».
«Sicuro!».
«Lo sai che cos’hai fatto, Mario?».
«Che cosa?».
4
«Una metafora».
«Però non vale, perché mi è venuta così, per caso».
«Non c’è immagine che non sia casuale, figliolo».
2.2. accusa ed elogio della metafora (e, soprattutto, della metafora per analogia)
2.2.1. tutto il male per l’analogia (e per le “velature”). “Le analogie sono letali”: nemiche della
conoscenza profonda e analitica, dissolvono le differenze, annullano ogni specificità e quindi ogni
conoscenza. È Tzvetan Todorov che, con particolare riferimento alle scienze storico sociali, mette
in guardia dalle metafore e dal pensiero analogico spesso veicolo dello “wishfull thinking”: il
leggere e definire gli eventi storici secondo i desideri profondi (talora istintivi e inconfessati) e
secondo le opportunità del momento.
La storia delle analogie tra ambiti ha pagine ancora più tristi.
2.2.1.1. Vale l’esempio del darwinismo sociale: 1. sulla natura si riflettono le concezioni politiche
della società in cui quelle teorie si sono sviluppate: guerra, competizione, adattamento, emulazione,
sopravvivenza; 2. una volta che metafore prese a prestito dal politico vengono proiettate nella
natura, così come le loro ideologie esplicite o implicite, diventano leggi naturali universali e
necessarie; 3. vengono quindi reimportate nella politica col fine di applicare al progetto
colonialistico il suggello di un ordine naturale indiscutibile e irrefragabile. Più in generale: spiego i
comportamenti animali importando nell’etologia comportamenti sorti per cogliere e descrivere il
sociale umano (sia che si tratti di biologia o di cartoni … il re leone, gli aristogatti, il capitan
nemo…), i comportamenti sociali diventano automaticamente normali e consacrati come naturali.
2.2.1.2. Vale l’esempio del ricorrere di formulari “obbligatori”, capaci di sfiancare ogni tipo di
metafora e di eliminare ogni forma di pensare in proprio.
«Scrivere dovrebbe essere un tentativo di ricerca, di inventiva, non già adesione al detto e ridetto,
un consenso che appaga le pigre attese del lettore. Il quale ama trovarsi comodamente sdraiato sul
già pronto all’uso, sul già confezionato. E capisco benissimo che debba accadere, quando l’urgenza
assilla, tant’è che se apri il giornale, trovi senza fallo l’«autentica prodezza», il «diffuso malessere»,
«in progressivo aumento», il «tema scottante», di «scottante attualità», la «svolta decisiva»,
l’«imponente spiegamento» di uomini e di mezzi, il «fatidico sì», il «parere diametralmente
opposto» [fino al ripetuto allarme, preventivo, pre-minacciante e vero alibi codardo, del “ci scappa
il morto”, pronunciato dai responsabili dell’ordine e della sicurezza]. Si tira via per la fretta,
cascando inesorabilmente nell’automatico. Tra le parole invece ci vorrebbero legami passeggeri e
non matrimoni indissolubili (lo diceva Alphonse Daudet nelle Notes sur la vie). Lo scrittore
autentico sa bene che l’aggettivo è l’amante del sostantivo e non già la moglie legittima. Se (apro
ancora il giornale) leggo cronaca politica, inciampo subito in un vivaio di replicanti: «un intervento
mirato», o «tempestivo», «un momento di aggregazione», «rispondere alle aspettative», «alle
istanze», «convogliarle» quelle istanze, «momenti di confronto», per una politica «capace di
confrontarsi con», si «sta minando la credibilità di…», ci sono «crepe nella maggioranza», siamo
«sull’orlo della crisi», «si respira aria di crisi»... Non è parodia, è soltanto una replica della
rappresentazione giornaliera, che va ripetendo che non è bene «abbassare la guardia», meglio una
«pausa di riflessione», già «si profila una schiarita», ma sta calando «la scure dei tagli alle spese». È
un tipo di italiano che tracima da tv e Tg, da interviste e comunicati vari dell’ufficialità: «occorre
fare chiarezza», «un colpo di spugna», «ha confessato con dovizia di particolari», «una mossa dagli
sviluppi imprevedibili», «inquietanti interrogativi», «un forte impatto ambientale», «qui si gioca il
futuro della ripresa», «i settori più delicati», «non ci faremo intimidire». Anche ardite innovazioni, a
forza di sentirne la ripetizione meccanica, sono diventate tediose: «l’arcipelago sanità», «il pianeta
giustizia», «il solito polverone», «siamo arrivati al capolinea», «la morsa del gelo», «la colonnina di
mercurio», «trincerarsi dietro...», «uscire dal tunnel», della crisi, della droga. Metafore vive quando
furono lanciate sul mercato, ma poi morte per tedio. Anche l’enfasi, l’abbondanza, è sempre quella:
un «caos indescrivibile», «di proporzioni bibliche» ogni fatto di cronaca, anche un «ingorgo», e poi
l’«esodo» per le vacanze, «spasmodica» l’attesa, «clamoroso» il colpo di scena, e «cifre da
5
capogiro», l’episodio «sconcertante», e via così con gli elativi. [aggettivi comparativi ma di cui non
esiste il secondo termine della comparazione]
Parole fast-food, precotte, predigerite, banalità di un neo-italiano omologato dai mass media, che si
va appiattendo e rimestando in se stesso, in un frasario ripetuto e stucchevole. L’omologazione, che
è il nostro avvenire, ci conduce al piattume del preconfezionato. La ricchezza del parlare si sta
spostando tutta dentro la specialità professionale e tecnica, che oggi è certo un codice ricchissimo e
vario, ma appena si lascia il settore e si torna uomini tra gli uomini, ecco che si ripiomba nel
ripetitivo. Anche vip e tecnocrati, appena abbandonano la sapienza del loro gergo settoriale, la
perizia nell’illustrare l’ultimo modello di un qualcosa, ripiombano nelle banalità: troppi marocchini
in Italia, a Bali le donne più belle del mondo, a settembre «vorrei farmi il Marocco», «mi sono
appena fatta il Kenya, a Capodanno mi voglio fare le Maldive», «non ci sono più le mezze
stagioni»...
Calvino concludeva le citate osservazioni sulla «pestilenza» che incombe con l’esaltazione della
letteratura, antidoto contro l’espandersi di quella peste che ha colpito politici, burocrati, intellettuali,
e poi si è estesa a masse sempre più larghe. Anche il linguaggio quotidiano, che fino a ieri era la
fonte viva a cui gli scrittori potevano ricorrere, «adesso non sfugge all’infezione», è un trionfo di
conformismi, automatismi, di formule generiche e anonime. Si è contagiati dal già troppo detto o
troppo scritto, le parole perdono in precisione e vitalità, si è da esse parlati, si comincia a ottundere
la capacità di discernimento tra ciò che conta e ciò che è superfluo tra ciò che è mezzo, mercanzia, e
ciò che è sostanza.» (Beccaria Gian Luigi 2006 Per difesa e per amore. La lingua italiana oggi,
Garzanti, Milano, p.17-18)
2.2.1.3. È necessario mettere in guardia dalle frodi subdole della metafora. Si tratta di inganni tanto
più gravi quanto più inavvertiti e etichettati come espressione della ricerca e della razionalità
scientifica sia nel campo della scienza che nei campi che ad essa fanno ricorso per definire
scientifica la propria linea di comportamento, come sovente accade nel campo della politica. Si
impone il compito di una coraggiosa disinfestazione: «Mostrare, per esempio, che l’immunologia è
tutta inquinata da metafore guerriere, che la neurobiologia consuma enormi quantità di principi di
organizzazione delle imprese, che la genetica si fa della pianificazione un’idea deterministica che
nessun architetto utilizzerebbe mai per parlare dei suoi piani significa denunciare altrettante frodi,
quelle attraverso le quali i contrabbandieri tentano di far passare valori contestabili mascherandoli
da fatti. Inversamente, denunciare l’uso che un partito politico fa della genetica delle popolazioni, i
romanzieri dei frattali o della teoria del caos, i filosofi del principio di indeterminazione della
meccanica quantistica, gli industriali delle leggi bronzee dell’economia [la “mano invisibile”, le
leggi “naturali” dell’economia] equivale a denunciare i contrabbandieri dell’altra sponda che fanno
passare in modo fraudolento, sotto la copertura della Scienza, certe affermazioni che non osano
esprimere chiaramente per paura di scandalizzare, ma che appartengono evidentemente al mondo
delle preferenze, ossia dei valori.» (Latour Bruno 1999 Politiche della natura. Per una democrazia
delle scienze, Raffaello Cortina editore, Milano 2000, 112-113)
2.2.2. tutto il bene per l’analogia. «Possedeva un formidabile istinto analogico, il quale non era
altro che il suo istinto logico portato al livello supremo. Appena posava l’orecchio a terra il velo
della dimenticanza veniva alzato. La memoria si risvegliava. Come al segnale di un razzo
fosforescente, tutto quanto stava sepolto nel baratro del ricordo si rivelava …» (P. Citati a proposito
di Thomas de Quincey in La Repubblica 29.07.1994)
Osserva Gianbattista Vico riferendosi alla fisica cartesiana: «prescrive di contenere le discussioni
fisiche entro brevi termini, a guisa di dimostrazioni geometriche e con divieto di ogni ornamento.
[…conseguentemente] essa limita negli ascoltatori quella facoltà che, propria dei filosofi, fa
scorgere analogie tra cose di gran lunga disparate e differenti, ciò che è ritenuto principio e base di
ogni fine e fiorita forma del dire. Non sono infatti la stessa cosa la sottigliezza e l’acutezza, giacchè
il sottile consta di una sola linea e l’acuto di due, e tra le molte acutezze il primo posto è tenuto
dalla metafora» (Gianbattista Vico De nostri temporis studiorum ratione, in Opere, Mondadori
6
Milano 1990 vol.I, p. 117; Pera M., Shea W.R. (a cura) L’arte delle persuasione scientifica,
Guerini e associati, Milano 1992 p. 173)
Il rapporto tra i quattro termini della metafora per analogia non si configura come un gioco di
carattere retorico, si presenta invece come un procedimento che fa emergere significati o addirittura
aree di senso insospettabili. «Ciò appare con maggior evidenza quando, di fronte a metafore che
stabiliscono analogie tra realtà diverse, ci accorgiamo che il risultato ottenuto attraverso la
trasposizione dei termini, non può considerarsi come la somma aritmetica dei singoli fattori;
l’immagine poetica conclusiva scopre invece relazioni nascoste e diventa dunque efficace strumento
di conoscenza.» (Gilberto Raffaelli, dattiloscritto)
2.3. il velo della metafora e la scienza: una ri-velazione. «Anche le scienze sono forme di
interpretazioni» (Hoy David, Il circolo ermeneutico, Il Mulino, Bologna 1990 p.118). «Il gioco
delle metafore nel discorso scientifico.»
2.3.01. Francesco Bacone (1561-1626). «Così l’edificio di questo universo appare nella sua
struttura come un labirinto all’intelletto umano che lo contempla; e sembra tutto occupato da vie
ambigue, da somiglianze ingannevoli di segni e di cose, dai giri contorti e dai nodi intricati delle
nature. Il cammino poi deve esser percorso sempre sotto l’incerta luce del senso, ora accecante ora
opaca, e bisogna aprirsi continuamente la strada attraverso le selve dell’esperienza e dei fatti
particolari. […] Ci occorre un filo conduttore per guidare i nostri passi, e tracciare la via fin dalle
prime percezioni dei sensi.» (Novum Organum, Prefazione) E compaiono in ricorrenza le metafore:
il cammino della scienza, l’edificio, l’universo, il labirinto, le vie ambigue, i nodi intricati, l’incerta
luce del senso, la strada, le selve dell’esperienza, le guide, gli erranti, il filo conduttore, i nostri
passi… È opinione diffusa che il linguaggio scientifico si distingua dagli altri codici linguistici in
quanto contrassegnato dalle caratteristiche dell’esattezza e dell’univocità. In realtà la scienza mutua
spesso termini da altri contesti linguistici, sia per colmare lacune del suo vocabolario, sia per
definire con maggior colore ed efficacia contenuti e percorsi del suo progetto; molti di questi
prestiti lessicali acquistano talvolta il valore di metafore dell’intera ricerca scientifica o di sue parti
essenziali. Metafore come l’«albero» della scienza, l’«edificio» della ricerca, il «labirinto»
dell’esperienza, il «cammino» delle scoperte, sono servite a raffigurare la ricerca scientifica nella
sua globalità, nella sua struttura, nelle sue difficoltà, nel suo procedere dinamico, con tale
suggestiva efficacia da far dimenticare la loro prima e diversa origine.
Lo studio della varietà dei campi linguistici da cui sono tratte, spesso inconsapevolmente, le
metafore scientifiche (il contesto religioso, quello politico, quello medico, quello giuridico ecc.)
permette sia di evidenziare le interrelazioni lessicali e concettuali tra saperi diversi, sia di mostrare
come la riflessione scientifica attinga da saperi, che non si qualificano come scientifici, alcuni dei
propri termini, delle proprie immagini, dei propri concetti.
Il fatto che la scienza ricorra sovente a metafore deve essere valutato non come segno di debolezza
o imprecisione del discorso scientifico, ma come segno della sua apertura e creatività: il carattere
aperto, non tecnico, non univoco della metafora mette infatti in luce la capacità della scienza di
accogliere spunti e stimoli dagli altri saperi e di intrattenere con essi rapporti dinamici e propositivi.
Il linguaggio dei primi filosofi moderni ci offre un ampio ventaglio di metafore che tende poi a
ripetersi nei diversi autori costituendo un bagaglio comune destinato ad ampliarsi e a trovare nella
scienza significati propri e funzioni specifiche. I testi di Bacone sono, in tal senso, un punto di
partenza obbligato: lo studio delle metafore di cui essi sono ricchi consente infatti di porre in luce il
significato e le funzioni della metafora nella scienza moderna e i legami che essa ha con gli altri
saperi.
2.3.02. Galileo Galilei (1564-1642) «La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico lo universo), ma non si può intendere se
prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in
lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi
è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro
7
laberinto.» (Il Saggiatore) La metafora del libro dell’universo. Tra le molte metafore che i filosofi
moderni utilizzano per dare efficacia e immediatezza alla loro esposizione (il viaggio, il labirinto,
l’edificio) quella del libro viene impiegata per indicare il mondo: essa consente una
contrapposizione tra il libro di carta (dell’auctoritas) e il libro della natura (dei sensi e della
ragione) e propone al filosofo-scienziato l’idea di un mondo interamente leggibile, interpretabile.
(All’uso della metafora del libro-universo nel testo galileiano sono dedicate alcune significative
pagine del saggio di H. Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura,
Il Mulino, Bologna 1984 pp. 63-78).
2.3.03. Renato Descartes (1596-1650) «La meditazione che feci ieri m’ha riempito lo spirito di
tanti dubbi, che, oramai, non è più in mio potere dimenticarli. E tuttavia non vedo in qual maniera
potrò risolverli; come se tutt’a un tratto fossi caduto in un’acqua profondissima, sono talmente
sorpreso, che non posso né poggiare i piedi su1 fondo, né nuotare per sostenermi alla superficie.»
(Meditazioni metafisiche).
«Allora come un uomo che cammina nell’oscurità e solo, presi la risoluzione di avanzare tanto
lentamente e con tanta circospezione in ogni cosa, per cui, pur progredendo di poco, evitassi tuttavia
di cadere.» (Discorso sul metodo)
«Al che l’esempio di molti corpi composti dall’artificio degli uomini mi ha molto servito: poiché
non riconosco alcuna differenza tra le macchine che fanno gli artigiani e i diversi corpi che la natura
sola compone, se non che gli effetti delle macchine non dipendono che dall’azione di certi tubi o
molle o altri strumenti, che… […] Poiché come un orologiaio ingegnoso può fare due orologi che
segnano le ore in egual modo… » (Principia philosophiae)
2.3.04. Isaac Newton (1642-1726) «Come dicono i filosofi. La natura non fa nulla invano, e
inutilmente viene fatto con molte cose ciò che può essere fatto con poche. La natura, infatti, è
semplice e non sovrabbonda in cause superflue delle cose. […] Perciò finché può essere fatto, le
medesime cause vanno attribuite ad effetti naturali dello stesso genere. Come alla respirazione
nell’uomo e nell’animale, alla caduta delle pietre in Europa e in America; alla luce nel fuoco
domestico e nel Sole; alla riflessione della luce sulla terra e sui pianeti.» (Principi matematici di
filosofia naturale)
2.3.05. Karl Raymund Popper «La scienza non si posa su un solido strato di roccia. L’ardita
struttura delle sue teorie si eleva, per così dire, sopra una palude. È come un edificio costruito su
palafitte» (Logica della scoperta scientifica)
2.3.06. James Clerk Maxwell. «Secondo la teoria di Maxwell, la luce è una forma di radiazione
elettromagnetica e di moto ondulatorio. Le onde del mare, quando si avvicinano alla riva, sono la
forma più familiare di moto ondulatorio … Einstein immaginò di muoversi alla velocità della luce
lungo un’onda luminosa. I surfisti si muovono alla velocità delle onde del mare, quindi l’ipotesi
sembra plausibile.» (Frank J. Tripler, Albert Einstein: uno scienziato reazionario, in Brockman
John (a cura di) 2006 Einstein secondo me, Bollati Boringhieri, Torino 2010 p. 70)
2.3.07. Albert Einstein. «Einstein terminò l’articolo facendo notare che se, davvero, la luce era
composta da tali particelle, la luce ultravioletta che colpiva una superficie di metallo avrebbe
spostato gli elettroni proprio come il pallino da biliardo sposta una palla di quelle raggruppate dal
rack a inizio partita» (Tripler 2006 o.c. p.73) La metafora delle palle da biliardo ha una grande
fortuna, e ricorrenza, nella presentazione della fisica quantistica e nel dibattito epistemologico
contemporaneo su legge, caso, caos. (cfr. Ruelle David 1991 Dal caso al caos, Bollati Boringhieri,
Torino 1992)
2.3.1. «La metafora come accesso epistemologico. È noto che la scienza, come a più riprese, sia
pure da punti i vista differenti, hanno ribadito R. Boyd e Th. S. Kuhn, è progredita a colpi di
metafore che, “proiettando” su ciò che non è ancora noto la strumentazione nota, diventano i veri
costituenti di nuove teorie. Max Black chiama interattive quelle metafore che non possono essere
sostituite da espressioni non metaforiche in quanto costituiscono “una ben caratterizzata operazione
intellettuale non riducibile a una analogia o a una similitudine”, e generative quelle metafore che
“creano esse stesse le somiglianze che noi vediamo tra le cose cui si riferiscono gli argomenti della
8
metafora stessa”.
Quando la metafora coglie una connessione tra le cose che la nominazione separa, allora, dice Th.
S. Kuhn, la metafora costituisce un vero ripensamento creativo che tra l’altro ci avverte “che un
altro linguaggio avrebbe potuto localizzare articolazioni diverse, che esso avrebbe potuto sezionare
il mondo in un altro modo”.
Del resto già con J. Locke e D. Hume l’empirismo settecentesco assegnava al linguaggio un ruolo
semplicemente euristico o concettuale, ma non referenziale nella costruzione delle teorie
scientifiche. Su questa linea A. Goldstein vede nella metafora linguistica lo strumento che “addita o
indica direzioni per futuri programmi di ricerca”, mentre W.V. Quine e J.S. Ullian non esitano ad
affermare che “il linguaggio estende i sensi”.
Molti successi epistemologici, scrive R. Boyd, sono stati raggiunti grazie agli “accessi epistemici”
dischiusi da metafore, “e proprio per questa ragione possiamo concludere che l’“imprecisione” delle
metafore non ne preclude l’impiego come costituenti di teorie scientifiche”. In ogni metafora infatti
“si nasconde una strategia per ricerche future, [...] e la sua validità è nel successo del programma di
ricerca che la metafora ha dischiuso”». (Galimberti Umberto 1999 Psiche e techne. L’uomo nella
realtà della tecnica, Feltrinelli, Milano, pp. 157-158.)
2.3.2. «La metafora come rimedio alle angustie metodologiche. Le conclusioni raggiunte dalla più
recente riflessione epistemologica consentono di percorrere una via che, ampliando il concetto di
vita, al di là della concezione determinista e fisicalista a cui neppure la biologia scientifica, come
abbiamo visto, riesce rigorosamente ad attenersi, consente di oltrepassare il dualismo anima e
corpo, spirito e materia, natura e cultura che, oltre a dividere l’uomo in realtà che poi risultano
incomponibili, non è in grado di esprimere quella specificità che fa dell’uomo un’ek-sistenza,
qualcosa cioè di dislocato rispetto alla sequenza evolutiva degli esseri che vivono, ma non
conducono la loro vita. Questa espressione di A. Gehlen: “l’uomo non vive, ma conduce la sua vita”
segnala quella differenza, per spiegare la quale non è richiesta l’introduzione dello “spirito”, ma è
sufficiente evitare quell’operazione che riconduce la biologia dell’uomo alla logica della materia, a
cui non la scienza, ma la tecnica scientifica, per le esigenze riduzionistiche della sua metodologia,
l’ha costretta, consegnando tutto ciò che fuoriesce da quegli angusti confini alle metafore dello
“spirito” che dischiudono scenari suggestivi, ma scientificamente inverificabili.
Ci sono infatti metafore che costituiscono veri e propri accessi epistemologici e metafore la cui
funzione è solo quella di supplire o rimediare angustie metodologiche. Tali sono le metafore che si
richiamano allo “spirito”, quando l’introduzione di questa categoria è richiesta solo per spiegare
quegli aspetti dell’uomo che risultano irriducibili allo statuto della materia. (Galimberti 1999 p159).
Osserva H. Blumenberg: «In maniera più bella non si può presentare la motivazione di un grande
complesso teoretico in figura di metafora; ciò che allo storico della scienza, il quale indaga
retrospettivamente i primi fondamenti della serie dei risultati di una disciplina, appare come
fondazione razionale e metodica, sorge e si sviluppa da un sottofondo di impulsi che prendono
forma in immagini e traggono non solo la loro direzione ma anche la loro forza da rappresentazioni
metaforiche.» (Blumenberg Hans Paradigmi per una metaforologia, il Mulino, Bologna 1969
p.154 )
2.3.3. in sintesi ed elenco, per quali aspetti la scienza è metafora, e la metafora nella scienza è velo
che rivela:
2.3.3.1. se il pensiero scientifico ha un’evoluzione e una storia, come il mutamento del metodo e del
paradigma, la metafora è la prospettiva che consente di cogliere e che determina storicamente il
cambiamento; l’evoluzione e il succedersi storico delle teorie è meglio presentabile come un
susseguirsi di descrizioni metaforiche, veri e propri programmi di ricerca e di sistematicità.
2.3.3.2. i sistemi scientifici esistono in forza di metafore assolute, “generative”: le metafore assolute
sono in grado di dare espressione ad una concezione originale del mondo capace di estendersi
progressivamente verso una nuova percezione della realtà colmando lacune e rispondendo a
richieste. Ad esempio, chiamare il mondo: cosmo, organismo, macchina, orologio, sfera, vita…e
per contrapposizione caos, vuoto, nulla, antimateria, universo, “pluriverso” …; definire il metodo:
9
viaggio, rivoluzione, bussola, filo…; introdurre i termini: possibilità, necessità, determinismo,
libertà … significa avviare percorsi di osservazione, di ricerca e di teoria.
2.3.3.3. le metafore permettono alla scienza di correggere la propria tendenza verso un eccesso di
isolamento specialistico che esclude drasticamente il legame tra gli ambiti disciplinari (scientifici e
no, misconoscendo così il loro indubbio apporto e prestito alla scienza in immagini, concetti e
ipotesi), cancella ogni ipotesi di rapporto tra scienza e pensiero e senso comune (ignorando il ruolo
che il senso comune, e i processi percettivi storicamente acquisiti e divenuti abitudine, svolgono nel
sostenere il passaggio ad un nuovo paradigma, secondo la logica delle rivoluzioni scientifiche
illustrata da Thomas S. Kuhn 1962 La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino
1978).
Concludi. L’alternanza delle metafore “generative”, nel corso del tempo, mette in luce la funzione
ambivalente del rivelare: la metafora rivela, svela, fa cogliere la realtà e ne permette la lettura e la
composizione teorica (il mondo è cosmo); la metafora ri-vela, copre con un vela la realtà
escludendo dalla propria costruzione altre rivelazioni, svelamento (se il mondo è cosmo non caos;
se è macchina non è organismo…). Ad essere velata, forse, in ultima analisi, è la realtà in sé.
3. la realtà velata
3.1. dall’essere al noumeno.
3.1.1. La concezione classica (iniziale e mitica) della filosofia è anche la storia dell’accesso
dell’uomo all’essere e quindi del suo incontro con la verità. È l’esperienza di iniziazione raccontata
in versi da Parmenide ed è la definizione stessa di filosofia: una strada per garantire l’incontro con
la verità. «Orbene ti dirò e tu ascolta attentamente le mie parole,/ quali vie di ricerca sono le sole
pensabili: / l’una che è e che non è possibile che non sia, / è il sentiero della Persuasione giacché
questa tien dietro alla Verità.»
3.1.2. La storia di quel viaggio, che è progetto – promessa, è molto più tormentata di quanto il tono
epico di Parmenide lasci intendere; si può pensare che abbia la sua fine consapevole nella filosofia
di Kant: la realtà in sé è inconoscibile; può essere pensata come una nozione (noumeno: la nozione
di ciò che è in sé), ma noi conosciamo solo i fenomeni: ciò che è dato ai sensi e sulla base di come i
nostri sensi sono conformati al percepire, di come il nostro intelletto e la nostra ragione sono
conformati nel conoscere e nel ragionare. Sulla realtà in sé si estende un doppio velo (poi, con e
oltre Kant, un “quadruplice” velo): 1. il velo dei fenomeni, delle apparenze, dell’esperienza
sensibile che svela e vela; coglie e rivela portando a conoscenza umana (cioè nelle forme possibili
per l’uomo) la realtà in apparenza (nel suo apparire); 2. il velo delle forme con cui le facoltà
dell’uomo colgono e organizzano i dati sensibili (forme a priori della sensibilità,
dell’immaginazione, dell’intelletto, della ragione, della volontà, del sentimento).
In sintesi preliminare quattro tipi di veli: 1. la rappresentazione sensibile, 2. le categorie e le idee
della mente (3.2.), 3. la tecnica (3.3.), 4. il finalismo del sentimento (3.4.).
3.2. il velo del pensare la realtà
3.2.1. pensare, leggere la realtà secondo concetti, velare dunque il dato dell’esperienza a partire
dalle forme della mente (della sensibilità e della ragione) è l’unico modo umano per rivelare il senso
della realtà. Si tratta proprio, ancora una volta di “ri-velare”: il concetto dando forma svela, mette in
evidenza un senso della realtà ma, contemporaneamente, la “vela” (ri-vela, vela di nuovo) legandola
ai concetti con cui la forma per conoscerla, interpretarla, gestirla. Un’altra possibile visione del
mondo riprenderà il gioco tra mente e realtà: svelare e velare; svelare velando. È nota la stima
espressa da Schopenhauer sul risultato cui giunge la conoscenza quando, seguendo l’impostazione
kantiana, la mente umana “conosce” l’esperienza (il fenomeno) attraverso le forme a priori della
mente: essa giunge a delineare gli oggetti della realtà come entità individuali, le singolarità
determinate che la costituiscono; proprio questo risultato, la visione concettuale di oggetti
individuali, è per Schopenhauer il “Velo di Maia” che la ragione stende sulla realtà. Vedere
individualità, cogliere oggetti, muoversi con il principium individuationis significa nascondere,
10
velare, non cogliere l’essenza metafisica della realtà in sé, unica ed universale, velata, forse per
inutile misericordia, dalla ragione.
Quel velo delle forme che determinando svela ci obbliga ad uscire da una antica e recente
impostazione dualistica della conoscenza che è impostata su di una contrapposizione frontale di
soggetto e oggetto; oggetto come un già definito, rigido e resistente ad ogni arbitraria
manipolazione (per esigenze di oggettività e correttezza), soggetto sempre da sottoporre ad un
esame critico così che non rivesta di soggettività e quindi di arbitrio relativistico l’oggettività della
natura in sé. Di contro a tale visione occorre ribadire e precisare con consapevolezza analitica come
soggetto e oggetto crescono insieme e stanno in perenne rimando.
È quello che accade in una degustazione in “cave”: «Più noi disponiamo di apparecchi, più tempo
trascorriamo in cantina o in laboratorio, più il nostro palato è esercitato, più il direttore della cave è
abile, più il cromatografo diviene sensibile: più le realtà abbondano. Nella vecchia tradizione
occorreva sempre segnare a debito del realismo il lavoro per accedere alla realtà e a credito la sola
natura dell’oggetto, anch’esso sempre inaccessibile. Ora, da questo piccolo esempio risulta
chiaramente che la realtà cresce nella stessa misura del lavoro speso per divenire sensibili alle
differenze. Più gli strumenti si moltiplicano, più il dispositivo è artificiale e più diveniamo capaci di
registrare dei mondi. L’artificio e la realtà compaiono nella stessa colonna positiva, mentre nella
colonna negativa si inscrive tutto ciò che è diverso dalla fatica: noi ci troviamo ora l’insensibilità.
La differenza non passa, quindi, tra la parola e la realtà attraverso il fragile abisso del riferimento,
come nel vecchio modello polemico degli enunciati semplicemente veri o falsi, ma tra le
proposizioni capaci di montare dispositivi sensibili alle minime differenze e quelle che restano, di
fronte alle differenze massime, ottuse.» (Latour 1999 p. 95) Dunque non laceriamo i nostri veli.
3.2.1.1. il metodo da adottare per impostare il problema è quello della partita da tennis:
«L’immagine della partita di tennis non è malvagia. Lungi dal rimandare a sfere isolate che
occorrerebbe in seguito unire con una coscienza superiore, o “superare” con un movimento
dialettico, i concetti di oggetto e di soggetto hanno come unico fine quello di rimandare la palla nel
campo dell’avversario, mantenendolo costantemente in allerta.» (Latour 1999 p.81)
(non dunque sintesi hegeliana di superamento-conservazione [aufhebung] di tipo sommatorio,
oppure sì alla logica hegeliana se la sintesi è intesa come rimando continuo tra opposti [nella partita
da tennis la sintesi non consiste nel mettere la pallina al centro (!?), ma nel continuo rimando])
3.2.2. nell’analisi della conoscenza possono essere messi sotto accusa i concetti di definizione della
realtà come fonte di inganno in quanto si rivelano come pregiudizi che partendo da concezioni già
definite del mondo ne impediscono la corretta conoscenza; spessi veli che ottundono la stessa
percezione.
3.2.2.1. critica del pregiudizio. L’obiettivo di fondare il pensiero su principi chiari e distinti, di
liberare l’uomo dalla tradizione e dal principio di autorità per condurlo alla “maggiore età” si è
tradotto, con Descartes prima e programmaticamente con i filosofi illuministi, in una critica ai
pregiudizi e al pregiudizio stesso. Dall’urgenza di liberazione prende forma l’idea di una ragione
“pura”, che solo quando viene considerata per se stessa, del tutto a priori, astratta dalle condizioni
storiche considerate contingenti, conserva la propria autonomia conoscitiva e morale. Questa linea
filosofica è stata fin dal suo sorgere affiancata da considerazioni critiche volte a richiamare la
insopprimibile storicità del pensare e del comprendere.
3.2.2.2. funzione e difesa del pregiudizio. L’attacco ai pregiudizi, condotto in forma indiscriminata,
nasconde la natura della conoscenza e la impedisce. Nell’opera Verità e metodo, H.J. Gadamer, pur
esaltando l’illuminismo per la liberazione avviata nei confronti delle molte servitù, segnala come,
nel campo della tradizione e della storia, sia diventato vittima dei mali che denuncia; in particolare
mette sotto accusa “il pregiudizio degli illuministi nei confronti del pregiudizio” e come quella
filosofia non «sia riuscita a riconoscere nella sua giusta portata la storicità del comprendere»: « È
proprio vero che stare dentro a delle tradizioni significhi anzitutto sottostare a pregiudizi e subire
una limitazione di libertà? O piuttosto non è la stessa esistenza umana, anche la più libera, che è
limitata e condizionata in maniera molteplice? Se questo è vero, allora l’ideale di una ragione
11
assoluta non costituisce una possibilità per l’umanità storica. La ragione esiste per noi solo come
ragione reale e storica; il che significa che essa non è padrona di sé stessa, ma resta sempre
subordinata alle situazioni date entro le quali agisce.» (p.324) Quindi: « Solo il riconoscimento del
carattere costitutivo che ha il pregiudizio in ogni comprensione pone il problema ermeneutico nei
suoi veri termini estremi.» (p.317) Nella comprensione, come evento di comunicazione, è in gioco e
in atto il richiamo e la realizzazione della coscienza storica di ciascuno compreso il necessario
bagaglio di pre-comprensioni e stereotipi che nel comprendere e interpretare sono richiamati come
necessari e sottoposti a verifica critica e, talora, a impietosa denuncia. « Si può così formulare
chiaramente il problema centrale di una vera ermeneutica storica, la sua questione gnoseologica
basilare, e cioè: che cos’è che fonda l’eventuale legittimità dei pregiudizi? Che cosa distingue i
pregiudizi legittimi da tutti gli innumerevoli pregiudizi il cui superamento costituisce l’istanza
indiscutibile della ragione critica?» (p.325) (Gadamer, Hans Georg (1960), Verità e metodo,
Bompiani, Milano 1986)
3.2.3. In conclusione: un doppio possibile bilancio. 1. Seguendo l’impostazione della indagine
trascendentale dell’apriori, ciò che viene posto in analisi filosofica, come compito preliminare, è
quindi l’analisi critica del velo antropologico sulla natura: il velo dei concetti e dei progetti umani, e
quindi una lettura antropologica della natura. 2. Seguendo la consapevolezza che il concetto di
natura in sé è improponibile, in quanto la sua definizione è sempre inscindibilmente connessa con i
concetti che ne permettono l’acquisizione e la lettura, l’analisi filosofica e scientifica diventa
confronto tra le visioni, le raffigurazioni, le “teorie” che storicamente e con propria autonomia si
susseguono. «…questa natura possiamo conoscerla tramite le scienze: si è formata attraverso reti di
strumenti; si definisce mediante professioni, discipline, protocolli; è distribuita in banche dati; se ne
dibatte grazie a società di scienziati. … Come siamo lontani dalla tranquilla distinzione, sempre già
fatta, tra la natura delle cose e le rappresentazioni che gli umani se ne fanno... Ciò che sembrava
buon senso non aveva senso comune.» (Latour Bruno 1999 Politiche della natura. Per una
democrazia delle scienze, Raffaello Cortina editore, Milano 2000, p. XIV e p. 241)
3.3. il velo della tecnica sulla natura. Sulla natura si proietta un terzo ineliminabile velo: la
tecnica. La tecnica è la nostra forma “velata” per accedere alla natura; la natura non si dà se non
attraverso il pensiero e l’azione tecnica. Allo scopo di fare il punto sulla sensibilità presente si
possono evidenziare tappe ideali presunte (e semplificate) verso una storia di ri-velazione. 1. Prima
tappa: l’idea di una “natura in sé”, dell’“oggetto naturale” pensato come entità autonoma e
originaria in assoluta esclusione opposizione con l’umano (si può parlare di Aristotele, ma, in tempi
contemporanei, è il realismo metafisico che presenta la conoscenza come registrazione di una realtà
in sé, è il fondamentalismo ecologista che blocca ogni ragione e scelta di politica ecologica). 2.
Seconda tappa: l’idea dell’essenza tecnica della natura e della sua totale manipolabilità; non c’è
distinzione alcuna tra natura e tecnica, tutto è a disposizione per un progetto d’uso e di dominio (si è
soliti evocare, sul tema, Bacone e Cartesio, ma, in tempi contemporanei, la tesi della forma mitica
di un qualsiasi concetto di natura, della inesistenza del concetto stesso di natura da intendere come
una semplice “costruzione sociale” e l’idea di assenza di limiti nell’agire produttivo e d’uso [come
nel caso dell’amianto, dei prioni, nei mangimi animali con conseguente “mucca pazza”…]). 3.Terza
tappa: l’idea che la tecnica svela e rivela la natura e ne porti ad effetto le potenzialità; non è
possibile una separazione tra tecnica e natura, non è possibile una subordinazione che riduce l’una
all’altra, si tratta di una relazione e di un incontro consegnato a tentativi e trattative, insuccessi
(talora clamorosamente drammatici) e scoperte. Gli oggetti non hanno più contorni definiti e ben
marcati ma flessibili e in mutamento (non sono “oggetti calvi” ma “oggetti arruffati” Latour); è
impostazione senza senso e contraddittoria la ricerca di un netto confine tra naturale e tecnico, tra
natura e uomo; questo confine potrebbe essere definito solo grazie agli strumenti tecnici
storicamente a disposizione dell’uomo.
12
«I loro [degli oggetti] caratteri sono del tutto diversi dai precedenti, ed è questo che spiega il motivo
per cui, ogni volta che essi fanno irruzione, si parla di crisi. Contrariamente ai loro predecessori,
non hanno contorni netti né essenze ben definite né una decisa separazione tra un nocciolo duro e
quanto li circonda. Per questo assumono l’aspetto di esseri arruffati, che formano rizomi e reticoli.
In secondo luogo, i loro produttori non sono più invisibili, fuori campo, bensì compaiono in piena
luce, impacciati, controversi, complicati, coinvolti, con tutti i loro strumenti, laboratori, officine,
stabilimenti. Fin da subito la produzione scientifica, tecnica e industriale fa parte integrante della
loro definizione. In terzo luogo, questi quasi-oggetti non hanno alcun impatto, propriamente
parlando, come se cadessero dall’esterno su un mondo diverso da loro. Hanno un gran numero di
connessioni, di tentacoli, di pseudopodi che li collegano in mille modi a esseri altrettanto incerti,
che pertanto non costituiscono più un altro universo indipendente dal primo. Per averci a che fare,
non vi è, da un lato, il mondo sociale e politico e, dall’altro, quello dell’oggettività e della
redditività. Infine, ed è probabilmente l’aspetto più singolare, non li si può più svincolare dalle
inaspettate conseguenze che essi metterebbero in moto a lunghissimo termine, a grande distanza da
loro, in un mondo incommensurabile. Al contrario, tutti paradossalmente si aspettano le
conseguenze inattese che essi non mancheranno di produrre — conseguenze che pertengono loro a
pieno titolo, di cui essi accettano la responsabilità, da cui traggono insegnamenti, secondo un
processo di apprendimento affatto palese che rimbalza sulla loro definizione e che ha luogo nel loro
stesso universo.» (Latour Bruno 1999 Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze,
Raffaello Cortina editore, Milano 2000, p. 18-19)
Quindi: «Il velo delle immagini tecniche, che ci avvolge in maniera così similare a quelli che
possono essere i veli orientali, ci esorta a un impegno che si contrappone alla scelta orientale. I
nostri veli non sono da lacerare, bensì da tessere in maniera sempre più spessa.» (Flusser Vilém
1985 Immagini. Come la tecnologia ha cambiato la nostra percezione del mondo, Fazi editore,
Roma 2009, p.54)
3.3.1. sulla fine (per improponibilità) del concetto di natura in sé, il tema del silenzio della natura,
della morte del dio Pan, nella versione della proposta di una ecologia politica, condizione di nuova
democrazia. L’annuncio della Morte della natura non è annuncio di tragedia, ma di liberazione:
scompare un concetto di natura subdolamente astorico e asettico, che nascondeva i suoi occulti
mandanti e bloccava la politica impedendo all’uomo di assumersi le proprie responsabilità nei
confronti dell’ambiente. Afferma Latour: « Quando gli ecologisti più frenetici urlano tremanti: “La
natura sta per morire”, non sanno quanto hanno ragione. Grazie a Dio, la natura sta per morire. Sì, il
grande Pan è morto! Dopo la morte di Dio e quella dell’uomo, finalmente anche la natura doveva
cedere. Ed era ora: presto non sarebbe più stato possibile fare alcuna politica. Forse il lettore griderà
al paradosso. Perché ha in mente la cosiddetta versione popolare dell’ecologia profonda, movimento
dai contorni peraltro vaghi che pretende di riformare la politica degli uomini in nome “dei superiori
equilibri della natura”. Ora, l’ecologia profonda si colloca il più lontano possibile dall’ecologia
politica … non è una forma estrema di ecologia politica: non le appartiene affatto poiché la
gerarchia degli esseri che essa si è data si compone interamente di quegli oggetti senza rischio,
calvi, moderni, che si ordinerebbero per gradazioni successive dal cosmo ai microbi, passando per
la Madre Terra, le società umane, le scimmie, ecc.; i produttori di questi saperi discussi rimangono
del tutto invisibili, e così pure le fonti d’incertezza; la distinzione tra oggetti e mondo politico che
essi bombardano rimane completa, al punto che all’apparenza l’ecologia profonda avrebbe quale
unico fine di umiliare ancor più la politica riducendone il potere a vantaggio di quello, molto
superiore e meglio occultato, della natura — e degli esperti invisibili che hanno deciso in merito a
ciò che essa voleva, poteva e doveva. L’ecologia profonda, dando a credere di liberarci
dall’antropocentrismo, ci respinge di nuovo nella Caverna [platonica] in quanto appartiene per
intero alla definizione classica della politica resa impotente dalla natura — concezione da cui
l’ecologia politica, quanto meno nella pratica, comincia appena a tirarci fuori. Essa (l’ecologia
politica) soltanto porta, finalmente, in primo piano la qualità intrinsecamente politica dell’ordine
naturale.» (Latour Bruno 1999 p. 21,23.)
13
3.4. il velo della visione teleologica degli oggetti (e della realtà), il velo del sentimento (quarto
velo). Ancora a proposito di una prassi quotidiana e la sua ragione filosofica sul tema della fine (per
improponibilità) del concetto di natura in sé: visioni teleologiche degli oggetti (e della realtà), un
velo antropologico del sentimento.
Pensare secondo fini o come disporre le merci in un supermarket.
3.4.1. un episodio di disorientamento al Supermarket di fronte al succo di pomodoro: «Succo di
pomodoro. Si pensa spesso che la metafisica, complice quel suo nome fuorviante, parli di cose non
fisiche, e magari un po’ astruse, o futili, o indecidibili. Sicuramente non si pensa che abbia a che
fare con la vita quotidiana, per l’ottimo motivo che l’idea di fondo è che le faccende della vita
quotidiana, che si svolgono nello spazio e nel tempo, siano eccellentemente risolte dalla fisica o da
qualche sua derivazione. Il punto sarebbe: il mondo è composto di atomi che si aggregano in
molecole. Chi se ne intende di atomi, se ne intende di tutto. Ma non è sempre così, come vorrei
ricordare attraverso un aneddoto minimo.
Recentemente, i succhi di pomodoro sono scomparsi, almeno in apparenza, dai supermercati. Non si
trovavano più nel posto dove solitamente li esponevano, insieme ai succhi di frutta. Una
classificazione abbastanza intuitiva anche se non esattissima (davvero i pomodori sono frutti allo
stesso modo che mele e pere?), ma che quantomeno era sostenuta da una tradizione.
Sono andato a cercarli nel settore dei sughi pronti. In fondo (ragionavo da fisico e da chimico) le
molecole sono quelle, dunque saranno lì. Niente da fare. Ho smesso di cercare. Lo prendevo al bar,
ma lì ovviamente non potevo fare domande tipo: «lei dove li trova?», perché la risposta sarebbe
stata «dal grossista».
Poi, per caso, dopo che avevo perso ogni speranza, ho ritrovato i succhi di pomodoro. Erano vicino
agli aperitivi, il che non corrispondeva in nulla alle nostre cognizioni sul mondo fisico, visto che il
succo di pomodoro non è una bevanda alcolica, diversamente dalla stragrande maggioranza degli
aperitivi. A cosa rispondeva, allora? Pensandoci, me ne sono fatto una ragione: la classificazione
era dettata dal fine, dalla modalità di impiego e dal suo ambito. Diremmo, in lessico filosofico, che
era una classificazione teleologica. La metafisica, come il buon Dio, si nasconde nei dettagli.»
(Ferraris Maurizio 2008 Il tunnel delle multe. Ontologia degli oggetti quotidiani, Einaudi, Torino
pp. 207-208)
3.3.2. giudizi determinanti e giudizi riflettenti (della specie dei giudizi teleologici) di fronte al
“succo di pomodoro”: dalla Critica del Giudizio di I. Kant
3.3.2.1. giudizio determinante o della chimica (e la visione – velo dei concetti determinanti,
“sussuntivi”. « Il Giudizio determinante sotto le leggi trascendentali universali date dall’intelletto, è
soltanto sussuntivo; la legge gli è prescritta a priori, e così esso non ha bisogno di pensare da sé ad
una legge per poter sottoporre all’universale il particolare della natura. — Ma vi son così molteplici
forme nella natura, e del pari sono tante le modificazioni dei concetti trascendentali universali della
natura, le quali son lasciate indeterminate da quelle leggi che fornisce a priori l’intelletto puro,
poiché tali leggi non riguardano se non la possibilità di una natura (come oggetto dei sensi) in
generale, che vi debbono essere perciò anche leggi, le quali, in quanto empiriche, potranno ben
essere contingenti secondo il modo di vedere del nostro intelletto, ma che, per essere chiamate leggi
(com’è richiesto anche dal concetto di una natura), debbono essere considerate come necessarie
secondo un principio, sebbene a noi sconosciuto, dell’unità del molteplice.» (Kant Immanuel 1790
Critica del Giudizio, Laterza, Roma-Bari 1979 pp.18-19.)
3.3.2.2. giudizio riflettente o degli aperitivi (e la visione – velo di principi empirici-finalistici
personali o del desiderio, aspirazione…). «Il Giudizio riflettente, che è obbligato a risalire dal
particolare della natura all’universale, ha dunque bisogno di un principio, che esso non può ricavare
dall’esperienza, perché è un principio, che deve fondare appunto l’unità di tutti i principi empirici
sotto principi parimente empirici ma superiori, e quindi la possibilità della subordinazione
sistematica di tali principii. Questo principio trascendentale il Giudizio riflettente può dunque
darselo soltanto esso stesso come legge, non derivarlo da altro (perché allora diventerebbe Giudizio
14
determinante); né può prescriverlo alla natura, poiché la riflessione sulle leggi della natura si
accomoda alla natura, ma questa non si accomoda alle condizioni con le quali noi aspiriamo a
formarci di essa un concetto, che è del tutto contingente rispetto alle condizioni stesse.» (Kant, ivi)
3.4.2.1. “…ragionavo da fisico e da chimico”: giudizi determinanti: si parte da concetti universali e
si deduce da essi allo scopo di definire (dare forma, leggere) un caso particolare e determinarne in
modo scientifico (con riferimenti ai vari campi della scienza: fisica, chimica, botanica…) la natura.
3.4.2.2. “…la classificazione era dettata dal fine”: giudizi riflettenti teleologici. Il giudizio
riflettente parte da un particolare (già noto, per quanto serve [ad esempio, devo dissetarmi e allo
scopo non mi serve conoscere la formula chimica dei vari liquidi], nella sua natura) che viene
ripreso in considerazione e in vista di una finalità soggettiva; un particolare (già quindi noto a
livello di giudizio determinante) che “deve trovare un universale” a giustificarne la presenza alla
nostra attenzione, interesse, coinvolgimento ecc.
3.4.2.3. i secondi (giudizi riflettenti teleologici [in compagnia di quelli estetici]) prevalgono per
ricorrenza e per rilevanza sui primi (giudizi determinanti) [sono loro a determinare il nostro
aggirarci tra gli scaffali di un supermarket e ad ispirarne la logica] ; il fine (lo scopo) e il senso
estetico del bello non sono certo alla fonte formale (per competenze) della conoscenza («la natura…
non si accomoda alle condizioni con le quali noi aspiriamo a formarci di essa un concetto» Kant
CdG. cit.) ma spingono alla conoscenza e determinano la direzione dell’agire. Finalità e bellezza,
due veli attraverso i quali, consapevolmente o meno, passa la nostra concezione concettuale e
operativa nei confronti del mondo in cui siamo. Il principio finalistico, che consente al soggetto di
ordinare e organizzare la realtà in vista di un fine, viene indicato come principio a priori del
sentimento e presentato nell’etica come principio dell’azione; il finalismo diviene così una forma
trascendentale che si colloca alla congiunzione tra conoscenza teoretica e coscienza morale e si
presenta come una nuova prospettiva a priori destinata a coinvolgere l’intera attività della ragione
nella sua forma teoretica e pratica.
4. arte velata, veli d’arte (a integrare il tema dell’arte muta)
L’arte è definita, nella sua essenza ed efficacia, dal velo: “Ars est celare artem” (D’Angelo
Paolo 2005 Ars est celare artem. Da Aristotele a Duchamp, Quodlibet, Macerata). Nascondere la
fatica del produrre; la pesantezza dei materiali raccolti e da portare a convergenza, la complessità
del gesto compositivo e il controllo di tutte le sue componenti dinamiche devono scomparire dietro
al risultato; lo sorreggono senza presentare se stessi come oggetto e fatti, senza farsi notare in primo
piano per dar luogo all’armonica semplicità formale dell’opera. In questo consiste l’arte, nel celare
il proprio prodursi, il proprio essere risultato e nel presentarsi come il fatto primo originario nella
solenne semplicità del suo accadere e manifestarsi. È un sapiente e raffinato velo che raccoglie e
nasconde (ri-vela) materiali, gesti, emozioni e comportamenti portandoli a soddisfazione,
compimento e realtà nell’opera. Un velo che opera paradossalmente secondo due modalità
storicamente ben distinte, anzi contrapposte, solitamente consegnate agli “stereotipi”: concezione
“classica”, concezione “contemporanea” dell’arte.
4.1. La concezione classica del principio ars est celare artem e la produzione “classica”
dell’arte come opera unica: arte è velare la tecnica della sua produzione. «Nell'uso tradizionale
del principio ars est celare artem era espressa l'idea che si dovesse celare l'arte come abilità, come
maestria, come eccellenza. Il grande artista era colui che sapeva fare uso di una suprema capacità,
ma sapeva anche dissimularla, in modo che essa agisse più sottilmente, non si imponesse allo
spettatore o al fruitore.» (D’Angelo o.c.) Da tale abilità nasceva l’unicità estetica dell’opera d’arte
e la sua solenne semplicità (vedi note di Heidegger: Heidegger Martin 1944 L'inno Andenken di
Hölderlin, ed. Mursia, Milano 1997). Celare la fatica, la tecnica, la produzione (e quindi la
riproduzione) in vista dell’unicum, di fronte all’accadere dell’unicum.
4.2. Il velarsi dell’arte contemporanea si muove, detto sinteticamente e preliminarmente, in tre
contesti e consegnandosi a tre direzioni produttive e fruitive: 1. arte e la riproducibilità tecnica; 2.
15
arte per oggetti utili, prodotti in funzione e intenzione estetica; 3. arte dei ready made come sfida
provocazione ricolta ai processi del guardare per un nuovo vedere; 4. arte dei graffiti di strada,
un’arte che rivendica appartenenza universale e spazi pubblici totali.
Si tratta di aspetti che caratterizzano l’arte contemporanea e ne costituiscono lo specifico velo, ma si
tratta anche di aspetti che impediscono a noi di cogliere l’arte in opere e produzioni che vengono
mostrate (messe in mostra) come arte; velano l’arte in quanto arte o velano l’arte al nostro guardare,
ponendoci nella sofferente e stupita situazione di chi guarda ma non riesce a vedere; al punto che ci
troviamo nella condizione di faticare a considerare arte ciò che ci viene presentato come tale; e ciò a
causa di molti “veli”.
4.2.1. La demolizione del concetto estetico classico dell’opera d’arte come unicum il velo della
tecnica sull’arte: l’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.
4.2.1.01. Premesse d’intesa. Chiamo merce la riproducibilità tecnica dell’oggetto, nella produzione
l’oggetto è numero di una serie di uguali, perde la caratteristica dell’unicità artistica artigianale e
assume la propria destinazione al mercato dove è definito in bade il proprio valore di scambio. La
possibilità di trasformare oggetti in merce è propria della logica di produzione destinata a garantire
il massimo profitto, non conosce confini se non di tipo tecnico o per decisioni (labili e provvisorie).
Fin dalla prime analisi della produzione industriale a gestione capitalistica Marx denuncia la
mercificazione come mezzo attraverso cui si produce con le merci l’alienazione delle persone e
delle relazioni sociali.
4.2.1.1. Arte e riproducibilità tecnica. Anche all’arte possono essere applicati i processi produttivi di
seriazione e “l’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica” perde la caratteristica, il
privilegio e il fascino (l’aura) dell’unicum che la definiva come arte. Si tratta delle ormai ben note
tesi dell’opera di Benjamin Walter 1936 L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.
Arte e società di massa, Einaudi, Torino 2000.
4.2.2. La demolizione del concetto estetico classico dell’opera d’arte come unicum: l’incontro
bello e utile. Il risultato cui conduce la seriazione riproduttiva dell’arte è quello di ricostruire il
legame tra arte e produzione, quindi tra bello e utile. Far entrare l’arte nella produzione tecnica
significa creare, produrre oggetti che assumono la bellezza come proprio canone formale. È
indubbio (non si deve peccare di eccessiva ingenuità) che in questo contesto la bellezza diventa un
raffinato strumento per rilanciare e sostenere occasioni di profitto (“L’aura è viva e vende bene”
Dal Lago Alessandro, Giordano Serena o.c.), ma, misurata a partire dagli effetti possibili sulle
lunghe distanze la riproducibilità tecnica e quindi seriale dell’arte crea situazioni estetiche che
interessano il quotidiano in ogni suo aspetto, mettono a disposizione l’arte, la produzione artistica
non è pensata per un destino di museo, di galleria, di salotti per pochi ma entra ne quotidiano e
(perciò) nel circuito dello scambio.
Il nuovo velo cui l’arte si consegna è l’utile. Torna il motto “ars est artem celare”, il motto “larvatus
prodeo” dove il velarsi è ancora e sempre un modo per rivelarsi. Il confronto con le religioni non
risulta irriverente: Dio, assumendo la forma di uomo o di altre realtà terrene come acqua, fuoco,
soffio, angelo, agnello, velandosi cioè in un corpo o in sembianze terrene, si rivela e crea situazioni
di soccorso e salvezza sempre più universali; l’arte non disdegnando l’utile quotidiano, ma
assumendone le forme e velandosi in quegli oggetti “banali”, ne redime lo squallore, lo stridio
estetico e crea progressivamente la dimensione estetica del quotidiano, mette il vivere quotidiano
nella situazione della bellezza. Il velo dell’utile rivela e realizza quindi la destinazione universale
dell’arte. Senza questo esito la bellezza viene meno alla propria natura; la stessa estetica romantica
finisce storicamente per consegnare l’arte ad una nicchia aristocratica borghese o ai riti delle
ostensioni di massa dalla vasta risonanza mediatica e commerciale. (Emblematica in tal senso è la
descrizione, stile Goffman, dei comportamenti dei visitatori del Louvre nei confronti della
Gioconda di Leonardo da Vinci).
16
4.2.3. La demolizione del concetto estetico classico dell’opera d’arte come unicum e la nuova
interpretazione del principio ars est celare artem nei ready made. «Nel ready-made, invece,
questa dimensione fabrile, artigianale dell'arte va completamente perduta. Se celare l'arte significa
nascondere un'abilità, qui non c'è nessuna abilità da nascondere. Lo dice il nome stesso escogitato
da Duchamp: ready-made vuol dire già fatto, bell'e pronto, vuol dire che l'artista non ha compiuto
sulla materialità dell'oggetto il minimo intervento metamorfico. Non ha lavorato la materia, non l'ha
trasformata. La dimensione artigianale, tecnica dell'arte risulta totalmente azzerata. Quest'arte non è
"fatta ad arte". Lo dimostra il dato della sua assoluta riproducibilità. Si sa che gli oggetti
originariamente scelti da Duchamp sono andati perduti e sono stati sostituiti da repliche. Si sa che
Duchamp ha autorizzato la circolazione di repliche o duplicati dei suoi ready-made. La Galleria
Schwarz di Milano, nel 1964, mise in circolazione tredici ready-made in un'edizione di otto copie
firmate. E si sa che il gesto di Duchamp si può raccontare senza che vada del tutto perduto il suo
impatto.» (D’Angelo, o.c.) L’arte è talmente celata da non esserci; il paradosso è che l’arte è celata
proprio mentre si presenta un’opera d’arte; è velata in un oggetto quotidiano già pronto mostrato nei
luoghi “sacri” delle ostensioni dell’arte, nelle mostre. L’arte si affida alla forme del quotidiano,
della riproducibilità degli oggetti, della loro serialità, del loro essere merce tecnicamente prodotta e
riproducibile.
4.2.4. La demolizione del concetto estetico classico dell’opera d’arte come unicum e la
produzione “stradale” di graffiti. Una produzione invadente e “molesta” che richiede per sé il
titolo di arte avanzando più meriti: 1. la spontaneità incontrollata dell’ispirazione, 2. la natura
universale della proprietà dell’arte che sono in grado di realizzare e garantire, 3. la sede sempre
pubblica della produzione ed esposizione dell’arte (in contrasto con la tendenza dell’arte
professionale a stare in luoghi deputati e “chiusi”, 4. la nuova estetica percettiva e produttiva che
sono in grado di attivare, 5, la capacità di attirare su di sé l’attenzione interessata del mondo della
pubblicità (utile) e dello stesso mondo ufficiale dell’arte (un esempio emblematico: Keith Haring,
Jean-Michel Basquiat)
4.3. le trasformazioni, le rivoluzioni, le ri-velazioni
4.3.1. La inesorabile conseguenza è l’eccesso di arte. «Il y a trop d’art». «Questo il titolo di
un’opera dell’artista Ben Vautier esposta al Museo di Nizza: a mio parere l’emblema della
situazione attuale del design e del suo rapporto complesso con l’estetica. Noi viviamo in un’epoca
di estetizzazione di massa. Eppure, a ben vedere, l’allargamento del campo estetico è andato di pari
passo con il suo indebolimento: il campo estetico, cioè quello delle forme visibili, percettive, del
gusto e della capacità di scelta, non è mai stato così debole come ora, privo di indipendenza e legato
ai meccanismi produttivi che danno origine alla bellezza formale degli artefatti e dei prodotti. La
bellezza moderna non c’è più, checché ne pensino i designer. Il luogo fondamentale di apparizione
della bellezza moderna era quel dominio relegato ma relativamente indipendente, enfranchised
[Danto, 1986] che si chiamava “opera d’arte”. Le avanguardie artistiche hanno distrutto
completamente questo senso di indipendenza della bellezza, non la si ritrova più nelle opere d’arte
ma la gradevolezza, l’ambito del gusto si è spostato sul sistema degli oggetti quotidiani. La bellezza
è stata sradicata dal dominio dell’arte e si è dislocata sul dominio della merce.» (Carmagnola Fulvio
2009 Design, la fabbrica del desiderio, Lupetti, Milano p. 41)
Contrariamente alle cupe previsioni che portano a cogliere nella seriazione la morte dell’arte,
soprattutto quando essa è consegnata come merce ad un consumo di massa stereotipato e distratto, il
quadro sociologico che, sulla distanza, può essere delineato non è a tinte fosche.
4.3.2. Si tratta di valutazioni critiche riguardanti l’arte e l’estetica, fondate su basi sociologiche, che
sono già presenti, in realtà, nelle opere degli autori della Teoria critica della società (Scuola di
Francoforte), le cui tesi non si possono quindi ridurre alla visione cupa che in esse sembra
dominare. Nei propri studi Benjamin rivolge l’attenzione all’«avvento delle nuove tecniche e per il
loro carattere di massa, da un angolo visuale per cui tale processo è considerato non solo inevitabile,
17
ma largamente positivo, in quanto pone termine a una concezione aristocratica dell’arte» (Cesare
Cases, in Benjamin, 1936 o.c. p.8); ripensare l’arte, la bellezza e il bene in questo ambiente è
momento per scoprire nuove e rinnovate relazioni. «Certo la perdita dell’aura corrisponde ad
un’evidente alienarsi dell’opera, ma ciò avviene a favore di una forma nuova di fruizione, data dal
carattere intrinsecamente innovativo della tecnica di riproduzione, e la cui principale connotazione è
costituita da una implicita politicità.» (P.Pullega in Benjamin, 1936 o.c. p.177).
4.3.3. È indubbiamente un umor nero quello che circola nelle opere di sociologia critica della
Scuola di Francoforte destinate allo studio dell’arte osservata dal punto di vista della sua fruizione e
soprattutto della fruizione di massa: ridotta a oggetto da collezionare, gadget da esibire, jingle per
fastidiosi spot pubblicitari e canzonette per ipod… l’arte è sottofondo di atti meccanici quotidiani in
cui la ripetizione ossessiva crea l’abitudine alla deformazione, alla semplificazione, al cattivo gusto
fino a impedire di avvertirne la presenza e ad annullare l’originario sdegno nei confronti del
dilagante “cafonal”. In questa direzione, prevalentemente di denuncia critica, si muovono autori
come Adorno, Marcuse, Benjamin, Baudrillard, Débord, Habermas …
4.3.3.1. Posizioni più recenti, riflessioni in saggi che non hanno più il proposito di costituirsi in
tradizione e scuola, descrivono uno scenario diverso. Il riferimento va a studi come: Francalanci,
Ernesto L. 2006 Estetica degli oggetti, il Mulino, Bologna; Dal Lago Alessandro, Giordano Serena
2006 Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, il Mulino, Bologna; Di Giacomo
Giuseppe, Zambianchi Claudio (a cura di) 2008, Alle origini dell’opera d’arte contemporanea,
Laterza, Roma Bari; Di Napoli Giuseppe 2006 Il colore dipinto. Teorie, percezione e tecniche.
Einaudi, Torino; Carmagnola Fulvio 2009 Design, la fabbrica del desiderio, Lupetti, Milano;
Muzzarelli Federica 2009 L’immagine del desiderio. Fotografia di moda tra arte e comunicazione,
Bruno Mondadori, Milano.
4.3.4. L’utopia della bellezza. La nuova aura dell’arte e della sua produzione: non è la singola opera
d’arte ad essere dotata di aura ma è l’intera società in quanto dispone del bene della bellezza. La
situazione è possibile grazie a riprese di relazione essenziali: 1. relazione tra arte e tecnica (il
termine “techne” torna alla sua plurivalenza di tecnica e arte); 2 la produzione di merci e la
produzione di opere d’arte non sono più separabili formalmente; 3. nessun confine tra opera d’arte e
oggetto (“Anything can be art without having to look like art at all”, così Arthur Danto; ogni cosa
può essere arte senza dover assolutamente apparire arte e di conseguenza l'arte può recuperare
qualsiasi procedimento all'artisticità); 4. arte e serie: è difficile (impossibile, inutile) distinguere
nell’arte l’unicum dal seriale (al centro dell’estetica si colloca la forma e prendono la parola i
processi innovativi che la sua autonomia in campo percettivo e artistico è in grado di generare).
4.3.4.1. una testimonianza. «Saper guardare. Saper osservare. Saper vedere ciò che i nostri occhi
satolli e distratti non vedono più. Bruno Munari era fatto così: guardava con ammirato stupore la
perfezione di un’arancia, di un pisello, di una rosa. L’incessante lavorio artigianale compiuto dalle
onde del mare. La meraviglia formale e funzionale di un fiasco di vetro o di una mezza luna da
cucina, oggetti anonimi ma depositari di una perfezione progettuale e realizzativa da cui era
convinto si dovesse inevitabilmente ripartire. La sua eccezionalità nasce in gran parte proprio da
qui: dalla capacità di rubare immagini al mondo per restituirle in forma di progetto. Munari era
capace di creare una lampada (Falkland, 1964) ispirandosi al modello di una calza di nylon da
donna. O di affrancare un orologio dalla tirannia del tempo consentendo all’utente di scegliere l’ora
preferita (il modello Tempo libero per Swatch, 1997). O, ancora, di dedicare agli “ospiti senza
sorriso” una Sedia per visite brevissime (1945), con sedile inclinato e schienale altissimo, tanto da
sollecitare il visitatore inopportuno a ridurre al minimo la propria permanenza. Un po’ funambolo e
un po’ giocoliere, ma anche filosofo, epistemologo e poeta, Munari pratica la cultura del progetto
come gioco e come invenzione continua: bastano gli elementi della natura (sassi, carta, pietre,
tessuti) per creare un paese delle meraviglie e per immergersi in un’altra dimensione. Con lui il
design diventa davvero immaginazione al potere: non capriccio, non reverie, ma capacità di
semplificare le cose conservando l’infanzia dentro di sé, in un inesauribile processo di reinvenzione
del mondo e delle sue forme. (Silvana Annicchiarico in Romanelli Marco 2008 Vietato l’ingresso
18
agli addetti al lavoro, per Bruno Munari 1907 – 1998 in occasione della mostra realizzata dalla
Triennale di Milano a Tokyo nel 2007, Corraini, Mantova)
4.3.4.2. Il bene della bellezza: un’utopia estetica. L’incontro tra il bello e l’utile diventa il
contemporaneo nuovo contesto del bene: il bene della bellezza. Bene come merce e bene come
felice opportunità. Già Benjamin individuava qui un processo non solo inevitabile, ma largamente
positivo, in quanto pone termine a una concezione aristocratica dell’arte e la predispone per una
fruizione allargata, di massa. Bellezza e bene si incontrano, finalisticamente, in una utopia estetica,
coraggiosamente pensata e rivolta proprio ad una “società di massa”. «L’estetica diffusa è, in
conclusione, un’impresa incompleta; potrebbe essere la salvezza dell’umanità, immergendola nella
felicità, se caratterizzasse il modo di vita di ogni individuo sulla terra, in quanto, una volta liberatosi
dalle difficoltà della sopravvivenza propria e della propria prole, sollecitato ad un comportamento
ritualizzato continuo, impegnato in una festa perenne di scienza, musica, danza e arti, non avrebbe
più tempo per pensieri di guerra e per conflitti personali e collettivi, inverando l'antico sogno
sociale di un’umanità appagata.» (Francalanci Ernesto L. 2006 Estetica degli oggetti, il Mulino,
Bologna)
4.3.5. Presenze antiche e consapevolezza.
4.3.5.1. Si tratta della consapevolezza della natura trascendentale del giudizio di bellezza. La
dipendenza estetica dalla finalità soggettiva come principio trascendentale del sentimento, espressa
dalla filosofia critica applicata al sentimento ad opera di Immanuel Kant.
«Ma quell’elemento soggettivo di una rappresentazione che non può essere elemento di conoscenza
è il piacere o il dispiacere congiunto con la rappresentazione stessa: perché con l’uno o con l’altro
io non conosco niente dell’oggetto rappresentato benché essi possano bene essere l’effetto di
qualche conoscenza. Ora la finalità di un oggetto, in quanto è rappresentata nella percezione, non è
una proprietà dell’oggetto stesso (perché tale proprietà non può essere percepita), sebbene possa
esser desunta dalla conoscenza degli oggetti. Sicché la finalità, che precede la conoscenza di un
oggetto e che, anche quando non si voglia usare la rappresentazione in vista di una conoscenza, è
immediatamente legata con la rappresentazione stessa, è l’elemento soggettivo di essa, ciò che non
può mai divenire elemento di una conoscenza. Si dice perciò che l’oggetto è conforme al fine, solo
perché la sua rappresentazione è legata immediatamente col sentimento di piacere; e questa
rappresentazione stessa è una rappresentazione estetica della finalità. — Rimane solo il problema se
vi è in genere una simile rappresentazione della finalità.» Kant Immanuel 1790 Critica del Giudizio,
Laterza, Roma-Bari 1978 p. 30-31.
4.3.5.2. Si tratta, ancora di più, di un autentico ritorno alle origini del pensiero occidentale; al Timeo
di Platone, racconto della costruzione del mondo come cosmo ad opera del Demiurgo.
«Timeo: Diciamo dunque per qual cagione l’artefice (il Demiurgo) fece la generazione e
quest’universo. Egli era buono … volle che tutte le cose divenissero simili a lui … quando
l’artefice, guardando a quello che è sempre nello stesso modo e giovandosi di così fatto modello,
esprime la forma e la virtù di qualche opera, questa di necessità riesce tutta bella … perché il
mondo è il più bello dei nati, e dio il più buono tra gli autori … è stato fatto secondo modello che si
può apprendere con la ragione e con l’intelletto perché è sempre nello stesso modo.» (28a, 29a,e)
L’artefice, con lo sguardo rivolto ai modelli eterni di ogni cosa (le forme, le idee, i paradigmi, le
essenze) plasma la materia, sostrato unico ed universale, materiale ed invisibile, secondo i caratteri
generali della bellezza e della bontà, dotando il mondo di ragione ed anima, presentandolo quindi
come uno ed unico; «…componendo l’intelligenza nell’anima e l’anima nel corpo, fabbricò
l’universo, affinché l’opera da lui compiuta fosse la più bella secondo natura e la più buona che si
potesse» (30 b). La sede della bellezza è una sede universale. Non è consegnata all’opera d’arte
tecnicamente prodotta come unicum o come oggetto seriale, ma è disposta in una sede universale
(anche nei ready-made) e totale, il cosmo, di cui costituisce l’intrinseca e “silenziosa” armonia.
5. donne che portano il velo
Ritorna il tema dell’avvio: una storia circolare di affermazione e autonegazione
19
Donne che portano il velo, donne che prendono il velo per rivelare la propria scelta, appartenenza,
situazione…
La complessità e quindi la difficoltà posta dal tema, che è un tema sociale, deriva dal fitto intreccio
di settori che si annodano intorno alla questione. I diritti individuali, sociali e politici; le tradizioni
culturali e religiose, il loro vincolo, la loro rilevanza etica e politica; i modi e le forme delle
relazioni e delle comunicazioni sociali; le competenze e i limiti delle comunità culturali e familiari
nel doppio confronto con gli individui e con la società fondata sulla legge e sul diritto.
Forse la tradizione e la riflessione filosofica, come filosofia del diritto e filosofia della
comunicazione, può mettere a disposizione alcuni concetti utili ad una riflessione in corso.
(un sito per il problema dibattito: http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/artejournal/3310616.html)
5.1. le fonti religiose ritenute “responsabili” (ma si tratta di problemi interpretativi e di tradizioni
che danno vita a forme e comportamenti sicuramente successivi o non più conforme a quanto si dice
negli stessi testi indicati come fonte; testi che diventano qui “pretesti”; del resto, molti altri e di ben
altra rilevanza, sono volutamente trascurati e trasgrediti quotidianamente e a tutti i livelli: quelli
relativi alla equa distribuzione dei beni, alla giustizia, alla carità, alla comprensione, all’amore…)
5.1.1. Paolo di Tarso, Prima lettera ai Corinti: «2. E vi lodo, perché di me ricordate tutto, e
conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. 3. Ma voglio che sappiate che capo di ogni
uomo è il Cristo, mentre capo della donna è l’uomo, e capo del Cristo è Dio. 4. Ogni uomo che
prega o profetizza avendo qualcosa che gli scende dal capo disonora il proprio capo. 5. E ogni
donna che prega o profetizza avendo il capo non velato disonora il proprio capo: perché è tale e
quale alla donna rasata. 6. Ora, se una donna vuol fare a meno di velarsi, si tagli pure i capelli! Ma
se è così vergognoso tagliarsi i capelli o rasarsi, allora si metta il velo. 7. L’uomo, infatti, non deve
velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio; la donna, invece, è gloria dell’uomo. 8. Non è
l’uomo che viene dalla donna, ma la donna dall’uomo: 9. né l’uomo fu creato per la donna, ma la
donna per l’uomo. 10. Per questo la donna deve avere (un segno di) potere sul capo, a motivo degli
angeli. 11. Nondimeno, né la donna è senza l’uomo, né l’uomo è senza la donna, nel Signore.
12. In effetti, come la donna deriva dall’uomo, così l’uomo deriva dalla donna: e tutto deriva da
Dio. 13. Giudicate voi stessi: è forse conveniente che una donna si rivolga a Dio a capo scoperto?
14. Non vi insegna la natura stessa che se un uomo si fa crescere i capelli è per lui motivo di
disonore, 15. mentre se una donna si fa crescere i capelli è per lei motivo di gloria? La chioma
stessa le fu data a guisa di mantello. 16. Ora, se qualcuno ama far polemica, sappia che noi non
abbiamo una tale consuetudine, e neppure le chiese di Dio.» (Paolo 1 Cor. 11, 2-16)
5.1.2. Corano. «Nel versetto XXIV, 30-31, del Corano compare la parola khumur, tradotta come
"velo" nell'edizione italiana del Corano curata da Alessandro Bausani e nell'edizione curata
dall'Ucoii con i commenti di Hamza Roberto Piccardo. Ma per Bausani è un velo che deve ricoprire
solo i seni, mentre per Piccardo è un velo che deve scendere dalla testa al petto.
Bausani: "E dì alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non
mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare e si ricoprano i seni d'un velo".
Piccardo: "E dì alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro
ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto".
Nel versetto XXXIII, 53 del Corano compare la parola hijab, abitualmente tradotta come "velo", ma
che è intesa come "tenda" da Bausani e come "cortina" da Piccardo.
Bausani : "E quando domandate un oggetto alle sue spose, domandatelo restando dietro una tenda:
questo servirà meglio alla purità dei vostri e dei loro cuori."
Piccardo: "Quando chiedete ad esse un qualche oggetto, chiedetelo da dietro una cortina: ciò è puro
per i vostri cuori e per i loro"
Nel versetto XXXIII, 59, del Corano compare la parola jilbab, tradotta come "mantelli" dal Bausani
e come "veli" da Piccardo. » (Luciana Cencioni, sito internet)
20
5.2. diritto: una definizione per fornire una prospettiva. L’espressione “diritti umani” fa
riferimento a una serie piuttosto lunga di norme contenute in documenti, carte, trattati internazionali
a partire (per non retrocedere troppo) dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalla
assemblea generale delle Nazioni Unite il10 dicembre 1948. La natura di quelle dichiarazioni è
molto varia per contenuti e contesto ma soprattutto per capacità di rappresentare un vincolo
normativo efficace; la stessa Dichiarazione «sarebbe un documento “non giuridicamente
vincolante” caratterizzato dalla sua formulazione “generica e solo moralmente impegnativa”». La
direzione giuridica delle dichiarazioni è però evidente: proclamare diritti aventi valore universale
perché fondati sull’individuo. È dunque possibile disporre di una nozione condivisa di diritto.
«Proverò a fornire una definizione di diritto in senso soggettivo (la cui titolarità spetta ad un
soggetto): un diritto è fondamentalmente uno strumento per liberarsi dalla coercizione politica,
culturale, religiosa, familiare, sessuale, razziale, e dunque uno strumento per consentire ai soggetti
di programmare la loro vita; tale scopo può essere realizzato mediante libertà sia negative sia
positive (nel senso che i diritti non possono essere intesi solo come ‘libertà da’, se essi non sono
corredati anche dalla ‘libertà di’), ovvero sia chiedendo allo Stato, alla famiglia, all’etnia, alla
religione di permettere al soggetto di scegliere, sia prevedendo che lo Stato, la famiglia, l’etnia etc.
si attivino per far sì che il soggetto realizzi le sue aspirazioni di autonomia; l’obiettivo
dell’autonomia non è affatto in contraddizione con la libertà positiva e l’attivazione da parte dello
Stato e degli altri soggetti indicati: infatti, è del tutto intrinseca al concetto di diritto l’idea che esso
venga ‘maneggiato’, gestito, garantito anche da quei soggetti — lo Stato, in primis — di cui i diritti
tendono ad arginare i poteri.» (Tedesco Francescomaria 2009 Diritti umani e relativismo, Laterza,
Roma-Bari p.8-9)
5.2.1. il tema del diritto e del diverso ruolo Stato e Comunità applicato al problema del “velo”.
« Il «velo». Quando lo Stato francese, dopo aver riconosciuto, sotto Napoleone, le comunità
cattoliche, luterane riformate ed ebree, comincia a organizzare la rappresentanza dei musulmani di
Francia e la affida a un organismo eletto, riconosce l’esistenza di una comunità musulmana, senza
che questo implichi una gestione comunitarista della società. Si può utilizzare questa espressione
solo per movimenti che reclamano, in nome di una comunità definita in senso culturale o etnico, il
monopolio della gestione delle relazioni tra i membri della comunità e di quest’ultima nel suo
insieme con lo Stato nazionale, se non addirittura con le istituzioni internazionali. Questa
concezione dell’organizzazione sociale può arrivare fino all’identificazione completa degli
individui con una certa comunità etnica, nazionale o religiosa. Identificazione che definisce tutti gli
aspetti del loro modo di vita e perfino la definizione dei loro diritti. Se un governo accettasse che
sulle carte di identità nazionali alcune donne portino un velo islamico o un chador, questo
significherebbe, per lo Stato, avere relazioni non con cittadini, ma con membri di una comunità.
Questa situazione estrema sarebbe il segno di un indebolimento generale e della sparizione
pressoché completa dello Stato nazionale.
Il comunitarismo che ci inquieta oggi è quello che si colloca al di sopra della cittadinanza ovvero
che riconosce l’appartenenza culturale come superiore all’identità nazionale. […]
Più le popolazioni si mescolano in un mondo che diventa nomade e più diventano numerosi gli
incontri che possono portare, da un lato, all’assorbimento di un gruppo in un altro gruppo, o alla
guerra tra due gruppi, ma anche, dall’altro, alla comunicazione interculturale. Quest’ultima,
tuttavia, non è tanto facilitata dalla partecipazione di tutti a una civiltà ampiamente mondializzata,
quanto dall’accettazione della modernità e dei suoi princìpi fondamentali. (Touraine Alain 2004 La
globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, il Saggiatore,
Milano 2008, p. 228,236) Il principio della comunità (Gemeinschaft) è garantito all’interno di un
patto di società (Gesellschaft) fondato sul riconoscimento e sulla garanzia dei diritti offerta dallo
stato a tutti i cittadini in quanto persone.
5.3. l’implicito di una “questione femminile” e della condizione storica della donna; il tema
prende rilievo ulteriore se si considerano i termini e il titolo stesso in cui il problema si pone:
21
5.3.1. si declina al naturale e all’interno di un palese sbilanciamento in quanto non esiste una
parallela “questione maschile”. Valga la breve ma incisiva annotazione del politologo e sociologo
Latour: «Le femministe ci hanno spesso fatto capire come l’assimilazione delle donne alla natura
abbia avuto per parecchio tempo l’effetto di privarle di ogni diritto politico. Gli esempi di legami tra
concezioni della natura e concezioni della politica sono così numerosi da legittimare chi sostiene
che ogni questione epistemologica è anche politica.» Latour Bruno 1999, p. 29
5.3.2. si declina ponendo al centro questioni marginali che hanno lo scopo di nascondere la volontà
di non affrontare in termini culturali sociali e politici la “questione femminile” nella su centralità ed
interezza; basta porre a confronto: «l’aggravarsi quotidiano della situazione della donna nel mondo
e in Europa, a causa della crescente mercificazione dei corpi, rispetto all’eco stonato della retorica
sull’emancipazione e sui diritti, sostenuta da un terzomondismo rovesciato che concentra sul “velo”
il livore dell’impotenza nel cortile di casa.» ( Amoroso Bruno 2009 Per il bene comune. Dallo stato
del benessere alla società del benessere, Diabasis, Reggio Emilia, p. 15)
5.4. la logica dell’appartenenza e delle gerarchie
Sul tema, antico, una citazione dalla tradizione epica greca: «nel momento in cui Troia inizia la sua
decadenza, dopo l’uccisione di Ettore, le due troiane più illustri si disfano del loro velo. Ecuba
gemendo «gettò via il suo splendido velo» mentre Andromaca «[...] cadde indietro [...]: le bende
splendenti scivolarono via dal capo, lontano, il diadema, la rete, il cordone intrecciato, il velo, che le
donò l’aurea Afrodite, nel giorno ch’Ettore elmo lucente la portò via dalla casa d’Eezione, offerti
doni infiniti». Questi due svelamenti prefigurano e attestano al contempo la caduta di Troia: il gesto
serve qui da illustrazione alla metafora.
L’allusione al velo matrimoniale di Andromaca accentua ulteriormente il carattere drammatico e
simbolico dell’episodio. L’effetto di contrasto è sorprendente: una notte di tenebra dolorosa
l’avviluppa prendendo il posto del velo splendente, dono di Afrodite, che cade a terra. Il velo che
scivola lontano era stato fino a quel momento il segno visibile del suo status di sposa e di donna
virtuosa. Ormai privata della presenza di Ettore, ella è alla mercé dei Greci assalitori. La caduta del
suo krêdemnon corrisponde, nella sfera del femminile, al disonore di Ettore trascinato nella polvere.
Il sistema dei valori che era in gioco nella metafora della città-donna si esprime dunque anche nei
gesti della “realtà”. » (Monsacré Hélène 1894 Le lacrime di Achille. L’eroe, la donna e il dolore
nella poesia di Omero, Medusa, Milano 2003 p.39-40) La caduta del velo, l’essere senza velo è
essere senza appartenenza, senza legame e, nel caso citato, senza protezione.
5.5. posizioni antinomiche sul velare e svelare (posizioni e testimonianze e … filosofia)
5.5.01. è il dilemma della Gioconda: Renzo Manetti nel saggio Il velo della Gioconda. Leonardo
segreto (ed. Polistampa, 2009) avanza l’ipotesi che vi sia un secondo quadro che ritrae la stessa
donna nuda: il dittico rappresenterebbe l’omaggio ai due volti di Venere, velata e svelata secondo
un vezzo in uso tra gli artisti del tempo; anche se il dipinto è andato perduto, esistono almeno una
decina tra riproduzioni e opere di analogo soggetto, eseguite da allievi e discepoli, che ci
permettono di ricostruire l’originale
Opposte testimonianze e posizioni, e il tentativo di richiamare radici filosofiche.
5.5.1. Alcune testimonianze di donne con velo per cultura religiosa e tradizione o rivendicazione
identitaria, nel contesto del dibattito sul velo in Francia. «Il niqab è un semplice vestito, non deve
far paura! Al contrario, col niqab mostro la mia dirittura morale. Ci si dovrebbe sentire sicuri vicino
a donne che portano il velo integrale, perché il segno che esse sono pie e oneste» «Io condivido
tutte le loro battaglie. Mi rifiuto di obbedire a ciò che gli uomini mi impongono. Mi rifiuto di
esibirmi di fronte a loro. Non sono un volgare pezzo di carne in esposizione, sono una donna.»
«Probabilmente è una prigione dal punto di vista degli altri, in realtà io non mi sono mai sentita così
libera in tutta la mia vita.» «Noi siamo diamanti. Come i diamanti, dobbiamo preservarci dal
desiderio di possesso esterno affinché nessuno ci rubi» (da Le Monde Magazine 20 gennaio 2010)
22
5.5.1.1. sul filo della filosofia: «Lo sguardo sull’altro corre sempre il rischio di essere un moto di
appropriazione. L’incontro impone di rispettare la parte nascosta di ognuno, per evitare la presa di
possesso che presta il fianco alla fusione e alla morte. Si tratta di creare una distanza grazie alla
quale lo scambio può verificarsi senza scalfire l’individualità di nessuno dei due soggetti. Questa
distanza attesta l’esistenza delle frontiere di ciascuno e gli offre protezione, sicurezza e libertà di
azione. A quel punto, il soggetto non deve più avere timore né di recare danno all’integrità
dell’altro, né di essere colpito nella propria. Mosè, protetto dalla mano di Dio stesso, potrà a sua
volta servire da mediatore, velo, schermo protettivo per il popolo. […] Cercare di eliminare questo
velo che separa ognuno dall’altro e ne preserva il mistero, significa prestare il fianco alla
confusione, alla differenziazione e all’appropriazione. … funzione del pudore, che consiste
nell’assicurare la separazione tra gli esseri e nel mantenere segreta la parte nascosta di ognuno, al
fine di proteggerla dal desiderio di possesso dell’altro.» (Selz Monique 2003 Il pudore. Un luogo di
libertà, Einaudi, Torino 2005 p. 112-113,122,125)
5.5.2. Testimonianze in opposizione alla prassi del velo, del velare… e il tema della comunicazione,
della relazione, dei diritti. Alla osservazione che “alcune donne che portano il burqa sostengono che
è una scelta identitaria, che è una scelta e non un’imposizione…” risponde Wassyla Tamzali, già
direttrice dei diritti delle donne all’Unesco, militante nel movimento femminista magrebino: «Sì,
come in certe pratiche sadomasochiste c’è sempre un’acquiescenza all’asservimento. Il burqa è
anche un attacco fisico all’integrità. Non può essere una scelta. Può essere un consentire a una
pressione esercitata all’interno di una coppia, di un contesto ecc. Può anche esercitare, come in
alcune pratiche settarie, una forma di fascinazione, di “sudditanza”. Con il velo integrale si
raggiunge una frontiera caricaturale della distinzione e segregazione dei sessi. Nel velo c’è in gioco
la cultura dell’harem, che ora ha raggiunto le strade. … È una pratica inammissibile nel XXI secolo,
che noi rifiutiamo e combattiamo in Afganistan; come se ne può ancora discutere in Francia?» (Le
Monde, citato)
5.5.2.1. sul filo della filosofia: la relazione (la comunicazione, il riconoscimento), lo sguardo e il
volto nelle riflessioni di Jean-Paul Sartre (1943, L’essere e il nulla. Saggio di ontologia
fenomenologia, Gallimard, 1977) di Emmanuel Lévinas (1961, Totalità e infinito. Saggio
sull’esteriorità, Jaka Book, Milano 1980)
5.5.2.1.1. L’analisi fenomenologia dello sguardo, tema centrale della fenomenologia ontologica di
Sartre; alcune citazioni. «Il rinvio di fatto a una nascita gemellata ove l’altro è presenza per me è
dato al di fuori della conoscenza propriamente detta … la sua essenza deve riferirsi ad una relazione
originaria della mia coscienza a quella dell’altro, relazione prima nella quale l’altro deve essermi
dato direttamente come soggetto sia pure in relazione con me, e che costituisce il rapporto
fondamentale, il tipo stesso del mio essere-per-altro.» (Sartre 1943, 299) «Se l’altro-oggetto è
definito dal legame con il mondo inteso come oggetto che vede ciò che io vedo, il mio legame
fondamentale con l’altro-soggetto deve potersi rapportare alla mia possibilità permanente di essere
visto dall’altro. È nella e attraverso la rivelazione del mio essere-oggetto per un altro che io devo
poter cogliere la presenza del suo essere-soggetto.» (Sartre 1943, 302) «Percepire è guardare, e
cogliere uno sguardo non è apprendere un oggetto-sguardo nel mondo (a meno che questo sguardo
non sia diretto su di noi), è prendere coscienza di essere-guardato. Lo sguardo che manifestano gli
occhi, di qualunque natura essi siano, è un puro rinvio a me stesso.» (Sartre 1943, 304-305)
5.5.2.1.2. Lévinas: la comunicazione e il volto
«L’idea importante quando evoco il volto d’altri, la traccia dell’infinito, o la Parola di Dio, è quella
di una significanza di senso che, originariamente, non è il tema, non è l’oggetto di un sapere, non è
l’essere di un essente, non è rappresentazione. Un Dio che mi concerne tramite una Parola espressa
in guisa di volto dell’altro uomo è una trascendenza che non diventa mai immanenza. Il volto d’altri
è il suo modo di significare.
Perché il volto che incontro quotidianamente non appartiene alla storia, non è un fenomeno, una
semplice esperienza?Perché si strappa al contesto? Ho sempre descritto il volto del prossimo come
portatore di un ordine, che mi impone nei confronti di altri una responsabilità gratuita — e
23
incedibile, come se l’io fosse eletto e unico — e in cui altri è assolutamente altro, vale a dire ancora
incomparabile e, così, unico. Ma gli uomini che mi attorniano fanno numero. Da qui la questione:
chi è il mio prossimo? Questione inevitabile della giustizia. Necessità di comparare gli
incomparabili, di conoscere gli uomini; da qui il loro apparire come forme plastiche di figure
visibili e, in qualche modo, “fissate”: come un raggruppamento da cui l’unicità del volto si distacca
come da un contesto, fonte della mia obbligazione verso gli altri uomini; fonte a cui la ricerca stessa
della giustizia ritorna in fin dei conti e il cui oblio rischia di trasformare in calcolo puramente
politico — e fino agli abusi totalitari — l’opera sublime e difficile della giustizia. … penso che la
responsabilità per l’altro uomo o, se preferisce, l’epifania del volto umano costituisca un varco nella
crosta dell’“essere che persevera nel suo essere” e si prende cura di sé. Responsabilità per altri, il
per-l’altro “dis-interessato” della santità.» (Lévinas Emmanuel 1995 Alterità e trascendenza, il
Melangolo, Genova 2006 p. 143-144)
5.5.2.1.2.1. Le pagine di Lévinas così vengono richiamate da Paul Ricoeur: «Sono famose le pagine
sul volto che, come afferma Lévinas, non appare nel senso di una rappresentazione, ma si esprime.
Esso insegna: “Nella sua transitività non-violenta si produce proprio l’epifania del volto” (ibidem,
p. 49). Il volto interpella, sino nel faccia a faccia. Esso non è dato alla visione: “La sua rivelazione è
parola” (ibidem, p. 197). “La parola sporge sulla visione” (ibidem, p. 200). Esso è “presente nel suo
rifiuto di essere contenuto” (ibidem, p. 199). In una relazione inversa rispetto a quella della
“appercezione analogica” di Husserl, il volto coniuga trascendenza ed epifania. Ma l’epifania non è
una appercezione analogica bensì una rivelazione sui generis. L’io, interpellato, viene strappato dal
suo stato di separazione e di godimento di sé e chiamato a rispondere. Responsabilità non è perciò
affermazione di ipseità, ma risposta secondo il modello dell’“eccomi” di Abramo.» Ricoeur Paul
2004 Percorsi del riconoscimento (Parcours de la reconnaissance), Raffaello Cortina, Milano 2005
p.178 (il tema verrà ripreso in Storie del riconoscimento).
L’“epifania del volto” è manifestazione di una alterità e di una trascendenza non assimilabili. Si è di
fronte ad una dissimmetria che non può e non deve dar corso all’assimilazione e alla riduzione
all’uguale, all’unico. Parte da qui anzi un tormentato e affascinante cammino del riconoscimento
dell’altro, nell’attesa, nell’apertura all’alterità, mista a meraviglia e gratitudine. La dissimmetria tra
l’altro e l’io, evento della manifestazione, è espressa nella trascendenza del volto, nella sua natura
“infinita” quanto ai significati che contiene e che può esprimere.
A seguire come possibile (e infinito) dibattito
Il “complesso” dell’identità e il suo uso politico
Una guida “estetica”: Busto A. (a cura di) 2007 Il velo, catalogo della mostra “Il velo”, Carigliano
28 ottobre 2007-24 febbraio 2008.
24