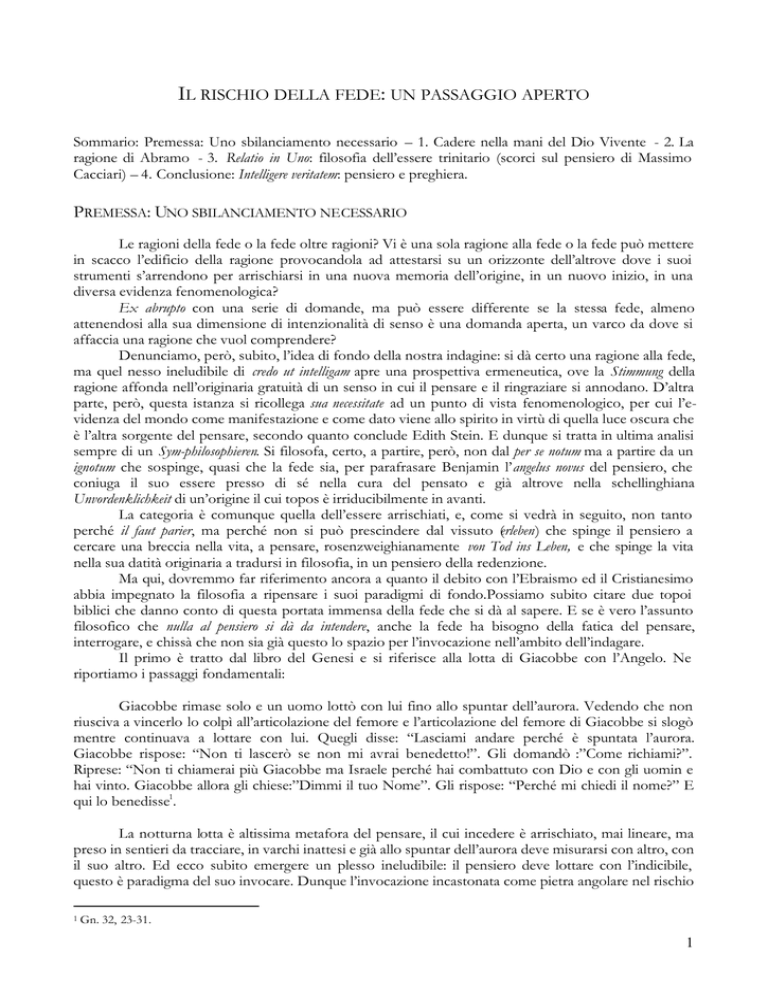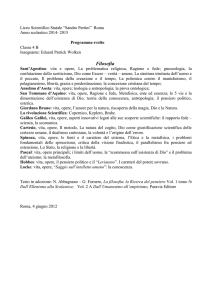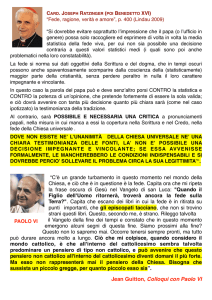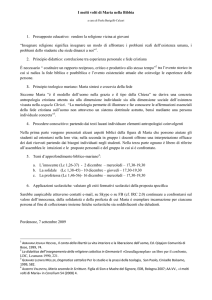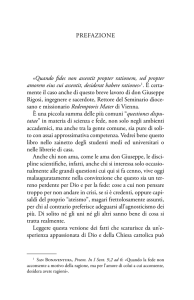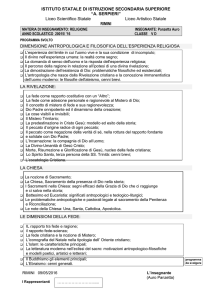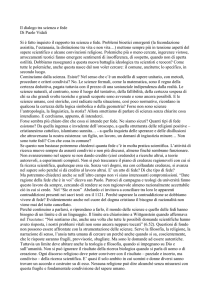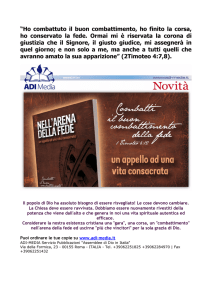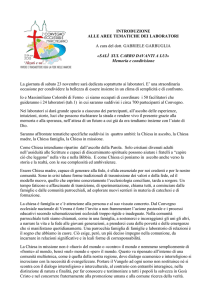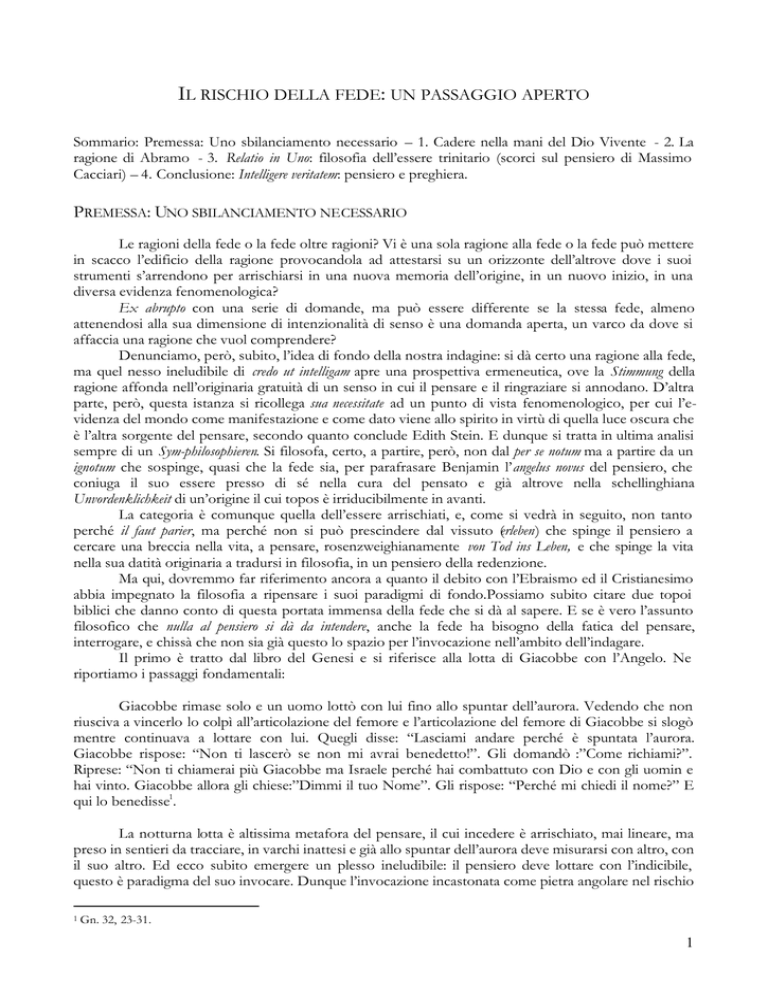
IL RISCHIO DELLA FEDE: UN PASSAGGIO APERTO
Sommario: Premessa: Uno sbilanciamento necessario – 1. Cadere nella mani del Dio Vivente - 2. La
ragione di Abramo - 3. Relatio in Uno: filosofia dell’essere trinitario (scorci sul pensiero di Massimo
Cacciari) – 4. Conclusione: Intelligere veritatem: pensiero e preghiera.
PREMESSA: UNO SBILANCIAMENTO NECESSARIO
Le ragioni della fede o la fede oltre ragioni? Vi è una sola ragione alla fede o la fede può mettere
in scacco l’edificio della ragione provocandola ad attestarsi su un orizzonte dell’altrove dove i suoi
strumenti s’arrendono per arrischiarsi in una nuova memoria dell’origine, in un nuovo inizio, in una
diversa evidenza fenomenologica?
Ex abrupto con una serie di domande, ma può essere differente se la stessa fede, almeno
attenendosi alla sua dimensione di intenzionalità di senso è una domanda aperta, un varco da dove si
affaccia una ragione che vuol comprendere?
Denunciamo, però, subito, l’idea di fondo della nostra indagine: si dà certo una ragione alla fede,
ma quel nesso ineludibile di credo ut intelligam apre una prospettiva ermeneutica, ove la Stimmung della
ragione affonda nell’originaria gratuità di un senso in cui il pensare e il ringraziare si annodano. D’altra
parte, però, questa istanza si ricollega sua necessitate ad un punto di vista fenomenologico, per cui l’evidenza del mondo come manifestazione e come dato viene allo spirito in virtù di quella luce oscura che
è l’altra sorgente del pensare, secondo quanto conclude Edith Stein. E dunque si tratta in ultima analisi
sempre di un Sym-philosophieren. Si filosofa, certo, a partire, però, non dal per se notum ma a partire da un
ignotum che sospinge, quasi che la fede sia, per parafrasare Benjamin l’angelus novus del pensiero, che
coniuga il suo essere presso di sé nella cura del pensato e già altrove nella schellinghiana
Unvordenklichkeit di un’origine il cui topos è irriducibilmente in avanti.
La categoria è comunque quella dell’essere arrischiati, e, come si vedrà in seguito, non tanto
perché il faut parier, ma perché non si può prescindere dal vissuto (erleben) che spinge il pensiero a
cercare una breccia nella vita, a pensare, rosenzweighianamente von Tod ins Leben, e che spinge la vita
nella sua datità originaria a tradursi in filosofia, in un pensiero della redenzione.
Ma qui, dovremmo far riferimento ancora a quanto il debito con l’Ebraismo ed il Cristianesimo
abbia impegnato la filosofia a ripensare i suoi paradigmi di fondo.Possiamo subito citare due topoi
biblici che danno conto di questa portata immensa della fede che si dà al sapere. E se è vero l’assunto
filosofico che nulla al pensiero si dà da intendere, anche la fede ha bisogno della fatica del pensare,
interrogare, e chissà che non sia già questo lo spazio per l’invocazione nell’ambito dell’indagare.
Il primo è tratto dal libro del Genesi e si riferisce alla lotta di Giacobbe con l’Angelo. Ne
riportiamo i passaggi fondamentali:
Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell’aurora. Vedendo che non
riusciva a vincerlo lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò
mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: “Lasciami andare perché è spuntata l’aurora.
Giacobbe rispose: “Non ti lascerò se non mi avrai benedetto!”. Gli domandò :”Come richiami?”.
Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele perché hai combattuto con Dio e con gli uomin e
hai vinto. Giacobbe allora gli chiese:”Dimmi il tuo Nome”. Gli rispose: “Perché mi chiedi il nome?” E
qui lo benedisse1.
La notturna lotta è altissima metafora del pensare, il cui incedere è arrischiato, mai lineare, ma
preso in sentieri da tracciare, in varchi inattesi e già allo spuntar dell’aurora deve misurarsi con altro, con
il suo altro. Ed ecco subito emergere un plesso ineludibile: il pensiero deve lottare con l’indicibile,
questo è paradigma del suo invocare. Dunque l’invocazione incastonata come pietra angolare nel rischio
1
Gn. 32, 23-31.
1
del pensiero. Ed è l’eterna lotta con l’indicibile che provoca la slogatura del pensiero, sia come memoria
della sua paradossale capacità di intenzionarlo appena suggerendolo, sia come impegno ad attestarsi
sulla domanda, comprendendo appena per speculum et in aenigmate la cognitio mattutina che sporge
da quel vespro del suo stesso dire. Così si dà la logica del paradosso: il climax dell’attingimento del
divino è la resa all’impotenza di dirlo, o meglio a dirlo nel balbettio, nella slogatura, mai più nella
definizione o determinazione, né nella deduzione ma nell’invocazione.
Bisogna però sgomberare il campo da ogni illusione, invocazione non già come alienazione o
frettolosa mediazione, quanto invece come veglia della ragione presso il suo altro, come passione per
l’indicibile che la piaga e forse la guarisce. Dunque il rischio della fede è già kenosis del Logos.
C’è, però, come si diceva dianzi, un altro luogo che dice della fede come affidamento dialogico e
come interpellazione, e che ci pone subito dinanzi ad una categoria euristica da evidenziare più
diffusamente nel prosieguo: quella del Dieu caché. Si tratta della Lettera agli Ebrei:
La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Per mezzo
di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza2.
Pistis è il termine greco per fede, e lo stessa radice si trova nella parola epistemologia che
implica, appunto, un fondamento certo, accertabile. Tra fede e fondamento, tuttavia, non si può non
avvertire un ossimoro. La fede non è accertabile da un punto di vista gnoseologico. Si può certo parlare
di un’epistemologia dell’actus fidei, ma della fede, certo, non si dà demonstratio scientifica. Essa,
secondo la lettera agli Ebrei è ordinata alla speranza, ma la speranza è a sua volt a ordinata all’invisibile.
Il fondamento della fede è un circolo ermeneutico ove il credere si fonda sulla testimonianza, ove la
testimonianza è fondata sulla Parola, ove la Parola è creduta e sperata in un atto di adesione del tutto
libero, in una scelta assolutamente originaria che sottende il rischio della libertà. La fede è prova, ma il
suo essere probante è ancora nell’ambito di una analogia fidei che pone assolutamente ed unicamente alla
libera potestà della Parola, come, recuperando Lutero, insegnerebbe Karl Barth.
Ma, pure, qui non si dà irrazionalismo. La Parola implica la testimonianza ed essa ha bisogno di
donare ragione, di intelligere la fede. Certamente siamo dinanzi ad una epistemologia sui generis che
sfida la ragione e la fa desistere dalla tentazione della presa concettuale, ponendola all’ascolto di un
Appello. Da questo punto di vista, può accompagnarci un’altra citazione dalle Sacre Scritture,
precisamente dalla Lettera di Pietro:
pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi3.
Il fondamento teoretico della fides è dunque la speranza creduta e testimoniata, che si avvale
della ragionevolezza per poter essere esplicata. Eccoci giunti al nodo problematico già da sempre noto
alla filosofia. Fede e ragione non possono separarsi, ma la loro posizione non può che essere dialettica e
nessuna Aufhebung può assorbire la fede nella chiarezza del concetto giunto a sé dopo la fatica della
rappresentazione. La fede splende oscuramente e spinge la ragione al suo oltre, slogatura necessaria e
avventura del rischio, se è vero che il pensiero non può non voler cercare e la fede sottende la stessa
ricerca come la sua logica più paradossale e feconda.
1. CADERE NELLA MANI DEL DIO VIVENTE
Fissare l’attenzione sulla fede significa sgombrare il campo da qualsivoglia teologia che non
cerchi nella Parola di Dio la propria fondazione. La critica all’ontoteologia così forte nella filosofia del
Novecento, come ben evidenzia lo Heidegger del Brief über den Humanismus4 ha toccato un punto
centrale dove pensiero filosofico e pensiero teologico convergono. Il primo, infatti, viene invitato a
depurarsi da ogni contaminazione ontologico-deduttiva nel suo riferimento a Dio, evitando, in ultima
Ebr.11, 1-2
1 Pt, 3, 15b.
4 Cfr. M. Heidegger, Lettera sull’ “umanismo”, in Segnavia, trad. it. A cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1987.
2
3
2
analisi, di ridurlo al climax del sapere: il Summum Ens, il secondo viene sfidato a cercare nella Scrittura la
certificazione del proprio fondamento, tenendo ben presente la Assoluta differenza. Come afferma Karl
Barth: Dio è Dio e l’uomo non è Dio. Non si tratta di una mera tautologia, come l’asserto potrebbe far
pensare, quanto invece di un invito alla consapevolezza che il Radicalmente Altro non può assoggettarsi
a forme di sapere terreno, che, anzi, è sempre inadeguato, se pur paradossalmente assetato di
attingimento. Ed, infine, secondo quanto asserisce il filosofo Italo Mancini: il massimo della filosofia è
parlare di Dio, il massimo della teologia è parlare con Dio e per la teologia il telos della filosofia non è che il
minimo. Se la filosofia esige la dimostrazione dell’esistenza di Dio come pienezza di tutte le
determinazioni, pena la contraddizione che inficia l’esistenza in Atto, la fede si basa sulla logica del
paradosso. La sapienza della fede, diremmo, meglio, è la kenosis, così che ci si deve attestare
sull’inevitabile imperativo ne evacuata sit Crux Christi. Tale logica del paradosso ci mette di fronte ad un
nuovo ossimoro: quello di una filosofia della kenosis e della Croce.
La kenosis e la Croce sia pure skandalon e follia dicono di un’eccedenza della Verità che mette in
crisi l’apofansi ed il principio di non contraddizione. Esse, infatti, legano, finito ed eterno, morte e vita,
e soprattutto rivelano la profonda aporia della ragione avvinta nelle maglie della medesimezza. Esse
aprono il Logos all’infinita possibilità dell’eteron, evidenziando che l’eteron non può essere inghiottito
nelle maglie della demonstratio come un momento del generale.
La categoria teologica della revelatio Dei sub contrario espressa dalla kenosis e ripresa dal locus
classico della teologia luterana deve essere una riserva critica della ragione, il cui sapere non culmina
nell’astrazione, ma più che mai, nel Novecento nella aspirazione a serbare la cura della finitezza, a
renderla alla sua dignità. Altrimenti anche la vita e la morte non sarebbero che momenti di una
Aufhebung esangue.
Come criterio euristico impiegheremo quello del Dieu caché, del Dio nascosto pascaliana, e su
Pascal non potremo non fissare la nostra attenzione, dato il paradigma filosofico che propone con una
incidenza rilevante circa il rapporto fra fede e modernità5. E’ nota la dicotomia pascaliana fra il Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe ed il Dio dei filosofi, la quale permette di rilevare la necessità di un diverso
modo di procedere da parte di un filosofo credente che fa filosofia a partire dalla sua fede, la quale
occupa una posizione centrale e non già marginale. Questo evidenzia per altro che la mediazione
filosofica della metafisica greca non è adeguata a rendere ragione della Rivelazione e soprattutto della
Rivelazione di un Dio che si fa presente come liberatore assumendo la storia come luogo teologico della
manifestazione della Sua identità.
Nella notte mistica, nella quale egli sente il Mistero della kenosis divina in tutta la drammaticità
del paradosso, il filosofo di Port Royal comprende che dinanzi all’esistente segnato dalla fragilità e dalla
morte, il Dio causa sui non è che un surrogato della ragione che lo risolve nell’ipotesi di lavoro su cui
fondare la spiegazione del mondo; un Dio chiquenaude, insomma che dà al mondo il primo colpo per
porsene fuori. Questo Dio è totaliter alter dal Dio biblico che fa della storia dell’uomo una storia di
salvezza. Così egli annoterà nelle Pensées:
Il Dio dei cristiani non consiste in un Dio autore semplicemente delle verità geometriche e
dell’ordine degli elementi: questa è la posizione dei pagani e degli epicurei…..Ma il Dio di Abramo, il
Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei cristiani, è un Dio di amore e di consolazione, un Dio che
riempie il cuore e l’anima di quelli che possiede, un Dio che fa loro sentire interiormente la loro miseria
e la sua infinita misericordia, che si unisce al fondo della loro anima, che la riempie di umiltà, di gioia, di
fiducia, di amore, che li rende incapaci di avere altro fine che lui stesso6.
Forse, di qui si diparte l’idea pascaliana di un entendment inteso come intus-ire rispetto alla raison
intesa come ratio, ovvero come calcolo e misura. Dunque è impossibile cercare una prova del paradosso
divino attraverso il procedere razionale. La paradossalità divina si esplica tanto nella sovrarazionalità del
suo evento, quanto nel sentimento che tocca l’ordine del cuore, altrimenti definito esprit de finesse. La
5
Rinviamo per questo a C. Ciancio - U. Perone, Cartesio o Pascal? Un dialogo sulla modernità, Rosenberg & Sellier, Torino 1995.
6
Pascal, Pensieri, ed. Brunschvicg, n. 556.
3
sovrarazionalità divina fa parte dell’ordo gratiae, e tuttavia la grazia a caro prezzo, di bonhoefferiana
memoria, si esplica in una contraddizione di ogni dato razionale. Essa è scandalo e stultitia. Proprio per
questo motivo l’actus fidei implica adesione e testimonianza, e dunque nasce dall’ordine del cuore che è il
nostro contatto, originario, intimo, diretto con l’assoluto, con l’essere, con la verità, con Dio, cioè è a un tempo il fondo del
nostro essere e la facoltà dell’infinito7.
Tuttavia, anche in questo caso, la paradossalità sembra evidente. Da un lato, infatti, la ragione
sembra non poter attingere l’infinito e l’assoluto, dall’altro il sentimento ne è apertura e intuizione. In
questo senso si tratta, poi, di un intuire che fa capo ad una verità come eccedenza e che immette l’idea
del mistero nell’ambito della riflessione filosofica. Si potrà già evincere la posizione pascaliana, non
tanto come un fideismo antifilosofico, ma come un momento critico all’interno della stessa filosofia e
delle sue pretese. Quasi si potrebbe trattare di un momento di demistificazione. Se la vraie philosophie se
moque de la philosophie, come lo stesso Pascal asserisce ricorrendo ad una figura ossimorica, ciò implica
che essa non può escludere che i luoghi di manifestazione della verità non siano solo l’intelletto e la
ragione. Se poi, ammettiamo con Pascal che il lume naturale è chiarezza naturale sostenuta dalla ragione
dove difetta il discorso, non è così difficile immaginare che i principi certi dell’intelletto provengano da
un rapporto preintellettuale e forse prerazionale che sorregge il discorso del logos. L’indicazione più
importante che ci viene da questo tipo di teoresi è quella di far professione dei due contrari.
La stessa logica pascaliana è paradossale anche perché, come si diceva, recupera il nucleo più
autentico del Cristianesimo: l’Incarnazione da cui poi si evince l’idea della Croce. Uno dei luoghi
fondamentali capaci di esibire una filosofia della Rivelazione è la lettera che Pascal scrive a M.lle De
Roannez:
Dio si cela ordinariamente e sis copre raramente, è rimasto nascosto sotto il velo della natura
che ce lo copre, fino all’Incarnazione:quando è stato necessario che apparisse, si è ancora di più
nascosto ricoprendosi di umanità8.
La kenosis di Dio sostiene la logica della fede, che non procede per asserti del lume naturale, ma
anzi si consegna alla notte luminosa della Rivelazione divina, perché trop de lumière eblouit e Dio sarebbe
luce accecante se non si celasse nel velo della carne, nella sfigurata bellezza del Servo sofferente. Pascal
rivisita senza dubbio i luoghi privilegiati della tradizione mistica cristiana da Agostino allo Pseudodionigi
fino a Tommaso D’Aquino, ma sicuramente la sua riflessione segna un’importante conquista
ermeneutica, cui la riflessione filosofica contemporanea fa sempre maggiore attenzione, quella di
pensare un Dio non contaminato dalle categorie metafisico-ontologiche, un Dio al di là dell’essere,
inverando così, da un lato le istanze di Heidegger, secondo il quale la teologia stessa dovrebbe tentare di
non far entrare l’idea dell’essere nel suo discorso su Dio e dall’altro quelle barthiane, legate alla legittima
pretesa della teologia di fondarsi solo sulla Pa rola divina.
Tuttavia si diceva che Pascal confessa la necessità di fare professione dei due contrari; questo
implica la possibilità di un pensiero tragico, ben consapevole che lo sguardo di Dio non è sostenibile, e
che, se Dio si rivela lo fa di spalle perché vederlo è morire. Dall’altro lato, però, si tratta di un pensiero
consapevole che credere è entrare in conflitto, ovvero essere arrischiati sul passaggio stretto ove
vengono meno immagini e concetti, ove, come scrive David Turoldo muore anche la più luminosa metafora9
ed il cammino ha fine in una misteriosa consegna al Vivente. Potremmo ipotizzare dunque una
philosophia crucis? Anche questo sarebbe un ossimoro, ma a nostro avviso un ossimoro fecondo.In effetti,
consegnarsi, indica in primis un’azione ex parte Dei, in Cristo; paradidonai attesta una doppia consegna:
la prima di affidamento al Padre nell’ora estrema, la seconda ha il senso di una donazione, un estremo
atto kenotico per cui colui che non aveva conosciuto peccato si è fatto peccato per noi. La consegna alle mani del
Padre è implicata in quella estrema al peccato del mondo per crocifiggerlo nella carne. Anche in questo
caso la consumata Rivelazione si dà attraverso la carne sfigurata. Il Mistero del Verbo si dà nell’estremo
silenzio del Dio crocifisso.
L. Pareyson, L’etica di Pascal, Giappichelli, Torino 1966, p. 173.
Lettera a M.lle de Roannez dell’ottobre 1956, in Pensieri, Brunschvicg , pp. 214-231.
9 Cfr. Canti ultimi, Garzanti, Milano 1991 p. 172.
7
8
4
Similmente a questa vi è una consegna da parte dell’uomo, quella della spogliazione avanti
l’entrata nella morsa divina in un morire e rivivere nel mistero dell’agonia di Cristo. Per questo Pascal
annoterà in uno dei suoi pensieri memorabili:
Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo10.
Consegnarsi dunque è riconoscere l’assoluta signoria del Vivente e ciò implica, la posizione di
un differente piano del pensiero che l’istanza fenomenologica ci aiuta a meglio evidenziare. Qui, in
effetti, non si dà alcuna conoscenza secondo la logica delle prove dell’esistenza di Dio, quanto invece
un vissuto, un erleben secondo cui si sente di essere afferrati da una potenza assolutamente altra, se pur si
tratta di un essere afferrati ab intrinseco, per essere assimilati alla passione divina in una misteriosa
dialettica di giudizio e grazia. Si potrebbe applicare all’istanza di Pascal la lettura che Luigi Pareyson fa
di Barth e della paradossia Christi negli Studi sull’esistenzialismo:
La fede è dicevamo, morire col Cristo e risorgere con Lui: il Cristo è, infatti, negazione della
negazione della nostra negatività, e perciò posizione (….). La morte del Cristo è la fine dell’uomo
vecchio: è quella negazione dell’uomo la quale implica la posizione che viene da Dio11.
Si può notare una posizione dialettica il cui punto di non ritorno è presupposto in un atto di
fede nella vera testimonianza dell’Unico che poteva in se stesso annientare la negazione perché
posizione dall’eterno e dall’eterno umanità redenta. Cadere nelle mani del Vivente è dunque sottostare
senza che nulla resti al Suo giudizio di misericordia e lasciarsi assumere dalla scandalosa Verità della
Croce.
Essere arrischiati nell’apertura della fede è assumere il senso dell’esistenza tragica. Il giusto vive
sola fide, secondo la posizione paolina, ma proprio questo essere affidati nell’abbandono a Colui che in
sé stesso ha vissuto l’abbandono nell’eone che tocca il Mistero della comunione trinitaria implica la
tragicità dell’esistenza. Estrema logica del paradosso per cui è attraverso il passaggio in questo abisso del
Divino Nulla che si arriva alla tangenza intima con Dio. Così per il credente la paradossale dialettica
della fede implica che il mondo divenga nulla a causa dell’eterno e tutto per la lontananza e l’incognito
di Dio12.
Per Pascal può dunque valere quanto si chiedeva Lukács: “Può ancora vviere quell’uomo su cui si è
posato lo sguardo di Dio?” Ovvero può non avvertire lo spezzarsi irriducibile della propria esistenza
attraversata da un evento così assoluto e così paradigmatico, nonché così inaudito e razionalmente infondato come la Rivelazione? Può dunque non sentirsi in agonia dentro la ancor più misteriosa agonia
di un Dio che ha scelto l’impotenza come climax della Sua stessa libera donazione?
2. LA RAGIONE DI ABRAMO
Parlare dell’esistenza credente implica necessariamente fare riferimento ad un personaggio
paradigmatico in quanto riassume in sé ogni credente affidato ad un incedibile atto di fede che sospende
ogni possibilità di conciliazione etica e che richiama ad una decisione nel kairós dove viene esclusa ogni
possibilità di rifugio nell’impersonalità in quanto la Parola assoluta irrompe nella singolarità di
un’esistenza appellata attraverso un vocativo ineludibile a cui si può solo rispondere con un accusativo
mai assumibile da altri: Ecco-mi. L’esistenza della fede è quella di un soggetto convocato che diventa
soggetto solo nella sua risposta all’Appello Assoluto. Si tratterebbe di una nuova chiamata all’esistenza e
dunque di una nuova posizione ex parte Dei.
Abramo, dunque come paradigma di questo ek-sistere nella totale apertura all’Evento di una
chiamata, vocazione senza compromessi, segno di una dialettica dell’estremo paradosso che
Pascal, Pensieri, Brunschvicg , n. 553.
L. Pareyson, Studi sull’esistenzialismo, Mursia, Milano 2001, p. 101.
12 Su questa tematica del paradosso e del pensiero tragico si co nfronti in particolare I. Mancini, Frammento su Dio, a cura di A.
Aguti, Morcelliana, Brescia 2000, p. 133.
10
11
5
contraddistingue la fondamentale istanza di una fede nella Rivelazione, fides ex auditu. Tale dialettica non
conosce sintesi secondo l’astuzia della ragione perché iscritta nel Mistero del Deus absconditus.
Kierkegaard ha elaborato magistralmente una filosofia della fede mettendosi alla scuola di Abramo,
facendo in modo di aprire fecondi passaggi all’esistenzialismo. Crediamo, però, che egli abbia anche
contribuito ad un’ermeneutica della fede che ha indotto la filosofia a ripensare la sua identità nel senso
di un’apertura al Mistero stesso, assunto come l’eteron fecondo del suo cercare.
Ci ricondurremo al pensiero di Kierkegaard attraverso il pensiero di Jean Wahl che recupera i
tratti principali della sua Renaissance. Innanzi tutto è importante porre in evidenza come Kierkegaard
rifiuti l’Aufhebung del soggetto assoluto in virtù dell’infinita soggettività pensante. Qui, però, si dà il
paradosso in quanto il singolo soggetto è apertura assoluta al Trascendente, che è oltre ogni rapporto,
ma che nonostante tutto non si dà che in un rapporto misterioso13. Lo stesso Abramo, eletto, si trova
nella sua singolarità irriducibile, chiamato da un Dio Assoluto che si rivela soltanto nel mistero di
un’azione che trascende l’etica, un’azione inaudita senza possibilità di comparazione. Dunque l’eksistenza nella fede tipizzata in Abramo è quella del timore e tremore, perché arrischiati, nella propria
finitudine, sul sentiero dell’Assoluto ove paradossalmente non altro soccorre che quello stesso rischio di
abbandonare ogni conforto nel generale. E dunque la fede può mettere in scacco l’esistenza
paradossalmente ridonandola alla sua autenticità in questa terribile spogliazione, ma si tratta di una fede
non consolatoria, che si arrischia nella domanda e nell’ultima solitudine. Così scrive Kierkegaard in
Timore e tremore:
La fede è infatti quel paradosso per cui l’Individuo è al di sopra del Generale e nondimeno (cosa
importante) in modo tale che il movimento si ripeta , e che, di conseguenza, l’Individuo, dopo essere
stato nel Generale, si isoli ormai come Individuo al di sopra del Generale. Se questa non è la fede,
Abramo è perduto……14.
La fede di Abramo che spera al di là di ogni speranza è un monito a non ridurre il Cristianesimo
ad un’etica e a restare nel paradosso che è la condizione ontologica dell’esistenza credente chiamata alla
decisione. Nella condizione della fede c’è un io polvere e cenere, per parafrasare Franz Rosenzweig in
cui fa irruzione il Mistero del Dio sempre celato pur nella Sua rivelazione a cui si può rispondere solo
da individui. Risuona ancora quell’ecco-mi che, non solo, non potrebbe fuggire nel Generale e nella
derelizione dell’impersonale, ma che sottende la deposizione ineludibile della propria esistenza.
Kierkegaard afferma dunque che l’individuo è in rapporto assoluto con l’Assoluto15 e qui la paradossalità
sgombra il campo da ogni conciliazione dialettica. L’elezione è ek-sistenza davanti a Dio persino
nell’assurdo, quell’assurdo che, però, si fa negazione della negazione e dona all’uomo la sua posizione.
Se, per parafrasare Karl Barth, il mysterium Crucis sottende un doppio movimento in Dio: il Suo no ed il
suo sì, il Suo giudizio e la Sua salvezza, e in quello stesso Mistero il nulla della propria morte è ri-posto
nella chiamata alla salvezza secondo l’elezione di Dio, Abramo, typus dell’uomo che vive sola fide
riconosce la propria esistenza contrassegnata dal doppio movimento della fede, ritornando alla sua
finitudine arrischiato nella confidenza che Dio ridonerà tutto ciò che sottrae16.
Questo, tuttavia, ci induce ad una riflessione circa l’esser-ci dinanzi a Dio. Il rischio della fede è,
infatti, ricondotto a quel vivo paradosso che è lo stesso soggetto credente dinanzi alla Parola di Dio.
Già Heidegger in Sein und Zeit ha condotto, sulla base di questa idea, una pregnante riflessione
sull’aspetto fenomenologico della colpa come criterio ermeneutico di un’ontologia della fatticità. A d
ogni modo, l’idea di fondo è quella incontrovertibile dell’homo simul justus et peccator. L’essere è sempre
legato all’ek-sistenza dinanzi a Dio, la quale è, tuttavia, coscienza del peccato e, inoltre, se è vero che eksistere è scegliersi, ci sis sceglie come peccatori. Si dà un dinamismo fra individuo, scelta e rapporto con
l’assoluto. La scelta ci contrassegnerà sempre più come individui, ma come individui coscienti del
Su questo si veda in particolare la bella analisi di L. Pareyson, op. cit., pp. 60 e ss..
S. Kierkegaard, Timore e tremore, S.E., Milano 1990, p. 67.
15 Ivi, p. 68.
16 V. a questo proposito, I. Sørensen, Il doppio movimento della fede in Timore e Tremore, in I. Adinolfi (ed.), Il religioso in
Kierkegaard, Morcelliana, Brescia 2002, p. 189.
13
14
6
proprio peccato; quanto più si avrà questa coscienza, tanto più si starà dinanzi a Dio. In tal senso la
Stimmung dell’ ek-sistenza credente si attesta come angoscia. Neppure questa Angst, tuttavia, è capace di
far declinare la fede, anzi ne invera ancor più sia il rischio che il paradosso. Essa sottende infatti l’instans che annoda l’attimo della colpa con l’attimo della grazia (questa è la stessa paradossia Christi) e la
grazia è al contempo dono ed atto. E’ indubbia la Wirkungsgeschichte kierkegaardiana nell’ambito della
teologia dialettica. Sotto questo aspetto, ci pare importante far riferimento a quanto asserisce Jean Wahl:
Si tratta d’una relazione, la cui intensità fa si ch’essa ha il suo centro tanto nel soggetto
considerato in sé irriducibile ad altro, quanto nel soggetto considerato nel suo rapporto con l’oggetto,
anzi, in un certo senso si può anche dire che il suo centro è nell’oggetto17.
Si evince chiaramente come la datità fenomenologica del soggetto, irriducibile ad altro e
considerato nella colpa come esistenziale fondamentale, viene riassunta nella sua apertura
trascendentale alla grazia che proprio per questo capovolge la stessa situazione di finitudine e colpa.
In questo senso, non solo Abramo è il typus dell’uomo di fede, ma anche paradigma di una
ragione della fede che, così come nel caso di Pascal, mette in scacco la certezza dell’intelletto. Si può
infatti dire che Abramo credidit spe contra spem. Una tale asserzione implica che il fondamento della fede è
la grazia, ma la grazia è l’actus exercitus della libertà divina che di per sé è inizio e telos. La grazia
comincia solo con la grazia, e basta questo a mettere in scacco ogni pretesa di fondazione deduttiva.
L’angoscia della finitezza colpevole sancisce il ritorno ineludibile a ciò che è ogni volta proprio
(Jemeinigkeit, direbbe Heidegger), che può essere ricondotto all’orizzonte stesso del peccato in quanto
connotazione ontologica, e pur tuttavia, è proprio in quella assunzione di sé che si esplica in
quell’accusativo non assumibile, l’istante dell’ecco-mi viene rovesciato in quello dell’ek-sistenza come
grazia. Per questo essa è dono ed atto. Siamo dinanzi ad un momento decisivo nel pensiero
kierkegaardiano che mette in guardia recisamente contro le stesse illusioni di una fede di diventare sale
scipito cercando la conciliazione con una dialettica del sistema per accordarsi alle ragioni dell’intelletto e
alla pretesa razionale della conciliazione della contraddizione.
Kierkegaard esprime un atto di critica serrata contro la Cristianità:
La più vergognosa offesa che si possa fare a Dio è quella in cui la Cristianità si rende colpevole:
di tramutare Dio, il Dio dello Spirito in una ridicola ciancia;è la forma più antispirituale di quanto mai
fece il paganesimo, più antispirituale dell’adorazione di una pietra (…) più antispirituale di tutto ciò che
è possibile come antispiritualità, è proprio questo:adorare come Dio una tale razza di idiota18.
La ridicola ciancia di cui parla Kierkegaard sarebbe quella di una dialettica che potremmo
definire negativa, la quale toglierebbe la serietà ineludibile dell’esistenza singola, ferita nel suo ora
storico dalla morte e dalla colpa. Paradossalmente, un Cristianesimo che si affida a questa logica dello
Spirito Assoluto, riducendo il venerdì santo storico, in cui Cristo si fa peccato per noi, ad un momento
speculativo di negatio che nulla ha più da dire alla stessa esistenza del singolo. Tuttavia, possiamo
ravvisare la possibilità di un reciproco nodo fra filosofia e teologia proprio sulla base del ruolo che
svolge il Cristianesimo nell’ambito di questo dialogo. Quanto alla filosofia, il dato kerygmatico che
attiene al nucleo salvifico della Croce di Cristo, può aiutarla a mantenere la sua prospettiva di apertura
all’alterità e all’ulteriorità del Mistero, laddove la teologia può essere spinta ad una serietà teoretica nel
considerare le ragioni della fede che sorreggono l’atto, così che essa possa sempre dare conto
dell’epistemologia dello stesso atto di fede.
Kierkegaard ci invita senza dubbio ad un Cristianesimo consapevole dell’assoluta differenza
qualitativa del Suo Oggetto, invitando altresì il singolo ad un’assunzione della propria scelta sapendo
che Dio si fa incontro in un evento di assoluta gratuità. A partire da Kierkegaard forse è possibile
individuare in Abramo il paradigma di una ragione credente.
17
18
J.Wahl, Vers le concret, Vrin, Paris 1932, p. 317.
Kierkegaard, L’Ora. Atto di accusa a Cristianesimo nel regno di Danimarca, trad. it. Di A. Banfi, Laterza, Roma 1977, p. 64.
7
Ragione credente, si diceva e questo può sollevare l’obiezione che il predicato preluda ad un
concetto ossimorico. Certo facciamo ricorso all’ossimoro come categoria teoretica ravvisandone, però,
tutta la ricchezza perché questo evidenzia come in realtà l’ingresso del pensiero nell’esistenza umana è
sempre segnato dalla coscienza di un indicibile e di un eccedente con cui è necessario lottare per poter
comprendere meglio, che è necessario interrogare nel dramma dell’inquietudine per riconoscere come il
mistero del vivere, per riconoscere, in ultima analisi, come quel tipo di eros di platonica e patristica
marca per cui l’apprendere a morire è già un tutto ricevere. Ma per questo è necessario lasciare la
propria terra. Forse immagine ante litteram del paradigma acroamatico della filosofia, Abramo ipostatizza
a nostro avviso quel modello dell’ascolto che non assimila e non consuma ma che è in grado di lasciarsi
interpellare, con-vocare ed inviare. Tre verbi a nostro avviso legati ad una riflessione teoretica che nasce
dalla terra biblica e che sanciscono la condizione necessaria dell’altrove e l’impulso teoretico della
speranza per meglio contrassegnare il rischio della fede, così ben descritto dallo stesso filosofo danese
nella metafora delle braccia tese attraverso l’abisso ignoto di Dio, arrischiati alla speranza che Lui stesso
attende per afferrare in quell’istante supremo di un tutto perdere per tutto vedere ridonato.
3. RELATIO IN UNO:
MASSIMO CACCIARI)
FILOSOFIA DELL’ESSERE TRINITARIO
(SCORCI
SUL PENSIERO DI
Si è compiuto un cammino attraverso passaggi talora inediti ed impensati, sentieri forse
interrotti a volte ma pregni di una fecondità sorprendente. Lo stupore del pensiero ritorna sempre
nuovo quando quest’ultimo vuole mettersi a nudo ed arrischiarsi su quella ulteriorità che lo sospinge
all’origine e che è il mistero sottratto per lasciare spazio al suo indagare, interrogare e ad-tendere, al suo
sostare sulla soglia dell’invisibile. Pensare Dio, ma forse, meglio, pensare a Dio nell’inguaribile nostalgia
dell’Incondizionato: questa è la vocazione che la ragione assume quando è capace di fare silenzio e
lasciarsi attraversare dal Mistero. Abbiamo iniziato con la categoria del rischio, ma ora non possiamo
non intersecarla a quella di libertà. Arrischiarsi è infatti consegna, come già si diceva, ma anche
acconsentire con un atto della propria esistenza intera a questo Assoluto indicibile e paradossale, un
atto che implica la relazione.
Ci vorremmo soffermare sul pensiero di Massimo Cacciari, specie nel suo ultimo libro19 perché
ci sembra che il filosofo veneziano recuperi al pensiero il tormento di un credere e comprendere che lo
lacera e lo ferisce che lo attesta irriducibilmente sull’invocazione e lo rinvia al suo gemito interiore.
Cacciari recupera il concetto di Deus relatio per individuare nel rischio della fede l’incontro di due libertà.
Si hanno, però, una serie di implicazioni. L’Assoluto che mette in questione ogni pretesa è già in se
stesso relativo, donde il recupero cacciariano di una teologia trinitaria, laddove l’ek-sistente che si
assume il rischio della fede si riconosce ontologicamente relazione, e come dice Cacciari si tratta di una
relatio non adventitia20. Paradossalmente, e qui, è evidente il richiamo a Kierkegaard si è relazione e
rapporto con ciò che è oltre ogni rapporto e relazione, ma, semplicemente perché li in-stituisce. Questo
apre il problema teoretico della Libertà ek-sistente nel Dono, perché l’Assoluto si dona come Relazione.
Con lo Spirito il nostro spirito testimonia che siamo “filii Dei”; con Cristo co-eredi; con Cristo
soffriamo sulla sua Croce; con lui glorificati. Il Cum è il problema21.
Com’è possibile che sia proprio lì il termine problematico? Tentiamo una possibile risposta; il
rischio della fede ex parte hominis pone il rischio in Dio stesso, quel rischio legato sia all’in-fondatezza
della libertà divina che ha inizio solo da se stessa e nel suo actus, sia alla Relazione come autentico atto
tetico. Se per l’uomo, occorre, pascalianamente, parier, come scrive Pascal, per Dio occorre l’ad-tesa, il
ri-trarsi l’atto assolutamente kenotico. Sostenere questo significa dire, non solo che la Relazione è la
posizione originaria dell’Assoluto, ma che la kenosis del Logos è lo stesso esse in Principio del Verbo pròs
M. Cacciari, Della cosa ultima, Adelphi, Milano 2004.
Ivi, p. 331.
21 Ibidem.
19
20
8
ton theòn ed altrettanto, il Verbo come Logos prophorikos è ancora un atto kenotico con cui il Mistero si dà
nella Parola.
Cacciari asserisce che il Cum è il problema, ma forse il cum implica anche un nodo fecondo di
pensiero circa il momento relativo dell’Assoluto. Crediamo che andare al cuore del problema tenendo
presente l’evento trinitario possa contribuire ad un incremento di senso. Assoluto sottende l’essere
sciolti, de-cisi direbbe Cacciari. Nonostante tutto l’Assoluto del Dio cristiano prevede un momento
relativo o relazionale, di relatio non aventitia che è quello pericoretico o della circuminsessione tale che si
parla di Persone divine che si inabitato nella comunione trinitaria. In questo senso Cacciari cita la
Summa Theologica di Tommaso, e precisamente laddove recita:
Relatio autem in divinis non est sicut accidens inhaerens subiecto, sed est ipsa divina essentia:
unde est subsistens sicut essentia divina subsistit22.
Tale momento relativo sottende un invio ed un ritorno, exitus e reditus per dirla con la filosofia
classica per cui le Divine Persone si riconoscono nell’unità della Charitas. Le relazioni pericoretiche ad
intra (nella Trinità immanente) si esplicano nella relazione ad extra per eccellenza che è la Rivelazione
divina, la quale costituisce un atto di affidamento ex parte Dei. Tanto è vero che Cacciari scrive:
Nell’Ego (di Dio) è essenzialmente compreso il Verbum, cioè la Relazione. Il nome stesso di
persona aggiunge Tommaso, significa già in sé relazione: “persona” vale come per sé una ma il per sé
implica la distinzione dall’altro e perciò la relazione con esso; per se ad alium23.
Se la figura paradigmatica di Abramo rappresenta la fede come esodo e rischio, la stessa
ontologia trinitaria che Cacciari riprende dalla magistrale asserzione di Tommaso implica che il primo
atto di esodo è stato compiuto da Dio, sia nella Creazione che nella Rivelazione, quindi ci troviamo
nell’ambito di un’ermeneutica dell’actus fidei nella quale vengono a cor-rispondersi Parola di Dio e parola
dell’uomo. L’esodo che sottende l’essere arrischiati nella fede è speculare alla kenosis nella quale Dio
stesso si è arrischiato affidando il Suo Mistero alla fragilità di questo incedere, interrogare, invocare,
facendosi più presente nell’invocazione e nell’interrogazione e nell’invio che non nella superba
asserzione della metafisica. Scrive Cacciari:
Egli è colui che ek-siste, ad gentes, che si dà nella Parola, per verba. E’ colui che provoca,
invoca, reclama (…) L’uomo potrà nasconderselo, dimenticarlo, ma non negarlo: in quanto è colui che
è e non può essere latro da sé, ek-siste ad alium , si manifesta ad altro da sé e dunque è-con24.
Il con-essere di Dio fonda l’essere relazione dell’uomo e qui si gioca il rischio della fede e la
profonda nostalgia del Vivente che tanto ha straziato di passione divina i mistici assediando il loro
cuore nella misteriosa spogliazione che li ha disposti ad ogni impiego, annegati nel Mistero di Dio e così
sottratti, nella loro creaturalità perché la relazione fosse lo spazio della pro-vocazione e della invocazione. Di tale nostalgia parla lo stesso Cacciari:
Questa “inseparabile pluralità” non si agita anche nel nostro cuore?Anselmo nel Cur Deus
afferma che l’uomo è chiamato ad elevarsi all’immagine della Trinità vincendo in sé lo spirito della
separazione e che in ciò consiste l’atto della sua libertà. Ma potremmo separarci realmente (….) dal
Cum?25.
Un passaggio interessante, questo, perché permette di leggere l’actus fidei come nostalgia per la
Trinità che già abita in noi, se pur ciò che saremo non è ancora rivelato come recita la Lettera di
Summa Theol.I, I, q. 29, a. 4.
M. Cacciari, op. cit., p. 332.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
22
23
9
Giovanni e come libertà, nella sua espressione di libertas maior, che è quella di corrispondere a Dio che
chiama lasciando che la Grazia, agendo ab intrinseco vinca ogni separazione.
Ma questo sarebbe altrimenti possibile che nella kenosis, quando, Figlio e Padre, uno per la Libertà
dello Spirito su fanno perfetto e gratuito Dono, abbandonanti-abbandonati?26 E, d’altro canto, sarebbe possibile
senza questa scandalosa ed abissale Libertà di Dio che nell’evento staurologico si fa persino Revelatio Dei
sub contrario che l’uomo possa arrischiarsi in un atto di fede che lo de-cide rispetto ad ogni
compromissorio sistema deduttivo? Si tratta sempre, infatti, come magistralmente asserisce Massimo
Cacciari di un Maius quam cogitari possit.
Ed eccoci ancora al climax: la fede è scacco della ragione o sua distretta salvifica? Noi vi
ravvisiamo un passaggio aperto, una feconda ferita della ragione. Infatti, essa stessa è crocifissa in
questo suo esporsi alla Verità; non può che testimoniarne l’eccedenza nella finitezza della forma,
custodendo con passione la bellezza che pure le giunge attraverso la fatica del suo cercare e discernere,
del suo morire per imparare la vita che la supera e la sostiene, attraverso la lotta notturna nella quale
cerca il Nome dell’Ospite ignoto che pure la dona a se stessa. Per questo motivo la ragione non può
essere soddisfatta della metafisica ontoteologica, ma essa sente di dover ascoltare questa alterità che
assume i tratti della persona e della gratuità fino alla sviluppo di un pensiero staurologico, nel quale
emerge il dolore di Dio coinvolto nella Sua creazione, nel rischio della libertà.Un Dio che reca molte
affinità con Fil.2, in cui Paolo enuncia il mistero della kenosis.
Se il Deus-Trinitas è relazione, si può comprendere dunque perché la Sua natura rivelativa sia
kenotica. Inoltre, però, se l’atto della kenosis inerisce allo stesso Logos nel suo volgersi all’esterno
(endiathekos-prophorikos), giustamente osserva Cacciari, Deus revelatus e Deus absconditus, Anzi, l’ultimo non
sarebbe che l’altra parola dell’ Ego sum qui sum di Es. 3, 14, essendo ogni categoria umana
inadeguata27Molto pregnante diviene, allora l’idea del rischio della fede rispetto al silenzio di Dio, che la
Bibbia molto spesso ci presenta, a sottolineare ancora la portata drammatica e assolutamente sospensiva
del generale dell’actus fidei. Osserva Cacciari:
Tutta la Bibbia sta a dimostrare che non vi è alcuna opposizione tra il Dio zelota, instancabile
nel voler discutere con l’uomo e che ama l’uomo agonista, e il Deus absconditus, il Dio che si nasconde,
il silenzio di Dio. E’ questo silenzio, anzi la Sua voce più forte, il Suo grido, il grido di dolore che Egli
rivolge all’homo absconditus, all’uomo che fugge la chiamata, che non intende ascoltarlo. Il Dio biblico
è nascosto quando non trova l’uomo, ovvero quando l’uomo nasconde a sé la propria essenza -ciò che
per Agostino costituisce la radice di ogni peccato. O quando ritiene che il mandatum consista nel
riconoscere che “Il Signore è uno solo”- ciò che tutti i filosofi sanno!- e non invece nella parola che
segue:”Tu lo amerai”. Il nascondersi di Dio non è che un momento del suo agón con l’uomo, e cioè del
suo essere Relatio28.
Se Dio è loquens Persona, il Suo tacere dice di una Parola sempre altra e sempre più alta affidata
alla storia dell’uomo che è un momento di questa Relazione teo-antropologica. D’altra parte l’uomo di
fede è affidato, nel suo stesso affidarsi, a questo mandatum novum dell’Agape in cui l’atto del credere
nell’intelligentia fidei è ad un tempo l’atto supremo di de-posizione di sé che riassume nell’ek-sistenza la
partecipazione al Christus patiens, suprema sapienza di Dio nella follia della kenosis. Per questo Cacciari
ravvisa un aspetto agonico che non può non richiamare la logica del paradosso con cui solo è possibile
balbettare appena qualcosa del Mistero, ma sempre feriti. Un altro aspetto che appare assolutamente
fondamentale è quello che ravvisa il nascondimento di Dio in riferimento al nascondimento da parte
dell’uomo della propria essenza. Tale regio dissimilitudinis di agostiniana memoria è l’inospitale
affermazione che contraddice l’ontologia della Relatio e che, da questo punto di vista, ravvisa nell’atto
di fede la possibilità di un capovolgimento per cui dal nascondimento e dall’elusione della chiamata
l’uomo possa pervenire ad una perfetta revelatio della sua umanità nell’apertura totale a quell’Archirelazione che si esplica come assoluta donazione. Non solo, è in questa stessa revelatio che si sa parlato
M. Cacciari, op. cit., p. 339.
M. Cacciari, op., cit., p. 342.
28 Ibidem.
26
27
10
dal Verbo nel Verbo ed attraverso il Verbo mettere in atto un’ermeneutica della fede che lo pro-vochi
sempre ad una sosta presso l’invisibile. Forse proprio in questa agonica figura della fede ragione e
mistero convivono.
4. CONCLUSIONE: INTELLIGERE VERITATEM :PENSIERO E PREGHIERA
L’ incipit del nostro cammino si è aperto con la domanda circa le possibili ragioni della fede, ed
ora si può evincere come quelle ragioni non siano solo possibili passaggi di un pensiero che è ferito e
tormentato, e per questo redento, dall’invisibile, ma addirittura necessari. Essi sottendono la necessità di
una Sinngebung, nonché di un intelligere veritatem, atti che debbono essere affidati al libero esercizio del
theorein, così come il Logos si è affidato ad un’ermeneutica dell’Incarnazione e al possibile rischio di
una incompletezza che richiama alla finitudine.
L’atto di intellezione della verità è dunque un atto ermeneutico, ovvero un atto affidato al
linguaggio, ad un logos semantikos e non già apofantico. In effetti, in questo caso si tratta di una
confessione di una veritas eccedente che scaturisce da una generosità originaria, così che confessarla
presente implica sempre un invocarne la luce che, ab intrinseco, orienti il cumprehendere. Il magistrale
credo ut intelligam di Anselmo può essere interpretato nell’ambito di una filosofia orante che sottende
maggiormente lo sforzo del pensiero. Da questo punto di vista ci sembra prezioso il contributo di
Massimo Cacciari:
Sembra esservi un’antica inimicizia tra preghiera e pensiero, se intendiamo la prima
come”richiesta”(….). Ma la preghiera è anche e anzitutto carmen, potente invocazione al divino
affinché si manifesti, volontà di stabilire con il sacro una relazione dialogante. Ciò che conta allora non
è il richiedere e neppure la fede nella straordinaria potenza del dio, ma la “pretesa”di poterlo
“affrontare” con l’arma della parola. Null’altro in realtà si chiede se non mettere quest’ultima alla prova.
Allora la preghiera può apparirci come akmé del discorso stesso, il “punto” in cui esso sfocia in pura
contemplazione. Dalla preghIera di Adamo che nulla chiedeva, come spiega Agostino, perché viveva
“furens deo” fino alla preghiera in Paradiso, che nulla ha più da chiedere ma si trasfigura in pura lodein questo pellegrinaggio si confrontano ai poli opposti, la preghiera che geme, piange invoca, e quella
del filo-sofo, intimissimo dialogo col divino , da solo a solo, preghiera che non chiede di avere, anzi: che
“chiede” di essere liberi da tutto di non-avere (così il Cusano commenta il libera nos del Padre Nostro)
per diventare capaci di Dio (adeveniat regnum tuum)29.
La cosa che emerge più notevolmente è non solo la fecondità del paradosso fra preghiera e
filosofia, ma anche come l’acme del discorso sia addirittura invocare. Il pensiero figlio di Poros e Penia,
come già ebbe ad insegnare Platone si realizza nella capacità di contatto fruitivo, assolutamente
indeducibile e trova la ricchezza dell’eccedenza nella povertà della parola provata.Non è forse l’invocare
una lotta con l’Indicibile? E forse l’Indicibile non si dona nella domanda di essere presente laddove
ferite sillabe osano confessarne la veritas? Crux dei doppi pensieri30 è questa, che non ha altra richiesta,
nessuna richiesta forse, se non quella intrinseca al theorein stesso, che Dio sia presente la dove si parla
di Lui. Ancora, mistero della parola provata il cui acme è la povertà del dire e paradossalmente la
ricchezza di un’eccedenza che porta oltre il suo dire, ed ecco, intelligere veritatem è sempre rinvio e provocazione.
La preghiera si intesse di pensiero, altrettanto il pensiero riceve dalla preghiera la sua sete
inesauribile. Il rischio di questo atto teoretico è dato dal fatto che esso non si fonda su certezze
geometriche, ma è spinto oltre, in quell’oltre ove il suo dire è possibile perché originariamente detto in
un Appello ineffabile, perché, già insegna Anselmo: Ti posso cercare solo se me lo insegni, Ti posso trovare solo se
Ti mostri. La preghiera diventa un pensiero sapiente, capace di insegnare perché insegnata.31 Dunque, si
M. Cacciari, op. cit., p. 455.
Usiamo l’espressione cara al compianto filosofo Italo Mancini, figura emblematica di irrinunciabilità del theorein da un
lato e dello spazio dell’invocazione dall’altro.
31 M. Cacciari, op. cit., p. 457.
29
30
11
tratta di un vigilare notturno, consumate le pupille dal cercare di scorgere la luce attraverso l’ombra dei
segni, e sempre trafitto da un contatto che può solo essere rammemorato al di qua dell’abisso.
Un pensiero che si arrischia nell’atto di fede e, per principio di reciprocità, un atto di fede che
cerca il dialogo con il pensiero può essere evidenziato ricorrendo alla metafora dell’anca di Giacobbe
perché essi si incontrano sull’ulteriorità, dall’uno anelata in una sete inesauribile, dall’altro mostrata per
speculum et in aenigmate. Tuttavia ci troviamo dinanzi ad un altro paradosso, lo stesso atto di fede è la
ricerca di una habitatio inaccessibilis proprio per questa sua inaccessibilità, così come il pensiero è pregare
di vedere Dio, dopo aver desiderato trovarLo. Se è vero allora che intelligere veritatem è vederLo, ma se è
altrettanto vero che ciò che si vede è inesprimibile, l’atto di fede è ciò che supera lo stesso pensiero
compiendolo.
Come dire che lo stesso pensiero è un itinerario si spossessamento che giunge al vertice
dell’abbandono, della simplicitas, aplosis, come già insegnava Plotino, e del silenzio ove ciò che si
comprende non è che il manifestarsi dell’incomprensibile. Il pensiero sarebbe dunque elettivamente
affine ad una esperienza mistica, penetrando nella inaccessibile luce di un silenzio che è già preghiera.
Questo, tuttavia, non vanifica nell’inopia, ma dà senso alla sua fatica, così che la fatica del pensiero
diviene di fatto l’altra facies della fatica di credere. Così fede e ragione ritrovano ancora a confrontarsi
ma in un intreccio fecondo di ascesa e domanda, di coscienza dell’inesprimibile e della necessità di
cercarlo, della coscienza, infine, di non essere mai a casa, perché ciò che si cerca è sempre eccedente.
Il nostro cammino sta per compiersi, attestato sul climax dell’atto di fede che è la preghiera; si
tratta comunque di una preghiera filosofica, di cui in modo pregnante dice Massimo Cacciari:
La preghiera non ha nulla a che fare con parole “dulces y sabrosas”, con sentimentalismi
edificanti; essa insegna che l’inesprimibile si dà –ma non solo: la sua forma mostra anche come ogni
nostra ricerca, in quanto “sete inesauribile” lo presuppone. Nos interrogantes cerchiamo appunto
l’inesprimibile – ma non esiste cercare se non nel presupposto della “fede” nell’esistenza del cercato, se
già non si ama ciò che si cerca32.
Ecco dunque che l’eccedenza dell’inesprimibile viene a contatto del nostro incedere teoretico
che, in questo suo desiderare, invocare, ad-tendere è di per sé un cammino erotico, come intende Platone,
cioè impossibilitato a cercare se non amando, a comprendere se non credendo, a dire se non perché
abitato dal Verbo. Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, insegna la tradizione cristiana dal
Agostino a Pascal, eppure mai trovare si dà senza la fatica della domanda, mai luce aurorale senza l’esser
desti alla notturna visita della Sapienza.
Paola Mancinelli
Dottore di ricerca in Filosofia e Scienze umane
32
Ibidem.
12