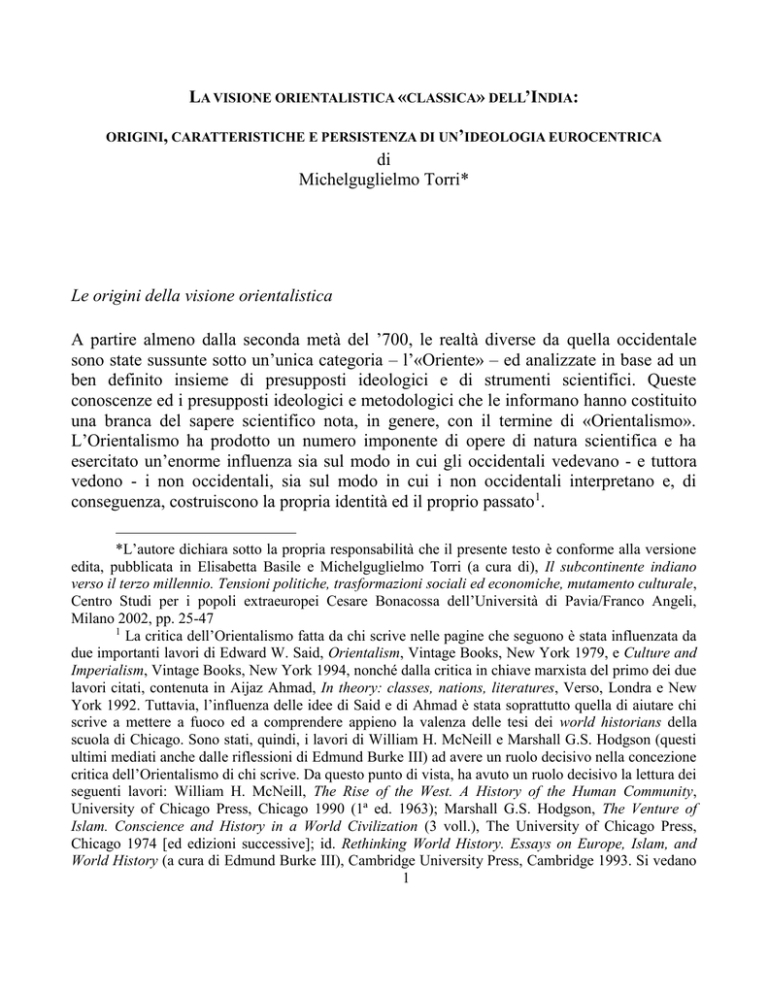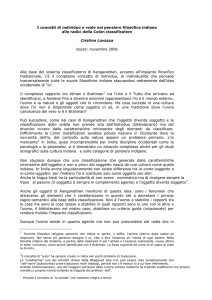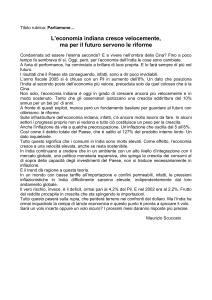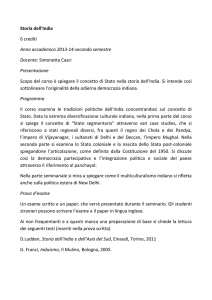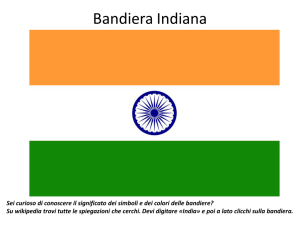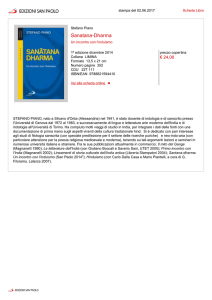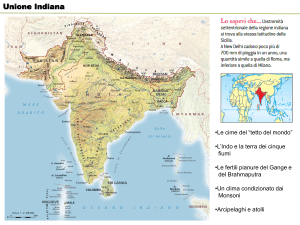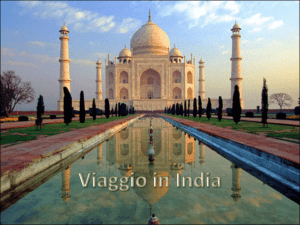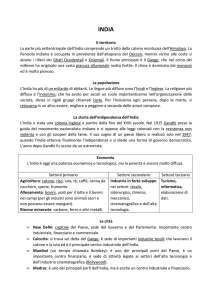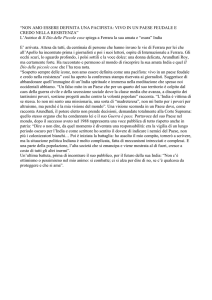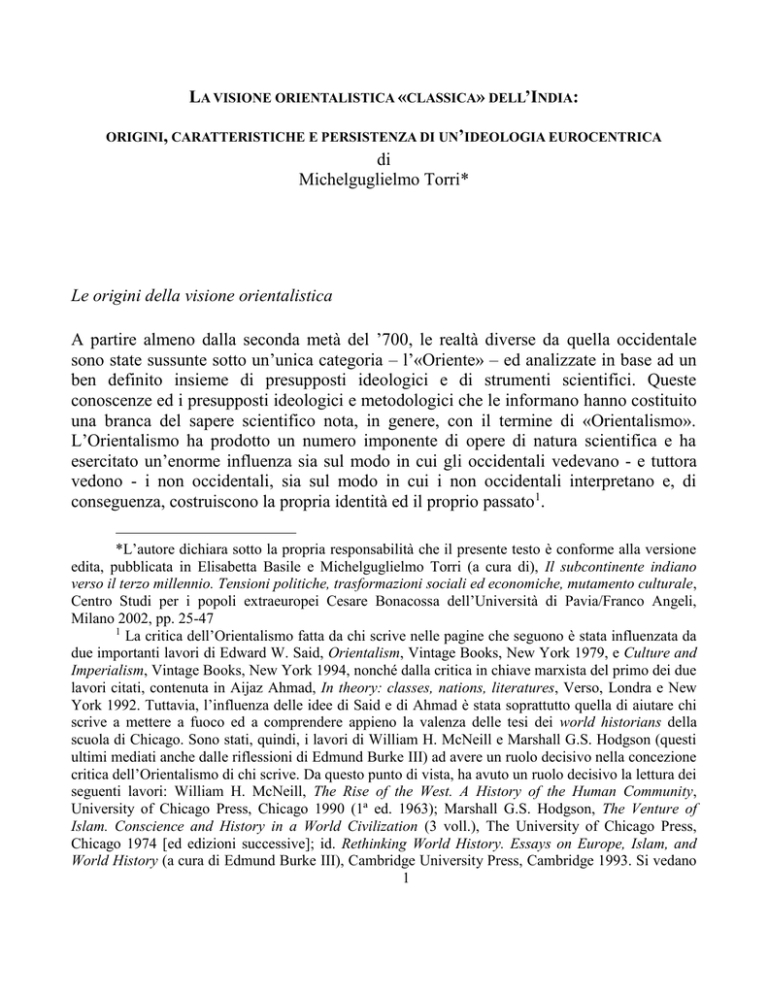
LA VISIONE ORIENTALISTICA «CLASSICA» DELL’INDIA:
ORIGINI, CARATTERISTICHE E PERSISTENZA DI UN’IDEOLOGIA EUROCENTRICA
di
Michelguglielmo Torri*
Le origini della visione orientalistica
A partire almeno dalla seconda metà del ’700, le realtà diverse da quella occidentale
sono state sussunte sotto un’unica categoria – l’«Oriente» – ed analizzate in base ad un
ben definito insieme di presupposti ideologici e di strumenti scientifici. Queste
conoscenze ed i presupposti ideologici e metodologici che le informano hanno costituito
una branca del sapere scientifico nota, in genere, con il termine di «Orientalismo».
L’Orientalismo ha prodotto un numero imponente di opere di natura scientifica e ha
esercitato un’enorme influenza sia sul modo in cui gli occidentali vedevano - e tuttora
vedono - i non occidentali, sia sul modo in cui i non occidentali interpretano e, di
conseguenza, costruiscono la propria identità ed il proprio passato1.
*L’autore dichiara sotto la propria responsabilità che il presente testo è conforme alla versione
edita, pubblicata in Elisabetta Basile e Michelguglielmo Torri (a cura di), Il subcontinente indiano
verso il terzo millennio. Tensioni politiche, trasformazioni sociali ed economiche, mutamento culturale,
Centro Studi per i popoli extraeuropei Cesare Bonacossa dell’Università di Pavia/Franco Angeli,
Milano 2002, pp. 25-47
1
La critica dell’Orientalismo fatta da chi scrive nelle pagine che seguono è stata influenzata da
due importanti lavori di Edward W. Said, Orientalism, Vintage Books, New York 1979, e Culture and
Imperialism, Vintage Books, New York 1994, nonché dalla critica in chiave marxista del primo dei due
lavori citati, contenuta in Aijaz Ahmad, In theory: classes, nations, literatures, Verso, Londra e New
York 1992. Tuttavia, l’influenza delle idee di Said e di Ahmad è stata soprattutto quella di aiutare chi
scrive a mettere a fuoco ed a comprendere appieno la valenza delle tesi dei world historians della
scuola di Chicago. Sono stati, quindi, i lavori di William H. McNeill e Marshall G.S. Hodgson (questi
ultimi mediati anche dalle riflessioni di Edmund Burke III) ad avere un ruolo decisivo nella concezione
critica dell’Orientalismo di chi scrive. Da questo punto di vista, ha avuto un ruolo decisivo la lettura dei
seguenti lavori: William H. McNeill, The Rise of the West. A History of the Human Community,
University of Chicago Press, Chicago 1990 (1ª ed. 1963); Marshall G.S. Hodgson, The Venture of
Islam. Conscience and History in a World Civilization (3 voll.), The University of Chicago Press,
Chicago 1974 [ed edizioni successive]; id. Rethinking World History. Essays on Europe, Islam, and
World History (a cura di Edmund Burke III), Cambridge University Press, Cambridge 1993. Si vedano
1
L’Orientalismo occidentale è nato in India nella seconda metà del ’700, e non per
caso, dato che l’India nord-orientale è stata – appunto nella seconda metà del ’700 – il
primo vasto territorio del continente asiatico ad essere conquistato ed amministrato da
europei. L’Orientalismo, quindi, ha storicamente avuto origine come il tentativo di
arrivare ad una comprensione non superficiale di parti sempre più vaste del
subcontinente indiano, in modo da poterle amministrare – e sfruttare – in maniera
efficiente ed economica2. Inizialmente articolato a proposito dell’India, il discorso
orientalista è stato poi gradualmente esteso, con le modifiche del caso, alle altre grandi
aree geopolitiche e culturali che, nel corso dell’800, passarono sotto il dominio diretto o
indiretto dell’Occidente.
Il discorso orientalista, quindi, appare sostanzialmente diviso in due parti: un
nucleo valido per l’«Oriente» in generale ed una parte specifica, applicabile, a seconda
dei casi, all’India, all’«Islam»3, alla Cina, o a qualsiasi altra «civiltà» o cultura non
occidentale. Il nucleo generale del discorso orientalista parte dalla divisione del mondo
in due parti: Occidente e «Oriente» (dove, sotto l’etichetta «Oriente», vengono raccolte
aree geopolitiche e culturali che, fra loro, non hanno in comune più di quanto ognuna di
esse abbia con l’Occidente4). Occidente e «Oriente» sono poi definiti in termini fra di
anche: Edmund Burke III, Islam and World History: The contribution of Marshall Hodgson, in
«Radical History Review, 39, 1987, pp. 117-123, e una recente traduzione in francese di una serie di
saggi di Hodgson, cioè: Marshall G.S. Hodgson, L’Islam dans l’histoire mondiale (a cura di
Abdesselam Cheddadi), Sindbad/Acte Sud, Arles 1998.
2
L'opera fondamentale su questo argomento è quella di David Kopf, British Orientalism and
the Bengal Renaissance. The Dynamics of Indian Modernization, 1773-1835, University of California
Press, Berkeley 1969. Si veda anche, dello stesso autore, Hermeneutics versus History, in «Journal of
Asian History», 39, 3, maggio 1980, pp. 495-506. Letta in controluce, l'opera di Kopf è, probabilmente,
la più chiara e convincente critica fin qui comparsa del carattere ideologico dell'Orientalismo. fin qui
comparsa. Un giudizio che rimane valido anche se lo steso Kopf non sempre (si veda in particolare il
suo Hermeneutis versus History cit.) sembra rendersi conto delle implicazioni ultime del suo stesso
lavoro di ricerca. Oltre ai contributi del Kopf, sono poi di grande interesse per l’analisi del pensiero
orientalista a proposito dell’India i saggi raccolti in Carol A. Breckenridge e Peter van der Veer (a cura
di), Orientalism and the Postcolonial Predicament, University of Pennsylvania Press, Philadelphia
1993.
3
In questo testo si usa il termine «Islam» [fra virgolette e maiuscolo] per indicare la visione
orientalistica della civiltà islamica. Invece, per indicare in modo neutro la civiltà islamica, si userà il
termine islàm [senza virgolette, minuscolo e con accento grafico].
4
Questa è la ragione per cui mettiamo fra virgolette il termine «Oriente», ma non il termine
«Occidente». Mentre, infatti, si può legittimamente sostenere che l’Occidente sia caratterizzato da
un’unità culturale di fondo, lo stesso è assolutamente falso nel caso dell’«Oriente». Questo, come si è
appena detto, è articolato in una serie di civiltà diverse che, in definitiva, sono tanto lontane fra di loro,
quanto lo sono dalla civiltà occidentale. Questo, ovviamente, non significa che non vi siano
interrelazioni fra queste varie civiltà e fra queste e quella occidentale, significa solo che l’unico comune
denominatore che distingua le civiltà orientali, ponendole a parte dalla civiltà occidentale, è quello – in
2
loro antitetici: l’Occidente, come si è già ricordato, è il regno della storia e della
razionalità (o, se vogliamo, dell’emergere della razionalità nella storia); l’«Oriente»,
invece, è un’area senza storia, nel senso che è dominato da tradizioni presenti da tempo
immemorabile, tradizioni che poco o nulla hanno a che vedere con la ragione. In altre
parole, l’Occidente è il regno della libertà e non è limitato e coartato nel suo sviluppo da
una qualche «essenza» profonda (o, se vogliamo, l’«essenza» profonda dell’Occidente è
appunto rappresentata dalla sua capacità di cambiare e svilupparsi lungo parametri
razionali); viceversa, l’«Oriente» ha un’«essenza» profonda, rappresentata dal fatto che,
al posto della razionalità, esiste la tirannide del costume e l’irrazionalità della religione.
Naturalmente, più che della divisione del mondo, si tratta della divisione
dell’umanità in due parti. Da un lato vi sono gli «Occidentali» razionali e dinamici,
impegnati a modificare il mondo in modo da ampliarne gli spazi di libertà e di ricchezza,
dall’altro vi sono gli «Orientali», irrazionali o quanto meno a-razionali, stolidamente
prigionieri della tradizione, incapaci di ogni dinamismo ma proni ad occasionali,
imprevedibili e, soprattutto, irrazionali scoppi di violenza. Scoppi di violenza che si
verificano in particolare come reazione nei confronti dell’inarrestabile e benefica marcia
civilizzatrice dell’Occidente5.
Quella appena riportata nei suoi tratti più generali è una visione dicotomica
dell’umanità, perfezionata e completata nel corso dell’800, cioè in un periodo in cui la
cultura occidentale stava impregnandosi in profondità di elementi di carattere razzistico6.
Quindi, e non a caso, quella orientalistica è una visione intrinsecamente e
profondamente razzista, predicata sulla convinzione dell’irrimediabile non
perfezionabilità culturale e umana di quella maggioranza della popolazione mondiale
che non ha la fortuna di essere di razza bianca. Si tratta di una visione che, nell’800
definitiva taitologico – che esse non sono Occidente. Quindi, parlare dell’«Oriente» come di un’entità
con caratteristiche a sé stanti significa già accettare le categorie interpretative dell’Orientalismo. Se
mai, si può legittimamente parlare di una serie di Orienti diversi.
5
È una tesi, questa, che continua ad essere riproposta soprattutto per il mondo islamico. Si
veda, ad es., Bernard Lewis, The Roots of Muslim Rage. Why so many Muslims deeply resent the West,
and why their bitterness will not easily be mollified, in «The Atlantic Monthly», settembre 1990. Ma,
mutatis mutandis, le medesime tesi sono state applicate anche ad altre civiltà non occidentali. Per una
rivendicazione del dinamismo delle civiltà asiatiche si veda Kishore Mahbubani, Can Asians Think?,
Key Porter Books, Toronto 2001. Mahbubani è un nativo di Singapore, la cui famiglia, come rivela il
nome, è originaria del Sind.
6
Per il persistente razzismo degli inglesi in India durante il periodo coloniale è sufficiente
leggere i libri di memorie da essi lasciatici o i romanzi e le novelle di argomento indiano di autori
britannici, da Kipling agli ormai dimenticati autori di letteratura popolare (in proposito si veda, ad es.,
Allen J. Greenberger, The British Image of India. A Study in the Literature of Imperialism, Oxford
University Press, Londra 1969). Per un'analisi del razzismo, spesso nascosto ma sempre presente, che
caratterizzò tanta parte della cultura europea dell'800, si veda Said, Culture and Imperialism cit.,
passim.
3
(anche se non nel ’700) e nella prima metà del ’900, è stata francamente articolata in
termini razziali, cioè razzistici7.
Dopo, però, la straordinariamente sanguinaria ed orrendamente devastatrice
parabola del nazismo, cioè di una dottrina quintessenzialmente razzista, qualsiasi
ideologia articolata in termini razzisti è diventata sospetta e ha perso di rispettabilità
politica, ideologica e culturale. Da quel momento, il lato razzista della visione
orientalistica è stato abbandonato, o quanto meno nascosto, e vi è stato il ritorno ad una
spiegazione «culturale». In un certo senso si è trattato di un «ritorno alle origini», dato
che, al momento della sua formazione da parte di studiosi inglesi residenti in India, nella
seconda metà del ’700, l’Orientalismo era articolato in termini culturali e, più che sulla
dicotomia inferiore/superiore, si basava sull’idea di differenza. Inoltre, ancora all’inizio
dell’800, quando l’idea della superiorità della cultura europea rispetto a quella indiana
(e, più in generale, rispetto a quella «orientale») venne articolata in maniera non
ambigua, negli europei che si occupavano di India (sia come studiosi, sia come
governanti, sia come governanti e studiosi) rimase forte l’idea che la superiorità
dell’Occidente sull’«Oriente» fosse un fatto contingente, rimediabile da parte
dell’«Oriente» nel medio termine, grazie a cospicue iniezioni di cultura occidentale e di
moralità cristiana (in particolare protestante). Rispetto ad allora, però, il ritorno alla
dimensione culturale del discorso orientalista presenta una differenza di fondo. Negli
ultimi decenni, infatti, è diventato sempre più influente a livello scientifico, e sempre più
diffusa nell’opinione pubblica occidentale, l’idea che la «cultura» sia qualcosa
caratterizzato da un’«essenza» profonda, sostanzialmente immutabile. Di conseguenza,
chi fa parte di una certa cultura non se ne può liberare ma, al limite, può semplicemente
arrivare a realizzare cambiamenti cosmetici che, come tali, sono assolutamente
superficiali, necessariamente temporanei e, in ogni caso, non in grado di cambiare
l’essenza profonda di quella determinata cultura8.
In sostanza, quindi, come ogni osservatore spassionato può facilmente
comprendere, il passaggio dal concetto di razza a quello di cultura, realizzato al fine di
mantenere una gerarchia fra le varie civiltà e di spiegare l’irrimediabile immutabilità di
tale gerarchia, è un’operazione di carattere mimetico. Così come definire i ciechi «non
vedenti» non cambia la sostanza della realtà descritta, la spiegazione «culturale»
7
Per una paradigmatica rivendicazione della superiorità razziale dei britannici nei confronti
degli indiani si veda quella fatta da sir James Fitzjames Stephen nell'articolo The Foundations of the
Government of India, in «Nineteenth Century», ottobre 1883 [ristampato in C. H. Philips (a cura di),
The Evolution of India and Pakistan, 1858-1947. Selected Documents, Oxford University Press, Londra
1962, pp. 57-60]. Sir James fu Legal Member del governo dell'India (1869-72) e giudice dell'Alta Corte
indiana (1879-91).
8
In proposito si veda l'importante monografia di Aziz Al-Azmeh, Islams and Modernities,
Verso, Londra 1996 (1ª ed. 1993), in particolare il prologo, Muslim «Culture» and the European Tribe.
4
dell’Orientalismo, oggi così in voga, non ne cambia la sostanza discriminatoria e
razzista.
La visione orientalistica dell’India: le tre componenti fondamentali
Quelle fin qui descritte sono le caratteristiche generali dell’Orientalismo. Ma, come si è
ricordato, accanto a questo nucleo fondamentale, ogni diversa branca dell’Orientalismo
ha costruito una precisa visione del suo specifico oggetto di ricerca: l’islàm, l’India, la
Cina, il Giappone, e così via. A questo punto è quindi necessario ricapitolare i tratti
essenziali della visione orientalistica dell’India.
I tratti essenziali di questa visione sono riconducibili all’idea che l’«essenza» della
società indiana è data, storicamente, da tre istituzioni sociali fondamentali: il sistema
castale, un’economia di sussistenza basata su villaggi autosufficienti e, per finire,
l’induismo (come religione e come modo di vita). Si tratta, inoltre, di tre istituzioni fra
loro strettamente interconnesse: l’una giustifica e rende possibile le altre. Fra queste, il
prius è rappresentato dal sistema delle caste9.
Le caste sono gruppi sociali caratterizzati da endogamia e commensalità, disposti
secondo un preciso ordine gerarchico, legato a criteri di purezza e di mancanza di
purezza. Il principio endogamico fa sì che qualsiasi individuo nasca e viva all’interno di
una determinata casta che, a sua volta, ha una precisa collocazione nella scala sociale.
L’appartenenza di un individuo ad una determinata casta non può essere mutata; o, per
9
A parte queste tre idee fondamentali ve ne sono altre, che, anche se strategicamente meno
importanti, rimangono rilevanti. In particolare vi sono l’idea di «dispotismo orientale» e quella secondo
cui, in «Oriente» (almeno in India e nel mondo islamico), non esisteva la proprietà privata della terra.
Ma, nel caso dell’India, esistono concezioni assolutamente contrapposte su cosa costituisse il
«dispotismo orientale». Secondo alcuni autori si trattava di una sorta di regime totalitario, dove tutti i
poteri erano concentrati nelle mani del monarca; ma, secondo altri, si trattava di un regime dove il
monarca aveva in realtà un potere scarsissimo, dato che questo era formalmente limitato dal costume e,
di fatto, parcellizzato e distribuito fra le varie componenti della classe dirigente. In altre parole, si tratta
di visioni mutualmente contraddittorie, il cui unico elemento comune è dato dal giudizio di valore
negativo, cioè l’insistenza sul fatto che il «dispotismo orientale», in qualsiasi cosa consistesse, fosse
qualcosa di profondamente negativo ed antitetico al progresso (si noti che in Occidente, le monarchie
assolute – che di fatto coincidono con una delle due versioni appena ricordate di «dispotismo orientale»
– sono invece considerate dalla critica storica come la fase di congiunzione, inevitabile e storicamente
benefica, fra il regime feudale e lo stato moderno). Una discussione del problema del «dispotismo
orientale» in questa sede è, quindi, sembrata superflua. Chi volesse approfondire il soggetto, può
consultare Ronald B. Inden, Imagining India, Indiana University Press, Bloomington 2000 (1ª
ed.1990). Sulla questione della proprietà della terra in India si veda, invece, Michelguglielmo Torri,
Storia dell’India, Laterza, Bari 2000, spec. pp. 365-70.
5
meglio dire, l’abbandono della propria casta d’appartenenza (o l’espulsione da essa)
comporta il passaggio allo status di fuoricasta, cioè la posizione più bassa e più
discriminata della società indiana. Ciascuna casta ha un proprio dharma: i suoi membri,
cioè, hanno il dovere di seguire una certa attività sociale, tipica appunto di quella
determinata casta. D’altra parte, ciascun individuo nasce in una casta pura o impura, alta
o bassa, come effetto della legge del karma. Secondo tale legge, le anime individuali
passano attraverso una serie potenzialmente infinita di nascite e di morti e la posizione
sociale del singolo (cioè la collocazione castale) in ogni successiva rinascita è
determinata dal karma positivo o negativo accumulato nelle vite precedenti. A sua volta,
il karma è positivo o negativo nella misura in cui, nella vita precedente, si è seguito,
correttamente o meno, il proprio dharma (in altre parole, ci si è attenuti ai doveri sociali
imposti dall’appartenenza ad un certo gruppo castale).
In sostanza, quindi, non solo l’ordinamento sociale è immutabile e la collocazione
in esso degli individui prefissata al momento della nascita, ma sia l’ordinamento sociale
nel suo complesso, sia il suo funzionamento, sia il ruolo dei singoli individui hanno
precise giustificazioni e sanzioni di ordine religioso. A sua volta, questo sistema sociale
può essere mantenuto con facilità proprio perché la popolazione è, in misura
preponderante, distribuita in villaggi economicamente autosufficienti. Non solo, quindi,
l’unità sociale di base – cioè il villaggio – è sufficientemente piccola perché la comunità
nel suo complesso possa controllare da vicino il comportamento dei singoli, ma
l’infrazione dei costumi castali comporta sanzioni irresistibili. In un contesto dove la
collaborazione socio-economica fra i gruppi castali del villaggio è indispensabile alla
sopravvivenza dei singoli, infatti, la possibilità di sfidare i costumi sociali prevalenti è di
fatto nulla: la struttura sociale, quindi, è in effetti immutabile.
L’insieme sociale risultante dall’interrelazione fra sistema castale, induismo e
villaggi autosufficienti ha, poi, due caratteristiche di fondo. La prima è che si tratta di un
organismo politicamente fragile, data la suddivisione del corpo sociale in caste. Ma,
l’altra faccia della stessa medaglia è che, per quanto fragile a livello politico, tale
organismo è sostanzialmente immutabile a livello socio-economico. L’India,
storicamente, è diventata preda di invasori stranieri; monarchie e imperi si sono
succeduti o hanno convissuto in modo convulso, precario e caleidoscopico. Ma si è
trattato di processi di mutamento che hanno coinvolto solo gli strati superficiali della
società indiana. A livello profondo, cioè a livello delle piccole comunità autosufficienti
di villaggio – il cui unico rapporto con il mondo esterno è dato dal pagamento delle
imposte richieste dal potere politico – nulla o pochissimo è mutato da tempo
immemorabile. O, quanto meno, quei mutamenti che si sono verificati hanno
incominciato a manifestarsi in seguito all’impatto della dominazione europea o,
addirittura, dopo il raggiungimento dell’indipendenza. Secondo una bella e fuorviante
metafora, la storia indiana, quindi, è simile ad un oceano in tempesta: mentre la
6
superficie (cioè le istituzioni politiche) sono sconvolte dai venti e dai marosi (le
invasioni straniere, il succedersi di regni e di imperi), le acque a pochi metri sotto la
superficie (cioé la società indiana nel suo complesso) rimangono immote.
Si tratta di una visione che comporta un corollario. Questo è che, se la società
indiana è sempre uguale a se stessa, è possibile fotografarla e, a qualsiasi epoca risalga
la fotografia, essa rimane sostanzialmente identica alla fotografia presa in un’epoca
diversa. Di fatto, secondo gli orientalisti, questa fotografia è rappresentata dai Dharma
Shastra, un insieme di raccolte di leggi, poste per iscritto nel III e nel IV secolo d.C. Ciò
che è mirabile – e che rappresenta la controprova della correttezza della visione
orientalistica – è il fatto che, come afferma un illustre antropologo francese, Louis
Dumont, qualora si osservi la realtà dei villaggi indiani di oggi (dove, dopo tutto, vive
ancora la maggioranza assoluta della popolazione indiana), vi è una chiara
corrispondenza fra le pratiche sociali individuate dalla moderna ricerca antropologica e
quelle codificate nei testi canonici della tradizione sanscrita10. Come spiegheremo qui di
seguito, però, a differenza di ciò che pensano Dumont e coloro che condividono le sue
idee, questa corrispondenza non è frutto del permanere attraverso i secoli di una società
immutabile, bensì una delle conseguenze di un insieme di politiche messe in atto dallo
stato coloniale, soprattutto nel periodo fra la fine del ’700 e la prima metà dell’80011.
Al di là della visione orientalistica della storia indiana
La visione orientalistica è stata e continua spesso ad essere enormemente influente. Ma,
negli ultimi decenni, la ricerca storica, valendosi anche degli apporti di una serie di altre
discipline, in particolare dell’archeologia, ha demolito o radicalmente messo in
10
Louis Dumont, Homo hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Gallimard,
Parigi 1979 (1ª ed. 1966), passim.
11
Su questo problema, oltre a quanto detto qui di seguito, si veda anche Peter van der Veer, The
Foreign Hand, in Breckenridge e van der Veer, Orientalism and the Postcolonial Predicament cit., pp.
24-44. Come ricorda il van der Veer, Louis Dumont, ponendo in luce la correlazione esistente fra
l’organizzazione dei gruppi castali da lui studiati e quelle caratteristiche sociali che sono descritte come
importanti nei testi canonici sanscriti, ha osservato come ciò non potesse avvenire per «pura
coincidenza». In tal modo, l’antropologo francese sottintendeva la permanenza di un ordinamento
castale sostanzialmente immutato da tempo immemorabile. Ma, sempre il van der Veer sottolinea come
la «configurazione sociale indiana degli anni ’50 (del ’900), che [Dumont] descrive come etnografo
postcoloniale, non è affatto il prodotto di una semplice coincidenza ma di una specifica ideologia
orientalistica [a specific orientalist discourse] all’interno della storia coloniale». E, continua, «mentre
Dumont pensa di aver scoperto l’‘India tradizionale’ attraverso il suo lavoro sul campo, egli, in realtà,
ha trovato il prodotto della storia coloniale». Ibidem, pp. 27-28.
7
discussione tutti gli elementi fondanti della visione orientalistica12. Qui di seguito
circoscriveremo il nostro discorso all’Asia Meridionale, ma molto di quanto diremo è
riferibile, mutatis mutandis, agli altri «Orienti», in particolare a quello formato dal
mondo islamico (se non altro, per il semplice fatto che mondo islamico e Asia
Meridionale sono due insiemi che, in parte, si sovrappongono).
In primo luogo, l’idea stessa che è alla base della visione orientalistica dell’India,
cioè che la società indiana – almeno fino alla conquista coloniale – sia stata una società
immobile, è dimostrabilmente falsa. Allo stesso modo è dimostrabilmente falsa l’idea
che questa società immobile fosse basata su un sistema di villaggi autosufficienti.
Una serie di fonti – fra cui, per i periodi più antichi, rivestono particolare
importanza quelle di tipo archeologico – ha dimostrato che, storicamente, la civiltà
indiana, lungi dall’essere caratterizzata dalla presenza pressoché esclusiva di villaggi
autosufficienti e dalla virtuale assenza di città (almeno di città che fossero qualcosa di
diverso da centri religiosi o sedi di corti), ha visto lo sviluppo, il declino e la ripresa di
fiorenti civiltà urbane.
Con «civiltà urbana» intendiamo società che, pur essendo preindustriali, erano
caratterizzate dalla presenza di un consistente ed esteso tessuto di centri urbani di varia
grandezza. Tali centri urbani, lungi dall’essere esclusivamente luoghi di culto o sedi di
corti (cioè, di fatto, accampamenti militari permanenti), erano centri di varia grandezza,
sede di una serie complessa di attività economiche ed amministrative. Di conseguenza,
tali centri urbani erano caratterizzati dalla presenza di demograficamente consistenti e
socialmente importanti strati sociali intermedi, impegnati nella gestione di tali attività.
A livello economico avevano particolare importanza i commerci. Questi erano
non erano solo commerci locali, ma di media distanza (estesi cioè all’hinterland della
città, hinterland che, in certi casi, comprendeva parti piuttosto estese del
subcontinente13) e di lunga distanza (cioè estesi al di fuori del subcontinente, e non solo
nel resto dell’Asia). Un’importanza analoga aveva la produzione di beni destinati ad
alimentare tali commerci. Infine vi era la gestione di una serie di pratiche
amministrative, volte non solo a drenare il surplus agricolo prodotto nel settore rurale,
ma a commercializzarlo, trasformandolo in metallo prezioso. Questo metallo prezioso,
La critica della visione orientalistica dell’India, portata avanti nei seguenti paragrafi, può
essere considerata come una sinossi delle idee alla base del volume di Michelguglielmo Torri, Storia
dell’India cit. Ad esso si rimanda per ulteriori approfondimenti, anche bibliografici.
13
Per un caso particolare, quello della grande città portuale di Surat nella seconda metà del ’700
(ma i dati sono validi per tutto il periodo successivo al collasso del potere moghul nel Deccan, cioè a
partire dagli anni ’20 di quel secolo), si rimanda a Michelguglielmo Torri, In the Deep Blue Sea: Surat
and its merchant class during the dyarchic era (1759-1800), in «The Indian Economic and Social
History Review», Vol. XIX, nn. 3-4, 1982, pp. 267-299; e id., The Hindu Bankers of Surat and their
business world in the second half of the 18th century, in «Modern Asian Studies», 25, 2, 1991, pp. 367401.
8
12
oltre ad alimentare il «consumo vistoso» delle classi dirigenti (il cui strato superiore
viveva nelle città), era destinato ad alimentare il commercio di media e di lunga distanza
e le attività produttive ad esso legate.
I commerci di media e di lunga distanza – e la produzione delle merci che
andavano ad alimentarli – sembrano essere stati trainati dalla necessità di procurarsi due
beni «strategici», non disponibili nel subcontinente. Il primo (cioè quello la cui richiesta
risale più indietro nel tempo, essendo ben visibile già in era antica) è il metallo prezioso.
Quest’ultimo era necessario per rendere possibile la circolazione monetaria (attestata da
fonti sia amministrative, sia archeologiche). Il secondo, la cui richiesta è documentata
quanto meno dalla metà del XIII secolo, è rappresentato dai cavalli da guerra.
L’importazione di metallo prezioso presupponeva una rete complessa di
interscambi economici a livello intercontinentale. Infatti, i metalli preziosi circolanti in
India non erano prodotti localmente ma avevano la loro sorgente in aree geografiche al
di fuori dell’Asia. Ad esempio, nell’era antica l’oro circolante in India proveniva
dall’impero romano; nell’era moderna (cioè a partire dal ’500), gran parte dell’argento
circolante in India aveva la sua fonte originaria nelle miniere sudamericane).
L’immissione di questi metalli preziosi nel subcontinente presupponeva, ovviamente, un
flusso in senso contrario di merci prodotte in India, da scambiare con tali metalli
preziosi.
Sicuramente a partire dal ’600, accanto all’argento coniato, vi erano, poi, altri
strumenti di scambio, usati soprattutto per le attività economiche quotidiane. Questi
strumenti includevano un particolare tipo di conchiglia proveniente dalle Maldive, un
particolare tipo di mandorla non commestibile proveniente dalla Persia e, soprattutto,
monetine di rame, cioè un metallo importato dal Giappone 14. Di nuovo, tutto ciò
presuppone non solo una fiorente economia monetaria in India e flussi commerciali che
unissero l’India al resto dell’Asia, ma l’esistenza di strati sociali specializzati nella
produzione delle merci scambiate con le conchiglie maldive, le mandorle iraniane ed il
rame nipponico.
Una parte maggioritaria dei beni prodotti in India, destinati non solo al consumo
locale ma anche all’esportazione, consisteva in manufatti tessili di cotone o di cotone
misto a seta. La produzione di questi manufatti presupponeva un’organizzazione
complessa. Questa comprendeva almeno tre tipi di operatori. In primo luogo vi erano i
gruppi castali specializzati in una particolare fase della lavorazione complessiva. Poi vi
erano piccoli mercanti-prestatori di denaro che commissionavano e raccoglievano le
merci, in genere pagando in anticipo le merci richieste. Infine vi erano gruppi ristretti di
grandi mercanti e finanziari (che agivano in partnership), che erano coloro che
14
Su questo argomento, rimane di fondamentale importanza il saggio di Frank Perlin, Protoindustrialization and Pre-colonial South Asia, in «Past and Present», 83, febbraio 1983.
9
acquistavano i beni commercializzati dai piccoli mercanti-finanziatori, in certi casi
pagando almeno in parte in anticipo le merci richieste. Quest’ultimo gruppo svolgeva
anche il ruolo di intermediazione nei confronti dei grandi mercanti impegnati nei
commerci di lunga distanza. Ovviamente, in alcuni casi, i grandi intermediari ed i
mercanti di lunga distanza erano le stesse persone. Dato che una parte consistente del
commercio di lunga distanza si svolgeva via mare, i grandi mercanti erano spesso anche
armatori15.
Nel complesso, si trattava di strati sociali presenti sia nelle grandi città, sia – nel
caso dei piccoli mercanti e degli artigiani - soprattutto in piccoli centri urbani o in
villaggi. Questi ultimi, però, erano lungi dall’essere autosufficienti ed isolati; al
contrario, non potevano non essere parte di un sistema economico di grandi dimensioni
(tali, in effetti, da estendersi oltre i confini del subcontinente).
Per quanto riguarda le monte da guerra, queste furono uno degli strumenti
fondamentali nel garantire la rapida conquista della Valle Gangetica da parte dei turcoafghani nel periodo a cavallo fra il XII ed il XIII secolo e la conseguente creazione del
sultanato di Delhi. A partire dal XIII e dal XIV secolo, anche le monarchie del Deccan e
dell’Estremo Sud, ancora indipendenti dal sultanato di Delhi, si resero conto della
necessità di dotarsi di una cavalleria adeguata. Il problema era, però, che le monte da
guerra allevate in India, per ragioni a quanto pare climatiche, erano di razza inferiore.
Era quindi imperativo importare monte adeguate dal Medio Oriente (dove si allevavano i
famosi purosangue arabi). Ma importare cavalli da guerra per equipaggiare gli eserciti di
una serie di stati (alcuni dei quali, come il sultanato di Delhi o l’impero di Vijayanagara,
di grandi dimensioni) comportava l’impegno di un volume di ricchezza veramente
considerevole. In ogni caso, era necessario produrre ed esportare una quantità di merci
in grado di controbilanciare l’importazione delle monte da guerra.
Nelle città, soprattutto in quelle di grandi dimensioni, esistevano strati sociali
specializzati nel finanziare tutte le attività sopra descritte. In certi casi questi strati
sociali erano formati da persone che, in contemporanea, gestivano attività commerciali;
in altri casi da operatori che si erano ormai specializzati in attività finanziare e, per i
quali, i rapporti commerciali, se pur venivano ancora gestiti, rivestivano un ruolo del
tutto subordinato.
Al pari della civiltà occidentale, quella indiana non fu sempre caratterizzata dalla
presenza di un fiorente sistema urbano. Alla graduale espansione dell’epoca antica,
infatti, fece seguito un processo di contrazione che incominciò già in era tardo-antica (III
Questa descrizione è basata, fra l’altro, sull’analisi in profondità, condotta da chi scrive, dei
documenti della East India Company relativi alla presidenza di Bombay e all’insediamento di Surat nel
periodo dagli anni ’20 del ’700 fino all’anno 1800. Per una discussione del valore di questa
documentazione, si rimanda a Michelguglielmo Torri, Surat, its hinterland and its trade, c. 1740-1800:
The British documents, in «Moyen Orient et Océan Indien», 10, 1998, pp. 35-56.
10
15
secolo d.C.) e culminò nella prima fase del periodo medievale (VI-X secolo). Con il
1000 o subito dopo, tale processo subì un’inversione che vide il rifiorire della civiltà
urbana nel subcontinente indiano, come, del resto, in Europa ed in altre parti del
Vecchio Continente. Sappiamo, inoltre, che, fin da periodi molto antichi, le varie aree
urbanizzate del mondo civile, in Asia Meridionale ed altrove, erano collegate fra di loro
da fiorenti commerci di lunga distanza.
In effetti, il parallelismo dello sviluppo urbano in Asia Meridionale ed in Europa
(ma anche fra l’Asia Meridionale e altre parti dell’Eurasia) fa pensare all’esistenza di un
unico sistema economico che abbracciava un’area che andava dalla Cina all’Europa
Occidentale. Questo sistema, come si è appena detto, era caratterizzato dall’esistenza di
importanti flussi commerciali di lunga distanza e, a quanto pare, da un processo di
scambio di idee filosofico-religiose16.
Tutto questo significa, fra le altre cose, che ciò che caratterizzò l’economia di una
serie di zone chiave, in Asia Meridionale come altrove, fu la stretta integrazione del
settore rurale e di quello urbano e l’inserimento di entrambi i settori in un circuito
commerciale che, come si è detto, abbracciava larghe parti del continente antico. In
questo contesto, non è che villaggi autosufficienti o quasi non esistessero; essi, però,
rappresentavano la parte meno vitale – e, soprattutto, quella meno importante – del
sistema economico. Già di per sé questo pone logicamente in dubbio che il sistema
castale potesse avere la capacità di controllo, teoricamente possibile in centri piccoli ed
isolati, le cui componenti sociali fossero interdipendenti.
È bensì vero che le caste avevano una presenza pervasiva nella società indiana,
tanto che esse si trovavano non solo fra coloro che appartenevano alla tradizione indù,
ma anche fra i musulmani e i cristiani indiani. Ma non è assolutamente vero che la
società indiana nella sua realtà storica sia mai stata organizzata secondo i principî
gerarchici indicati nei Dharma Shastra, se non, forse, nel periodo gupta (IV-V secolo
d.C.). La posizione effettiva delle caste, infatti, era legata alla ricchezza economica ed al
potere politico dei loro membri. In altre parole, i brahmani formavano effettivamente il
vertice della società solo in quelle zone ed in quei periodi storici in cui, per ragioni che
poco o nulla avevano a che fare con la «purezza» della loro casta, controllavano la
politica e/o l’economia a livello locale. Le caste stesse, poi, lungi dall’essere fisse e
immutabili, continuarono a modificarsi nel corso della storia, in rapporto all’evoluzione
dell’economia e della politica. In altre parole, il manifestarsi di nuove necessità
economiche, politiche o militari portava al parallelo sorgere di caste prima inesistenti,
che, ora, si specializzavano nelle nuove funzioni richieste dalla società. In parallelo, il
16
Per un approfondimento di queste tesi si rimanda in particolare a McNeill, The Rise of the
West cit.; Janet L. Abu-Lughod, Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350,
Oxford University Press, Oxford 1989; André Gunder Frank, ReOrient. Global Economy in the Asian
age, University of California Press, Berkeley 1998. Si veda anche Torri, Storia dell’India cit., passim.
11
venir meno di certe necessità sociali (per esempio, la scomparsa dei commerci di lunga
distanza all’inizio del Medio Evo indiano) poteva comportare il cambio di funzione di
una certa casta (che passava da una professione castale ad un’altra) e, se la nuova
funzione era più umile di quella che era stata in passato, lo spostamento verso il basso
della posizione dell’intera casta nella gerarchia castale17.
Infine, l’endogamia, che avrebbe dovuto essere il criterio fondamentale,
caratterizzante l’appartenenza castale, non era sempre rispettata. Quando le circostanze
richiedevano una crescita demografica rapida della casta, i matrimoni da parte di un
uomo di quella determinata casta con una donna di una casta diversa erano accettati
come perfettamente legittimi ed i rampolli dell’unione in questione erano considerati
come appartenenti alla casta del padre.
A parte questo, vi è un altro elemento che bisogna sottolineare. Questo è che,
prima dell’era coloniale, le caste non svolgevano alcuna funzione organizzativa e di
controllo né dal punto di vista economico, né da quello politico, ma, al più, dal punto di
vista sociale (soprattutto in quanto reti di scambio di partner matrimoniali 18). Si prenda
ad esempio il caso delle due grandi caste guerriere per eccellenza: i rajput ed i maratha.
Anche se, occasionalmente, tutti i rajput o tutti i maratha unirono le loro forze nel
perseguimento di un progetto politico comune, storicamente questi momenti unitari
rappresentano l’eccezione, non la regola. Lo stesso vale per le grandi caste mercantili.
Nonostante il tentativo di certi storici di scoprire organizzazioni che raccogliessero e
organizzassero politicamente ed economicamente i membri delle grandi caste mercantili,
sembra assodato come tali organizzazioni, quando esistevano, avessero un ruolo
puramente sociale19. Diversa sembra essere la situazione nel caso delle confraternite
contadine impegnate nell’opera di dissodamento di terre vergini. Qui l’interdipendenza
delle caste e la capacità di regolamentazione sociale del sistema castale sembrano essere
state alte. Ma si trattava pur sempre di un’area marginale della società indiana, quella,
cioè, che si collocava, geograficamente e socialmente, nelle aree di frontiera.
Anche la realtà castale, quindi, come quella rappresentata dai villaggi
autosufficienti, sembra avere avuto caratteristiche completamente diverse da quelle
Per un’analisi di fondamentale importanza sul mutamento del sistema castale nel periodo fra
la fine dell’era antica e l’inizio del Medio Evo, si veda l’articolo di R. S. Sharma, Problem of
Transition from Ancient to Medieval in Indian History, in «The Indian Historical Review», I, 1, marzo
1974.
18
Ma anche questa, come si è appena ricordato, non era una funzione che venisse svolta
sempre.
19
Su questo problema si veda, ad es., Michelguglielmo Torri, A Loch Ness monster? The
Mahajans of Surat during the second half of the 18th century in «Studies in History», 13, 1, n.s., 1997,
pp. 1-18.
12
17
imputatele dall’Orientalismo20. Lo stesso vale per il terzo degli elementi chiave della
visione orientalistica, cioè l’idea che esistesse una singola e ben determinata religione,
chiamata «induismo». La ricerca storica degli ultimi decenni ha ormai dimostrato che
l’induismo non era (e non è) un’unica religione, bensì una tradizione religiosa o, se
vogliamo, un insieme di religioni che condividono una serie di elementi comuni più o
meno importanti21. Insomma, dire che l’induismo è una religione – come fecero gli
Orientalisti e come, sulla loro scia, fa una corrente di pensiero indiana che ha
incominciato a diventare influente a partire dagli anni ’20 del secolo appena concluso –
è come affermare che esiste una religione «abramica», formata dall’ebraismo, dal
cristianesimo e dall’islàm. Ebraismo, cristianesimo ed islàm, infatti, sono tutte religioni
monoteistiche che condividono la tradizione profetica del vecchio testamento. In realtà,
quindi, le religioni semitiche hanno, fra di loro, almeno altrettanti elementi comuni
quanto quelli esistenti fra le varie forme di induismo (alcune delle quali, in definitiva,
non sono, a differenza di altre, strettamente monoteistiche; così come alcune delle quali
non hanno, a differenza di altre, una visione gerarchica dell’umanità).
Storicamente, quindi, la tradizione induista è stata percorsa da una serie di
correnti, anche considerevolmente diverse fra di loro. Alcune di queste correnti
ipotizzavano l’esistenza di una società castale gerarchica, in cui le caste più alte (in
quanto ritualmente più pure) erano le caste brahmaniche. Ma altre correnti svalutavano
completamente l’importanza della gerarchia castale, arrivando in certi casi a negare
completamente lo stesso ordinamento castale. Quindi, le idee che oggi ci appaiono come
tipiche dell’induismo (cioè la visione dell’umanità come articolata in un ordine castale
gerarchico, sanzionato da criteri religiosi) sono, in realtà, tipiche di un certo tipo di
induismo. Si tratta anche di un certo tipo di induismo che, per le ragioni che
indicheremo fra poco, diventò particolarmente influente in epoca coloniale. Esso faceva
riferimento soprattutto ai Dharma Shastra, cioè – come si è già ricordato - a raccolte di
leggi codificate e messe per iscritto presumibilmente fra il III ed il V secolo d.C. (il
periodo coincidente con quello che in Europa aveva visto l’ultima fase dell’impero
romano). Questi codici – che registravano l’ideale brahmanico di come la società
indiana avrebbe dovuto essere organizzata, ma, con ogni probabilità, non l’effettivo
funzionamento di leggi concretamente applicate – descrivevano un sistema sociale
rigidamente organizzato in caste, disposte secondo un preciso ordine gerarchico di
Per un approfondimento dell’intero problema dell’evoluzione reale del sistema castale, si
rimanda all’articolo di Dhirubhai L. Sheth, Caste e classi in India: realtà sociale e rappresentazioni
politiche, in AA.VV. L’India contemporanea. Dinamiche culturali e politiche, trasformazioni
economiche e mutamento sociale, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1998, pp. 21-48, ed alla
bibliografia in esso indicata.
21
Per una discussione di questo problema si rimanda a Richard King, Orientalism and Religion.
Postcolonial Theory, India and ‘The Mystic East’, Routledge, Londra 1999.
13
20
natura rituale, santificato e reso immutabile dai precetti dell’induismo. In altre parole, i
Dharma Shastra non solo davano l’impressione che in India esistesse e fosse sempre
esistita una società gerarchica, ma che questa fosse giustificata da una religione, che,
molto tempo dopo, gli europei avrebbero chiamato «induismo».
Il fatto che l’induismo gerarchico dei brahmani fosse accolto nel periodo coloniale
come il «vero» induismo – e tale, da allora, abbia finito per essere considerato anche
dalla maggioranza di coloro che si riconoscono nella tradizione religiosa indù – non
dovrebbe, però, oscurare il fatto che, storicamente, esso fu tutt’altro che l’unica forma di
induismo (e tale, nonostante tutto, rimane la situazione ancora oggi). Senza soffermarci
su un tema assai complicato, vale tuttavia la pena di ricordare, quanto meno, che, in era
medievale, l’induismo fu attraversato da importanti movimenti mistici che, a livello
teorico e nella prassi, svalutarono in maniera radicale l’importanza delle caste o,
addirittura, la legittimità della divisione degli esseri umani secondo regole castali22.
Inoltre, anche in periodo coloniale, nonostante l’appoggio dato dallo stato alla visione
gerarchica dell’induismo, questo vide il sorgere di importanti movimenti di riforma che
negavano ogni validità alle divisioni castali23.
Infine, l’enfasi sull’induismo come la religione dell’India – un’enfasi così tipica
dell’Orientalismo (anche se poi accettata da molti indù) – oscura un’altra realtà storica
della massima importanza. Questa è che, in India, con l’induismo hanno convissuto – e
tuttora convivono – altre tradizioni filosofico-religiose che sono tanto indiane quanto
l’induismo. Questo vale in particolare (anche se non esclusivamente) per l’islàm e per il
cristianesimo. L’islàm e il cristianesimo, infatti, arrivarono in India praticamente in
contemporanea alla creazione delle due rispettive religioni24.
In conclusione, quindi, differentemente da quanto argomentato dall’Orientalismo:
la società indiana non è mai stata una società immobile;
il sistema dei villaggi autosufficienti era una parte – e, per lunghi periodi storici,
la parte meno importante – dell’economia indiana;
il sistema castale aveva caratteristiche completamente diverse da quelle che gli
sono state attribuite e, in molti casi, sembra essere stato assai meno importante di quanto
sostenuto dall’Orientalismo;
Per un approfondimento di questo tema si veda Torri, Storia dell’India cit., spec. pp. 240-246.
Ibidem, pp. 418-23, 451-61.
24
Secondo la tradizione, la prima moschea indiana venne fondata nel Kerala da un abitante del
luogo che, durante un suo soggiorno in Arabia, era stato convertito dallo stesso profeta Muhammad.
Dal canto loro, i cristiani «vecchi» del Kerala fanno risalire la propria conversione alla predicazione
dell’apostolo Tommaso. Ovviamente si tratta di tradizioni il cui fondamento storico non può essere
stabilito con alcuna certezza. Ma le ricerche più recenti tendono a dimostrare che il cristianesimo si
insediò stabilmente in India nei primi secoli della nostra era e che l’opera di apostolato dei missionari
shiiti e dei sufi sunniti si svolse indipendentemente e, in alcuni casi, precedette il processo di conquista
del subcontinente da parte prima degli arabi e poi dei turco-afghani.
14
22
23
l’induismo non è, in primis, una religione unificata, con le caratteristiche
attribuitegli dall’Orientalismo, bensì un fascio di religioni anche considerevolmente
diverse; e, per finire,
l’induismo, per quanto la tradizione religiosa maggioritaria, è ben lungi
dall’essere l’unica tradizione religiosa presente in India.
Quando si tiene presente tutto quanto è stato fin qui detto, la conclusione a cui non
si può fare a meno di arrivare è che i modelli interpretativi basati sull’Orientalismo
hanno un rapporto con la realtà effettuale decisamente tenue. Un rapporto così tenue, in
effetti, che un uso acritico dei modelli orientalisti, come unico strumento – o anche solo
come strumento privilegiato – attraverso il quale interpretare la realtà indiana non può
che essere fuorviante.
La visione orientalistica dell’India: da chi è stata creata e come
Se, quindi, l’Orientalismo ha un così scarso rapporto con la realtà effettuale, diviene
imperativo chiedersi per quale ragione e come esso venne elaborato, perché divenne così
influente e perché, nonostante tutto, continui a rimanere tale. La visione orientalistica
dell’India, mirabile nella sua armonia, eleganza ed onnicomprensività, venne formulata
nella seconda metà del ’700 e nel corso dell’800. I suoi creatori furono essenzialmente
funzionari britannici della Compagnia inglese delle Indie Orientali e missionari europei.
Entrambi questi gruppi – divisi in certi periodi da reciproche tensioni, ma uniti in altri da
rapporti di collaborazione – ebbero come fine quello di cercare di comprendere una
realtà immensa, multiforme, rutilante e complessa. Gli amministratori perseguirono
questa conoscenza per poter governare in maniera più efficiente; i missionari, al fine di
portare la luce della Cristianità a popolazioni «barbare e ottenebrate». Gli uni e gli altri,
per realizzare questo loro progetto di comprensione della società indiana, non poterono
fare a meno di ricorrere alla collaborazione di dotti indigeni. Da questo punto di vista, il
tipo di collaboratori scelti da amministratori e missionari fu cruciale nella creazione
della visione orientalistica dell’India. Tali collaboratori, infatti, appartenevano in misura
dominante alle caste brahminiche indù e, in proporzione minore, erano dottori della
legge musulmani. Nell’uno e nell’altro caso si trattava di specialisti nelle scienze
religiose «alte», profondi conoscitori dei rispettivi testi canonici 25. Nell’uno e nell’altro
caso, poi, si trattava di persone appartenenti a categorie che non erano state intimamente
legate alle classi dirigenti degli stati precoloniali (occupando, se mai, i gradini
subordinati della burocrazia).
25
Kopf, British Orientalism cit., passim.
15
In altre parole, gli intellettuali indiani con cui collaborarono gli amministratori
britannici e i missionari cristiani, soprattutto nel periodo sotteso fra la metà del ’700 e la
metà dell’800, rappresentavano solo una parte dell’intellettualità indigena dell’epoca e,
senza alcun dubbio, la parte culturalmente e socialmente più conservatrice. La sezione
culturalmente più vivace e socialmente progressista dell’intellettualità indigena, infatti,
era rappresentata soprattutto dai circoli dirigenti delle corti degli stati successori
dell’impero moghul. Si trattava, cioè, di persone appartenenti ad un ambiente sociale
caratterizzato da un clima che oggi si definirebbe multiculturale, i cui membri
appartenevano a religioni diverse, erano di regola poliglotti e, come formazione, erano,
in linea di massima, non teologi o giuristi, ma amministratori e storici. Come tali, essi
erano perfettamente coscienti sia della varietà, dell’indeterminatezza e della porosità
delle differenti tradizioni culturali e costumi sociali che caratterizzavano l’India, sia dei
processi di mutamento che ne attraversavano la società26.
Per ovvie ragioni, la collaborazione con questo tipo di intellettuali venne evitata
sia dagli amministratori della nuova potenza imperiale – la Compagnia inglese delle
Indie Orientali – sia dai missionari cristiani. Gli uni e gli altri preferirono stabilire un
rapporto con quegli intellettuali che non erano parte delle vecchie classi dirigenti e che
vedevano il proprio mondo articolato secondo criteri religiosi rigidi ed immutabili.
Ovviamente, gli amministratori della nuova potenza imperiale trovarono politicamente
più opportuno marginalizzare gli strati sociali che avevano detenuto il potere nel periodo
precoloniale, promuovendone altri, che, per ciò stesso, risultassero legati al nuovo
sistema di potere. D’altro canto, i missionari, per la loro formazione religiosa, trovarono
più facile confrontarsi con altri religiosi, legati ad un’interpretazione «ortodossa» della
religione di appartenenza, piuttosto che con intellettuali che sembravano muoversi con
estrema facilità fra «religioni» che, dal punto di vista dell’alta teologia, erano
radicalmente differenti (come appunto induismo ed islàm). Certamente, il fatto che un
indù potesse avere un maestro spirituale musulmano, o che un musulmano potesse avere
un maestro spirituale indù, o che indù e musulmani venerassero le tombe degli stessi
sant’uomini, o che monarchi indù facessero da patroni a istituzioni religiose musulmane
e, viceversa, monarchi musulmani facessero da patroni a istituzioni religiose indù erano
cose profondamente sconcertanti per i buoni missionari cristiani (in genere protestanti)
che operarono in India fra la metà del ’700 e la metà dell’800 (cioè il periodo formativo
dell’Orientalismo). Non stupisce più di tanto, quindi, che questi ultimi cercassero un
rapporto intellettuale con seri e dotti teologi – fossero essi musulmani o indù – che, se
non altro, avessero le idee chiare sul fatto che, in questo mondo, vi sono religioni diverse
e che ognuna di esse è rigorosamente separata dalle altre da una serie di dogmi fondanti.
26
Per un’elaborazione di questi punti si veda Torri, Storia dell’India cit., pp. 377-380.
16
La costruzione di una certa visione dell’India – una costruzione che divenne
paradigmatica non solo per l’Indologia ma per l’Orientalismo nel suo complesso – non
fu quindi (solo) l’imposizione da parte degli Europei di una certa visione dell’India – e
dell’«Oriente» – nei confronti delle popolazioni indigene, ma fu frutto di un rapporto
dialogico con certi settori della società indigena27. Naturalmente, questi settori della
società indigena operarono attivamente per rimodellare la società indiana secondo le
proprie idee, modificando in maniera radicale la realtà effettuale fin lì esistente. Furono
soprattutto i pandit (esperti nei testi canonici sanscriti) ad ottenere un immenso successo,
convincendo amministratori e missionari che la «vera» India, l’India autentica e
immutabile, era quella rappresentata in testi come i Dharma Shastra.
Come il regime coloniale diede sostanza ai fantasmi dell’Orientalismo
Il successo di questo particolare processo dialogico – che vide impegnati, da un lato,
amministratori e missionari europei e, dall’altro, intellettuali indiani (sia indù, sia
musulmani), che erano teologi e, spesso, anche giuristi – ebbe poi uno sbocco politico di
cruciale importanza nell’opera legislativa da parte della nuova potenza imperiale. Il
potere coloniale britannico, infatti, realizzò codici legislativi che recepivano le direttive
fondamentali di leggi religiose, sia indù sia musulmane. Si trattava di direttive religiose
che raramente o mai erano state parte della prassi giuridica degli stati precoloniali, in
particolare nei due secoli e mezzo precedenti la conquista europea28.
In sostanza, in India, il risultato socialmente più rilevante del processo di
modernizzazione rappresentato dall’introduzione – a partire dalla fine del ’700 – di
codici legislativi di tipo europeo fu, quindi, quello di dare l’appoggio della legge a
ideologie religiose conservatrici (indù e musulmane) che, fino a quel momento, non
avevano potuto contare, se non raramente, sul sostegno del potere statale. Una delle
conseguenze di questa decisione politica fu la «brahmanizzazione» della società indiana:
i fantasmi ideologici dei teologi, con l’appoggio potente delle leggi coloniali, assunsero
una sempre maggior concretezza. Se il diritto coloniale distribuiva le ricchezze
guadagnate dal singolo secondo il «tradizionale» diritto di famiglia indù (per cui la
ricchezza guadagnata dal singolo era in effetti proprietà della famiglia estesa ed era
amministrata dal patriarca che ne era a capo), è chiaro che l’evoluzione verso la famiglia
nucleare non poteva che essere bloccata o rovesciata. Di nuovo, se il diritto coloniale
27
Il concetto di rapporto dialogico fra colonizzatori e gruppi di intellettuali indigeni nel
«costruire» la visione orientalistica dell'India è mutuata da Eugene F. Irschick, Dialogue and History.
Constructing South India 1795-1859, University of California, Berkeley 1994.
28
Con la parziale eccezione dell’operato del padishah moghul Aurangzeb (1658-1707).
17
limitava la possibilità di svolgere certe attività economiche in base all’appartenenza
castale, è chiaro che la casta assumeva un’importanza che prima non aveva mai avuto29.
Ma né la creazione di un’ideologia, né l’introduzione di nuove leggi basate su tale
ideologia sono di per sé sufficienti ad imbrigliare lo sviluppo di una società, in
particolare in un’area geograficamente estesa e demograficamente densa come il
subcontinente indiano. Il problema fu che, mentre amministratori e missionari europei,
in collaborazione con teologi e giuristi indiani, elaborarono la visione «orientalistica»
dell’India, e mentre quegli stessi amministratori idearono quei codici legislativi in cui si
rispecchiava tale visione dell’India, il concreto funzionamento del sistema coloniale creò
– soprattutto nella prima metà dell’800 – quella stessa realtà sociale che gli orientalisti
andavano descrivendo.
Ancora alla vigilia della conquista coloniale, infatti, la società indiana era
politicamente, economicamente e socialmente dinamica. La disgregazione dell’impero
moghul aveva portato all’emergere di una serie di stati, molti dei quali apparivano più
centralizzati – e più efficienti – di quanto fosse stato l’impero che li aveva preceduti.
Questi stati, per quanto in guerra perenne fra di loro – come, del resto, i contemporanei
stati europei – sembravano evolversi – di nuovo come gli stati europei – verso un
sistema di equilibrio politico a livello continentale. Nonostante una crisi commerciale di
grandi proporzioni (che, nel ’700, coinvolse tutta la parte occidentale dell’Oceano
Indiano e che non mancò, nella seconda metà del secolo, di influire negativamente sulle
stesse fortune economiche della Compagnia inglese delle Indie Orientali), e nonostante
le distruzioni legate alla guerra nell’alta vallata gangetica, nel XVIII secolo l’economia
indiana attraversò, nella maggior parte del subcontinente, una fase di crescita. Ancora
nella seconda metà del ’700, i tessuti di cotone o di cotone misto a seta prodotti in India
erano concorrenziali sul mercato mondiale. A parte questo – e a parte alcune zone
geografiche, sfavorite dalle vicende politico-militari – il settore agricolo continuò a
crescere, in genere sia sotto la spinta delle esigenze di consumo degli stati indigeni, sia
sotto quella della domanda internazionale di prodotti quali i tessili e la seta grezza
(quest’ultima prodotta in Bengala)30. A livello sociale, nonostante la persistenza o il
riemergere di correnti intellettuali che dividevano gli esseri umani in base alla loro
29
David Washbrook, Law State and Agrarian Society in Colonial India, in «Modern Asian
Studies», 15, 3, 1981, pp. 649-721.
30
Sull’importanza della seta grezza e dei tessili bengalesi nell’economia indiana ed
internazionale fra ’600 e ’700 si vedano Om Prakash, The Dutch East India Company and the Economy
of Bengal 1630-1720, Princeton University Press, Princeton 1985, e il dibattito fra Sushil Chaudhuri e
Om Prakash in «Modern Asian Studies», 27, 2, maggio 1993, pp. 321-356. Sempre sul medesimo
argomento, si veda Sushil Chaudhury, International Trade in Bengal Silk and The Comparative Role of
Asians and Europeans, circa. 1700-1757, in «Modern Asian Studies», 29, 2, maggio 1995, pp. 373386.
18
appartenenza religiosa, la cultura egemonica era chiaramente basata sulla convivenza e
sulla ricerca degli elementi comuni fra le varie tradizioni religiose. Il sistema castale,
infine, appariva fluido e aperto. Alcune delle caste più importanti (ad esempio i maratha)
si erano formate in tempi relativamente recenti, attraverso il confluire in un unico
gruppo sociale di appartenenti a caste diverse, uniti dal fatto di aver acquisito, attraverso
il mestiere delle armi, rispettabilità sociale e agiatezza economica (l’una e l’altra
esemplificate dalla concessione del godimento di terre esentasse). Inoltre, in particolare
le caste più importanti ricorrevano normalmente alla cooptazione di individui che
tecnicamente, secondo le regole dei Dharma Shastra, avrebbero dovuto essere
considerati fuoricasta. In altre parole, come si è già ricordato, i rampolli di unioni con
donne appartenenti a caste diverse e ritualmente inferiori rispetto a quella del padre,
venivano considerati membri a tutti gli effetti della casta di quest’ultimo. Inoltre – come
del resto era stato spesso il caso nella storia indiana fin dai tempi più antichi –
l’appartenenza ad una determinata casta non preveniva l’ascesa ai pinnacoli del potere
politico ed economico31.
Tutto ciò cambiò in maniera drammatica nella prima metà dell’800, in
coincidenza con l’estensione dell’egemonia inglese a tutto il subcontinente e con
l’aumento di efficienza e di onestà della macchina statale creata dalla Compagnia
inglese delle Indie Orientali. Questo aumento di efficienza e di onestà, avviato dalle
riforme di Lord Cornwallis alla fine del ’700, è in genere visto come il momento in cui
si concluse la fase in cui il governo della Compagnia era stato poco più di una maschera
legale per le attività predatorie dei suoi funzionari (che, valendosi del potere politico
della Compagnia, avevano, fino a quel momento, perseguito come loro fine primario il
proprio arricchimento personale).
Questo tipo di analisi ha però sempre trascurato il fatto che il tanto lodato
aumento di efficienza e di onestà avviato dalle riforme di Cornwallis era finalizzato al
perseguimento di obiettivi che nulla avevano a che vedere con il benessere dell’India. La
Compagnia delle Indie rimaneva una gigantesca società per azioni, il cui obiettivo
ultimo era quello di pagare dividendi ai suoi azionisti in Gran Bretagna, non certo quello
di aumentare il benessere collettivo dei suoi sudditi indiani. Direttamente legato a questo
31
Per un approfondimento di queste tesi si rimanda a Torri, Storia dell'India cit., pp. 314-323.
Si tratta di tesi che – oltre che sullo spoglio, compiuto da chi scrive, delle fonti primarie inglesi
concernenti Surat ed il suo hinterland nella seconda metà del ’700, ed oltre che sul saggio di Perlin,
Proto-industrialization and Pre-colonial South Asia cit. – sono basate su C.A. Bayly, Rulers,
Townsmen and Bazaars. North Indian society in the age of British expansion, 1770-1870, Cambridge
University Press, Cambridge 1983; id., Indian Society and the Making of the British Empire,
Cambridge University Press, Cambridge 1988; Stewart Gordon, The Marathas 1600-1818, Cambridge
University Press, Cambridge 1993; id., Marathas, Marauders, and State Formation in EighteenthCentury India, Oxford University Press, Delhi 1994.
19
obiettivo primario, ve ne erano poi altri due, di uguale importanza: mantenere alto il
livello del proprio apparato militare in India, in modo da proteggere e da espandere i
propri dominî in loco; attuare una politica economica che proteggesse la Compagnia
dalle gelosie di quella parte maggioritaria della borghesia britannica che non aveva la
fortuna di far parte del circolo di azionisti della Compagnia (e che, di conseguenza, era
esclusa dal godimento dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento dell’India).
Soprattutto il primo e l’ultimo di questi obiettivi (il pagamento dei dividendi agli
azionisti, cioè il trasferimento di ricchezza dall’India all’Inghilterra, e il perseguimento
di politiche economiche che non entrassero in competizione con gli interessi della
borghesia britannica) si tradussero in una politica di spietato sfruttamento dell’economia
indiana. Questa politica comportò, fra l’altro, la ristrutturazione dei traffici
internazionali dell’India e la contrazione della spesa pubblica (una spesa pubblica che
era stata parte integrante degli obblighi dei prìncipi indiani e che, ora, venne
radicalmente ridimensionata al fine di realizzare economie che, a loro volta,
permettessero l’accumulo di ricchezza da trasferire in Inghilterra). Il risultato ultimo di
queste politiche – che, nei loro effetti negativi, furono rafforzate da un’avversa
congiuntura internazionale – fu una catastrofica depressione che portò alla contrazione
ed alla dislocazione delle attività artigianali, alla scomparsa di una serie di attività
commerciali di lunga distanza, al venir meno dell’economia monetaria in ampie zone del
subcontinente ed al declino economico di un numero considerevole di città (anche se
quest’ultimo processo fu in parte controbilanciato dalla crescita dei tre centri di
irradiazione del nuovo potere coloniale: Calcutta, Bombay e Madras)32. In sostanza,
quindi, in vaste parti dell’India – precedentemente caratterizzate da una fiorente
economia mercantile – vi fu l’emergere di un’economia dominata dalla presenza di
villaggi con scarsi contatti con il mondo esterno, che, al loro interno, funzionavano in
base all’interscambio – non mediato dal nesso monetario – di attività lavorative33.
Questa stessa realtà, descritta dagli studiosi dell’epoca coloniale, venne vista non come
Per un approfondimento delle argomentazioni sul collasso dell’economia indiana in
corrispondenza del sorgere del colonialismo si rimanda a Torri, Storia dell'India cit., pp. 389-394, 397408. Si tratta di tesi largamente basate sulla reinterpretazione dei dati presentati nelle due opere di C.A.
Bayly citate nella nota precedente e sullo studio, condotto da chi scrive, del mutamento dei rapporti
commerciali fra il Bengala e Surat nella seconda metà del ’700. Su quest’ultimo punto si veda Torri,
The Hindu Bankers of Surat and their business world cit., passim.
33
Solo in un secondo tempo, nel Nord dell’India questo interscambio di beni e di servizi fra i
vari gruppi sociali che formavano un villaggio venne legittimato in base ad obbligazioni di carattere
rituale e religioso, dando origine al cosiddetto sistema jajmani. Per quanto indicato dagli antropologi
del ’900 come un sistema di «grande antichità» (cioè come un’altra delle manifestazioni
dell’immutabilità della società indiana), il sistema jajamani nacque, quindi, solo nel tardo ’800. Sulla
questione, si veda Peter Mayer, Inventing Village Tradition: The Late 19th Century Origins of the
North Indian ‘Jajmani System’, in «Modern Asian Studies», 27, 2, maggio 1993, pp. 357-365.
20
32
il prodotto di una congiuntura recente, in misura dominante determinata dall’azione del
governo coloniale, ma come la manifestazione delle caratteristiche di fondo di una
società ristagnante e senza storia.
La diffusione e la persistenza dell’Orientalismo nel pensiero occidentale
Si è già accennato al fatto che l’Orientalismo, nel periodo della sua prima elaborazione,
cioè nella seconda metà del ’700, era una visione che, più che sul criterio di
inferiorità/superiorità, si basava sul criterio di diversità. L’«Oriente», cioè, era visto
come diverso dall’Occidente, non necessariamente come inferiore. Anzi, in molti dei
pensatori illuministi contemporanei dei primi orientalisti vi era stato un considerevole
rispetto verso le civiltà orientali; un rispetto che, nel caso particolare della Cina, era
spesso sfociato in esplicita ammirazione34.
Tutto ciò cambiò all’inizio dell’800. Sintomaticamente, questo mutamento si
verificò nel momento in cui divenne chiaro che il rapporto di forza militare fra
Occidente e «Oriente» si era ormai radicalmente spostato a favore del primo. In effetti, i
nuovi rapporti di forza erano tali da far ritenere ormai imminente la rapida conquista di
tutto l’«Oriente» da parte dell’Occidente (una conquista presagita da quella inglese di
gran parte del subcontinente indiano, negli anni a cavallo fra ’700 e ’800). Dall’inizio
dell’800, l’«Oriente» venne categorizzato non solo come diverso, ma anche come
«barbaro» ed «irrimediabilmente inferiore». Fu una copernicana rivoluzione intellettuale
esemplificata – e, al medesimo tempo, incoraggiata – da un’opera storica destinata a
diventare enormemente influente. Intendiamo parlare della History of British India di
James Mill, pubblicata nel 1817 a Londra, e destinata a diventare, nei
centocinquant’anni circa successivi alla sua pubblicazione, in assoluto il più influente
libro sull’India in circolazione.
Ma, in definitiva, la visione orientalistica dell’India in particolare e dell’«Oriente»
in generale rimaneva una branca specializzata, per definizione «esotica», del pensiero
europeo. Tuttavia, nel corso dell’800, l’Orientalismo divenne parte integrante della
Weltanschauung europea, permeando di sé anche elaborazioni intellettuali che, a prima
vista, poco o nulla avevano a che vedere con la tradizione intellettuale orientalistica.
Questo filtrare dell’Orientalismo nel senso comune occidentale fu dovuto alla
mediazione di una serie di grandi maître à penser, impegnati, in prima istanza nel
costruire una visione nuova del mondo in cui vivevano. Pensatori come Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Karl Marx e Max Weber (solo per ricordare alcuni dei più influenti fra
Sulla «sinofilia» europea nel ‘700, si veda Giorgio Borsa, La nascita del mondo moderno in
Asia Orientale, Rizzoli, Milano 1977, pp. 81-99.
21
34
di loro) sono giustamente ricordati come giganti intellettuali. Ma, nelle loro
elaborazioni, Hegel, Marx e Weber (e non solo loro) – parlando dell’«Asia», o
dell’«Oriente», o dell’«India» – si servirono delle conoscenze del loro tempo,
irrimediabilmente inficiate dall’Orientalismo35. Nel far ciò, questi pensatori spesso
usarono l’esotico mondo orientale costruito dagli Orientalisti come il contraltare in base
al quale definire tutto ciò che – a parer loro – vi era di buono e di valido in Occidente.
L’utilizzo dei loro schemi interpretativi, per quanto innovativi fossero, portò
all’accettazione, in genere inavvertita (ciò che, di fatto, rese la cosa più grave), della
dimensione orientalista del pensiero di questi autori. In questo modo l’Orientalismo
«filtrò» nel senso comune degli europei, in particolare degli europei colti e, spesso,
progressisti.
Oggi, i lavori di Hegel, Marx e Weber continuano ad essere assai più ampiamente
e diffusamente letti – come è giusto che sia – che non quelli degli storici all’avanguardia
nello studio delle varie realtà in cui si articola l’«Oriente». Ne consegue che la visione
che gli occidentali hanno del «non Occidente» continua ad essere profondamente
permeata di idee che, come è stato dimostrato dalla ricerca storica degli ultimi
quarant’anni, hanno una corrispondenza scarsa o nulla con la realtà.
Ma la persistente vitalità della visione orientalistica non è solo un caso di «blocco
intellettuale» spontaneo e di mancata diffusione dei risultati della ricerca più recente.
Dopo tutto, l’Orientalismo nacque per controllare politicamente e per sfruttare
economicamente il mondo non occidentale, giustificando e legittimando
intellettualmente questo stato di cose. Oggi, anche se il vecchio mondo coloniale è ormai
tramontato, il «valoroso nuovo mondo» in cui viviamo continua ad essere caratterizzato
da un ordine internazionale gerarchico ed ingiusto. Si tratta di un ordine che, per
mantenersi, non può basarsi esclusivamente sull’uso della forza, ma deve ricorrere a
varie forme di legittimazione. E, ovviamente, l’Orientalismo, sia nella sua versione
«classica», sia in versioni nuove, ha continuato ad essere una delle più influenti fra
queste forme di legittimazione.
-IIL’ORIENTALISMO ECONOMICO E LO SVILUPPO DELL’INDIA
di
Elisabetta Basile
35
Su un caso specifico, quello rappresentato dal concetto di «modo di produzione asiatico»,
elaborato da Karl Marx, si veda la seconda parte di questo saggio introduttivo, scritta da Elisabetta
Basile.
22
La questione dello sviluppo capitalistico dell’India
L’analisi corrente dei processi economici del subcontinente indiano è, in larga misura,
dominata da un’impostazione che ha molti elementi in comune con l’Orientalismo
classico. Anche quando si richiama a schemi interpretativi marxiani, keynesiani e
strutturalisti – anche quando cioè ha una matrice ideologica distante dall’Orientalismo
classico – l’analisi economica convenzionale dell’India si concentra sulle forme di
immobilismo della società e si propone di identificare i fattori responsabili della lentezza
nel ritmo della crescita e della trasformazione. Il prodotto di quest’analisi è una
interpretazione dello sviluppo indiano costruita intorno ad un «Orientalismo» di tipo
economico, che, anche se «inconsapevole» delle implicazioni ideologiche
dell’Orientalismo classico, entra in sintonia con esso, ponendo l’accento sulla specificità
dell’India e cercando di spiegare la stagnazione della sua economia di fronte alla forza
dirompente del capitalismo. Come l’Orientalismo classico, anche l’Orientalismo
economico non riesce a cogliere i segnali di cambiamento che attraversano la società e
l’economia indiana nel corso del ’900, né ad individuare la natura e la profondità delle
trasformazioni che portano al crescente inserimento del subcontinente nel processo di
globalizzazione iniziato con la crisi del Fordismo36.
36
Il termine «Fordismo» viene utilizzato per indicare una particolare fase dello sviluppo
capitalistico identificata da specifici equilibri produttivi e sociali. Nel Fordismo la produzione di beni
industriali è basata sulla tecnica della catena di montaggio, impiega lavoratori semi-specializzati, e
sfrutta le economie di scala di grandi impianti centralizzati. L’accumulazione e la crescita sono
assicurate dall’articolazione fra produzione e consumo: la crescita della produzione, dovuta alle
economie di scala, si traduce in crescita dei salari e, dunque, in crescita dei consumi. Sul fronte
dell’apparato di regolazione, le istituzioni che garantiscono il funzionamento del sistema fordista sono
lo Stato, che controlla le politiche macroeconomiche, e il sindacato, che contratta il livello dei salari in
relazione alle dinamiche della produttività. Il regime fordista entra in crisi alla fine degli anni ’60 del
secolo scorso, quando, in seguito all’aumento dei prezzi delle materie prime, il prototipo di welfare
state keynesiano che sostiene l’accumulazione fordista non può essere più sostenuto dal settore privato.
Il regime di accumulazione che si afferma nella fase successiva – correntemente indicato come postFordismo – è caratterizzato da un processo produttivo flessibile, basato sull’impiego di risorse umane e
macchinari impiegati in più linee produttive (che genera le cosiddette economie di scopo), sulla
diversificazione della produzione e del consumo, e su forme di regolazione decentrate a livello locale,
espressione di interessi particolaristici. (Cfr. B. Jessop, Post-Fordism and the State, in A. Amin (a cura
di), Post-Fordism. A Reader, Blackwell, Oxford, 1994.)
23
La discussione dell’impostazione orientalistica nello studio delle trasformazioni
sociali ed economiche è l’obiettivo di questo scritto. Ci si concentra in particolare sulla
controversa questione dello sviluppo capitalistico dell’India, ossia sulla discussione che
ha riguardato, da un lato, il livello e le forme di penetrazione del modo di produzione
capitalistico nell’economia indiana e, dall’altro, l’impatto che la transizione al
capitalismo ha esercitato sugli equilibri sociali e politici. La tesi che si sostiene è: i) che
vi sia stato un ritardo nella comprensione della transizione al capitalismo dell’economia
indiana; ii) che questo ritardo sia imputabile al confronto che gli analisti fanno del caso
indiano con altre esperienze di sviluppo; e che tale confronto abbia portato a
diagnosticare l’immobilismo della società indiana, imputandolo a fattori «culturali»; e
iii) che il ritardo di comprensione della transizione capitalistica in India si sia tradotto
nella difficoltà di cogliere appieno i caratteri del capitalismo indiano, in particolare nel
contesto della ristrutturazione indotta dalla crisi del Fordismo nella seconda metà del
’900.
Si comincia discutendo le ipotesi sulle quali la visione economico-orientalistica è
basata e l’interpretazione che essa produce della trasformazione capitalistica in India.
Viene considerato in particolare l’approccio marxista, che indaga i caratteri della
transizione al capitalismo; ci si sofferma poi sul concetto di «sviluppo economico
moderno» poiché esso costituisce il termine di confronto obbligato per valutare la
performance economica dell’India negli anni della sua Indipendenza. Successivamente
si mostra come l’enfasi sullo sviluppo economico moderno porta a misinterpretare le
specificità dell’organizzazione sociale e produttiva indiana e a sottovalutarne il ruolo nel
processo di sviluppo. Infine, si ragiona sulla natura del capitalismo indiano ed in
particolare sulla funzionalità delle caratteristiche istituzionali della società e
dell’economia per lo sviluppo del mercato.
L’India pre-coloniale e il modo di produzione asiatico
Uno dei pilastri dell’Orientalismo economico è rappresentato dalla costruzione teorica
nota come «modo di produzione asiatico». Questa costruzione è stata al centro del
dibattito sulle forme economiche pre-capitaliste tra studiosi in prevalenza marxisti (ma
non solo) e, sebbene non vi sia un’opinione concorde fra gli studiosi sull’esatto pensiero
di Marx ed Engels sull’Asia e sulle forme di produzione là prevalenti nei secoli
precedenti l’avvento del capitalismo37, è indubbio che lo sviluppo del concetto di modo
37
Ad esempio, Gianni Sofri, che ha studiato con particolare attenzione la questione, afferma che
non è neppure chiaro il ruolo che il modo di produzione asiatico, e più in generale la riflessione
sull’Asia, riveste nell’elaborazione di Marx nel Capitale. Si veda in proposito G. Sofri, Il modo di
24
di produzione asiatico parta dagli scritti dei padri del marxismo, ed in particolare di
Marx.
Marx cominciò ad interessarsi all’India nel suo ruolo di corrispondente da Londra
del New York Daily Tribune nel corso degli anni ’50 dell’’800, durante i quali seguiva
da vicino l’evoluzione delle vicende dell’occupazione britannica dell’India38. Tuttavia,
le sue convinzioni sull’Asia erano basate sul patrimonio di conoscenza, generale e
specifica39, al tempo disponibile, sul quale si innestavano le informazioni che
raccoglieva nel suo ruolo di giornalista. Inoltre, la cornice concettuale all’interno della
quale si muoveva nella sua elaborazione sull’Oriente era costituita dall’analisi di Hegel,
il quale, a sua volta, poggiava le sue riflessioni sulle conoscenze e sulle opinioni del
tempo. In altri termini, in una prima fase, l’elaborazione di Marx sull’India non
conteneva alcun elemento di originalità, limitandosi a riflettere l’opinione convenzionale
sull’argomento. Condivideva, così, le principali opinioni orientaliste dell’epoca: l’Asia
(e l’India) era il regno del dispotismo e della schiavitù, della stazionarietà dei rapporti
sociali e della stagnazione dell’economia, della rigida divisione del lavoro definita dal
sistema delle caste, il quale era una costruzione culturale, prima ancora che sociale40.
Quando l’interesse per l’osservazione dei processi economici divenne dominante
rispetto all’analisi di tipo culturale, l’elaborazione di Marx (e di Engels) si affinò e si
differenziò progressivamente da quella di Hegel. Ciò non implicò un radicale
ribaltamento della posizione sostanzialmente orientalista, quanto piuttosto un
arricchimento della stessa con osservazioni che si riferivano esplicitamente ai rapporti di
produzione. Così, l’accento venne posto sulla stagnazione di paesi che per «migliaia di
anni non hanno fatto progressi»41, stagnazione che era direttamente ricondotta al tipo di
organizzazione sociale ed economica prevalente. Responsabili dell’immobilismo e
dell’assenza di progresso dell’India erano il sistema delle caste – che era considerato un
potente fattore di «cristallizzazione» sociale – e il sistema di villaggio – che, per
conseguenza della sovrapposizione fra industria ed agricoltura nelle stesse unità
produzione asiatico. Storia di una controversia marxista, PBE, Einaudi, Torino, 1969-73, alle pagine
14 e 15. Un’altra analisi – ben fatta, anche se meno ampia e approfondita del lavoro di Sofri – del
concetto di modo di produzione asiatico è rintracciabile in Daniel Thorner, Marx on India and the
Asiatic Mode of Production, in Contributions to Indian Sociology, IX, dicembre 1966 (ristampato in
The Shaping of Modern India, a cura di Alice Thorner, Allied, New Delhi, 1980).
38
Per le edizioni italiane degli scritti di Marx sull’India si rimanda a Karl Marx e Friedrich
Engels, India, Cina, Russia (a cura e traduzione dagli originali di Bruno Maffi), Il Saggiatore, Milano
1960 [ed edizioni successive], e a Karl Marx, India, Roma, Editori riuniti 1993.
39
Come uomo colto del suo tempo, certamente Marx era familiare con i resoconti di viaggi in
India e con le prime elaborazioni orientaliste commentate nella prima parte di questo capitolo.
40
Per una puntuale ricostruzione del rapporto fra la visione di Hegel e quella di Marx cfr. Sofri,
Il modo di produzione asiatico, cit.,.
41
D. Thorner, Marx on India, cit, p. 355.
25
produttive, determinava l’autosufficienza delle comunità locali e, grazie ad essa,
consentiva l’isolamento economico, sia a livello locale sia a livello nazionale. Come
documenta Daniel Thorner42, per Marx i villaggi indiani erano delle «forme primitive
stereotipate» che non avevano nulla di idilliaco e che erano «contaminate dalle
distinzioni di casta e dalla schiavitù», le quali definivano una rigida divisione sociale del
lavoro43 che costituiva un solido fondamento per il dispotismo orientale44. In aggiunta,
un ruolo importante nell’immobilismo della società indiana era giocato anche
dall’assenza della proprietà privata della terra.
Questi tre fattori di immobilismo – le caste, il sistema di villaggio, e l’assenza di
proprietà privata – divennero il nucleo concettuale per identificare le comunità asiatiche
«primitive», che Marx considerava particolarmente resistenti al cambiamento. Per
questo motivo, quando cominciò a studiare le forme economiche pre-capitalistiche,
Marx collocò la comunità orientale al primo posto nella gerarchia delle organizzazioni
sociali antiche: una forma di organizzazione sociale che, per l’assenza della proprietà
privata, per il forte legame con la campagna e per il peso della comunità, fu definita
come «primitiva» in contrapposizione alle forme organizzative dei Greci e dei Romani
(in cui la base della società erano l’individuo e il nucleo familiare) che erano considerate
come «secondarie»45. Il «modo di produzione asiatico» – ossia l’insieme dei rapporti di
produzione osservati nelle comunità orientali – divenne quindi sinonimo di
un’organizzazione sociale e produttiva cristallizzata, basata su di un equilibrio molto
stabile e capace di sfuggire ad ogni tipo di cambiamento. La condizione necessaria di
questo equilibrio era costituita dall’autosufficienza della comunità nella produzione di
alimenti, di beni artigianali di consumo e di mezzi di produzione, autosufficienza che era
42
Ibid., pp. 355-357.
Secondo Marx, e secondo molti dei teorici dello sviluppo che hanno analizzato l’economia
indiana, la divisione del lavoro definita dal sistema castale era rigida poiché vincolava la posizione
sociale degli individui alla appartenenza castale e rendeva di fatto impraticabili i cambiamenti di status
e di ruolo, scoraggiando così qualunque iniziativa individuale – ad esempio l’imprenditorialità –
finalizzata al progresso economico e sociale.
44
Va ricordato, anche se solo rapidamente, che, in linea con la visione orientalistica dominante,
Marx riteneva che un elemento fondamentale dell’organizzazione sociale orientale fosse costituito dal
governo centrale. Una delle caratteristiche principali del governo centrale, che era funzionale
all’esercizio del già menzionato dispotismo, era quella di realizzare e gestire le grandi opere pubbliche
necessarie all’organizzazione economica, e tra queste in particolare le infrastrutture irrigue.
45
Marx identificò quattro modi di produzione attraverso i quali ritenne potesse essere ricostruita
l’evoluzione dell’organizzazione sociale ed economica: il modo di produzione asiatico, il modo di
produzione antico, il modo di produzione feudale e il modo di produzione capitalistico. Cfr. D.
Thorner, Marx on India, cit., pp. 368-370, e G. Sofri, Il modo di produzione asiatico, cit., pp. 39 e
seguenti.
26
43
considerata come garanzia di un isolamento dal resto del mondo destinato (in assenza di
shock esterni) a durare nei secoli.
La convinzione che il modo di produzione asiatico identificasse organizzazioni
sociali particolarmente arretrate, e soprattutto destinate ad un perenne immobilismo,
spiega l’atteggiamento di Marx nei confronti della colonizzazione inglese. Sebbene i
termini drammatici della colonizzazione dell’India gli fossero completamente noti46,
Marx affidava alla Gran Bretagna la «doppia missione» di «demolire l’antica società
asiatica e gettare le basi materiali della società occidentale in Asia». Per Marx, i
maggiori veicoli della trasformazione economica erano la diffusione dell’industria e la
costruzione delle grandi infrastrutture di trasporto, le quali sarebbero state capaci di
rompere gli equilibri del sistema autosufficiente dell’economia di villaggio e di spezzare
l’isolamento che garantiva la cristallizzazione dei rapporti sociali indotta dall’esistenza
delle caste. In altri termini, la colonizzazione inglese era considerata come un potente
fattore di cambiamento – ancorché doloroso – capace di creare le condizioni per il
superamento del modo di produzione asiatico e di introdurre il capitalismo in India.
Divenuta familiare grazie alla dominazione inglese, la divisione del lavoro definita
dall’industria sarebbe stata in grado di liquidare la tradizionale divisione del lavoro
basata sul sistema castale, che Marx considerava «un ostacolo fatale» al progresso
dell’India.
I valori tradizionali dell’India
Ma la convinzione che l’India pre-coloniale fosse dominata da un’organizzazione
sociale e produttiva che inibiva il cambiamento e il progresso economico, ossia la
convinzione che i valori (e le istituzioni) tradizionali fossero responsabili
dell’immobilismo economico dell’India, era radicata anche nel pensiero di una vasta
gamma di analisti dell’economia e della società che non condividevano l’impostazione
marxista. Come acutamente osserva Sanjay Subrahmanyan47, una lunga teoria di
eminenti studiosi, a partire da Max Weber, sottolinea che l’Asia (e dunque l’India) è il
regno dell’irrazionalità e della tradizione, «un altro mondo» rispetto all’Occidente dove
46
Come documenta un articolo per il New York Daily Tribune sulla Dominazione britannica in
India citato da G. Sofri, Il modo di produzione, cit., pp. 32 e 33.
47
In Institutions, agency and economic change in South Asia, pubblicato in Institutions and
Economic Change in South Asia, a cura di B. Stein e S. Subrahmanyan, Oxford University Press, Delhi,
1996, pp. 22 e seguenti.
27
invece regna la razionalità e dove vive l’«uomo economico»48. Per Weber, è la religione
dell’India, che considera la contemplazione e l’astrazione49 come obiettivi della vita
umana, a rendere poco attraente per la popolazione indiana la produzione di merci; ed è
il sistema castale stesso, impregnato com’è del concetto di gerarchia, ad apparire
estraneo al principio dell’azione individuale che caratterizza la società occidentale, e a
cui si deve la rivoluzione industriale50.
La costruzione weberiana aggiunge, così, un altro elemento all’edificio
orientalista nell’analisi dell’organizzazione socio-economica indiana. Il sistema castale è
letto in duplice prospettiva: non è soltanto un sistema di relazioni che definisce una
forma di divisione del lavoro cristallizzata, cui l’organizzazione sociale deve adeguarsi,
ma è anche, e soprattutto, un sistema di valori – una costruzione intellettuale – che,
qualora venga accettato e condiviso, rende l’idea di progresso economico improponibile.
In altri termini, le caste non solo delineano un’organizzazione sociale che è basata su
una divisione dei compiti e dei ruoli funzionale alla riproduzione di una società statica e
autosufficiente, ma definiscono anche un apparato istituzionale – derivato da un sistema
di valori – che fa sì che questa divisione del lavoro sia accettata universalmente e che
non esistano possibilità di fuga verso sistemi di valori (e organizzazioni sociali)
alternativi.
Con questi contenuti, l’impalcatura concettuale dell’Orientalismo economico
domina lo studio delle prospettive di sviluppo dell’India durante i primi decenni
dell’Indipendenza. Il sistema castale e il rituale ad esso collegato sono al centro di una
scena di immobilismo e di stagnazione. La responsabilità delle caste (e dell’Induismo)
per il mancato sviluppo economico dell’India è diagnosticata in modo concorde sia da
studiosi occidentali sia da analisti indiani. Tra i primi, spiccano in particolare Gunnar
Myrdal e Immanuel Wallerstein, i quali in lavori di ampio respiro ripropongono
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle di Weber. Gunnar Myrdal, in Asian
Drama attribuisce al sistema castale, congiuntamente alle particolari caratteristiche dello
Mentre in Asia (anzi in India) vive l’homo hierarchicus (cfr. Luis Dumont, Homo
Hierarchicus, cit.).
49
Come puntualmente osserva André Béteille, la leggenda della spiritualità indiana è un altro
pezzo importante della costruzione orientalista (cfr. Caste in Contemporary India in Caste Today a
cura di C.J. Fuller, Oxford University Press, Delhi, 1996).
50
Va sottolineato che per Weber il sistema castale non è di per sé in contraddizione con la
divisione del lavoro alla base del sistema di fabbrica introdotto dal capitalismo; ciò che inibisce la
formazione di un capitalismo endogeno, capace di trasformare l’Asia del Sud da economia agricola ad
economia industriale, è piuttosto il rituale indù che ostacola fenomeni come l’apprendistato e la
partecipazione al mercato, che sono all’origine dell’imprenditorialità. Cfr. D.N. Gellner, Max Weber
and the Religion of India, in DN. Gellmner, The Antropology of Buddism and Hinduism. Weberian
Themes, Oxford University Press, Oxford, 2001.
28
48
Stato, il fallimento economico indiano51, mentre Wallerstein nella sua analisi dei «world
systems» sottolinea il carattere stagnante dell’economia indiana tradizionale nella fase
che precede il colonialismo, prima cioè che il subcontinente sia «incorporato» nel
capitalismo mondiale52. Ma l’analisi orientalista degli studiosi indiani si spinge ancora
più a fondo. L’economista Deepak Lal afferma che il sistema castale, mentre appare
come una istituzione funzionale ed efficiente nell’economia di villaggio, diventa un
ostacolo al cambiamento non appena l’India entra in contatto con il capitalismo poiché
definisce un «equilibrio» basato su un sistema di valori a cui il profitto è sostanzialmente
estraneo. Secondo Deepak Lal, dunque, il sistema castale definisce delle condizioni di
stazionarietà – il cosiddetto «equilibrio indù» – che spiegherebbero l’assenza di
crescita53. Una conclusione analoga è raggiunta da Raj Krishna con la teorizzazione del
«tasso di crescita indù», ossia di un tasso di crescita che non può superare un certo
(basso) livello perché vincolato dall’organizzazione sociale derivata dall’Induismo.
L’immagine dell’India che ci viene consegnata dall’analisi economica è dunque
quella di una economia stagnante, imprigionata nella tradizione e nei valori che essa
esprime, primo fra tutti il sistema castale. Così, il fallimento dell’industrializzazione, e
più in generale della crescita, è imputato a fattori che poco o nulla hanno a che vedere
con la struttura e il funzionamento del sistema economico: è cioè un «fallimento
culturale». Non vi è spiegazione di questo fallimento se non quella, sostanzialmente
circolare, che afferma che l’economia indiana è stagnante perché i valori e le istituzioni
indiane definiscono una struttura produttiva predestinata alla stagnazione. Ma vi è di più.
Non solo l’organizzazione sociale e produttiva indiana è strutturalmente immobile e
stagnante per i fattori culturali che abbiamo fin qui visto, e non solo è rimasta immobile
nei millenni precedenti il contatto con gli occidentali nella colonizzazione; ma anche
quando questo contatto si è avuto, quando cioè la società indiana ha cominciato ad avere
rapporti con il capitalismo, i vincoli culturali hanno continuato ad operare, impedendo (o
rallentando) le trasformazioni strutturali necessarie alla crescita.
51
Cfr. G. Myrdal, The Asian Drama: an Inquiry Into the Poverty of Nations, Penguin Press,
New York, 1968.
52
In particolare Wallerstein afferma che fino al 1600 l’economia dell’Asia del Sud è stata
sostanzialmente stagnante. E sostiene anche che le principali trasformazioni sociali ed economiche
avvengono tra il 1600 e il 1700, solo dopo la nascita e il rafforzamento dei legami fra l’area
dell’Oceano indiano e l’Europa. Cfr. I. Wallerstein, The Incorporation of India in the Capitalist WorldEconomy, in The Indian Ocean. Exploration and History, Commerce and Politics, a cura di S. Chandra,
Sage, Delhi,1987.
53
Cfr. Deepak Lal, The Hindu Equilibrium, vol. I, Cultural Stability and Economic Stagnation,
c.1500 BC-AD 1980, Oxford University Press, Oxford, 1988.
29
L’Orientalismo e lo sviluppo economico moderno
Per l’Orientalismo economico, la stagnazione dell’India tradizionale è dunque
imputabile al sistema di valori prodotto dall’Induismo il quale genera un’organizzazione
sociale ed economica scarsamente intaccabile dai processi di crescita e di
trasformazione. Ma qual è questa organizzazione sociale? E per quali motivi riesce ad
opporsi alla forza trasformatrice del capitalismo? La risposta economico-orientalista a
questi interrogativi fa riferimento alle «deviazioni» che si osservano nell’economia
tradizionale dell’India rispetto alla struttura sociale e produttiva propria dell’Occidente
capitalistico54.
Il primo indizio di arretratezza economica dell’India è l’assenza delle classi sociali
che invece costituiscono la base della stratificazione della società capitalistica.
L’assenza delle classi dipende, congiuntamente, da tre ordini di fattori: la non esistenza
della proprietà privata; lo stato di quasi-schiavitù di alcuni individui determinato
dall’ordine castale; l’organizzazione produttiva basata sull’economia di villaggio.
L’ordine castale nega la divisione in classi, imponendo invece un tipo di stratificazione
diverso che poggia sul sistema di valori espresso dalla religione. Tale forma di
stratificazione sociale è accettata universalmente proprio perché è ratificata dalla
religione; e trova un altro elemento di supporto nel sistema di villaggio che attribuisce
alle relazioni tra individui un carattere prettamente paternalistico. Infine, l’assenza della
proprietà privata concorre a sostenere l’ordine castale poiché esclude altri fattori di
differenziazione tra gli individui. Questa situazione contrasta con l’organizzazione della
società capitalistica in cui esiste la proprietà privata della ricchezza e la divisione in
classi è definita sulla base del controllo da parte delle singole categorie di individui sui
mezzi di produzione.
La società capitalistica è basata sulla divisione del lavoro definita sulla base delle
esigenze dell’accumulazione, che richiede un continuo aumento della produttività delle
risorse attraverso la specializzazione. La prima e basilare forma di divisione del lavoro è
quella che si osserva tra i settori e nello spazio: nel corso della trasformazione
capitalistica, l’attività agricola si separa progressivamente dalla manifattura, sia nell’uso
delle risorse umane, sia nell’occupazione degli spazi. L’industria si concentra
progressivamente nelle città, che diventano centri di produzione, oltre che centri di
commercio e di controllo politico-culturale. Viceversa, nella società orientale primitiva,
le città hanno prevalentemente un ruolo culturale e religioso, e l’attività produttiva – sia
per la produzione di alimenti e di materie prime, sia per la produzione di manufatti –
rimane localizzata nella campagna. A questa forma di divisione del lavoro territoriale e
54
Per discutere queste deviazioni viene qui utilizzata la classica analisi di M. Dobb, Studies in
the Development of Capitalism, Routledge & Kegan Paul, London, 1963.
30
settoriale si aggiunge la divisione sociale del lavoro. Mentre la divisione del lavoro tra i
settori, con la concentrazione dell’industria nelle città, consente l’introduzione del
sistema di fabbrica e, con esso, l’adozione delle innovazioni, la divisione sociale del
lavoro accentua la professionalità degli individui e consente l’aumento della produttività
delle risorse. Nella società capitalistica, dunque, la localizzazione della produzione e la
divisione del lavoro, tra settori e tra individui, rispondono ad esigenze maturate nella
sfera economica, e non alla necessità di ratificare socialmente una gerarchia definita su
base religiosa, come invece accade nella società orientale.
L’economia capitalistica è dinamica, mentre invece quella primitiva asiatica è
statica. Questa differenza si osserva a due livelli. Il primo è determinato
dall’introduzione della scienza nella produzione sotto forma di tecnologia. Il secondo è
rappresentato dagli spostamenti delle risorse. Si hanno spostamenti di risorse nello
spazio – di cui si è già detto commentando la separazione fra i settori – e spostamenti di
risorse all’interno dei settori. Gli spostamenti delle risorse fra i settori si osservano nei
processi di aumento della scala della produzione: nell’economia capitalistica la
produzione è concentrata in imprese sempre più grandi, cui corrisponde una progressiva
contrazione del numero delle imprese piccole a gestione familiare. Questi processi di
concentrazione attribuiscono un carattere dinamico alle varie forme di divisione del
lavoro su cui si basa il capitalismo, determinando una situazione che contrasta
nettamente con l’immobilismo di una divisione del lavoro su base religioso-gerarchica .
Gli spostamenti delle risorse nei settori e nello spazio sono alla base della
trasformazione capitalistica che ha come sbocco lo «sviluppo economico moderno»55.
Questa espressione identifica lo «stato» raggiunto da una economia che ha attraversato
con successo la «trasformazione strutturale», ossia che ha sperimentato un’ampia
ridefinizione degli equilibri fra i settori, raggiungendo in tutti un elevato livello di
produttività delle risorse. Il processo che guida la trasformazione strutturale è
l’industrializzazione, e lo sviluppo economico moderno è il prodotto delle
trasformazioni ad essa associate che hanno un impatto sia sull’organizzazione produttiva
sia sull’organizzazione sociale56. Protagonista del processo di industrializzazione è
l’impresa capitalistica, orientata all’aumento della produttività delle risorse attraverso
55
Simon Kuznets utilizza per primo questa espressione per descrivere la situazione dei paesi
industrializzati (cfr. S. Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread, Yale
University Press, New Haven, 1966); il lavoro di Kuznets ha fornito la base per l’analisi strutturalista
sviluppata da H. Chenery, S. Robinson e M. Syrquin nel famoso libro Industrialization and Growth,
Oxford University Press, New York, 1986.
56
Tra queste trasformazioni si ricordano in particolare: la contrazione del settore agricolo, la
crescita qualitativa e quantitativa delle città, il cambiamento dei modelli di consumo e la
modernizzazione della struttura sociale, la crescita dell’impiego dei prodotti intermedi nella produzione
di manufatti e di merci agricole, la crescita degli investimenti, la concentrazione dell’industria.
31
l’aumento della scala della produzione e l’inserimento del progresso tecnico. L’evidenza
empirica suggerisce che i processi alla base della trasformazione strutturale si osservano
con modalità che si ripetono regolarmente in ogni esperienza di industrializzazione. Essi
definiscono cioè un «paradigma» con cui le esperienze dei singoli paesi possono essere
confrontate. Così, il concetto di «sviluppo economico moderno» è definito sulla base
delle «regolarità» della crescita – ossia dell’insieme delle trasformazioni della struttura
economica osservate sistematicamente nelle diverse esperienze.
Le esperienze dei paesi che «arrivano prima» alla maturità industriale diventano
così il termine di confronto «naturale» per i paesi «che arrivano dopo». Nei suoi termini
generali, questo confronto prescinde dalle differenze culturali esistenti fra le due
situazioni e presuppone che la trasformazione della struttura economica possa riprodursi
nei tratti principali, malgrado i condizionamenti della sovrastruttura sociale e ideologica.
Ciò implica che si ipotizzi l’esistenza di un sentiero di trasformazione capitalistica che
costituisce il «modello» per le esperienze dei singoli paesi. Il confronto con questo
modello assume che: i) il successo della trasformazione capitalistica sia subordinato alla
presenza di particolari dinamiche economiche e sociali osservate nei paesi di prima
industrializzazione57; ii) che l’assenza di (alcuni di) questi processi – o la loro
incompletezza – comporti un giudizio negativo sulla performance economica; e iii) che,
a seconda del tipo e del numero di «deviazioni», questo giudizio possa indicare o
l’immobilismo o diversi gradi di arretratezza. Si tratta comunque sempre – è il caso di
sottolinearlo qui con forza – di un giudizio «relativo» basato su di modello costruito su
di un numero limitato di esperienze specifiche, le quali sono avvenute in condizioni di
tempo e di spazio sostanzialmente irripetibili, in paesi caratterizzati da strutture sociali
molto distanti.
La conclusione di questo discorso è che l’affermazione che un paese è immobile o
stagnante è di regola il prodotto di un confronto con una situazione che è l’esito di un
processo di sviluppo e di cambiamento spesso non esportabile al di fuori del contesto in
cui viene inizialmente osservato. La convinzione – ripetutamente espressa con
riferimento ai paesi del subcontinente indiano – che un’economia sia immobile o
stagnante, o anche semplicemente arretrata, dipende dunque dal termine di confronto
che si è individuato, il quale «per costruzione» è definito come dinamico e sviluppato. Si
tratta certamente di un giudizio affrettato, oltre che superficiale, che non tiene conto dei
condizionamenti della struttura sociale che spesso rendono improponibili i cambiamenti
ricercati, nei tempi e nei modi considerati «normali».
57
Tra queste in particolare vanno sottolineate: il superamento delle relazioni di produzione precapitalistiche, la formazione delle classi sociali e la modernizzazione della struttura sociale, la crescita
e la concentrazione dell’industria; la contrazione e la modernizzazione dell’agricoltura; la contrazione
del settore informale; la formazione dei mercati dei fattori e dei prodotti (compreso il mercato del
lavoro); l’apertura agli scambi.
32
Il peccato originale dell’analisi economico-orientalista dell’India è dunque quello
di avere giudicato immobile e stagnante un’economia in cui non si osservavano i
processi di cambiamento paradigmatici e di avere considerato come replicabile nel caso
del subcontinente indiano lo stesso percorso di sviluppo sperimentato dai paesi europei
di prima industrializzazione. Ma qual è il sentiero di sviluppo effettivamente seguito
dall’economia indiana? È vero, come dicono Marx e Wallerstein e un vasto numero di
studiosi, che l’India è stata immobile per migliaia di anni prima di entrare in contatto
con l’Occidente con il processo di colonizzazione? Quali sono le caratteristiche
economiche e sociali che rendono «anomalo» lo sviluppo economico indiano? E infine è
corretto sostenere che il sistema castale e, più in generale, la struttura sociale indiana
abbia bloccato il processo di sviluppo?
Processi di cambiamento nell’India pre-coloniale
La ricerca degli ultimi due decenni ha dimostrato che molte delle affermazioni
dell’Orientalismo economico non trovano fondamento né nella storia né nella realtà
attuale del subcontinente indiano. Gli storici dell’India pre-coloniale hanno raggiunto
due conclusioni di primaria importanza per il nostro discorso, e cioè: i) che nella fase
precedente la colonizzazione, in particolare nel corso del ’600 e del ’700, la struttura
economica indiana era tutt’altro che immobile e stagnante; e ii) che nell’organizzazione
dell’economia e nella società si osservavano dei processi di cambiamento in molti casi
strutturalmente diversi da quelli registrati nei paesi europei nella fase pre-capitalistica58.
Innanzitutto, sono state messe in discussione le convinzioni consolidate in merito
alla base dell’economia dell’India tradizionale, e cioè il sistema di villaggio. Dai lavori
degli storici è emerso che l’economia di villaggio non era uniformemente basata sul
58
La letteratura su questo punto è abbondante. Per alcune riflessioni di ordine generale, si
vedano: B. Stein e S. Subrahmanyan, Introduction, in Institutions and Economic Change in South Asia,
a cura di B. Stein e S. Subrahmanyan, Oxford University Press, Delhi, 1996; C.J. Baker, An Indian
Rural Economy 1880-1955, Clarendon Press, 1984; M. Torri, Storia dell’India, cit.. Su aspetti specifici
più specifici vedano anche: M.H. Gopal, Tipu Sultan's Mysore. An Economic Study, Popular Prakashan,
Bombay 1971; Asok Sen, A Pre-British Economic Formation in India of the Late Eighteenth Century:
Tipu Sultan's Mysore, in Barun De (a cura di) Perspectives in Social Sciences I. Historical Dimensions,
Oxford University Press, Oxford, 1977 M. Torri, In the Deep Blue Sea: Surat and its merchant class
during the dyarchic era (1759-1800), in «The Indian Economic and Social History Review», Vol. XIX,
nn. 3-4, 1982, pp. 267-299; id., The Hindu Bankers of Surat and their business world in the second half
of the 18th century, in "Modern Asian Studies" 25, 2, 1991, pp. 367-401. Per un inquadramento di
ordine geneale si veda A.G. Frank, ReOrient. Global Economy in the Asian Age, University of
California Press, Berkeley, 1998.
33
rapporto paternalistico descritto con il nome di «jajmani», all’interno del quale la
divisione del lavoro era imposta dal sistema castale; è stato dimostrato invece che, in
molti contesti, le transazioni economiche passavano per il mercato. Questo si verificava
nel caso dei rapporti di lavoro, in cui sia l’allocazione del lavoro sia il pagamento per le
prestazioni tenevano conto delle caratteristiche degli individui e dei lavori prestati,
seguendo una logica razionale ed efficientistica. Si è osservato anche che la penetrazione
del mercato nelle transazioni economiche si estendeva alle modalità seguite per il
pagamento delle prestazioni; in particolare, è stata documentata la pratica diffusa di
pagare il lavoro in termini monetari o con quote di prodotto che non erano consumate
direttamente dai lavoratori, ma vendute o scambiate nel mercato con l’obiettivo di
procurare gli alimenti per la famiglia. In altri termini, l’approvvigionamento alimentare
richiedeva l’esistenza del mercato. Un’ultima caratteristica del sistema di villaggio che è
stata confutata riguarda la localizzazione della produzione. Contrariamente alle ipotesi
orientaliste, la ricerca ha dimostrato che la produzione di manufatti non era localizzata
esclusivamente nelle campagne, all’interno delle unità produttive del villaggio; al
contrario erano frequenti i casi di artigiani che lavoravano nelle città, le quali erano
centri che assumevano un ruolo economico primario come luoghi di produzione e
scambio di beni consumo.
Un’altra radicata convinzione dell’Orientalismo messa in discussione riguarda
l’assenza di differenziazioni di tipo economico fra gli individui. Gli storici hanno
dimostrato sia l’ampia stratificazione sociale sia l’esistenza di classi sociali definite sulla
base del controllo della ricchezza e del ruolo degli individui nell’organizzazione
dell’economia. Esisteva una classe di «imprenditori» (che possiamo oggi considerare
particolarmente
«moderni»)
che
realizzava
investimenti
di
capitali,
contemporaneamente, nella produzione agricola e nella manifattura, differenziando le
attività sulla base del rischio. A questa classe imprenditoriale, si aggiungeva poi uno
strato di agricoltori ricchi e di classi medie; queste ultime costituivano una specie di
«piccola borghesia» impegnata nella produzione artigianale o nella produzione agricola
all’interno di aziende a gestione familiare. Anche la classe dei mercanti aveva una
configurazione sostanzialmente diversa da quella che ci è consegnata dalla letteratura
orientalista: si è registrato il caso – tutt’altro che infrequente – di mercanti che
investivano nella produzione di alimenti con l’obiettivo di disporre di merce da
commercializzare nel medio e lungo periodo.
È poi interessante notare che l’organizzazione dell’economia e della società
indiana nella fase pre-coloniale si distaccava da quella osservata nei paesi europei nella
fase pre-capitalistica per almeno due aspetti «strutturali». Questi aspetti, che ricoprono
una primaria importanza nello sviluppo successivo del subcontinente, giustificano
34
l’opinione diffusa59 che il colonialismo non sia stata l’unica differenza importante nella
storia economica dell’Asia del Sud e dell’Occidente. Il primo riguarda la scarsità
relativa della manodopera, in particolare di quella agricola. La ricerca storica sottolinea
il peso di questo vincolo e documenta azioni di limitazione della mobilità dei lavoratori
tra le varie terre che includevano anche investimenti in infrastrutture mirati a migliorare
le condizioni di vita dei coltivatori e ad aumentare l’efficienza del sistema. La scarsità
relativa di manodopera evidenzia come la contrazione dell’occupazione agricola non
fosse una strategia idonea per aumentare la produttività delle risorse nell’economia
indiana, e marca una differenza tutt’altro che marginale con il modello europeo in cui
l’esodo agricolo è il fattore principale della crescita capitalistica, nell’agricoltura come
nell’industria.
Il secondo aspetto riguarda il ruolo dello Stato. La ricerca storica recente ha
sottolineato la forte presenza dello Stato nell’economia indiana pre-coloniale che è stata
dedotta dagli elevati investimenti in infrastrutture irrigue – necessarie per l’attività
agricola nelle zone aride – che solo entità statali erano in condizioni di realizzare. Non si
trattava però di uno Stato centrale dispotico, come sostenuto dai pensatori orientalisti; si
trattava invece di uno Stato fortemente ramificato e sparso, che esercitava un forte
controllo a livello politico locale60.
La ricerca storica ha dunque individuato anche nell’India pre-coloniale la
presenza dei due processi di base del modo capitalistico di produzione, ossia i) la
differenziazione sociale – che è dimostrata dall’esistenza di una classe di imprenditori
capaci di trovare occasioni di investimento in più settori, cui si aggiungeva un ampio e
diversificato strato di piccola borghesia – e ii) l’accumulazione di capitale – che
59
C.J. Baker, An Indian Rural Economy 1880-1955, cit..
60 In altre parole, almeno nel periodo moghul e nel ’700, non sembra esserci stato un intervento
centralizzato da parte dello stato nell’economia, bensì l’intervento da parte dei singoli membri della
classe dirigente, dai monarchi ai grandi nobili. Il sovvenzionare una serie di attività giudicate
socialmente utili era visto sia come parte dei doveri del monarca (che era tenuto ad agire come «madre
e padre» dei suoi sudditi) e del grande nobile, sia come una manifestazione di potere. Le attività
socialmente utili patrocinate dai monarchi e dalla nobiltà andavano dal supporto dei templi e delle
scuole religiose (in genere del tutto indipendentemente dal fatto che tali templi e scuole appartenessero
alla stessa religione del patrono) agli investimenti in pozzi, canali, alberazione di strade e costruzione
di caravanserragli. Vale la pena di ricordare che templi e scuole religiose avevano una funzione anche
di carattere economico. Alle une ed alle altre erano in genere legati mercati, mentre soprattutto i templi
agivano anche come imprenditori agricoli. Sul ruolo della nobiltà moghul e degli stati successori
dell’impero moghul si vedano, ad esempio, C.A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazaars, North Indian
society in the age of British expansion, 1770-1870, Cambridge University Press, Cambridge 1983 [ed
edizioni succ.] e id., Indian Society and the Making of the British Empire (vol II, 1 di The New
Cambridge History of India), Cambridge University Press, Cambridge 1988. Sul ruolo della nobiltà
maratha si veda Stewart Gordon, The Marathas 1600-1818 (vol II, 4 di The New Cambridge History of
India), Cambridge University Press, Cambridge 1993.
35
avveniva per opera di queste classi imprenditoriali ed era agevolata dalla creazione di
infrastrutture per la produzione da parte delle élite politiche e nobiliari. Ciò suggerisce
che l’economia e la società dell’India nella fase pre-coloniale erano attraversate da
processi il cui sbocco prevedibile sarebbe stato la trasformazione capitalistica, seppure
con alcuni caratteri contrastanti con la strada percorsa dai paesi europei. La dominazione
inglese bloccò questa trasformazione e cristallizzò la situazione indiana negli equilibri
produttivi e sociali osservati alla fine del ’700 (perché quella struttura era funzionale ai
«bisogni» del colonizzatore). Ciò spiega la stagnazione del secolo successivo che si
registra nell’industria ed in particolare nell’agricoltura. Solo alla fine dell’’800
l’economia indiana ricominciava a mostrare dei deboli segni di crescita con una serie di
investimenti, finanziati congiuntamente con capitale indiano e capitale britannico,
nell’industria tessile e meccanica, concentrati in alcune, ristrette, aree del paese61.
Stagnazione e cambiamento in cinquanta anni di indipendenza indiana
Quando ha conquistato l’indipendenza politica, l’India era un paese molto povero, con
una struttura economica arretrata62 ed un ampio numero di problemi sociali, identificati
da Jawaharlal Nehru in «povertà, ignoranza e malattia e disuguaglianza di
opportunità»63. La storia recente è una storia di gravi fallimenti e ancora oggi, dopo oltre
cinquanta anni di indipendenza, l’India deve confrontarsi con povertà e disuguaglianza
diffuse64.
Questa situazione è stata frequentemente imputata al basso livello di efficienza
dell’economia, responsabile di comprimere il tasso di crescita e di determinare una
prolungata stagnazione. Secondo alcuni influenti studiosi65, l’inefficienza della struttura
produttiva dell’India indipendente sarebbe stata determinata dai «controlli pubblici» che
avrebbero distorto l’uso e la distribuzione delle risorse tra le diverse attività.
Cfr. M.Torri, Storia dell’India, cit.
La quota agricola sul PIL era pari al 49%, quella dell’industria intorno al 17%, quella dei
servizi e delle costruzioni intorno al 34%. Le quote relative all’occupazione erano rispettivamente il
71,8%, il 9,5% e il 18,7% (cfr. Sudip Chauduri, Debates on Industrialization, in The Indian Economy.
Major Debates Since Independence, a cura di T.J. Byres, Oxford University Press, Delhi, 1998).
63
Citato da Amartya Sen in Radical Needs and Moderate Reforms, in Indian Development.
Selected Regional Perspectives, a cura di J. Drèze e A. Sen, Oxford University Press, Delhi, 1998, p. 5.
64
A. Sen, Radical Needs and Moderate Reforms, cit.
65
Cfr. V. Joshi e I.M.D. Little, India. Macroeconomics and Political Economy 1964-1991,
Oxford University Press, Delhi, 1998 p. 350. Si veda anche J.N. Bhagwati, India in Transition: Freeing
the Economy, Clarendon Press, Oxford, 1993.
36
61
62
L’intervento pubblico66 avrebbe cioè la responsabilità di avere cristallizzato gli equilibri
socio-economici dell’India post-coloniale, ostacolando il libero gioco delle forze di
mercato e, con esse, la crescita. Questa convinzione, piuttosto consolidata tra gli studiosi
e le élite indiane, ha ispirato la politica di liberalizzazione inaugurata nel 1991, la quale
si proponeva di rimuovere gli ostacoli alla libera iniziativa e di transitare l’India al
mercato. Tuttavia, dopo oltre un decennio di liberalizzazione, l’economia indiana
continua a mostrare segni di costante peggioramento, com’è evidenziato dai più comuni
indicatori di progresso economico e civile67. Questa performance di basso profilo, anche
dopo l’apertura dell’economia, solleva più di un dubbio sulla fondatezza della diagnosi
liberista e suggerisce l’opportunità di ricercare altrove le cause della persistenza della
povertà e del sottosviluppo del paese.
Vi sono molte ragioni per ritenere che la persistenza della povertà e della
disuguaglianza nell’India contemporanea, insieme al peggioramento diffuso delle
condizioni di vita osservate nell’ultimo decennio, debba essere imputata non tanto alla
stagnazione dell’economia negli anni della pianificazione, quanto piuttosto al particolare
modello di sviluppo capitalistico che si è andato affermando nel paese dalla fine della
colonizzazione in poi. In particolare sembra evidente che, nella seconda metà del ’900,
l’economia indiana non sia stata immobile e cristallizzata sotto i controlli statali, ma che
abbia subito una serie di trasformazioni che ne hanno alterato gli equilibri sociali in
profondità e che hanno determinato l’aggravamento della povertà e della disuguaglianza.
Queste trasformazioni, che sono insufficientemente riflesse negli indicatori aggregati
utilizzati nelle analisi macroeconomiche, si osservano in particolare con riferimento
all’organizzazione produttiva a livello locale.
Se si ricompone in linee estremamente generali, sulla base della letteratura
economica più recente68, il quadro dello sviluppo indiano nella seconda metà del secolo
scorso, si può vedere come l’intervento pubblico sia stato fin dai primi anni la
componente di gran lunga più dinamica dell’economia e abbia costituito la voce più
importante della domanda aggregata. Questa caratteristica dà ragione della convinzione
diffusa che la prolungata fase di stagnazione attraversata dal settore industriale, a partire
Che era stato inizialmente disegnato con l’obiettivo di indirizzare lo sviluppo dell’economia
in modo da impedire la concentrazione della ricchezza in mano a pochi e di promuovere lo sviluppo
equilibrato delle diverse attività, e che era accettato da un vasto numero di capitalisti indiani come
supporto all’iniziativa privata (cfr. Sudip Chauduri, Debates on Industrialisation, cit.).
67
Cfr. M. Torri, Corruzione, oscurantismo e globalizzazione dell’India del BJP, in Asia Major
2001, Il Mulino, Bologna.
68
Cfr. T.J. Byres, Introduction: Development Planning and the Interventionist State versus
Liberalisation and the Neo-Liberal State, e I.J. Ahluwalia, The Contribution of Planning to Indian
Industrialisation, entrambi in The State, Development Planning and Liberalisation in India, a cura di
T.J. Byres, Oxford University Press, 1997. Si vedano anche i saggi contenuti nel volume a cura di T.J.
Byres, The Indian Economy. Major Debates Since Independence, cit.
37
66
dalla seconda metà degli anni ’60 del ’900 e fino alla metà degli anni ’70, sia imputabile
alla contrazione degli investimenti pubblici, che ha influito negativamente sul mercato
dei beni capitali69. Questa contrazione mette a nudo una debolezza strutturale
dell’economia indiana che è correntemente ritenuta essere il principale fattore
responsabile della stagnazione, ossia l’insufficienza della domanda interna. Nei suoi
aspetti essenziali, l’insufficienza della domanda interna indica una crescita ridotta dei
consumi rispetto alla produzione, nelle due componenti di prodotti finali (destinati alle
famiglie) e di beni intermedi e capitali (acquistati dalle imprese). L’insufficienza
strutturale della domanda (privata) interna è un indicatore importante di squilibri nel
sistema economico, che porta al centro dell’attenzione questioni cruciali come quella del
trade-off tra equità ed efficienza nel processo di crescita e della distribuzione dei
benefici della crescita fra i diversi strati sociali e fra campagna e città.
Fin dai primi anni dell’indipendenza, l’importanza dell’agricoltura in termini di
valore aggiunto e di occupazione contrastava con l’arretratezza in cui versavano le aree
rurali70. Si trattava di una arretratezza multidimensionale, che si osservava nelle
condizioni di vita delle vaste masse di lavoratori occupati nel settore, nei rapporti
istituzionali tra terra e lavoro, nelle tecniche impiegate per la produzione 71. La
modernizzazione appariva la strada obbligata per consentire al settore agricolo di
partecipare al progresso dell’India con tutte le sue potenzialità. La scelta fu iniziare il
processo dalla modernizzazione tecnologica, nella duplice convinzione che l’arretratezza
delle tecniche fosse responsabile del basso livello di produttività delle risorse e che la
69
Sudip Chauduri, Debates on Industrialization, cit..
Lo sviluppo agricolo nella fase post-coloniale è analizzato in J.Mohan Rao, Agricultural
Development under State Planning e U. Patnaik, India’s Agricultural Development in the Light of
Historical Experience, entrambi in The State, Development Planning and Liberalisation in India, a cura
di T.J. Byres, cit.. Si veda anche J.Mohan Rao e Servaas Storm, Distribution and Growth in Indian
Agriculture, in The Indian Economy. Major Debates Since Independence, a cura di T.J. Byres, cit..
71
L’arretratezza sociale ed istituzionale del mondo rurale è ben documentata dall’importante
dibattito sul «modo di produzione in India» – ospitato dalla fine degli anni ’60 alla metà degli anni ’70
del secolo scorso sulle pagine di «Economic and Political Weekly» e di altre riviste indiane – che si
interrogava sul livello e le forme di penetrazione del capitalismo nelle campagne indiane. La
discussione, tra i molti ed autorevoli partecipanti, echeggiava i toni orientalisti dell’analisi marxista. Il
nucleo della discussione riguardava la composizione di classe della società indiana e lo sforzo
maggiore consisteva nell’accomodare la stratificazione definita dal sistema di casta all’interno di quella
in classi definita dall’analisi marxista. Il tentativo era quello di localizzare nelle aree rurali le categorie
sociali che nell’esperienza inglese avevano innescato il processo di accumulazione primitiva, creando
le condizioni per la transizione al capitalismo. Per un resoconto si vedano A. Thorner, Semi-Feudalism
or Capitalism? Contemporary Debate on Classes and Modes of Production in India, in Economic and
Political Weekly, numeri 4, 11, 18, 1982, e J. Harriss, The Mode of Production Controversy: Themes
and Problems of the Debate, in Approaches to Development Studies: Essays in honour of Athole
Mackintosh, Gower, Aldershot, 1982.
38
70
modernizzazione istituzionale e sociale seguisse spontaneamente quella tecnologica. La
cosiddetta «rivoluzione verde» introdusse nell’agricoltura le nuove sementi ibride
(prodotte in laboratorio) e ne accompagnò l’introduzione con misure di incentivazione,
costituite in larga misura da credito agevolato e sussidi sugli input. La scelta della
modernizzazione tecnologica rispondeva ad una logica economica articolata, che non si
limitava ad aumentare la produzione agricola, ma puntava ad indurre la crescita anche
negli altri comparti dell’economia grazie all’impatto esercitato dalla domanda espressa
dal settore primario. L’obiettivo era cioè quello di attivare un meccanismo attraverso il
quale le nuove tecnologie (introdotte in agricoltura) potessero generare la crescita
nell’industria e nei servizi grazie all’aumento dei consumi degli agricoltori – di beni
manufatti e di beni d’investimento – per conseguenza della crescita dei redditi
imputabile alle nuove tecniche di produzione72. Si riteneva inoltre che l’effetto
moltiplicativo della domanda agricola si sarebbe potuto manifestare a due livelli
territoriali diversi: a livello locale, qualora la domanda degli agricoltori si fosse diretta a
prodotti dell’industria localizzata nel comprensorio che ospitava anche la produzione
agricola; e a livello nazionale, qualora le industrie fossero state localizzate altrove nel
territorio dell’Unione.
La debolezza strutturale della domanda interna dimostra che il meccanismo
attivato nelle aree rurali non ha funzionato. In primo luogo, l’impatto della rivoluzione
verde in termini di aumento della produzione è stato nel medio-lungo periodo e a livello
aggregato molto più modesto di quanto si ritenesse nei primi anni; inoltre, mentre l’India
ha raggiunto a livello globale l’autosufficienza alimentare, alcuni distretti hanno
registrato in oltre trenta anni una riduzione della capacità produttiva a causa
principalmente dei problemi ambientali collegati all’intensificazione nell’uso di acqua
irrigua e fertilizzanti indotta dall’impiego delle sementi ibride73. In secondo luogo, il
carattere dello sviluppo innescato dall’introduzione della nuova tecnologia è stato
fortemente diseguale. Questa disuguaglianza non riguarda tanto la concentrazione delle
terre74, quanto piuttosto la formazione della capacità produttiva determinata dalla
possibilità di accedere agli input (acqua e fertilizzanti) che consentono l’introduzione
delle sementi ibride. Analogamente, l’effetto moltiplicativo della domanda degli
Il funzionamento per l’India del modello di crescita trainata dalla domanda agricola è
illustrato da J. Mellor in The New Economics of Growth: A Strategy for India and Developing World,
Cornell University Press, Ithaca e NY, 1976.
73
Cfr. B. Harriss-White, La rivoluzione verde nell’India meridionale, in «Politica
internazionale», n. 5, 1996.
74
Poiché non vi è stata a livello aggregato la polarizzazione della concentrazione delle terre che
gli studiosi marxisti avevano ipotizzato (cfr. T.J.Byres, The New Technology, Class Formation and
Class Action in the Indian Countryside, in «The Journal of Peasant Studies», Vol. 8, No. 4, 1981).
39
72
agricoltori si è distribuito in modo ineguale, dirigendosi spesso verso produzioni di altre
località, se non addirittura di altri paesi.
Il diseguale impatto della rivoluzione verde ha determinato una riduzione della
potenzialità del settore agricolo come componente della domanda interna. Gli squilibri
territoriali e sociali dello sviluppo agricolo hanno determinato una crescita ridotta e
distorta dei consumi degli agricoltori. Poiché i redditi dei lavoratori dipendenti e dei
piccoli agricoltori sono cresciuti poco (in qualche caso si sono persino ridotti) la
domanda dei beni manufatti (a tecnologia matura) destinati ai fabbisogni quotidiani è
aumentata in modo molto contenuto; per contro, è aumentata la domanda degli
agricoltori ricchi. Come è noto però il modello di consumo dei ricchi è sostanzialmente
diverso da quello dei poveri – sia per la presenza dei beni capitali sia per la
composizione del paniere di consumo – e la domanda da essi espressa può essere
soddisfatta con beni d’importazione o con beni che impiegano tecnologia importata75.
L’insufficienza strutturale della domanda nelle aree rurali è ampliata ed aggravata
da quella che si osserva nei comprensori urbani. Questa appare essere determinata da
due processi che si sostengono e rafforzano a vicenda: l’insufficiente crescita della
domanda di beni capitali e la ridotta e distorta crescita della domanda di beni di
consumo. Entrambi possono essere ricondotti alle caratteristiche dello sviluppo
industriale indiano, polarizzato fra settore formale e settore informale.
Le scelte di industrializzazione dei primi anni dell’indipendenza erano basate su di
un modello che puntava sulla grande impresa – a capitale pubblico nei settori strategici –
finalizzata alla produzione di beni capitali. La produzione di beni capitali, a sua volta,
era destinata ad essere impiegata nella formazione di un tessuto industriale, in larga
misura privato, costituito da imprese di dimensioni medio-piccole impegnate nella
produzione di beni di consumo. L’equilibrio del sistema richiedeva il verificarsi di una
doppia condizione: i) le imprese finalizzate alla produzione di beni di consumo
dovevano esprimere una domanda crescente per i beni capitali prodotti dall’industria
pesante controllata dai capitali pubblici; e ii) la crescita del potere di acquisto dei salari,
nell’interno comparto industriale, doveva garantire un ritmo sostenuto di crescita della
domanda di beni di consumo. In altri termini, questo modello richiedeva la formazione
di un tessuto industriale «formale», costituito da imprese di diverse dimensioni registrate
e regolate, che impiegavano lavoro sulla base di rapporti regolamentati e tutelati dalla
legge e che pagavano salari capaci di sostenere la domanda.
Il fallimento di questo modello di industrializzazione è mostrato dalla strutturale
insufficienza della domanda privata, sia di beni capitali sia di beni di consumo. E questo
fallimento deve essere spiegato non in termini di stagnazione – ossia non con il fatto che
non vi è stata crescita dell’industria – quanto piuttosto sulla base delle caratteristiche
75
Sudip Chauduri, Debates on Industrialization, cit., p. 266.
40
specifiche del tessuto industriale che si è andato formando dall’Indipendenza in poi. La
crescita industriale, che si è affermata in India in oltre cinquanta anni di indipendenza e
che si è rafforzata negli anni della liberalizzazione, ha interessato in misura prevalente il
settore dell’economia cosiddetto «informale», ossia quella parte dell’organizzazione
produttiva non registrata e non regolamentata, che cresce al di fuori dei controlli
pubblici sulle condizioni e sui tempi di lavoro. Il settore informale indiano – che spesso
opera ai margini della legalità – è caratterizzato dalle più svariate forme organizzative,
che spaziano dalla grande impresa segmentata e decentrata, all’impresa familiare e
individuale, a forme di lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo all’interno di
micro-imprese; e questa varietà di forme risponde all’esigenza di sfuggire ai controlli
pubblici con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione, in particolare quelli del lavoro.
In cinquanta anni di indipendenza, il settore informale ha costituito la componente
maggioritaria dell’economia indiana, con una quota di occupati sul totale che si è
mantenuta oltre il 90%76.
I motivi per cui lo sviluppo del settore informale inibisce la crescita della
domanda vanno ricercati nei fattori di competitività di questo tipo di industrializzazione,
ed in particolare nel controllo dei costi di produzione. Con l’obiettivo di contenere i
costi, le imprese informali tendono ad operare con tecniche produttive arretrate, a forte
intensità di lavoro. Ciò spiega il fatto che non esprimano domanda di beni capitali, o la
esprimano a livelli molto contenuti. Analogamente, sempre con l’obiettivo di acquisire
vantaggi competitivi sui mercati, i livelli dei salari sono molto più bassi di quelli pagati
in condizioni analoghe nel settore formale. Anzi, l’informalità delle relazioni di lavoro
viene ricercata dalle imprese con l’obiettivo esplicito di sfuggire ai controlli pubblici e
alla regolamentazione in merito alle condizioni di lavoro, livello salariale incluso. Ciò fa
sì che le condizioni di lavoro siano di quasi sfruttamento e i livelli salariali siano molto
vicini alla sussistenza. Poiché il settore informale ha in India una consistenza molto
ampia, quest’ultimo aspetto concorre a giustificare la strutturale insufficienza della
domanda di beni di consumo che ha portato al fallimento del modello di
industrializzazione inaugurato dopo l’indipendenza.
La questione dell’insufficienza della domanda aggregata è servita fin qui per
mettere in luce gli aspetti nodali dello sviluppo economico indiano nella seconda metà
del secolo scorso. Si è così potuto mostrare che la situazione indiana non può essere
descritta in termini di immobilismo. Al contrario, l’India ha registrato un complesso
76
Alcune stime basate su dati ufficiali indicano che nel 1981 meno del 10% della popolazione
attiva era occupata nel settore «formale», oltre il 70% della quale operava all’interno di imprese
pubbliche (cfr. V. Joshi e I.M.D. Little, India. Macroeconomics and Political Economy, 1964-1991,
cit., p. 26). Stime più recenti indicano livelli ancora più bassi (cfr. B. Harriss-White e N. Guptu,
Mapping India’s World of Unorganized Labour, in The Socialist Register 2001, a cura di L. Panitch e
C. Leys, Merlin, Londra, 2000).
41
processo di cambiamento che ha interessato le aree urbane e le campagne, l’industria e
l’agricoltura. Si è anche rilevato il pieno inserimento della realtà indiana all’interno della
logica capitalistica, com’è evidenziato dall’azione dei meccanismi dell’accumulazione
nei diversi settori produttivi. Infine, si sono ricostruiti i processi di marginalizzazione
che spiegano perché i cambiamenti dell’economia indiana non si siano tradotti in un
generalizzato miglioramento delle condizioni sociali. Il quadro tracciato non suggerisce
che l’economia indiana non è cresciuta; dice invece che è cresciuta male e che i
progressi economici raggiunti sono rimasti concentrati nelle mani di pochi. E dice anche
che il processo di crescita dell’India è «diverso» da quello dei paesi europei di prima
industrializzazione, la differenza principale essendo l’incapacità di generare un
progresso generalizzato delle condizioni di vita. La questione che rimane da discutere è
a cosa debba essere imputata questa diversità e quale ruolo svolga nello sviluppo del
capitalismo in India.
Le impurità dello sviluppo economico indiano
La risposta orientalista classica a questo interrogativo farebbe riferimento ai fattori
culturali, spiegando il processo di crescita distorto dell’India con il prevalere nella
società di valori e istituzioni scarsamente compatibili con lo sviluppo economico
capitalistico. Una alternativa preferibile alla visione orientalistica è quella di interpretare
le anomalie del capitalismo indiano utilizzando un approccio istituzionalista che tiene
conto dei valori e delle istituzioni e ne analizza il ruolo nello sviluppo del capitalismo.
Ciò comporta l’abbandono dei concetti di «sviluppo economico moderno» e di
«capitalismo puro» e l’assunzione dell’ipotesi che ogni economia capitalistica è
costituita da una struttura dominante – le relazioni di produzione – e da una serie di
caratteristiche (o «residui») culturali e istituzionali country-specific, che sostengono il
processo produttivo e l’accumulazione di capitale. Questi residui culturali e istituzionali
costituiscono una sorta di «impurità» che rendono specifica la trasformazione
capitalistica nelle diverse situazioni di spazio e di tempo. Tuttavia, queste impurità non
vengono superate con l’affermazione del modo di produzione capitalistico: esse sono
«necessarie» alla riproduzione del sistema perché definiscono gli equilibri sociali ed
economici che, nella situazione particolare, consentono l’affermazione e la durata nel
tempo delle relazioni alla base dell’accumulazione capitalistica77.
77
In altri termini, si assume che esista una «via nazionale al capitalismo»: ogni paese può
individuarla e percorrerla se riesce a plasmare la propria struttura sociale in modo da consentire
l’accumulazione. Evidentemente, questo processo può condurre ad individuare figure sociali e relazioni
42
Questo approccio consente di leggere lo sviluppo capitalistico non come una
progressiva purificazione dalle forme pre-capitalistiche – destinate a dissolversi nella
trasformazione della società – ma piuttosto come un processo di adattamento evolutivo
della struttura sociale e produttiva, processo che dipende dalle condizioni storiche e di
contesto all’interno delle quali ogni singola economia è collocata. Non esistono così
leggi di movimento «universali», ma ogni paese produce una specifica forma di
capitalismo sulla base del «proprio bagaglio storico di impurità»: queste impurità
dunque non si dissolvono con la crescita economica, ma rimangono a caratterizzare il
modello di sviluppo nel lungo periodo78. Sulla base di questa impostazione, il vero
problema analitico che ora si presenta è quello di identificare le impurità del capitalismo
indiano e di comprendere in che modo esse segnano lo sviluppo economico della
regione.
La principale «impurità» del capitalismo indiano va ricercata nella struttura
sociale che influenza in modo determinante l’organizzazione dell’economia. Si tratta di
una struttura sociale complessa che può essere analizzata con riferimento i) alla
stratificazione da cui è attraversata e ii) alla natura delle figure sociali che la
compongono.
La stratificazione sociale dell’India contemporanea è generata dall’interagire di
più forme di aggregazione. La prima e certamente la più importante per pervasività e
persistenza è costituita dal sistema di casta. Le caste, così come sono descritte dalla
letteratura del periodo post-coloniale, appaiono sia come il principio ordinatore della
società civile indiana, sia come aggregati sociali che conservano nella religione induista
la fonte della propria legittimità di fronte ai cambiamenti socio-economici. Secondo le
ricerche del periodo successivo all’indipendenza, la principale conseguenza del legame
fra caste e Induismo è che la società indiana è organizzata in forma gerarchica,
all’interno della quale la legge, la religione e la moralità sono strumenti per rafforzare la
subordinazione dell’individuo al gruppo79. Il sistema castale quindi definisce il contesto
culturale e, contemporaneamente, plasma i comportamenti sociali, definendo un codice
per l’identificazione degli individui e degli interessi. Inoltre, ogni casta costituisce un
«gruppo di interesse» che può essere coinvolto a sostegno di particolari azioni sociali e
politiche80.
estranee al modello del «capitalismo puro», che però, in quel determinato contesto, diventano
necessarie per realizzare l’accumulazione di capitale.
78
Cfr. G.M. The Evolution of Capitalism from the Perspective of Institutional and Evolutionary
economics, in Capitalism in Evolution. Global Contentions – East and West, a cura di G.M. Hodgson,
M. Itoh e N. Yokokawa, Edwar Elgar, Cheltenham, 2001.
79
Cfr.A.Béteille in Caste in Contemporary India, cit.
80
Questo tipo di immagine corrisponde alla realtà quale esisteva alla metà del secolo appena
concluso. Tuttavia, ciò che, in genere, non è percepito da sociologi e da antropologi è il fatto che la
43
Il mutamento del sistema castale, diventato sempre più rapido, complesso e
percepibile a partire dagli anni ’50 si è verificato all’interno di quadri ideologici di
riferimento in radicale contrapposizione fra loro, cioè quello costituito dall’ideologia
democratica dell’India indipendente e quello rappresentato dall’induismo gerarchico.
L’ideologia democratica dell’India indipendente si è appropriata del discorso di tutela e
promozione dei gruppi castali subordinati81 e lo ha portato avanti come parte di una
politica di promozione degli strati deboli della società. Tale politica, sanzionata nella
Costituzione, ha trovato espressione in una serie di leggi ad hoc, approvate in tempi
diversi, ma tutte inquadrabili nella cosiddetta reservation policy, cioè nelle
discriminazione positiva a favore prima dei fuoricasta e, più recentemente, delle
cosiddette backward classes (di fatto caste intermedie contadine, che occupano una
posizione subordinata dal punto di vista rituale ma che, spesso, sono potenti dal punto di
vista politico ed economico). D’altra parte, la rivitalizzazione dell’induismo, in corso fin
dagli anni ’20, ma diventata particolarmente percepibile e politicamente rilevante a
partire dagli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, ha contribuito ad aumentare la rilevanza
sociale per una casta di essere considerata quanto più «pura» possibile82. L’effetto
situazione da essi descritta non è il permanere di una realtà immutabile, bensì è il risultato dell’operare
del governo coloniale. Questo significa che i) se è vero che il sistema castale ha continuato a mutare nel
tempo, non deve in alcun modo stupire che, dopo la pausa coloniale, tale sistema riprendesse ad
evolversi e ii) che il concreto operare del governo coloniale aveva dato al sistema castale delle
caratteristiche che prima non aveva. In particolare, sono stati i provvedimenti politici presi dal governo
coloniale a trasformare le caste in reti organizzative politiche. Paradossalmente, quindi, la
modernizzazione coloniale ha effettivamente trasformato il sistema castale nel principio organizzatore
della società indiana, anche se in termini nuovi e più complessi di quelli indicati nei testi canonici
dell’induismo. Per approfondimenti sulla questione delle trasformazione del sistema castale, si veda la
prima parte di questa introduzione scritta da Michelguglielmo Torri.
81
Iniziato dal regime coloniale con il fine di indebolire il movimento per l’indipendenza,
considerato espressione delle caste brahmaniche (cfr. Torri, Storia dell’India, cit.).
82
Si è così assistito alla «sanscritizzazione» di molti gruppi castali che, adottando i costumi
sociali tipici delle caste alte (dal vegetarianesimo alla segregazione delle donne), hanno rivendicato uno
status sociale più «puro» – e, pertanto, più alto – nell’ordinamento castale tradizionale (Cfr. M.N.
Srinivas, The Cohesive Role of Sanskritisation and Other Essays, Oxford University Press, Delhi,
1989). Ma si è anche visto come, di per sè, il processo di sanscritizzazione fosse del tutto insufficiente
a fare accettare l’«elevazione» sociale di un gruppo castale. Nella realtà concreta, infatti, l’elevazione
sociale di un gruppo castale (un processo che, come ben sanno gli storici, è lungi dall’essere una novità
degli ultimi cent’anni) è del tutto indipendente dal processo di sanscritizzazione. Questo può esserci o
non esserci ma, in ogni caso, da solo non porta mai al riconoscimento di uno status più alto da parte
degli altri gruppi castali. Il riconoscimento di questo status più alto è , infatti, legato alla conquista di
potere economico e/o politico da parte di strati più o meno ampi di un certo gruppo castale (che, poi,
agiscono come patroni nei confronti dai loro confratelli di casta meno fortunati). A sua volta, la
conquista di potere economico e/o politico coincide o si risolve con l’abbandono delle occupazioni
«ereditarie» di una determinata casta e con l’assunzione di occupazioni nuove e più prestigiose.
44
combinato di questi processi e della contestata applicazione della Reservation Policy del
governo indiano – accelerata dalla pubblicazione del Rapporto Mandal – è stato il
prevalere di una «cultura duale» per cui una casta reclama uno stato alto nell’ambito
religioso e uno stato basso nell’ambito economico e sociale83. Si ha così una separazione
fra la sfera religiosa e la sfera sociale che genera la «secolarizzazione» delle caste. Il
sistema castale, quindi, appare oggi – rispetto al sistema «classico» descritto nei testi
canonici dell’induismo – come un «sistema mutilato» il cui futuro «non è nella religione,
ma nella politica»84.
Esso stesso in fase di trasformazione, il sistema castale influenza l’organizzazione
sociale in forme nuove che vengono segnalate dalla letteratura. In primo luogo, si
osserva un raggruppamento degli individui appartenenti allo stesso gruppo castale nelle
nuove professioni, che ricorda da vicino l’associazione tra caste e mestieri definita dalla
religione. Questa diversificazione dell’occupazione nei settori moderni sulla base dei
gruppi castali assume però un significato nuovo, poiché non riflette la gerarchia
tradizionale delle caste, ma è generata dalla distribuzione delle capacità professionali e
delle risorse e dalle imperfezioni del mercato del lavoro dovute al controllo individuale
e/o di gruppo sulle informazioni e sulle opportunità professionali. Inoltre, il nuovo
sistema di casta è caratterizzato dalla mobilità verso l’alto e dalla crescita di una
eterogenea «classe media» prodotta dalla Reservation Policy e dai movimenti delle caste
basse. Infine, si registra una saldatura fra questo nuovo tipo di ordine castale e le altre
forme di stratificazione della società indiana.
La liberalizzazione fa emergere la forte segmentazione della società indiana,
all’interno della quale le caste sono intimamente interconnesse con un network di
organizzazioni della società civile che regolano ogni aspetto della vita politica ed
economica85. Queste organizzazioni comprendono sia associazioni che emulano
aggregazioni tradizionali – come quelle tra individui appartenenti alla stessa casta e alla
Sull’argomento si vedano S.N. Srinivas, The dominant caste and other essays, Oxford University
Press, Delhi 1987, e id., Village, caste, gender, and method : essays in Indian social anthropology,
Oxford University Press, Delhi 1996.
83
Cfr. G.K. Karanth, Caste in Contemporary Rural India, in Caste. Its Twentieth Century
Avatar, a cura di M. N. Srinivas, cit.
84
Cfr. A. Béteille, Caste in Contemporary India, cit., p. 158.
85
Vi è una crescente letteratura su queste forme di organizzazione della società civile in varie
parti dell’India. Si vedano in particolare E. Basile e B. Harriss-White, The Politics of Accumulation in
Small Town India, in «IDS Bulletin»,Vol. 30, No. 4, Sussex University, Brighton, 1999; C. Uphadya,
Culture, Class and Entrepreneurship: a Case Study of Coastal Andhra Pradesh, in Small Business
Entrepreneurship in Asia and Europe, a cura di M. Rutten e C. Uphadya, Sage, Delhi, 1997; M. Rutten,
Farms and Factories. Social Profile of Large Farmers and Rural Industrialists in West India, Oxford
University Press, Delhi, 1995; M.L. Reiniche, The Urban Dynamics of Caste: A Case Study from
Tamilnadu, in Caste today, a cura di C. Fuller, Oxford University Press, Delhi, 1996.
45
stessa religione – sia aggregazioni di tipo nuovo – come quelle tra individui che
svolgono la stessa attività economica o la stessa professione, o che sono uniti dagli
stressi interessi culturali e politici. Esse definiscono una segmentazione sociale che è
espressa in un linguaggio associativo che riecheggia l’ordine castale, e ciò avviene
perché il sistema delle caste definisce ancora la base culturale dell’India contemporanea.
Sarebbe, tuttavia, un errore interpretare questa segmentazione come segno di
cristallizzazione della società indiana «tradizionale»; al contrario, essa è il prodotto di
forme associative che definiscono, tra i diversi gruppi sociali, delle distinzioni di status
che sono in molti casi delle distinzioni di classe. Questa situazione si verifica in generale
nel caso delle associazioni dettate da interessi economici, ma si può osservare talvolta
anche per le associazioni di casta, che, in specifici contesti locali e sociali, finiscono per
aggregare individui che condividono la stessa posizione di classe.
Questo tipo di stratificazione presenta due importanti anomalie rispetto a quella
osservata nei paesi di prima industrializzazione. La prima è che le varie forme di
segmentazione, che si intrecciano e si sovrappongono, rendono difficile delimitare in
termini univoci le categorie sociali che identificano il capitale e il lavoro. Così, è
frequente imbattersi in un capitalista che persegue la rendita, oltre che al profitto, con
mezzi che spaziano dalla corruzione alla violenza, e che ha uno stile di vita analogo a
quello di un redditiero. Allo stesso modo, la categoria del lavoro dipendente può
apparire inadeguata a rappresentare la situazione di quei lavoratori che sono
formalmente impegnati in attività autonome, ma che nei fatti sono imprigionati in
legami contrattuali squilibrati con chi fornisce loro il capitale per l’acquisto dei
macchinari e di altri input e con chi gestisce la commercializzazione dei loro prodotti.
La seconda anomalia è individuabile nelle implicazioni della persistenza del sistema di
casta sulle relazioni fra lavoro e capitale. Le caste costituiscono ancora la base culturale
dell’India contemporanea e l’ordine che esse definiscono continua ad essere nei fatti la
base della stratificazione sociale che oggi osserviamo. Ciò implica che le relazioni fra i
vari gruppi sociali siano presentate in termini di armonia sociale piuttosto che di
antagonismo. Questo fatto, associato al carattere spurio delle categorie che individuano
il capitale e il lavoro, concorre a ridurre lo spazio per i conflitti di classe, delegando alle
varie associazioni il compito di rappresentare gli interessi dei propri membri al di fuori
di una logica sindacale86.
Queste due anomalie – che descrivono un rapporto fra capitale e lavoro molto
contrastante con quello osservato nelle fasi iniziali e centrali dell’industrializzazione nei
paesi europei – assumono nel contesto indiano un ruolo tutt’altro che marginale e
86
Questa situazione può essere descritta come una forma di «corporativismo sociale», in cui le
caste assumono il ruolo di mediatore dei conflitti sociali ricoperto dallo Stato nel corso del Fascismo in
Italia. Su questo punto cfr; E. Basile e B. Harriss-White, The Politics of Accumulation in Small Town
India, cit.
46
secondario poiché spianano la strada a forme di sfruttamento del lavoro che non
sarebbero socialmente sostenibili in una situazione conflittuale, e che consentono la
crescita del vasto e complesso settore informale. In altri termini, queste anomalie
consentono di aumentare lo sfruttamento del lavoro, contenendone i costi e
aumentandone la flessibilità d’impiego. Se si considera che questi fattori che sono alla
base della competitività dell’industria indiana dopo il fallimento del modello di
industrializzazione proposto con i piani quinquennali, si vede che le caratteristiche della
stratificazione sociale, anche se appaiono in contrasto con il modo di produzione
capitalistico, nei fatti operano a sostegno del processo di accumulazione del capitale.
Grazie a queste anomalie si possono cogliere gli aspetti principali delle deviazioni del
capitalismo indiano rispetto al modello di «capitalismo puro». Queste anomalie – queste
impurità – affondano le radici in una stratificazione sociale che è frequentemente
espressa in un linguaggio che re-interpreta e re-inventa la «tradizione» dell’India
classica. Si è qui mostrato che queste impurità sostengono l’accumulazione capitalistica
e definiscono il percorso dello sviluppo economico moderno dell’India contemporanea.
È dunque legittimo concludere affermando che le istituzioni indiane rappresentano
elementi che, contrariamente alla visione orientalista, si dimostrano funzionali
all’accumulazione capitalistica e da quest’ultima traggono forza per la legittimazione di
quelle condizioni sociali che rappresentano uno, ma soltanto uno, dei fattori culturali
specifici della realtà indiana.
47