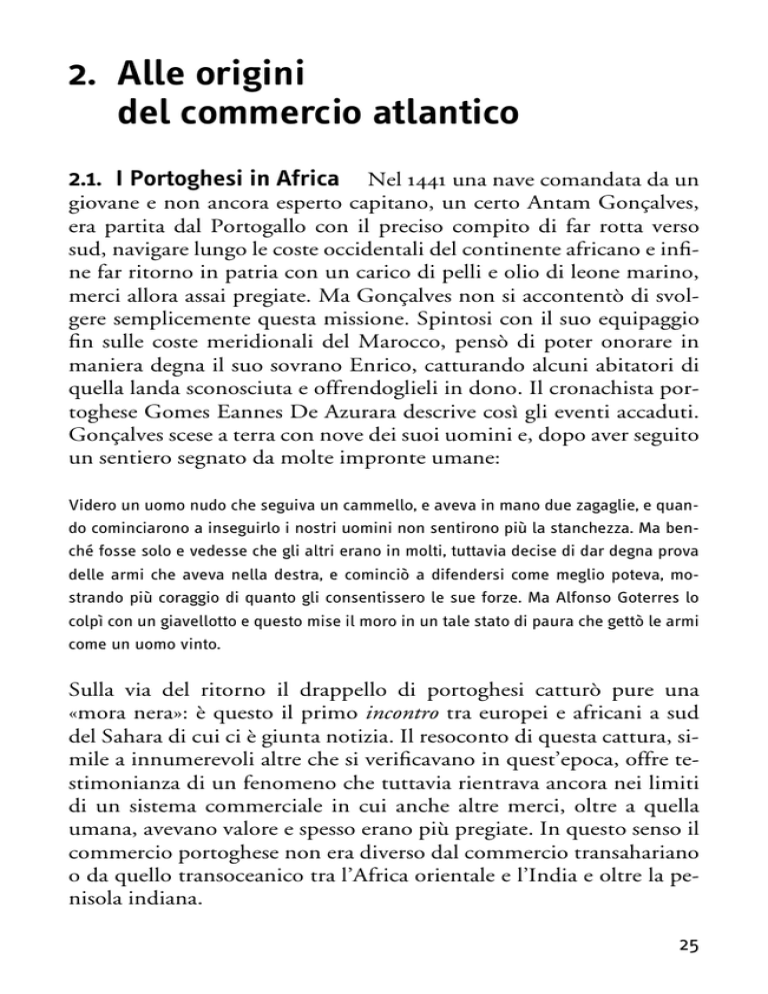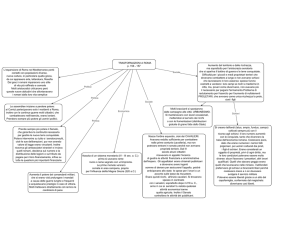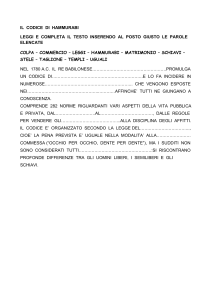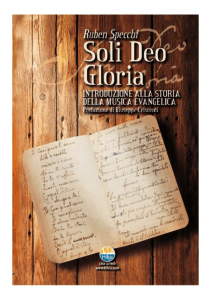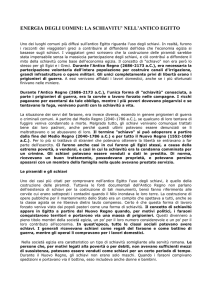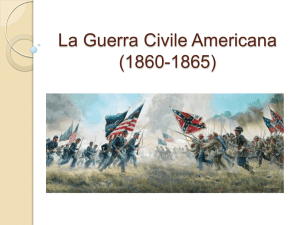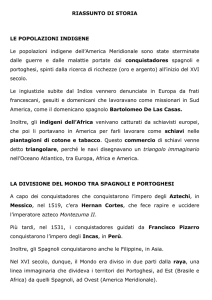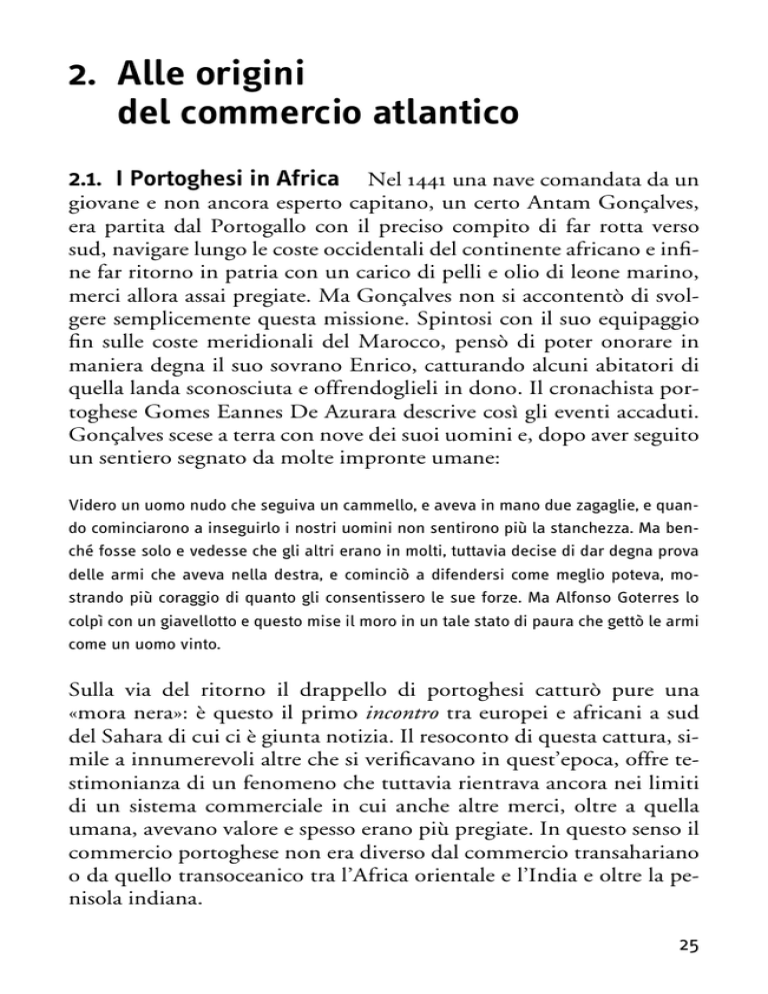
2. Alle origini
del commercio atlantico
2.1. I Portoghesi in Africa Nel 1441 una nave comandata da un
giovane e non ancora esperto capitano, un certo Antam Gonçalves,
era partita dal Portogallo con il preciso compito di far rotta verso
sud, navigare lungo le coste occidentali del continente africano e infine far ritorno in patria con un carico di pelli e olio di leone marino,
merci allora assai pregiate. Ma Gonçalves non si accontentò di svolgere semplicemente questa missione. Spintosi con il suo equipaggio
fin sulle coste meridionali del Marocco, pensò di poter onorare in
maniera degna il suo sovrano Enrico, catturando alcuni abitatori di
quella landa sconosciuta e offrendoglieli in dono. Il cronachista portoghese Gomes Eannes De Azurara descrive così gli eventi accaduti.
Gonçalves scese a terra con nove dei suoi uomini e, dopo aver seguito
un sentiero segnato da molte impronte umane:
Videro un uomo nudo che seguiva un cammello, e aveva in mano due zagaglie, e quando cominciarono a inseguirlo i nostri uomini non sentirono più la stanchezza. Ma benché fosse solo e vedesse che gli altri erano in molti, tuttavia decise di dar degna prova
delle armi che aveva nella destra, e cominciò a difendersi come meglio poteva, mostrando più coraggio di quanto gli consentissero le sue forze. Ma Alfonso Goterres lo
colpì con un giavellotto e questo mise il moro in un tale stato di paura che gettò le armi
come un uomo vinto.
Sulla via del ritorno il drappello di portoghesi catturò pure una
«mora nera»: è questo il primo incontro tra europei e africani a sud
del Sahara di cui ci è giunta notizia. Il resoconto di questa cattura, simile a innumerevoli altre che si verificavano in quest’epoca, offre testimonianza di un fenomeno che tuttavia rientrava ancora nei limiti
di un sistema commerciale in cui anche altre merci, oltre a quella
umana, avevano valore e spesso erano più pregiate. In questo senso il
commercio portoghese non era diverso dal commercio transahariano
o da quello transoceanico tra l’Africa orientale e l’India e oltre la penisola indiana.
25
L’analisi della complessa realtà sociale africana agli albori del commercio schiavista, posta anche in relazione alla coeva situazione europea, resta uno dei punti essenziali per la comprensione dell’avvio e
del successivo sviluppo della tratta. Negli anni in cui i primi europei
si introdussero in regioni dell’Africa fino a quel momento poco o
nulla frequentate, fra le diverse società africane si era raggiunta una
fase di relativa stabilità. Come lo storico Basil Davidson ha sottolineato, «lo stabilizzarsi delle concentrazioni di potere dell’età del ferro, l’evoluzione dell’amministrazione centrale, la creazione di eserciti, l’investitura sotto giuramento dei vassalli e l’eliminazione dei rivali, che avevano accompagnato gran parte dell’evoluzione sociale dell’Africa nel millennio precedente», furono fattori che, unitamente all’assenza di invasioni dall’esterno, diedero origine a un sistema feudale paragonabile in qualche aspetto a quello europeo, anche se profonde diversità distinguevano questi due ordinamenti sociali.
Così come in Europa anche negli stati e negli imperi africani la sottomissione di popoli vinti aveva prodotto masse di soggetti asserviti
che dipendevano, attraverso uno stretto rapporto di vassallaggio, dai
loro padroni. Un’altra analogia tra i due sistemi feudali può essere riscontrata nel graduale dissolvimento della linea divisoria tra schiavo e
uomo libero seppur dipendente dalle evoluzioni economiche e dalle
stratificazioni sociali dei diversi stati africani; dai popoli musulmani
della fascia costiera settentrionale alle nazioni della cintura delle foreste o delle aree più interne e meridionali.
Nel diciottesimo secolo, i propugnatori del commercio schiavista
usarono spesso una distorta lettura dei complessi fenomeni di asservimento esistenti negli stati africani come argomentazione contro gli
abolizionisti: la deportazione nelle colonie americane diventava ai
loro occhi una paradossale forma di liberazione da una condizione
giudicata ben peggiore. Le non trascurabili affinità tra il sistema feudale europeo e quello africano non devono però trarre in inganno.
All’epoca delle grandi scoperte geografiche, se l’Africa aveva raggiunto una certa stabilità sociale sulla base di un ordine prettamente tribale, l’Europa, per contro, si stava allontanando dal modello feudale
per imboccare un nuovo indirizzo caratterizzato da una grande intraprendenza economica.
La schiavitù nel continente africano non fu affatto un fenomeno secondario ma, come nel medioevo europeo, fu un’istituzione di scarso
26
significato prima dell’inizio del commercio atlantico. Pochi furono
infatti gli stati africani che svilupparono forme di produzione alimentate da lavoro servile. Durante il xvi secolo, nell’area subsahariana, l’impero Songhay sviluppò effettivamente un’economia agricola
fondata su un largo impiego di schiavi, ma si trattò di un caso pressoché isolato e di breve durata. Fu solo a partire dall’viii secolo, con
l’espansione islamica, che effettivamente il commercio assunse dimensioni più significative: si stima infatti che dal ix al xv secolo ogni
anno venissero trasportati lungo le vie carovaniere dai 5.000 ai 10.000
schiavi per approvvigionare il mercato dei diversi paesi islamici.
L’impiego di schiavi all’interno della maggior parte delle società africane era peraltro assai diffuso. Accanto al commercio islamico, un
fiorente commercio intracontinentale si era infatti sviluppato, soprattutto nell’area sud orientale, molto prima dell’arrivo dei portoghesi, i primi europei a interessarsi alla merce umana. Secondo alcune stime relative ai sei secoli che precedettero l’apertura del commercio atlantico, dai 3,5 ai 10 milioni di africani furono strappati alle loro
terre d’origine e venduti come schiavi all’interno del continente africano. Sebbene la quantità di persone coinvolte risulti impressionante, queste forme di commercio preatlantico differivano notevolmente dalla successiva pratica europea. Innanzitutto, in considerazione
dell’impiego principalmente domestico degli schiavi nelle società
africane, erano le donne e i bambini a essere più richiesti. In secondo
luogo, il fenomeno si accordava con un livello di produzione e un’articolazione sociale nella quale la schiavitù restava un fattore incidentale nell’organizzazione economica e politica. Agli inizi del Quattrocento, la comparsa degli esploratori e dei primi trafficanti portoghesi
sul continente africano diede all’intero processo un’accelerazione determinante. Attratti principalmente dall’oro, i portoghesi si preoccuparono di rifornire il mercato interno di schiavi per ricavarne in cambio il prezioso metallo. Fu solo in seguito alla colonizzazione delle
isole atlantiche – Azzorre, Madeira – e di alcune africane – Isole di
Capo Verde, São Tomé – e all’introduzione della coltivazione della
canna da zucchero, che i portoghesi si interessarono direttamente alla
schiavitù. Se tra il 1450 e il 1460 il numero degli schiavi trasportati su
legni portoghesi era di circa 800 all’anno, nei decenni successivi passerà alle 2.000 unità, per giungere alle 2.600 all’inizio del Cinquecento.
27
Ma ancor prima di analizzare i tempi e i modi degli esordi del traffico
schiavista è necessario interrogarsi su questioni di diverso ordine:
quale fu e come cambiò l’atteggiamento europeo verso gli africani in
considerazione della loro diversità razziale? E soprattutto in che misura il colore della pelle segnò il loro destino di schiavitù?
2.2. Razzismo e schiavitù Dalla società inglese del sedicesimo
secolo, per certi versi una sorta di osservatorio privilegiato, giungono
a riguardo alcune significative indicazioni, embrioni di un’elaborazione concettuale razziale che, in ragione del ruolo centrale svolto
dall’Inghilterra nell’intera vicenda schiavista, risultano quanto mai
significative.
È innegabile che il colore della pelle degli africani fu l’elemento che
maggiormente colpì i primi viaggiatori inglesi. Malgrado i riferimenti all’etiope presenti nelle Scritture, nella letteratura classica e medioevale o nelle arti figurative, la conoscenza diretta e l’impatto del colore
provocarono infatti ben altro effetto. D’altra parte, ancor prima di
scoprire l’esistenza di uomini neri, lo stesso concetto di blackness si
caricava in Inghilterra, forse più che nell’Europa meridionale, di particolari significati. Come ha notato Winthrop D. Jordan, «l’idea della blackness rappresentava per gli inglesi il simbolo di alcuni dei loro
più radicati valori, e soltanto il bianco, fra gli altri colori, aveva su di
loro, dal punto di vista emotivo, un impatto altrettanto forte». Prima
del xvi secolo infatti, “sporco”, “lurido”, “malvagio”, “mortale”,
“pernicioso”, “sinistro”, “cattivo”, “orribile”, “perfido”, erano solo
alcune delle negative accezioni della parola nero riportate nell’Oxford
English Dictionary, proprio a dimostrazione di come questo colore
fosse emotivamente legato a quanto di più basso e maligno si potesse
immaginare. Per contro, nell’idea di whiteness era invece identificabile una serie di valori, assunti in maniera quasi ossessiva dalla cultura
elisabettiana, esattamente opposti, quali la purezza, la verginità, la
virtù, la bellezza. Il bianco e il nero, in ultima analisi, come simboli
del bene e del male, di Dio e del diavolo. Ma gli interrogativi che
maggiormente creavano imbarazzo agli inglesi del xvi secolo derivavano dalla natura della carnagione degli africani, dalla sua origine e
dal suo possibile significato. Tenendo conto dell’assoluta incontrovertibilità del racconto biblico della creazione, una soluzione al problema non era poi così facile da trovare. Si poteva far ricorso all’azio28
ne del sole che avrebbe potuto scurire la pelle degli africani lungamente esposti ai suoi raggi: ipotesi questa che sembrò convincere addirittura William Shakespeare se nel Mercante di Venezia il principe
del Marocco affermava: «Non ti dispiaccia il colore della mia pelle,
ombrata livrea del sole brunito, del quale io son vicino, e vicino al
quale son stato allevato». La soluzione climatica aveva però un grosso
limite: non funzionava per quelle popolazioni che in America vivevano a latitudini equatoriali e che, a rigore di logica, avrebbero dovuto
subire gli stessi effetti dell’azione svolta dal sole in Africa, fatto questo che non si era verificato. Al massimo, gli abitatori delle regioni
più calde del Nuovo Mondo potevano infatti essere considerati di
carnagione olivastra, ma non certamente neri. D’altra parte la permanenza in luoghi dove l’effetto del sole era minore avrebbe dovuto
far ridiventare bianchi gli africani ma questo in Europa e in America
settentrionale non si era verificato.
Se le maldestre spiegazioni di ordine naturalistico risultavano poco
soddisfacenti, un’alternativa poteva essere trovata nelle Scritture, in
due capitoli della Genesi in particolare. La storia è nota: Cam, figlio
di Noè, aveva osato guardare il padre ubriaco nella tenda, mentre i
suoi fratelli, Sem e Jafet, lo avevano coperto senza guardarlo. Al suo
risveglio, Noè aveva maledetto Canaan, figlio di Cam, condannandolo a diventare «servo dei servi» dei suoi stessi fratelli (Genesi 9-10).
Gli effetti dell’insubordinazione camitica venivano definiti, questa
volta in forma normativa, nel Levitico (25, 44-46):
Lo schiavo e la schiava di tua proprietà vi verranno dai popoli che abitano intorno a voi;
da loro prenderete schiavi e schiave. Anche fra i figli degli ospiti che abitano presso di
voi potrete prenderli e dalle loro famiglie che si trovano presso di voi e che hanno generato nella vostra terra; essi saranno vostro possesso. Li lascerete in eredità ai vostri
figli dopo di voi, perché li assumano in possesso eterno, presso di loro prenderete gli
schiavi.
Nella narrazione biblica, che per molti prefigurava la schiavitù, non
vi è però alcun riferimento al colore della pelle, anche se le genealogie
bibliche indicano che i figli di Cam avessero popolato l’area nordafricana, dalla Libia all’Egitto, parti dell’Arabia e della Palestina e quella
terra che allora veniva chiamata Cush (termine che in ebraico signifi29
ca “nero”), corrispondente all’odierna Etiopia. Resta pertanto aperta
la questione di come i due elementi, blackness e schiavitù, siano stati
correlati: secondo Jordan, l’accettazione della presunta prova biblica
fu probabilmente favorita «dall’impressione che la blackness non potesse essere altro che una maledizione e dal diffuso bisogno di trovare
conferma ai fatti naturali in specifiche citazioni delle Scritture».
È in ogni caso evidente che le descrizioni degli africani, dei loro comportamenti e delle loro caratteristiche somatiche diffuse in patria dai
viaggiatori inglesi contribuirono a formare un’opinione assai poco
edificante su queste popolazioni. Una vita allo stato selvaggio, un
pervicace paganesimo, abitudini alimentari e costumi sessuali decisamente poco ortodossi, tutto contribuì a rendere la società africana
nel suo complesso, vagliata attraverso un solido etnocentrismo britannico, un’entità culturalmente irriducibile, anche dove presentava
qualche elemento di civilizzazione. Diverso sarà l’atteggiamento inglese nei confronti degli indiani d’America il cui “comportamento
selvaggio” sarebbe stato diversamente valutato: se infatti nel Nuovo
Mondo i colonizzatori videro una possibilità di insediamento, in
Africa gli inglesi erano semplicemente in viaggio d’affari. Uno degli
elementi che maggiormente contribuì a creare una “immagine animalesca” degli africani nella mentalità inglese fu la presenza, nelle regioni dell’Africa occidentale dove si sarebbe concentrato il commercio degli schiavi, dei mammiferi più simili all’uomo, gli orangutan,
grandi scimmie senza coda capaci di camminare su due zampe. Intorno a queste scimmie antropoidi sorsero infatti fantasiose elucubrazioni che davano continuità a vecchie credenze medioevali. Edward Topsell nella sua Historie of Foure-Footed Beastes (1607) aveva
sottolineato la generale «disposizione lussuriosa» delle scimmie: un
babbuino donato al re di Francia «amava particolarmente la compagnia delle donne e delle fanciulle; il suo membro genitale era così
grosso da risultare sproporzionato alle altre parti del suo corpo». Ma
Topsell andava oltre affermando che «gli uomini con narici basse e
piatte sono lascivi come le scimmie che attentano alle donne» e stabilendo un certo qual nesso fra le scimmie e il concetto stesso di male.
Queste e altre associazioni mentali unite a vecchi pregiudizi spinsero
a supporre l’esistenza di una sorta di parentela tra animali antropomorfi e uomini animaleschi. Malgrado che la scienza avesse già alla
fine del xvii secolo dissipato ogni dubbio sulla presunta comune
30
identità tra uomini e scimmie attraverso le osservazioni anatomiche
di Edward Tyson sugli oranghi, l’idea di un legame sessuale tra scimmie e africani non venne abbandonata e anzi continuò ad alimentare
le fantasie degli europei. Se così già nel Cinquecento Jean Bodin aveva parlato riguardo all’Africa di coiti promiscui tra uomini e animali,
ancora agli inizi del Settecento John Atkins, un colto medico della
Marina di sua Maestà, sosteneva che:
In alcuni luoghi i Negroes sono stati sospettati di atti bestiali con tali animali [le scimmie], e la impudente attenzione che, come si sa, in alcune circostanze essi hanno
espresso verso le nostre donne; e d’altro canto l’ignoranza e la stupidità che impediscono loro di indirizzare e dominare la lussuria; ma soprattutto la stretta somiglianza [delle scimmie] con la specie umana indurrebbero ad accettare il fatto come avvenuto.
In età elisabettiana, letterati e viaggiatori fecero sovente ricorso a una
rappresentazione iperrealistica della sessualità degli africani, che
esplicitava in maniera palese una componente animalesca della loro
identità: l’Otello shakespeariano è un esempio illuminante di questo
atteggiamento. La vicenda del “Moro lussurioso”, con le sue evidenti
implicazioni razziali, oltre a indicare un nesso fin troppo evidente tra
la blackness del protagonista e la sfera sessuale, rivelava altresì una distanza culturale da una realtà ignota come quella africana che, per lo
spettatore come per Desdemona, restava un luogo «di vaste caverne e
desolati deserti, dirupati abissi, rocce, colline le cui sommità toccano
il cielo e di cannibali che si divorano l’un l’altro, gli antropofagi, e di
uomini la cui testa sbuca da sotto le spalle».
Ma nell’Inghilterra del primo Seicento, in anni in cui le narrazioni
dei viaggi compiuti dagli esploratori inglesi e le notizie sui primi insediamenti coloniali nel Nuovo Mondo cominciavano a circolare
diffusamente, la rappresentazione dell’altro, del diverso prendeva
nuove forme. È ancora Shakespeare, questa volta in maniera davvero
prodigiosa, ad ipotizzare nella Tempesta, il celebre dramma scritto
nel 1611, uno scenario dove l’eterogeneità razziale costituisce un elemento di grande rilevanza. Sui significati più o meno impliciti di
quest’opera molto si è discusso, giungendo a una serie di suggestive
interpretazioni. Che l’isola di Prospero non sia da cercare nel Mediterraneo, tra Tunisi e Napoli, ma che invece appartenga a uno spazio
31
geografico nuovo, non è più in discussione; non a caso sembra che la
notizia del naufragio al largo delle Bermuda di sir George Somers nel
1609 sia stata una delle fonti d’ispirazione per Shakespeare.
Secondo il critico Leslie Fiedler, lo scenario in cui si muovono i protagonisti della Tempesta «non ha nulla a che vedere né con l’Africa né
con l’Europa ed è del tutto remoto dall’asse archetipo nord-sud della
civiltà mediterranea che ha finora occupato i pensieri di Shakespeare». Per quanto l’autore non lo confessi apertamente, la Tempesta si
muove su di un diverso asse, da est verso ovest, transatlantico; un’omissione comprensibile «così eterodosso doveva sembrargli il nuovo
orientamento dell’Europa che a quel tempo la scoperta dell’America,
come nuovo polo magnetico, stava stabilendo». Se pertanto nella figura di Prospero, mago e colonizzatore, potrebbero riverberare le imprese del grande avventuriero elisabettiano sir Walter Raleigh, alchimista e promotore di molte spedizioni nel Nord America, è su Calibano, unico abitatore dell’isola, che l’attenzione della critica si è molto soffermata. Su questo «schiavo velenoso», cannibale come sembra
suggerire il suo nome, figlio di una strega «bandita da Algeri» e abbandonata sull’isola da alcuni marinai, su di lui, «creatura delle tenebre», sembrano infatti ricadere antichi pregiudizi che già avevano
connotato l’africano. Spossessato di tutto ciò che gli apparteneva,
Calibano, nel tentativo di ribellarsi al suo padrone, denuncerà gli
strumenti dell’oppressione: il linguaggio – «Mi avete insegnato a parlare, e il mio solo vantaggio è che ora so maledire» – e la scrittura, i libri di Prospero – «Ricorda, prima, di prendergli i libri: senza i libri è
uno sciocco come me... brucia i suoi libri».
Nel nostro secolo, concedendo a Shakespeare una buona dose di preveggenza, alcuni interpreti radicali hanno dato una lettura fortemente ideologica del testo prefigurando nella Tempesta un dramma colonialista ante litteram, una sorta di parabola dell’imperialismo transatlantico e della colonizzazione. È in questa prospettiva che la vicenda
di Calibano, refrattario a ogni educazione, «un demonio nato sulla
cui natura nessuna educazione potrà mai avere effetto» e la cui razza
inferiore «ha qualcosa in sé per cui non potrà mai ospitare una buona
indole», lascia presagire il legame fatale che vedrà unite l’Europa all’Africa e all’America con un vincolo di colpa e di terrore, il vincolo
della schiavitù. In definitiva, negli umori degli elisabettiani traspaiono i contorni di una società in rapida trasformazione, animata da
32
uno spirito d’iniziativa pragmatico. Il graduale contatto con popolazioni meno progredite come gli africani, spinse gli inglesi a porre
l’accento su quei caratteri – la religione, il colore della pelle, l’animalità – in aperto contrasto con i parametri di “civiltà” comunemente
accettati.
2.3. Il commercio degli schiavi nel Mediterraneo Al momento in cui i commercianti europei avviarono i primi traffici lungo
le coste del Benin, acquistare schiavi era pratica diffusa. Le regole vigenti erano comuni a tutto il bacino del Mediterraneo: nell’Impero
del Benin come tra la cristianità, gli schiavi dovevano appartenere a
un’altra comunità etnica o religiosa. Che questa regola fosse riconosciuta ma spesso trasgredita, da entrambe le parti, lo attesta un’ampia documentazione, cosicché sovente i mercanti europei vendevano
i loro concittadini sui mercati d’Egitto o del Nord Africa come i sovrani africani offrivano i loro sudditi agli europei. Veneziani e Genovesi si distinsero nel commercio di schiavi cristiani per secoli, suscitando a più riprese il biasimo della Chiesa. Agli inizi del Trecento,
Clemente v scomunicò i veneziani, autorizzando tutti i cristiani a ridurli a loro volta in schiavitù. Anche ai mercanti genovesi di Caffa,
una colonia della Repubblica sulle coste del Mar Nero, toccò la stessa sorte, quando un secolo dopo una bolla di Martino v li scomunicò
per la vendita di schiavi cristiani. Gli effetti di questi interventi papali non furono particolarmente avvertiti se, nel 1441, le leggi che regolavano il commercio nella comunità genovese sul Mar Nero prevedevano ancora il commercio sia di schiavi cristiani sia di schiavi musulmani. Altri elementi avvicinavano la situazione europea a quella africana per quel che riguarda l’istituzione della schiavitù e la sua presenza nella società. Come in Africa, dove gli schiavi potevano cominciare quasi subito a salire la scala sociale che portava all’affrancamento da una condizione quasi priva di diritti, anche nel Portogallo e
nella Spagna del xv secolo erano contemplate forme analoghe di
mobilità sociale.
Questa mutua accettazione del commercio servile tra i due continenti invalida così due teorie accusatorie che per molto tempo sono state
contrapposte: la prima secondo cui l’Europa avrebbe introdotto il
commercio degli schiavi in Africa, la seconda secondo cui la schiavitù – nel senso classico del termine – sarebbe stata un’istituzione pe33
culiare nella società africana. Non va inoltre dimenticato il fatto che,
per gran parte dell’età moderna, il Mediterraneo fu teatro di un’intensissima attività corsara e piratesca, regolarmente praticata da musulmani e cristiani, che potrà considerarsi chiusa solo con la presa di
Algeri da parte dei francesi nel 1830. In particolare, con la conclusione delle lotte tra i grandi stati in seguito alla pace di Cateau-Cambrésis nel 1559, la pirateria, una «guerra inferiore», come la definì Braudel, dominò la storia mediterranea. Algeri, Malta, Valona, Livorno,
Pisa, Trapani e molte altre città divennero le nuove capitali di un’industria antica che fra le sue modalità contemplava la cattura di uomini, donne e bambini, la loro riduzione in schiavitù, il loro commercio o scambio attraverso la richiesta di un riscatto: «In tutto il Mediterraneo – ricorda ancora Braudel – l’uomo è cacciato, rinchiuso,
venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità
degli “universi concentrazionari”». Una delle maggiori potenze mediterranee, la Repubblica di Genova, proprio nel tentativo di riportare in patria coloro che erano stati catturati e condotti come schiavi
sulle coste nordafricane o nell’Impero ottomano istituì nel 1597
un’apposita magistratura al fine di provvedere al loro riscatto.
2.4. Il Nuovo Mondo e l’inizio del commercio atlantico La
scoperta europea del Nuovo Mondo non presupponeva un’automatica espansione della schiavitù africana nelle Americhe. La presenza
di una ragguardevole popolazione di nativi avrebbe potuto garantire
un’abbondante forza lavoro, senza contare che la stessa Europa, grazie a una consistente crescita demografica, avrebbe potuto contribuire alla domanda di uomini nelle nuove colonie. Questo non avvenne
e già nel 1501, solo nove anni dopo il primo viaggio di Colombo, la
corona spagnola aveva emanato leggi riguardanti l’esportazione di
schiavi in America, nell’isola di Hispaniola. Nei secoli che seguirono
le imprese dei conquistatori iberici dall’Africa giunsero così nel Nuovo Mondo circa dieci milioni di schiavi. Sono però forse i Portoghesi
a poter essere considerati gli iniziatori del commercio atlantico degli
schiavi africani. Liberato dalla presenza musulmana già a metà del
xiii secolo, il nuovo regno del Portogallo assunse una sua definitiva
connotazione con la salita al trono di João i. Una spiccata propensione mercantile, spinse i navigatori lusitani a esplorare le coste nordoccidentali dell’Africa e, a dispetto di un non imponente apparato mili34
tare, a occupare significative posizioni quali, per esempio, Ceuta,
presa nel 1415. Grazie all’impulso dell’infante Enrico, soprannominato in seguito Enrico il Navigatore, i portoghesi moltiplicarono i loro
viaggi lungo le coste africane ed entrarono in contatto con il grande
commercio sahariano. Capo Bajador fu doppiato nel 1434, il Senegal
venne raggiunto nel 1444, mentre la leggendaria Costa d’Oro nel
1470. Prima della fine del secolo Diego Cão avrebbe raggiunto il
Congo, Bartolomeo Diaz il Capo di Buona Speranza e Vasco da Gama l’India.
Il consolidamento della presenza portoghese sulle coste occidentali
dell’Africa e la quasi contemporanea colonizzazione delle isole atlantiche – Madeira nel 1419, le Azzorre negli anni 1427-50, e le Isole di
Capo Verde tra il 1450 e il 1460 – incrementarono notevolmente i
traffici commerciali. Una certa dimensione assunse anche il commercio degli schiavi, utilizzati come merce di scambio per rifornire il regno lusitano d’oro. A partire dalla seconda metà del Quattrocento, la
corona iniziò a rilasciare regolari concessioni ai trafficanti, stabilì a
Elmina, una postazione commerciale nella Costa d’Oro e, infine,
diede vita alla Casa dos Escravos, un organismo controllato dal re, attraverso il quale tutto il commercio di schiavi veniva sorvegliato e,
soprattutto, fortemente tassato.
Senza dubbio, l’area in cui maggiormente si concentrarono gli interessi portoghesi fu quella dell’Africa centrale. Il regno del Congo fu
oggetto di grandi attenzioni; in particolare dopo l’ascesa al trono nel
1506 di Nzinga Mbemba, il Portogallo si adoperò per instaurare rapporti di amicizia e di alleanza al fine di assicurarsi traffici e approdi in
quella parte del continente africano. Personaggio di grande levatura,
Dom Alfonso i, nome assunto da Nzinga Mbemba dopo la sua conversione al cristianesimo, organizzò, durante il suo lungo regno
(1506-43), un potente stato che proprio sul commercio degli schiavi
con i portoghesi fondò la sua prosperità. Con l’introduzione nelle
isole atlantiche della coltivazione della canna da zucchero, importata
dalla Sicilia nel 1446, il Portogallo iniziò a sfruttare direttamente la
manodopera servile africana. La prima isola a ospitare piantagioni di
canna da zucchero fu Madeira. Sul finire del secolo la sua produzione
costituiva una quota considerevole di quella mediterranea: su una
popolazione di 15.000-18.000 abitanti, 2.000 erano schiavi. Nelle altre isole atlantiche, le Azzorre e le Isole di Capo Verde, la coltivazio35
ne della canna da zucchero non diede grossi rendimenti a causa del
clima poco favorevole: solo a São Tomé e Principe, isole situate nel
Golfo di Guinea, i Portoghesi ottennero una produzione di qualche
significato. Anche nelle Canarie – spagnole a partire dal 1519 – venne
introdotta la coltivazione della canna da zucchero con buoni risultati. In questo caso la forza lavoro servile utilizzata fu decisamente eterogenea. Innanzitutto i guanches, la popolazione nativa, considerati
dalla corona spagnola pagani, vennero trattati alla stregua degli
schiavi e forzatamente impiegati per il lavoro in piantagione. A questi si deve aggiungere un certo numero di schiavi africani – circa un
migliaio – e, seppur più limitatamente, schiavi provenienti dal continente americano. Secondo lo storico Philip Curtin, tra il 1450 e il
1600, circa 180.000 schiavi furono condotti nelle isole atlantiche dall’Africa, ma altre stime riferiscono numeri molto maggiori. A metà
Cinquecento, circa diecimila schiavi vivevano a Lisbona, poco più di
trentamila nell’intero Portogallo. Le isole atlantiche divennero ben
presto anche una base intermedia, un luogo di transito nel quale gli
schiavi giunti dall’Africa venivano comprati per poi essere condotti
nelle Indie.
In ragione delle continue scoperte geografiche nelle Americhe a opera degli esploratori spagnoli, quando il commercio di schiavi stava
palesemente diventando cruciale nell’impresa di colonizzazione del
Nuovo Mondo, i re portoghesi tentarono di stabilire le regole di
quella che sarebbe diventata agli occhi di molti un’attività assai lucrosa. Le Ordenações Manuelinas, promulgate da Manuel i tra il 1514
e il 1521, sono un chiaro esempio del ruolo imperiale che il Portogallo
avrebbe svolto nel processo di civilizzazione atlantica. Se nella seconda metà del Cinquecento il celebre poeta Luis de Camões celebrava il
destino fatale della nazione portoghese con un’opera, Os Lusíadas
(1572) che esaltava il coraggio e la virtù lusitani, negli stessi anni non
mancarono le prime voci di dissenso. Fernão Oliveira nell’Arte da
Guerra do Mar (1555) fu tra i primi a denunciare vigorosamente la
schiavitù, accusando i suoi compatrioti di essere gli inventori di un
commercio malvagio che consentiva di vendere e comprare pacifici
uomini liberi come fossero animali. L’occupazione e lo sfruttamento
delle isole atlantiche per certi versi potrebbero essere intesi come
un’anticipazione, in scala ridotta, di una vicenda, la colonizzazione
del Nuovo Mondo, di cui Spagna e Portogallo sarebbero stati prota36
gonisti, seppur con specificità assai diverse. Infatti, se da un lato, nell’arco di alcuni decenni, la corona spagnola fu capace di occupare
gran parte del continente sudamericano e altre vaste regioni come il
Messico, la Florida e la Bassa California, sottomettendo le popolazioni native e organizzando un efficiente sistema coloniale, dall’altro i
Portoghesi, ancora a metà del Cinquecento, si muovevano in Brasile
intorno a una poco sviluppata rete di enclave costiere, preferendo un
più modesto commercio alla conquista.
Grazie alle imprese di Cortés e di Pizarro e alla visione imperiale di
sovrani quali Carlo v e Filippo ii, nelle colonie spagnole del Nuovo
Mondo prese corpo una società che, attraverso l’importazione di istituzioni amministrative, giuridiche, politiche e religiose replicava, per
quanto possibile, l’ordine socioeconomico della madre patria, un sistema che gli storici hanno definito come la più elevata forma di feudalesimo. Gli effetti negativi di tale processo di colonizzazione e,
conseguentemente, di sfruttamento delle risorse coloniali, pesarono
drammaticamente sulle popolazioni indigene. Se, secondo alcune stime prudenti, agli inizi del Cinquecento, la popolazione del continente raggiungeva i cinquanta milioni, sul finire del secolo non arrivava a dieci milioni. La popolazione del Messico e dell’America centrale passò dagli 8-15 milioni nel 1520 al milione nella metà del Seicento, stessa sorte toccò alla popolazione andina, che era stimata intorno ai dieci milioni a metà del Cinquecento per scendere, dopo un
secolo, a meno di un milione. Nelle isole caraibiche, una delle prime
aree a essere colonizzate, i nativi praticamente si estinsero in pochi
decenni.
Le cause di un tale tracollo demografico non sono unicamente da imputare all’imposizione dei pesanti regimi lavorativi nei campi o nelle
miniere; lo shock anafilattico provocato dalla grande quantità di microbi che gli Europei diffusero nel Nuovo Mondo, contribuì in larga
parte a questo catastrofico evento. In seguito alle reiterate proteste
provenienti in particolare dagli ambienti religiosi, la corona spagnola
tentò di porre rimedio alla crescente decimazione delle popolazioni
native e alla rapacità dei conquistadores: questo l’obiettivo delle Leggi
nuove del 1542. L’encomienda, la principale istituzione attraverso la
quale un certo numero di indios veniva affidato a un colono con
l’obbligo di prestare servizio nelle sue proprietà, venne così riformata. In questa prospettiva, man mano che il centro del sistema colo37
niale spagnolo si spostava dalle isole all’interno del continente, gli
schiavi africani diventarono una risorsa strategica nel processo di colonizzazione, soprattutto in ragione della loro affidabilità e resistenza
al lavoro rispetto all’inadeguatezza fisica della popolazione indigena.
L’introduzione di schiavi africani avvenne comunque lentamente:
fino al 1550 si aggiravano intorno ai 15.000, ma questo numero era
però destinato in breve tempo a crescere notevolmente. Tra il 1550 e
il 1595, infatti, secondo i dati ufficiali, 36.300 schiavi africani furono
importati nell’America spagnola, cifra che nel periodo 1595-1640 passò a 268.800.
In ragione del trattato di Tordesillas, stipulato con il Portogallo nel
1496, la Spagna non disponeva di basi commerciali sulla costa africana e, conseguentemente, l’arrivo di schiavi nelle sue colonie americane dipendeva da altre nazioni. Poiché però, come ogni altra impresa
economica nel Nuovo Mondo, anche il commercio degli schiavi restava una prerogativa del re, la corona spagnola stabilì che questo fosse regolato attraverso la concessione di licenze assegnate a mercanti,
ai quali veniva, per così dire, appaltata l’organizzazione del traffico.
Attraverso un formale contratto, l’asiento, termine che propriamente
indicava un qualsiasi accordo stipulato tra il sovrano e un privato cittadino ma che, col passare del tempo, divenne sinonimo di contratto
per l’importazione di negri, asiento de negros, si determinarono così
precise condizioni di prezzo e di consegna. Nel 1518, Carlo v assegnò
un primo importante asiento a uno dei suoi cortigiani, l’olandese
Laurent de Gorrevod, che dietro congruo compenso lo cedette a un
consorzio ispano-genovese.
Per quasi tutto il Cinquecento, l’importazione di schiavi africani nelle colonie spagnole continuò con questo sistema ma, a partire dal
1595, la corona optò per un diverso regime; invece di accordare più licenze a diversi soggetti, si decise di concedere il monopolio della tratta degli schiavi a un solo impresario, per un periodo di tempo determinato. Il primo asiento di questo genere fu concluso da Filippo ii
con Pedro Gómez Reynel, il quale si impegnò a trasportare in nove
anni dall’Africa al porto di Cartegena de Indias, nell’attuale Colombia, almeno 31.500 schiavi, con il diritto di venderli al prezzo ritenuto
più adeguato e con l’obbligo di corrispondere alla corona una somma
di 900.000 ducati. Dopo l’asiento concesso a Gómez Reynel, scaduto
nel 1601, la Spagna stipulò simili contratti con trafficanti portoghesi
38
fino al 1640. Resta peraltro difficile stabilire di quanto il contrabbando abbia aumentato le cifre ufficiali. Se pochi furono gli schiavi venduti nelle isole caraibiche, una larga parte fu destinata ai principali
centri urbani di Messico, Perù, Venezuela e Colombia, dove venivano impiegati per svolgere le più disparate mansioni, mentre una certa
quantità di manodopera servile fu impiegata nelle piantagioni di prodotti tropicali, cacao, tabacco, e zucchero in particolare. Contrariamente a quanto si possa pensare, la presenza di schiavi africani non si
concentrò nei distretti minerari, soprattutto quelli andini, dove la
conservazione del sistema incaico di lavoro tributario rendeva più
economico l’impiego di forza lavoro locale. Secondo i dati relativi a
circa trecento dei maggiori centri minerari messicani, sul finire del
Seicento la forza lavoro era composta da 3.690 schiavi, 1.850 spagnoli
e ben 4.450 nativi.
In ogni caso a partire dalla seconda metà del sedicesimo secolo, il
viceregno del Perù, quando le miniere d’argento intorno a Potosí
entrarono in funzione a pieno regime, costituì per la maggior parte
degli schiavi condotti nelle colonie spagnole la meta conclusiva di
una lunga peregrinazione, che in alcuni casi poteva durare fino a
cinque mesi.
Attraversato l’Atlantico, gli schiavi venivano inizialmente sbarcati a
Cartagena, per poi essere convogliati verso il porto di Portobello sull’istmo di Panama. Raggiunta la costa pacifica per terra, venivano
reimbarcati verso Callao, il porto d’accesso alla città di Lima e, una
volta nella capitale peruviana, venivano infine venduti nelle diverse
regioni del viceregno. Un dato generale riguardante la colonizzazione
del Nuovo Mondo va tenuto in considerazione: a partire dai primi
decenni del Seicento, l’immigrazione spagnola su base annua fu
quantitativamente superata dal corrispettivo arrivo di schiavi dall’Africa. Il rovesciamento di questo rapporto comportò una graduale ricomposizione razziale della società: nel 1636 gli abitanti di Lima erano 27.394 di cui ben 14.481 neri o mulatti, e la situazione della capitale peruviana era simile a quella di Città del Messico – 8.000 spagnoli,
8.000 schiavi neri, 1.000 mulatti – e di molte altre città messicane.
Forse però l’aspetto più singolare dell’introduzione della schiavitù
africana nelle colonie spagnole fu quello relativo alla scarsa attenzione che la questione suscitò nelle coscienze. Se il dibattito sulla natura
delle popolazioni indigene e sulla liceità del loro asservimento vide in
39
prima fila i principali esponenti della cultura laica e religiosa spagnola, non si registrò un analogo impegno morale riguardo al tema della
schiavitù africana. Sorprendentemente, coloro che, come Bartolomeo de Las Casas, avevano difeso i diritti degli indios, non trovarono
scandaloso questo commercio. Invero il domenicano ebbe modo di
modificare la sua iniziale opinione in merito, ma pochi lo seguirono
su questo terreno. Fra questi, Tomás de Mercado, un altro domenicano che nel 1569 diede alle stampe un’opera, la Suma de Tratos y
Contratos, contenente un duro atto d’accusa nei confronti del commercio schiavista: una denuncia che in ogni caso indicava come illegittima la pratica e non l’istituzione in quanto tale. Seguendo le orme
del Mercado, nel 1573, Bartolomé de Albornoz nell’Arte de los contratos attribuiva ai commercianti di schiavi la responsabilità di aver violato il diritto naturale alla libertà degli africani e giungeva a condannare quella parte del clero che aveva eluso la questione. A differenza
degli scritti di Las Casas, che ebbero una grande diffusione in tutta
Europa, queste e poche altre opere apertamente ostili alla pratica
schiavista ebbero pochissima ricezione. Il modello spagnolo di organizzazione schiavista, unitamente a quello portoghese, venne accolto
dalle altre potenze coloniali, così come il termine “negro” fu adottato
nella lingua inglese, con una pesante connotazione legata alla riduzione in schiavitù. Ricorda lo storico Robin Blackburn:
Coloro che colonizzarono Providence Island, Giamaica, Virginia e Sud Carolina avevano
in mente con chiarezza la pratica spagnola del commercio schiavista africano, anche se
l’adattamento che ne proposero comportò un mutamento sul senso di cosa significava
essere uno schiavo e un negro, restringendo e appiattendo in entrambi i casi i significati barocchi delle nozioni spagnole di razza e schiavitù.
A partire dalla seconda metà del Cinquecento, le crescenti difficoltà
commerciali in Asia e in Africa indussero la corona portoghese a prestare maggiore attenzione al Brasile e alle sue enormi potenzialità
economiche. Per lungo tempo, questo territorio coloniale, diviso in
dodici capitanerie, era stato utilizzato dai portoghesi come un semplice approdo, il cui interno restava quasi sconosciuto. La principale
produzione brasiliana restava il legno tintorio, non essendo stato scoperto alcun importante giacimento di metalli preziosi né essendo stata avviata alcuna coltivazione intensiva. Generalmente, il decollo del40
l’economia brasiliana viene collegato alle dinamiche iniziative del governatore Mem de Sá (1557-72): la produzione di zucchero di canna
ne fu l’elemento trainante. Ma per sostenere adeguatamente lo svilupparsi del sistema delle piantagioni era essenziale la disponibilità di
una consistente forza lavoro servile.
Poiché così come nell’America spagnola anche in Brasile gli indigeni
non potevano soddisfare a pieno questa necessità, il mercato africano
risultò essere una valida alternativa. In trent’anni, dal 1570 al 1600, il
numero degli schiavi africani passò da 3.000 a 15.000, per giungere a circa 200.000 a metà del Seicento. Circa nello stesso periodo, gli zuccherifici triplicarono: da 115 nel 1583 a 350 nel 1629. In pochi decenni la produzione di zucchero brasiliano assunse quindi dimensioni assai considerevoli, così come l’esportazione del prodotto sul mercato europeo.
Malgrado il passaggio del Portogallo sotto il dominio spagnolo
(1580) e le minacce che gravavano sul traffico marittimo atlantico dovute alle turbolenze politiche europee, lo zucchero brasiliano divenne
una fonte di ricchezza insostituibile per le casse portoghesi. La crescita del commercio atlantico di schiavi finì anche per trasformare la natura della presenza portoghese in Africa. Oltre a consolidare la rete di
approvvigionamento di merce umana già esistente, i Portoghesi stabilirono nuovi contatti con i regni del Sud-Ovest e dell’Africa centrale, dando vita, come nel caso dell’Angola, a stabili insediamenti coloniali. All’inizio del Seicento i Portoghesi detenevano ancora il monopolio virtuale sulla fornitura di schiavi per il Nuovo Mondo; la loro
abilità nel penetrare nei sistemi commerciali e politici africani e nell’organizzare una propria rete di rifornimento di schiavi, permise che
10.000-20.000 schiavi ogni anno attraversassero l’Atlantico. Come in
Spagna anche in Portogallo non furono in molti ad opporsi al commercio africano; l’attenzione si rivolse infatti prevalentemente alle
condizioni degli indios. In questo senso resta esemplare il coraggio
morale di uomini come il gesuita António Vieira, che continuò l’azione di denuncia intrapresa da Las Casas.
Per riassumere...
• Il Portogallo fu la prima nazione europea a entrare in contatto con la
realtà africana anche se, inizialmente, le spedizioni portoghesi si limitarono a brevi permanenze sulle coste nordoccidentali dell’ignoto continente.
41
• Agli inizi dell’età moderna la società europea e la società africana pre-
sentavano alcuni tratti per certi versi simili. La schiavitù era pratica ben
nota in Africa e una considerevole circolazione di merce umana faceva
fronte sia alla domanda del mercato interno sia a quella del mercato
islamico.
• Prima ancora che il commercio atlantico di schiavi assumesse i suoi
definitivi connotati, nella cultura europea incominciarono a definirsi pregiudizi sugli africani e sulla loro diversità/inferiorità razziale. Nell’Inghilterra elisabettiana e giacobita, questo processo fu particolarmente evidente. La colonizzazione e lo sfruttamento delle isole atlantiche attraverso
l’impiego di manodopera servile fu una sorta di anticipazione in scala ridotta della colonizzazione e dello sfruttamento ispano-portoghese nel
Nuovo Mondo.
• La Spagna, in particolare, definì rapidamente le modalità dell’impresa
coloniale; l’asiento , un contratto stipulato tra la corona spagnola e un privato cittadino, fu la formula adottata per soddisfare la crescente domanda
di schiavi proveniente dalle colonie americane.
42