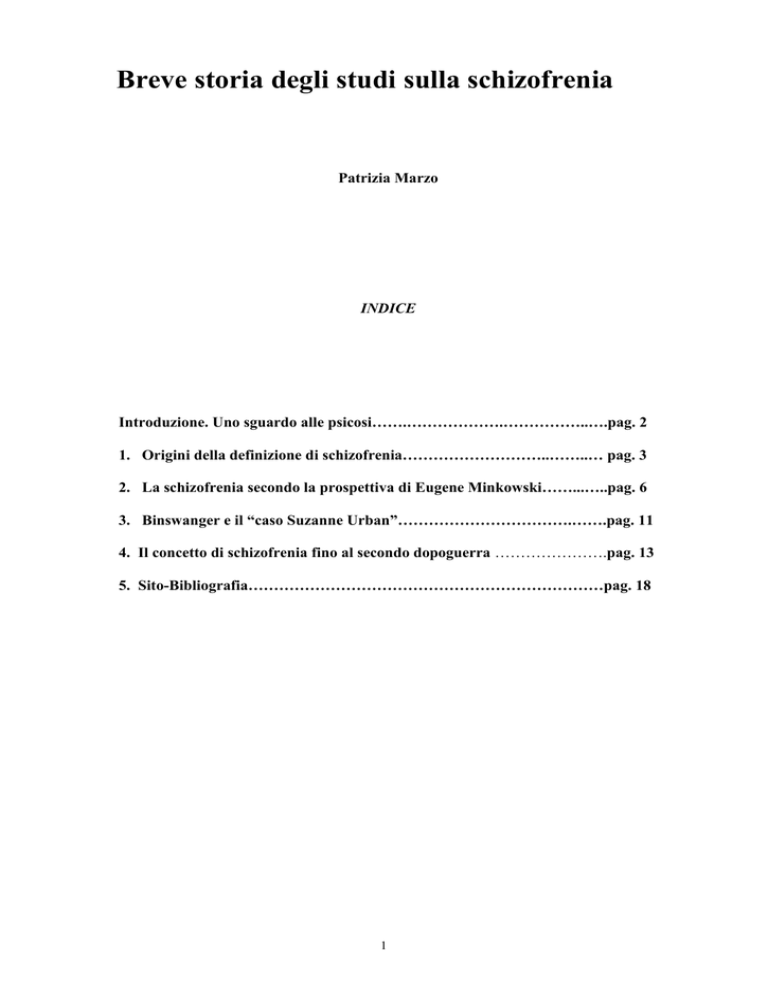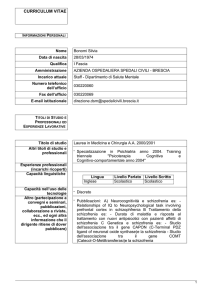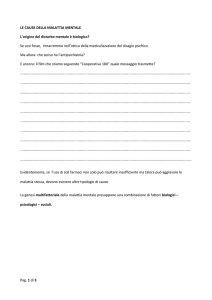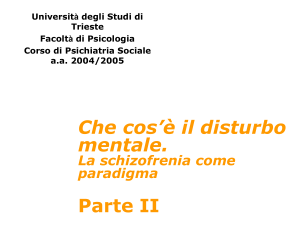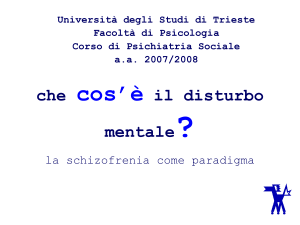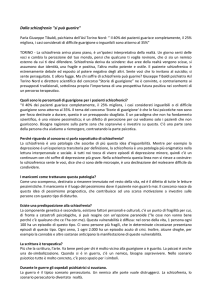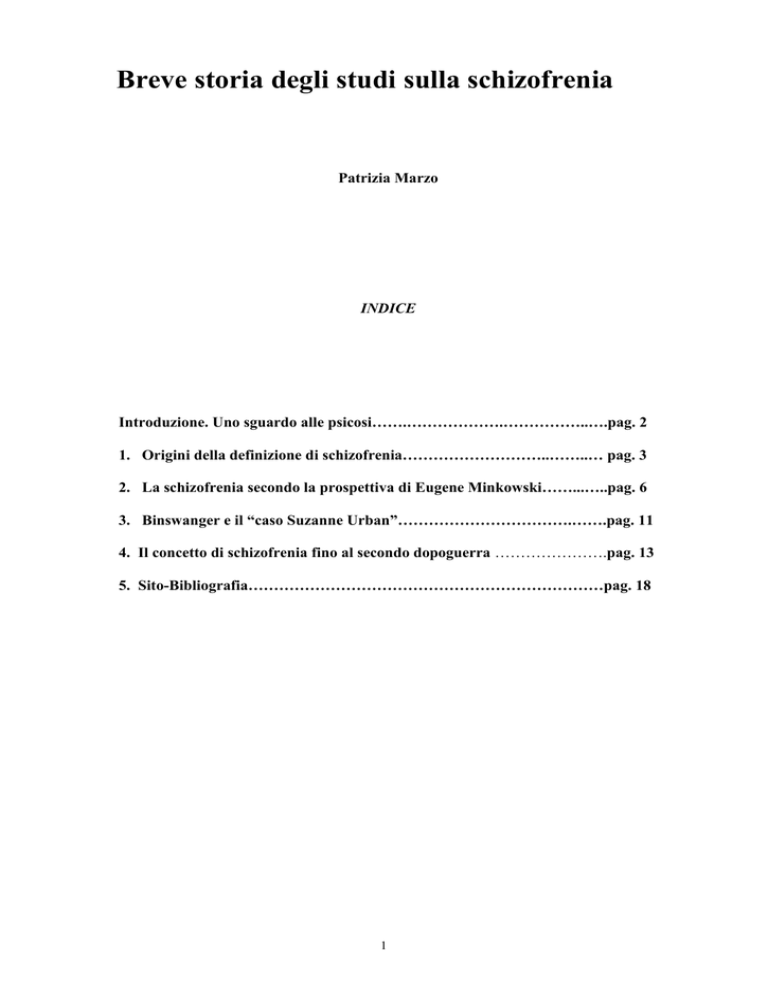
Breve storia degli studi sulla schizofrenia
Patrizia Marzo
INDICE
Introduzione. Uno sguardo alle psicosi…….……………….……………..….pag. 2
1. Origini della definizione di schizofrenia………………………..……..… pag. 3
2. La schizofrenia secondo la prospettiva di Eugene Minkowski……...…..pag. 6
3. Binswanger e il “caso Suzanne Urban”…………………………….…….pag. 11
4. Il concetto di schizofrenia fino al secondo dopoguerra ………………….pag. 13
5. Sito-Bibliografia……………………………………………………………pag. 18
1
Introduzione. Uno sguardo alle psicosi
Il tema delle psicosi, introdotto nella disciplina psichiatrica durante il XIX secolo, è
stato progressivamente arricchito da conoscenze e competenze che nel tempo si sono
rafforzate, fino a costituire un sapere ampiamente condiviso. Oggi molti autori concordano
sulla definizione delle psicosi, sulle loro differenze dalle nevrosi e su una classificazione che
comprende diverse connotazioni della malattia. La suddivisione “classica” fra nevrosi e
psicosi colloca le prime nelle forme funzionali dei disturbi mentali e le seconde nell’insieme
dei disturbi organici, ossia quei problemi connessi a vere e proprie lesioni della struttura
cerebrale. Col passare del tempo, tuttavia, tale classificazione ha subito profondi
ripensamenti, soprattutto mediante l’estensione della connotazione di psicosi non solo alle
manifestazioni prettamente organiche, ma anche a tutte quelle configurazioni dis-funzionali
dei processi mentali che, a tutt’oggi, non trovano spiegazioni esaustive nei progressi della
scienza.
Diversi studiosi, comunque, riconoscono generalmente una duplice manifestazione
delle psicosi, sia a livello psicopatologico (in relazione alla gravità e alla possibile
irreversibilità del decorso del disturbo) sia a livello sociale (in relazione alla condizione di
disadattamento sociale del malato, alle sue difficoltà di comunicare ed interagire con gli altri e
al suo scarso contatto con la realtà).
Le psicosi sono caratterizzate da una forte componente soggettiva, costituita dalle
condizioni della singola personalità malata: elemento che rende le osservazioni dei medici
non generalizzabili ed inquadrabili in rigidi modelli. La variabilità delle definizioni delle
psicosi, inoltre, dipende anche dai differenti indirizzi di studio della psichiatria e della
psicologia che, sommariamente, confermano le due macro-aree dell’impostazione
organogenetica (secondo la quale un fattore tossico e/o costituzionale sarebbe alla base di
ogni disturbo mentale) e di quella psicologica (che, invece, attribuisce la causa delle patologie
a degenerazioni di disturbi inizialmente “solo” psicologici).
I fattori che generalmente vengono identificati con le cause delle psicosi sono di
ordine organico (come la psicosi acuta confusionale, che viene attribuita ad una condizione
tossica o tossinfettiva), costituzionale (nel senso della predisposizione ereditaria di alcune
forme) e psichico.
I sintomi
più
facilmente riscontrabili
nei
quadri psicotici
riguardano la
percezione/consapevolezza della posizione del sé nel mondo: il mondo viene percepito dal
2
soggetto in modo distorto, incomprensibile per chi lo circonda, popolato da allucinazioni,
fissazioni, stati maniacali e progressiva perdita degli affetti.
La persona psicotica può vivere – secondo la gravità del suo disturbo – per poche ore
oppure per lunghi anni in uno stato di oggettiva e profonda difficoltà di capire il mondo e di
essere, a sua volta, compresa da esso.
Ad ogni modo, per quanto controverse ed, ancora oggi, indefinite siano le
rappresentazioni dei disturbi psicotici, la scienza dispone ormai di elementi più che sufficienti
per definire “la schizofrenia come la psicosi per eccellenza”1.
1. Origini della definizione di schizofrenia
Esiste davvero la schizofrenia? E, in caso affermativo, in cosa consiste, quali sono i
suoi confini?
Numerosi studiosi tentano da oltre un secolo di dare - a questi e a molti altri
interrogativi sulla psichiatria - risposte il più possibile condivisibili ed inscrivibili nella
prospettiva olistica della condizione umana. Ad oggi, tuttavia, la ricerca di una definizione
chiara, unitaria ed esaustiva della patologia, appare ancora un “oggetto in costruzione”, una
sorta di carburante che alimenta senza sosta il dibattito sulle cause e gli effetti di questa forma
di malessere individuale e (inevitabilmente) sociale.
Nella prefazione italiana del libro di Jean Garrabè2, in relazione ad una possibile
definizione di schizofrenia, viene ribadita l’assenza di un confine preciso della patologia. Le
molteplici componenti che costituiscono e caratterizzano la schizofrenia interessano, infatti,
ambiti vitali profondamente differenti e, almeno in apparenza, tanto lontani fra loro da indurre
l’Autore – in maniera provocatoria – a chiedersi, appunto, “se” la patologia esista davvero.
Al fine di contribuire ad una possibile definizione della schizofrenia e dei suoi pesanti
condizionamenti nella vita delle persone, Garrabè realizza nel suo libro un importante lavoro
di ricostruzione storica dello studio della patologia. Egli individua nel 1911 il momento
cruciale in cui inizia il passaggio culturale dalla mera considerazione dei sintomi e dei
comportamenti patologici – che nei secoli erano stati osservati e, in linea di massima,
giudicati, condannati, istituzionalizzati e stigmatizzati - alla ricerca di una eziologia della
schizofrenia e all’elaborazione di ipotesi metodologiche funzionali all’aiuto e al recupero dei
malati.
1
Giovanni Jervis, Manuale critico di psichiatria, Feltrinelli, Milano, 1975, pag. 302
Jean Garrabè, Storia della schizofrenia, ed. Ma.Gi, Roma, 2001. La prefazione e la traduzione sono curate da
Marco Alessandrini
2
3
Il dibattito scientifico sulla definizione della schizofrenia aveva preso avvio già
diversi anni prima con il lavoro di Benedict Augustin Morel (1809-1873) sulla nozione di
dementia praecox, che egli descrisse
come un disturbo mentale caratterizzato
prevalentemente dall’insorgenza precoce, dalla rapidità dell’evoluzione e dall’esito inevitabile
(demenza effettiva).
Questo ragionamento aveva introdotto l’elemento innovativo della degenerazione,
ossia l’idea di deviazioni patologiche trasmissibili per via ereditaria destinate a provocare il
decadimento psico-fisico della vittima. Per la prima volta i saperi psichiatrici furono orientati
non solo all’osservazione clinica, ma anche ad una prospettiva dinamica/evolutiva e ad
un’attenzione all’eziologia del disturbo.
Le scoperte di Morel erano avvenute in un momento particolarmente importante per la
scienza e la storia della psichiatria. A partire dal 1845, erano già stati avviati gli studi relativi
alle psicosi, che in Germania (la Prussia di allora) seguirono fino alla fine del secolo due
grandi correnti di pensiero: quella dei “Somatiker”, che attribuivano alle psicosi un’origine
organica, e quella molto più diffusa degli “Psychiker” che, al contrario, sostenevano le origini
psichiche della malattia.
In quel periodo, il mondo accademico franco-prussiano era impegnato nell’analisi del
problema concernente la classificazione delle malattie mentali, dividendosi fra l’ipotesi
dell’esistenza di diverse tipologie di psicosi e l’idea – predominante – di un’unica psicosi,
suddivisa in vari stadi di gravità, caratterizzati da sintomi e manifestazioni differenti.
Negli ultimi anni del 1800, ulteriori elementi di grande innovazione per gli studi
psichiatrici furono introdotti dagli studi di Emil Kraepelin sulla dementia praecox. Lo
psichiatra prussiano pubblicò, fra la fine del 1800 ed il 1900, ben otto edizioni del suo celebre
“Trattato”.
In particolare, nella quinta edizione della sua opera, l’Autore confermò l’evoluzione di
alcune malattie mentali (dementia praecox, catatonia e dementia paranoide); nella sesta
edizione egli considerò la dementia praecox una malattia che può evolvere in tre differenti
tipologie: ebefrenica, catatonica e paranoide. Quest’ultima classificazione della demenza –
che aveva conferito a Kraepelin una fama internazionale – suscitò, tuttavia, anche pesanti
critiche da parte di altri studiosi appartenenti alle Scuole francesi e russe (come Jules
Christian e Vladimir Serbski), i quali sostanzialmente gli contestarono i seguenti argomenti:
a) la compresenza in un’unica malattia di sintomi eccessivamente differenti;
b) la possibilità di poter effettuare una diagnosi solo a “degenerazione avvenuta” e
non all’insorgenza della patologia, secondo i canoni classici della medicina;
4
c) la mancanza di
chiarezza nell’interpretazione eziologica della malattia
(determinata secondo Kraepelin da un’autointossicazione di origine sessuale);
d) la quasi totale esclusione degli strumenti allora disponibili di analisi psicologica.
Nell’ottava ed ultima edizione del suo “Trattato”, concluso nel 1913, Kraepelin prese
in seria considerazione le critiche dei suoi colleghi ed elaborò un’ultima ipotesi di
classificazione, nella quale la dementia praecox venne sostituita dalle demenze endogene
(comprendenti la demenza precoce e le parafrenie), la paranoia fu completamente separata da
questo gruppo e fu reintrodotta l’analisi psicologica del paziente.
Il definitivo passaggio dal concetto di dementia praecox a quello di schizofrenia
avvenne proprio nel 1911 con la pubblicazione degli studi di alcuni fra i più importanti
psichiatri e psicoanalisti dell’epoca, quali Eugen Bleuler, Sygmund Freud, Carl Gustav Jung
ed un quarto autore sconosciuto, considerati i fondatori della moderna psichiatria.
Fu Bleuler a coniare il termine “schizofrenia” per indicare – in aperta rottura con i
suoi colleghi predecessori e soprattutto con Kraepelin – la condizione di separazione delle
diverse funzioni della mente umana e, quindi, la scissione (ma anche la dissociazione, la
dislocazione, la discordanza) della personalità dell’individuo. Per Bleuler la dementia
praecox si suddivideva in quattro gruppi di malattie: la forma paranoide, la catatonia,
l’ebefrenia e la schizofrenia semplice. Per quanto concerne la forma schizofrenica, Bleuler era
convinto che non si trattasse di una patologia destinata alla cronicizzazione e al
deterioramento cognitivo della persona sofferente, anche perché egli ipotizzò che la malattia
fosse suddivisa in una forma semplice, più curabile poiché caratterizzata da sintomi manifesti,
ed in una forma latente, più complessa ed irreversibile.
Secondo Bleuler, le origini della schizofrenia erano di natura psichica più che organica
e ciò spiegava il perché i disturbi dei soggetti malati erano spesso di carattere
comportamentale e relazionale più che di tipo cognitivo. Di conseguenza, egli inquadrava
nella patologia schizofrenica le forme di autismo, ambivalenza, anaffettività e alterata
associazione di idee: disturbi non necessariamente compresenti con una scarsa intelligenza.
Nello stesso periodo, Jung adottava, nei confronti dei pazienti cui era stata
diagnosticata la psicosi schizofrenica, terapie di tipo psicoanalitico. In quegli anni egli curava,
fra gli altri, anche una paziente molto particolare, Sabina Spielrein, una giovane ebrea
tedesca cui Jung aveva diagnosticato una forma di “psicosi isterica” e per il cui trattamento
egli aveva più volte chiesto l’aiuto di Freud (con il quale – a partire dal 1906 – intrattenne una
regolare corrispondenza che durò per quasi sette anni). Il caso della Spielrein ebbe un esito
positivo, al punto che la stessa riuscì a portare a compimento i suoi studi in medicina e in
psichiatria. In quest’ultimo ambito Sabina Spielrein è ricordata come la prima studiosa delle
5
connessioni fra l’istinto di morte ed autodistruzione con quello sessuale e procreatore. Solo di
recente è stata rivelata l’importanza che il legame sentimentale fra la giovane studiosa e
l’affermato psichiatra Jung ha rivestito per la storia della psichiatria3.
Circa la presenza e la funzione degli istinti nei quadri psico-patologici, Jung, al
contrario della Spielrein, era fortemente convinto dell’esistenza di un unico istinto di vita, che
non consentiva differenziazioni fra l’istinto sessuale, quello di conservazione, di
autodistruzione, ecc. Lo studio degli istinti, sul quale si era avventurata con tanto impegno
anche la Spielrein, fu in quel periodo di grande importanza per la comprensione e per i primi
tentativi terapeutici (soprattutto) dell’autismo.
Anche Freud si occupò dello studio degli istinti ed in particolare del concetto di
libido, ossia una forma di impulso sessuale (e non solo): nel 1911 veniva pubblicato un suo
lavoro sulla follia del “Presidente Schreber”, ispirato al caso di un magistrato sassone
gravemente affetto da una patologia mentale, alla cui base Freud ipotizzò un istinto
fortemente represso di tipo omosessuale e persecutorio. La pubblicazione suscitò
un’eccezionale risonanza nel mondo accademico della psichiatria di allora e, in particolare,
stimolò Jung ad approfondire l’idea della libido come elemento completamente distaccato dal
mondo esterno nelle forme di demenza precoce.
Nel decennio immediatamente precedente la Prima guerra mondiale, in relazione agli
studi sulle psicopatologie e sulle terapie psicoanalitiche, determinante fu l’esperienza
dell’equipe guidata da Freud e composta da esperti di valore ancora oggi fondamentale per la
psichiatria, quali, oltre Jung, Eitington, Binswanger, Abraham, Ferenczi.
Freud introdusse nel 1914 il concetto di narcisismo quale forma di pulsione sessuale
patologicamente orientata al proprio Io, avente un ruolo fondamentale nelle patologie
dell’autismo parziale e nelle nevrosi narcisistiche (queste ultime definite dall’Autore anche
come parafrenie). In quel periodo, diversi studiosi approfondirono le connessioni fra
schizofrenia e istinto di morte, riprendendo e spesso appropriandosi – come, del resto, fece
anche Freud - delle originali e sottovalutate intuizioni di Sabina Spielrein. In particolare
Freud, condizionato dalla prospettiva dualistica degli istinti, produsse una visione di
contrapposizione fra “eros e thanatos” (amore/vita e odio/morte) che pose in diretta relazione
causale con la schizofrenia.
In proposito appare di grande interesse anche il film di Roberto Faenza, “Prendimi l’anima”, del 2002, che tenta di
focalizzare anche i periodi della vita della giovane psichiatra successivi alla relazione con Jung.
3
6
2. La schizofrenia secondo la prospettiva di Eugene Minkowski
Un’innovativa interpretazione della schizofrenia fu offerta negli anni compresi fra le
due Guerre mondiali da Eugene Minkowski, una delle più importanti figure della storia della
psichiatria. La sua vita (San Pietroburgo 1885 – Parigi 1972) è stata caratterizzata dalla sintesi
di tre grandi passioni: lo studio della psichiatria, la riflessione filosofica e l’attività medica
intesa come una sempre rinnovata relazione fra la duttilità del terapeuta e la rigidità dei
pazienti; tutto ciò affrontato con quella “armonia con la vita”, come la definì sua figlia
Jeannine, che gli consentì una straordinaria produzione di intuizioni e approfondimenti teorici
e operativi.
Al di là di tutte le “scoperte” di carattere teorico e metodologico - fonti di ispirazione
per diverse generazioni di psichiatri - Minkowski improntò il suo agire professionale sulla
difesa irremovibile dell’importanza dei processi di identificazione terapeuta-paziente e
sull’accettazione del “diverso”, quale segno prioritario della “responsabilità” della persona
sana nei confronti di quella malata.
Sul piano filosofico – che riteneva naturalmente connesso alla psicopatologia Minkowski fu fortemente condizionato dal pensiero di Henri Bergson, che superava il
positivismo attribuendo all’intuizione e all’istinto una funzione di primaria importanza per la
ragione umana. Per quanto concerne, invece, il rapporto con i colleghi, Minkowski si schierò
con la maggior parte degli psichiatri suoi contemporanei nella critica all’eccessiva rigidità
della classificazione di Kraepelin, pur riconoscendone il grande valore nella diagnostica e
nella nosografia. Nella “storica” clinica svizzera di Burgholzli, egli affiancò per diversi anni
Bleuler negli studi sulla schizofrenia ed ebbe importanti confronti con studiosi del calibro di
Jung, Spielrein, Binswanger, Abraham e Freud. In particolare, Minkowski fu decisamente
attratto dall’esperienza psicoanalitica di quest’ultimo, comprendendo – a differenza di altri
suoi colleghi – il valore del confronto fra le due discipline, al punto da contribuire alla
costituzione di un’associazione (la Evolution Psychiatrique) avente l’obiettivo di tutelare il
rapporto teorico e metodologico fra psichiatria e psicoanalisi.
Nel suo testo sulla schizofrenia4, che Minkowski pubblica nel 1927, egli muove dalle
considerazioni di Bleuler sulle origini ereditarie della malattia ed, in particolare, sulla sua
distinzione fra la “forma latente” e la “forma manifesta”, molto meno frequente, che veniva
studiata nei manicomi. Minkowski riconosce all’interpretazione ereditaria un indubbio valore
causale del fenomeno patologico, tuttavia preferisce analizzare con maggiore attenzione la
nosologia della schizofrenia – già avviata da studiosi come Kretschmer, Bleuler, Delmas e
4
E. Minkowski, La schizofrenia. Psicopatologia degli schizoidi e degli schizofrenici, ed. G. Einaudi, Torino, 1998
7
Boll – che distingue la malattia nelle due macro-tipologie di sintonia e di schizoidia (che in
Kretschmer si suddivide a sua volta in cicloidia, schizotimia e ciclotimia). Anche se non in
modo pedissequo, alla prima vengono ricondotti gli aspetti psicopatologici (come quelli
maniaco-depressivi) che non impediscono al soggetto malato di percepire ed avere relazioni
significative con gli elementi essenziali dell’ambiente che lo circonda. Al contrario, nella
schizoidia (o schizofrenia) la persona è completamente avulsa dal contesto ambientale e
relazionale cui appartiene, non si lascia attraversare/contaminare da ciò che è esterno ad essa.
Minkowski spiega che tale fondamentale e dolorosa peculiarità della schizofrenia non
è generata dalla diminuzione di una funzione intellettiva piuttosto che di un’altra: la lesione
che costituisce la malattia interessa trasversalmente tutte le funzioni mentali del soggetto,
poiché disturba ed impedisce la loro connessione armonica. Spesso gli studiosi hanno
rimarcato – ciascuno a suo modo – che, a differenza del demente, lo schizofrenico possiede
tutte le facoltà mentali di un’intelligenza “normale”, ma queste appaiono “scombinate” fra
loro, prive di nesso, come “un libro completo non rilegato con le pagine in disordine”.
Minkowski non condivide pienamente questa interpretazione “definitiva” della malattia e cita
gli studi di Henry Bergson sulla contrapposizione fra concetto di istinto e di intelligenza, che
collocano i dati più importanti della coscienza e dell’intelletto umano (l’affettività, le
sensazioni, gli stimoli, i riflessi,..) nella sfera irrazionale. Il disturbo essenziale della
schizofrenia diviene, pertanto, la perdita del contatto vitale con la realtà, concetto di cui
Minkowski rivendica una buona quota di paternità e che esprime più di ogni altro
l’orientamento ed il pensiero dell’Autore.
Nel testo di Minkowski, le argomentazioni sulla perdita del contatto vitale con la realtà
sono ricercate ed individuate nella pratica medica quotidiana: vengono messi a confronto casi
gravissimi di paralisi generale nella fase di rimbambimento e casi altrettanto disperati di
persone schizofreniche i cui comportamenti manifesti appaiono ad una prima osservazione
molto simili.
A differenza dei primi, negli schizofrenici si possono notare soprattutto l’assenza di
senso
statico
(ossia
il
significato
dell’essere
“io-qui-adesso”),
una
marcata
depersonalizzazione (manca l’affermazione dell’io), l’assenza del fattore pragmatico (gli
schizofrenici perdono interesse nei confronti dello scorrere del tempo e della loro
collocazione nello spazio) e l’interruzione del dinamismo mentale (i soggetti percepiscono se
stessi e la realtà circostante come elementi immobili, manca la percezione della durata di un
avvenimento).
Circoscritto entro precisi limiti, l’isolamento dal mondo viene riconosciuto fisiologico
anche da Minkowski, che considera tale atteggiamento un’esigenza reale di ogni essere
8
umano; al contrario, l’isolamento della persona schizofrenica, unito ai tratti prima delineati,
diviene una delle componenti più dannose, in quanto essa spinge l’individuo a sviluppare un
agire improntato al cosiddetto “razionalismo morboso”, ossia ad un irrigidimento eccessivo
nei parametri logico-matematici della realtà e ad una contestuale diminuzione delle capacità
affettive ed emozionali.
L’isolamento della persona schizofrenica rispetto alle proprie reti parentali e sociali,
oltre che essere fonte di grande sofferenza per il paziente e per coloro che lo circondano,
rappresenta, tuttavia, l’elemento strategico nell’impostazione della terapia: mediante
un’efficace lettura delle citate reti da parte del terapeuta, è possibile infatti “realizzare una
strategia terapeutica capace di sottrarre il malato al processo di destoricizzazione che lo
allontana dall’Altro, per restituirlo alla sua storicità essenziale, e quindi alla pienezza e alla
libertà della sua compresenza.”5
Condizione ancora diversa è rappresentata dall’autismo, che Bleuler definisce “il
distacco dalla realtà e la predominanza della vita interiore”, un isolamento estremo del malato
causato dalla completa chiusura del suo mondo interiore ad ogni possibile contatto con la
realtà. Eugenio Borgna6, facendo proprie le considerazioni di Bleuler, afferma l’esistenza di
un autismo schizofrenico, ossia l’autismo come sintomo primario dell’esperienza psicotica,
decisamente differente per categorie sintomatologiche dall’autismo depressivo, le cui
diversità dalla forma schizofrenica vengono così sintetizzate dall’Autore:
“Se nell’autismo schizofrenico il distacco dalla realtà è oscillante nelle sue forme di espressione, e la
vita interiore è solcata dall’irrompere dell’immaginario (del fantasmatico) e dalla presenza, a volte, di una riverie
straziante, nell’autismo depressivo le cose sono diverse: non c’è questa epifania dell’immaginario e la
separazione dal reale è più radicale”7.
Secondo Minkowski esiste un “pensiero autistico” contrapposto ad uno “realistico”,
ossia il distacco totale dalla realtà (tipico della condizione patologica) in antitesi rispetto al
quotidiano “fare i conti” con la realtà per ricavare la massima soddisfazione dei propri bisogni
(come accade nella condizione fisiologica).
Fra le altre ipotesi nosologiche dell’autismo, vi è la distinzione fra quelle che
Minkowski definisce la forma ricca e la forma povera della malattia: l’una caratterizzata da
uno stretto rapporto con il sogno e con le fantasticherie (il fenomeno della rèverie) – al punto
da consentire al soggetto disturbato di vivere in un mondo immaginario – e l’altra che, invece,
M.Galzigna, “Binswanger e le strutture della presenza”, in L. Binswanger, Il caso Suzanne Urban, ed. Marsilio,
Venezia, 2001, pag. 51.
6
E. Borgna, Malinconia, Feltrinelli, Milano, 1992
7
E. Borgna, op. cit. pag. 88
5
9
riflette il più assoluto e drammatico vuoto o, per dirla con l’Autore “il soffio glaciale della
demenza affettiva”. Per lungo tempo gli studiosi hanno creduto in un presunto aspetto
“totalizzante” della rèverie nei confronti della schizofrenia, quasi che la persona malata
vivesse esclusivamente immersa nel suo mondo fantastico, ma progressivamente tale
prospettiva è stata ridimensionata. Esiste, infatti, anche nell’autismo, una sorta di “attività”,
anche se non pienamente coerente con la realtà e priva della consapevolezza degli obiettivi e
dell’importanza del loro conseguimento.
Minkowski riconosce, dunque, una rèverie normale – che, anche quando assume la
forma più incidente, viene costantemente affiancata dalla coscienza latente della realtà - ed
una morbosa, frutto inequivocabile della patologia schizofrenica, caratterizzata dalla
concentrazione del soggetto malato su pochissime idee e fantasie, reiterate costantemente .ed
in maniera stereotipata.
Insieme all’interiorizzazione e alla rèverie morbosa, altri tipici atteggiamenti
schizofrenici sono individuati da Minkowski nei malumori morbosi (costituiti da un
ripiegamento del malato su se stesso con produzione di comportamenti rabbiosi, collerici,
intolleranti e melanconici), nei cosiddetti rimpianti morbosi o atteggiamenti interrogativi,
ossia la mancanza di ogni capacità di immaginazione/proiezione/progettazione nei confronti
del tempo futuro, una sorta di continuo ritorno del soggetto malato sul suo tempo trascorso,
costituito da onnipresenti rimpianti e da una fossilizzazione del comportamento sulla costante
“interrogazione” delle scelte prese in passato e delle soluzioni trovate.
In questo caso l’atteggiamento interrogativo diviene l’unico legame significativo del
soggetto con il mondo esterno. Un ulteriore frequente atteggiamento schizofrenico è costituito
dalle stereotipie psichiche: movimenti corporei reiterati in modo esasperato, allo scopo di
riempire quei “vuoti” che la patologia determina fra la persona sofferente e l’ambiente
esterno.
Circa la probabilità di guarigione della persona schizofrenica, Minkowski chiarisce in
modo inequivocabile la grande influenza che assume la qualità del rapporto terapeutico fra
medico e paziente e, ancor di più, la convinzione e la consapevolezza da parte degli psichiatri
della “curabilità” dei malati: per l’Autore è infatti determinante, ai fini della cura e della
guarigione, che il medico non abbandoni mai la relazione – pur problematica e talvolta
apparentemente “impossibile” – dialogica ed empatica con il paziente.
Minkowski nel 1927 ha tracciato un’importante linea di demarcazione nella storia
della psichiatria distinguendo, forse per la prima volta, gli “eccessi” della nosologia e degli
“intellettualismi” sulla schizofrenia dall’esigenza di incentivare nel malato e nel rapporto
terapeutico gli aspetti più propriamente emotivi ed affettivi.
10
3. Binswanger e il “caso Suzanne Urban”
A partire dal secondo dopoguerra le osservazioni, gli studi e le pubblicazioni sulla
schizofrenia si moltiplicarono velocemente in Europa e in Nord America, a causa della
sempre crescente attenzione al problema e ai progressi della ricerca e delle terapie.
Nel 1952 fu pubblicato il testo di Ludwig Binswanger “Il caso Suzanne Urban, storia
di una schizofrenia”, una dettagliata riflessione su un caso di psicosi, destinata a mutare
definitivamente il corso degli studi psichiatrici, anche se la straordinaria vicenda umana e
professionale rappresentata dal rapporto terapeutico instaurato fra Binswanger e Susanne
Urban era, per la verità, iniziata diversi anni prima.
Nell’introduzione al testo di Binswanger8, Eugenio Borgna evidenzia le principali
correlazioni fra i tratti costitutivi della malattia della Urban e l’elaborazione della
Daseinsanalyse, ossia l’”analisi della presenza”, un approccio metodologico all’analisi
psichiatrica di tipo filosofico/fenomenologico, fondato sul rapporto che si instaura fra la
condizione del paziente psicotico e la sua percezione di “essere nel mondo”. Fu proprio
Binswanger ad introdurre per primo la Daseinsanalyse, movendo dalla considerazione della
condizione umana non limitata alla “semplice” esistenza, ma intesa come dasein, ossia esserenel-mondo, ossia essere in continuo mutare.
Si tratta di una costruzione che risente fortemente delle influenze filosofiche
dell’esistenzialismo (in quegli anni rappresentato soprattutto da Heidegger) che condizionò,
oltre l’Autore, numerosi altri studiosi delle “scienze umane”, come Minkowski, Strauss e
Cargnello in Italia. Mediante la Daseinsanalyse, Binswanger intendeva dimostrare che <<una
psichiatria è impossibile senza un antropologia e [egli] nei suoi malati ha cercato l’”uomo”,
l’”essere umano”, tentando di vedere ciò che lo rende più o meno umano. La Daseinsanalyse,
quindi, cerca attraverso il curriculum della storia di un individuo, attraverso la “storia della
vita interiore”, la “categorialità di fondo” dell’essere di quell’individuo, cerca il suo “a-priori
esistenziale”, lo specifico modo in cui quell’individuo progetta il mondo, conferendo un
significato a cose, eventi, rapporti.>>9.
Secondo Mario Galzigna – nell’introduzione al medesimo testo di Binswanger10 l’insorgenza della malattia mentale è conseguente ad un progetto-di-mondo (Dasein) limitato
e ridotto ad un’unica idea che predomina tragicamente tutta la prospettiva esistenziale di un
individuo: nel caso di Suzanne Urban, l’unica idea dominante il suo orizzonte di vita è una
8
L. Binswanger, Il caso Suzanne Urban, a cura di E. Borgna e M. Galzigna, ed. Marsilio, Venezia, 1994
G. Reale e D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. 3, ed. La Scuola, Brescia, 1983, pag. 475
10
L. Binswanger, Il caso Su zanne Urban, op.cit.
9
11
tremenda angoscia che scaturisce da un delirio di persecuzione. Binswanger diagnosticò
senza esitazione alla sua paziente una forma di schizofrenia, spiegando poi nel suo testo di
avere una visione della malattia di carattere decisamente antropoanalitico, basata su elementi
ben precisi come il superamento del dualismo fra soma e psiche, l’interpretazione di sintomi
come “intermittenze”, le temporanee interruzioni dell’esserci, una dimensione esistenziale
spazio-temporale completamente sopraffatta dall’orrore.
L’approccio antropoanalitico in Binswanger emerge anche sul piano metodologico
oltre che teoretico, poiché egli cercò di incontrare le persone sofferenti nei loro aspetti
esistenziali complessivi, redigendo successivamente ad ogni incontro una dettagliata
descrizione dei sintomi, delle condizioni dei disturbi e degli effetti delle terapie intraprese.
Nella relazione sul caso di Suzanne Urban, il terapeuta effettua una minuziosa
anamnesi della paziente, dalla quale emergono elementi di particolare interesse per la
comprensione della condizione esistenziale della stessa. Nel testo è riportata la storia di
Suzanne Urban partendo dalla sua infanzia; viene descritta la qualità delle relazioni con i suoi
familiari, l’episodio del suicidio della sorella, il legame profondo con il marito e le reazioni
alla notizia della grave malattia che colpisce quest’ultimo.
La notizia delle gravi condizioni di salute del marito, da parte dei medici, viene
individuata quale momento cruciale (la scena originaria) per la sintomatologia della malattia
della paziente. Dal momento in cui apprende il pericolo di vita del consorte, Suzanne
manifesta quei segnali di disagio psicologico e comportamentale che l’accompagneranno – a
fasi alterne – per il resto della sua vita, come i disturbi alimentari, l’insonnia, i frequenti
soliloqui, la profonda tristezza, i problemi funzionali legati alla “percezione, la memoria,
l’ideazione, il giudizio, l’affettività ecc.”11. Si tratta dei primi segnali di una condizione
destinata a divenire sempre più drammatica.
Negli undici mesi precedenti l’arrivo ed il ricovero della donna nell’Istituto di
Kreuzlingen, secondo la ricostruzione diacronica operata da Binswanger, la malattia si
manifesta attraverso una serie di episodi caratterizzati da un crescente panico e terrore,
accompagnati da deliri ed allucinazioni, inappetenza, notevole perdita di peso e pianti
continui. In quel periodo Suzanne vive tormentata dai sospetti di complotti e persecuzioni ai
danni della sua persona e delle sua famiglia, in un’angoscia che lei stessa non esita a definire
“senza fine”. Il rapporto con lo spazio diviene per la paziente completamente privo di ogni
senso, in quanto l’unico spazio che la stessa riconosce è la “scena del terrore”. Anche il
tempo, o meglio, il nuovo, la triste novità che il tempo le ha riservato (ossia la notizia della
11
M. Galzigna, in L. Binswanger, Il caso Su zanne Urban, op. cit., pag. 35
12
malattia del marito), è intriso di terrore e sofferenza ed ella cerca di eluderlo, di sfuggire al
tempo, in quanto esclusivamente portatore di dolore.
A seguito del ricovero e delle conseguenti analisi dell’esserci effettuate da
Binswanger, a Suzanne viene diagnosticato un delirio depressivo e, in particolare, di tipo
persecutorio quale principale segnale della condizione di schizofrenia che coinvolge la mente
della donna; tale condizione si rivelerà irreversibile e sarà costituita dall’unico “progetto di
mondo” improntato al terribile e all’autodistruzione.
4. Il concetto di schizofrenia fino al secondo dopoguerra
Gli studi sulla schizofrenia, durante gli anni della Grande guerra, erano stati
notevolmente influenzati anche dalle tragiche epidemie della “febbre spagnola” e della
“encefalite letargica”, che avevano causato nel mondo diversi milioni di vittime. I
sopravvissuti dell’encefalite letargica furono sottoposti ad accertamenti e cure che condussero
alle prime elaborazioni di modelli anatomici e biochimici del cervello, successivamente
utilizzati per gli studi sulla schizofrenia e sulle psicosi in genere.
A partire dall’immediato dopoguerra, la schizofrenia divenne il tema centrale sul quale
il mondo della psichiatria concentrò gran parte delle proprie energie e ricerche, complici
anche le congiunture storiche e sociali determinate dalla grande follia collettiva scatenata
durante il conflitto.
Fra gli aspetti più studiati cominciarono a farsi strada le strategie di cura. In
particolare, uno dei trattamenti più diffusi della schizofrenia era diventata la cosiddetta “cura
del sonno” o narcoterapia, applicata per la prima volta da Jacob Klaesi, all’epoca direttore
dell’Istituto di Burgholzhli (lo stesso dove era stata ricoverata la Spielrein anni prima). Questo
genere di terapia, indotto dalla somministrazione di abbondanti dosi di sonnifero, muoveva
dalla constatazione dei gravi problemi di insonnia di cui soffrivano i malati e dall’esigenza di
“liberare gli schizofrenici dai loro automatismi”, come avevano affermato gli studiosi Morel e
Quetel già all’inizio del secolo.
Altri metodi di cura che, in gran parte, cominciavano a sostituire la narcoterapia si
ispiravano al principio dello “shock”, una sorta di brusca modificazione della condizione
psico-fisica del soggetto, ottenuta mediante metodi diversi, come l’insulinoterapia
sperimentata a Berlino da Manfred Sakel dapprima con i morfinomani poi con gli
schizofrenici, la terapia convulsivante applicata dal ricercatore ungherese Laszlo Von
Medusa e l’elettroshock presentato dallo studioso italiano Ugo Cerletti, consistente
13
nell’impiego di elettricità per procurare convulsioni, che, dopo anni di alterne fortune, è stato
definitivamente superato nella cura della schizofrenia.
La terapia psicochirurgica costituisce un’altra significativa area di studi nel panorama
della psichiatria del primo dopoguerra, rappresentata soprattutto dalle ricerche del dott. Egas
Moniz, i cui esperimenti gli valsero anche un Premio Nobel per la medicina nel 1949. Le
pratiche di lobotomia conobbero una certa diffusione nei Paesi industrializzati, prima di essere
fortunatamente limitate a partire dagli anni ’80.
Nello stesso periodo, ricordato soprattutto per gli studi di Bleuler e Minkowski, si
svilupparono anche le riflessioni di Karl Jaspers, di fondamentali importanza per l’approccio
filosofico fenomenologico alla schizofrenia, che tanta influenza ha avuto e a tutt’oggi riveste
per lo studio e la cura della malattia: a differenza di molti suoi colleghi coevi, per tale Autore
la patologia era un fatto addirittura “creativo”, almeno nei suoi stadi iniziali.
In Europa, l’esperienza del nazifascismo condusse ad epici stravolgimenti anche nella
riflessione e nella gestione della schizofrenia: molti psichiatri e ricercatori furono costretti ad
emigrare dalla Germania facendo la fortuna della scienza e della ricerca dei Paesi ospiti. In
Francia, durante gli anni del conflitto, crebbe a dismisura il numero dei decessi di persone
ricoverate negli ospedali psichiatrici, prevalentemente causato dall’improvviso e drastico
abbassamento di calorie distribuite mediante le razioni alimentari. Secondo le direttive del
sistema nazista, la distribuzione di cibo giornaliero doveva essere inferiore alle 1700 calorie e
ciò rispondeva ad un preciso disegno di sterminio di massa.
In quel periodo vennero, inoltre, portati a compimento significativi progressi nella
sintesi chimica di molecole costitutive alcune droghe, quali l’acido lisergico (LSD) e la
mescalina. L’uso di tali sostanze fu, negli anni fra le due Guerre, un’abitudine decisamente
poco frequente, acquisita prevalentemente da parte di personaggi di prestigio come, ad
esempio, l’artista e poeta francese Antonin Artaud, una caso divenuto nel tempo
emblematico di assunzione di droghe e contestuale sofferenza da disturbi psicotici. Il caso
Artaud – che secondo J. Garrabè, potrebbe essere oggi definito un caso di farmacopsicosi divenne particolarmente importante perché condusse il mondo della psichiatria a riflettere: a)
sul dato dell’esito psicotico in alcuni (e non in tutti) i tossicomani e b) sull’eventualità che
alcune sostanze possano essere più dannose – ossia slatentizzanti, schizofrenizzanti- di altre.
Artaud aveva “subito” diverse terapie durante i suoi prolungati ricoveri, dall’elettroshok
all’assunzione di peyotl, ma senza conseguire risultati soddisfacenti; anzi, egli aveva più
volte, nei momenti di lucidità, criticato aspramente gli effetti delle terapie che gli venivano
somministrate: sperava di guarire definitivamente solo con l’assunzione di peyotl, cui
attribuiva poteri taumaturgici derivanti più dalla magia che dalle proprietà farmacologiche.
14
Il principio attivo del peyotl è la mescalina, una molecola dalle proprietà allucinogene
ed euforizzanti che alla lunga sfociano in patologie psicotiche molto simili ad alcune tipologie
schizofreniche; durante la Seconda Guerra mondiale, l’uso di tale sostanza fu diffuso
soprattutto fra i giovani militari, allo scopo di ridurre il senso di sonnolenza e di panico in
situazioni di particolare pericolo e violenza.
La sintesi chimica di determinate “amine” e l’osservazione dei loro effetti devastanti
per la mente umana attirarono ben presto l’attenzione di numerosi ricercatori sulle terapie
farmacologiche più efficaci per il contenimento e la riduzione dei danni provocati dalle
sostanze sintetiche. Furono, così, sintetizzate altre molecole (come le fenotiazine ed alcuni
anti-istaminici) che costituirono un antidoto agli stati di sovreccitazione e che furono
addirittura impiegate nella cura del parkinson.
La complessa questione delle connessioni fra sostanze sintetiche e governo della
mente era, tuttavia, negli anni’40, appena agli inizi: neppure le guerre, infatti, erano riuscite a
fermare le ricerche su queste interrelazioni. Progressivamente, fino ai giorni nostri, sono stati
approfonditi gli studi sulle farmacopsicosi (ossia quelle forme di psicosi causate dall’uso di
droghe) e, più di recente, sulla sindrome della doppia diagnosi (o comorbidità): ossia le forme
di compresenza in una stessa persona di comportamenti tossicomanici e di sintomi
psicopatologici. Tuttavia, se si sposta il focus di questi problemi da un piano più speculativo
ed “accademico” ad un livello più strettamente terapeutico, si osserva che in entrambi i casi si
tratta di condizioni di sofferenza per lungo tempo trascurate dal mondo della psichiatria, che
non ha saputo/potuto/voluto cogliere la dimensione olistica della propria operatività. Ancora
oggi, se pure con minore frequenza, si assiste ad episodi di “rimpallo” dei pazienti dai Servizi
di salute mentale a quelli per le dipendenze patologiche, poiché a torto ritenuti “di
competenza” di questi ultimi. In taluni casi si registra, inoltre, la confusione dovuta, da una
lato, ad un certo riduttivismo medico, che scaturisce da un approccio prevalentemente
patologizzante e psicofarmacologico ai disturbi psicotici e, d’altro canto, ad un pre-giudizio
sociale molto radicato nei confronti del ricorso alle droghe: un comportamento sovente
identificato come segnale di disadattamento e/o devianza. Alcuni recenti studi hanno
evidenziato problemi di comorbidità negli assuntori abituali di alcol, eroina e cocaina, spesso
afflitti anche da disturbi d’ansia, forme depressive, disturbi del sonno e della concentrazione.
In relazione a tali particolari tipologie di disturbo psichico, gli studiosi First e Gladis hanno
proposto una classificazione di massima12 che potrebbe essere sintetizzata come segue:
12
Paolo Rigliano, Paolo Miragoli, Tossicomania e sofferenza mentale: la questione della doppia diagnosi, in "Rivista
sperimentale di feniatria" n. 1/2000. La versione integrale, completa di riferimenti scientifici e di una ricca bibliografia,
è reperibile nel sito [email protected]
15
a) pazienti con disturbo psichiatrico primario e dipendenza secondaria,
b) pazienti con tossicomania primaria e disturbi psichiatrici secondari,
c) pazienti con disturbi psichiatrici e tossicodipendenza entrambi primari.
La letteratura scientifica e/o, comunque, “ispiratrice” di riflessioni di carattere
psichiatrico, ebbe, dunque, una progressiva e notevole crescita durante la prima metà del
ventesimo secolo. In proposito, determinanti sono ancora oggi considerate alcune opere,
quali: “L’essere e il nulla” di Jean Paul Sartre, un saggio di carattere fenomenologico
pubblicato nel 1943 e scritto in parte sotto l’effetto di una amfetamina, che reputava la
schizofrenia un’esperienza esistenziale; l’articolo di Kanner “Disturbi autistici e contatto
affettivo”, nel quale viene avanzata la proposta di indicare con la denominazione di autismo
precoce infantile la sindrome caratterizzata dalla mancanza di proprietà del linguaggio da
parte dei bambini più piccoli, in passato considerata vero e proprio ritardo mentale: tutto ciò
per evidenziare la “fisiologia” di determinate condizioni, vissute in chiave patologica dalla
società più che dalla scienza.
Un’altra importante opera è rappresentata dal “Comportamento individuale e di massa
nelle situazioni estreme” di Bruno Bettelheim, pubblicato anch’esso nel 1943, nel quale sono
descritti gli effetti sul comportamento umano conseguenti alla detenzione nei campi di
sterminio nazisti. Nel periodo della Seconda Guerra mondiale furono, inoltre, pubblicate le
opere di Anna Freud e Melanine Klein sulle psicosi infantili, di W.R. Bion sulle “nevrosi
traumatiche di guerra”, di Paul Federn e Paul Schilder sulle tecniche di psicoterapia.
Gli studi fin qui citati ebbero una notevole influenza anche sull’orientamento delle
strategie terapeutiche, improntato con sempre maggiore attenzione alla psicoterapia e alla
forza del colloquio fra tecnico e paziente. Circa l’importanza del colloquio terapeutico,
Eugenio Borgna cita la suggestiva riflessione di Martin Heidegger: “Noi siamo un colloquio.
L’essere dell’uomo si fonda nel linguaggio; ma questo accade autenticamente solo nel
colloquio”13.
Un’innovativa chiave di lettura – di grande interesse non solo per gli studiosi di
psichiatria – fu introdotta anche dall’etnologo psicoanalista Georges Devereux e da Geza
Roheim, che approfondirono le significative ed affascinanti implicazioni fra psicoanalisi ed
antropologia culturale: il primo, elaborando una “teoria sociologica della schizofrenia”, ed il
secondo mediante la pubblicazione di “Magia e schizofrenia” avvenuta nel 1955. In quel
periodo si aprì una nuova frontiera nello studio della psichiatria, relativa alla sfera “culturale”
13
E. Borgna, Malinconia, op. cit., pag. 166
16
dell’Io, che influenza la determinazione, la percezione e l’analisi delle patologie mentali
secondo le differenze culturali dei diversi gruppi umani.
Si tratta di una materia che, a partire dalla seconda metà del ‘900, si è sviluppata
prevalentemente negli Stati Uniti fino a fondare le basi di una nuova branca della scienza
psichiatrica, l’etnopsichiatria, che ha avuto altri importanti riferimenti nelle figure di Ruth
Benedict, Gregory Bateson, Margaret Mead e Claude Levi-Strauss.
Nel nostro Paese l’etnopsichiatria è una disciplina ancora giovane, anche se in
espansione: i legami fra il disagio mentale in generale ed i punti di osservazione dai quali si
cerca di cogliere le “differenze culturali” stanno progressivamente diventando un oggetto di
studio di fondamentale importanza, anche a causa dell’impatto che i fenomeni migratori
hanno prodotto negli ultimi anni nel tessuto sociale italiano. La percezione ed il rapporto con
l’”Altro”, intesi sia come fascinazione sia in quanto problema (pregiudizio, rifiuto,
discriminazione,..) è diventato anche in Italia un indicatore sociale, istituzionale, politico,
economico fondamentale per una seria analisi della comunità civile. A tale tematica, lo studio
dell’etnopsichiatria non potrà che contribuire in misura sempre maggiore e sempre più
opportunamente.
17
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
G..Jervis, Manuale critico di psichiatria, Feltrinelli, Milano, 1975
J. Garrabè, Storia della schizofrenia, ed. Ma.Gi, Roma, 2001. La prefazione e la traduzione
sono curate da Marco Alessandrini
E. Minkowski, La schizofrenia. Psicopatologia degli schizoidi e degli schizofrenici, ed. G. Einaudi,
Torino, 1998
M.Galzigna, “Binswanger e le strutture della presenza”, in L. Binswanger, Il caso Suzanne Urban,
ed. Marsilio, Venezia, 2001
E. Borgna, Malinconia, Feltrinelli, Milano, 1992
L. Binswanger, Il caso Suzanne Urban, a cura di E. Borgna e M. Galzigna, ed. Marsilio, Venezia,
1994
G. Reale e D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. 3, ed. La Scuola, Brescia,
1983
P. Rigliano, P. Miragoli, Tossicomania e sofferenza mentale: la questione della doppia diagnosi, in
"Rivista sperimentale di feniatria" n. 1/2000. La versione integrale, completa di riferimenti
scientifici e di una ricca bibliografia, è reperibile nel sito [email protected]
it.encarta.msn.com/enciclopedia
www.psychiatryonline.it
www.thiene.it
www.psicoanalisi.it
www.psicolinea.it
18