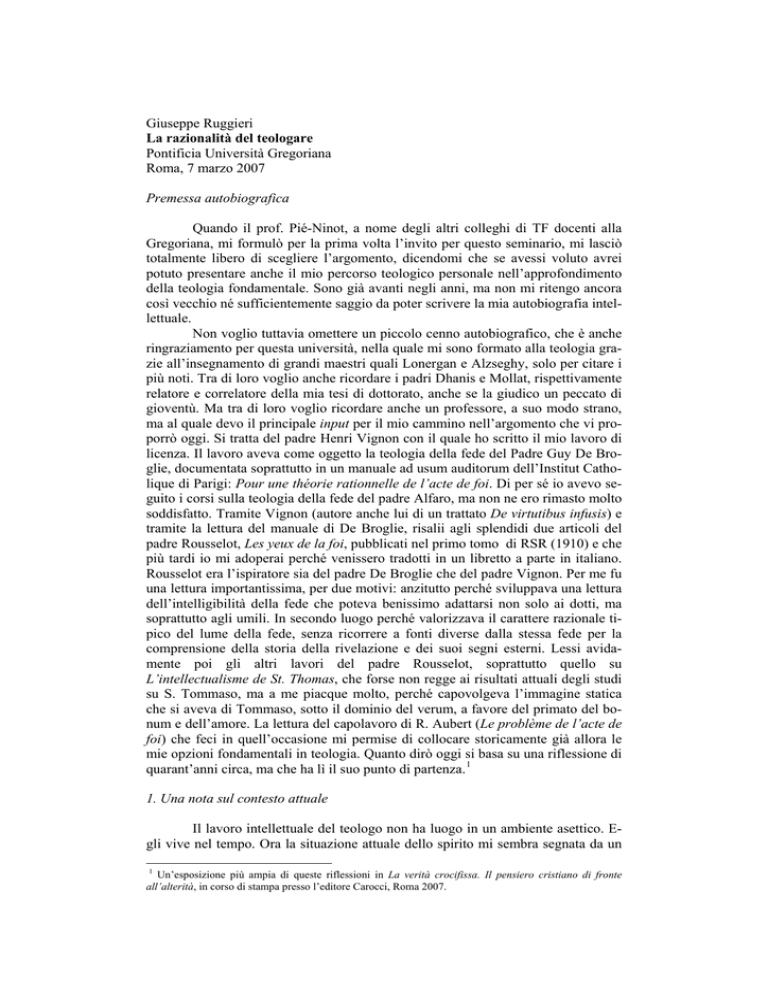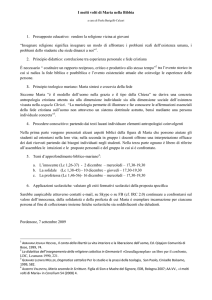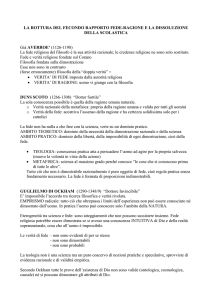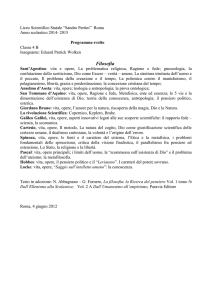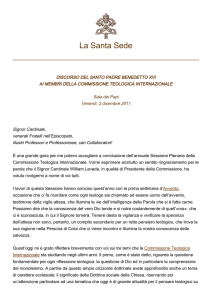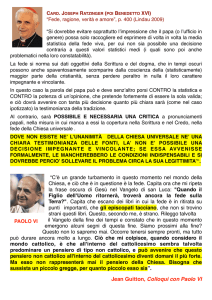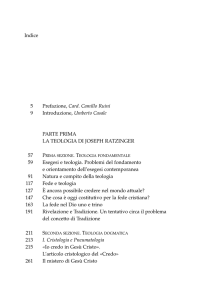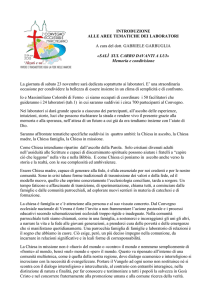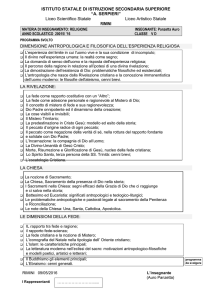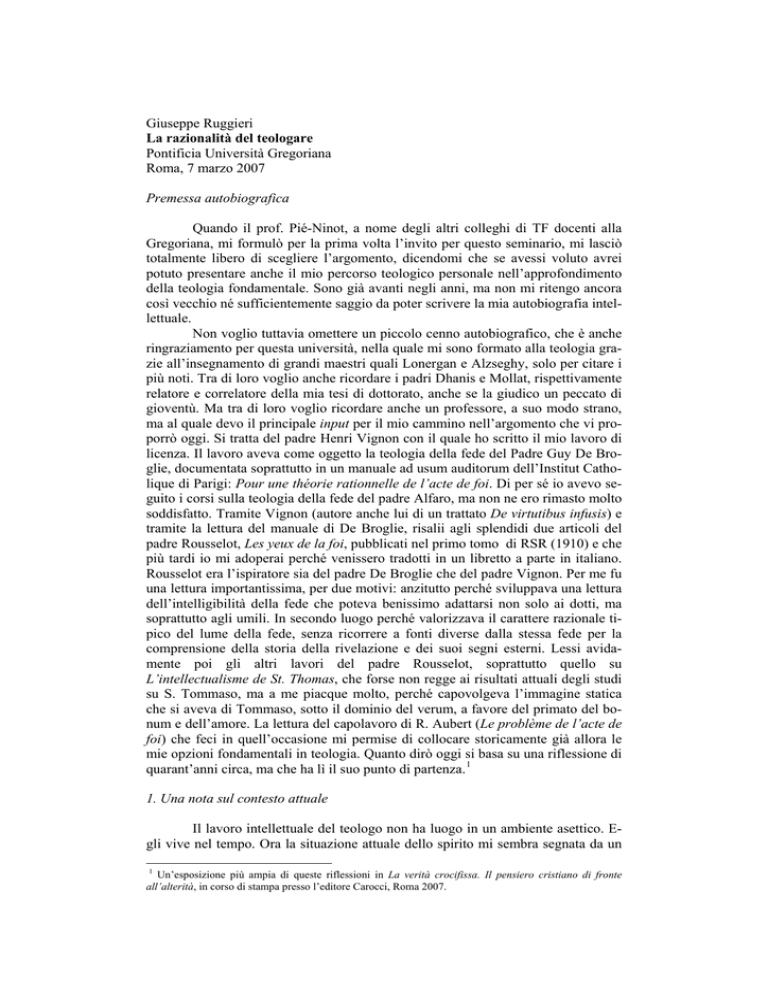
Giuseppe Ruggieri
La razionalità del teologare
Pontificia Università Gregoriana
Roma, 7 marzo 2007
Premessa autobiografica
Quando il prof. Pié-Ninot, a nome degli altri colleghi di TF docenti alla
Gregoriana, mi formulò per la prima volta l’invito per questo seminario, mi lasciò
totalmente libero di scegliere l’argomento, dicendomi che se avessi voluto avrei
potuto presentare anche il mio percorso teologico personale nell’approfondimento
della teologia fondamentale. Sono già avanti negli anni, ma non mi ritengo ancora
così vecchio né sufficientemente saggio da poter scrivere la mia autobiografia intellettuale.
Non voglio tuttavia omettere un piccolo cenno autobiografico, che è anche
ringraziamento per questa università, nella quale mi sono formato alla teologia grazie all’insegnamento di grandi maestri quali Lonergan e Alzseghy, solo per citare i
più noti. Tra di loro voglio anche ricordare i padri Dhanis e Mollat, rispettivamente
relatore e correlatore della mia tesi di dottorato, anche se la giudico un peccato di
gioventù. Ma tra di loro voglio ricordare anche un professore, a suo modo strano,
ma al quale devo il principale input per il mio cammino nell’argomento che vi proporrò oggi. Si tratta del padre Henri Vignon con il quale ho scritto il mio lavoro di
licenza. Il lavoro aveva come oggetto la teologia della fede del Padre Guy De Broglie, documentata soprattutto in un manuale ad usum auditorum dell’Institut Catholique di Parigi: Pour une théorie rationnelle de l’acte de foi. Di per sé io avevo seguito i corsi sulla teologia della fede del padre Alfaro, ma non ne ero rimasto molto
soddisfatto. Tramite Vignon (autore anche lui di un trattato De virtutibus infusis) e
tramite la lettura del manuale di De Broglie, risalii agli splendidi due articoli del
padre Rousselot, Les yeux de la foi, pubblicati nel primo tomo di RSR (1910) e che
più tardi io mi adoperai perché venissero tradotti in un libretto a parte in italiano.
Rousselot era l’ispiratore sia del padre De Broglie che del padre Vignon. Per me fu
una lettura importantissima, per due motivi: anzitutto perché sviluppava una lettura
dell’intelligibilità della fede che poteva benissimo adattarsi non solo ai dotti, ma
soprattutto agli umili. In secondo luogo perché valorizzava il carattere razionale tipico del lume della fede, senza ricorrere a fonti diverse dalla stessa fede per la
comprensione della storia della rivelazione e dei suoi segni esterni. Lessi avidamente poi gli altri lavori del padre Rousselot, soprattutto quello su
L’intellectualisme de St. Thomas, che forse non regge ai risultati attuali degli studi
su S. Tommaso, ma a me piacque molto, perché capovolgeva l’immagine statica
che si aveva di Tommaso, sotto il dominio del verum, a favore del primato del bonum e dell’amore. La lettura del capolavoro di R. Aubert (Le problème de l’acte de
foi) che feci in quell’occasione mi permise di collocare storicamente già allora le
mie opzioni fondamentali in teologia. Quanto dirò oggi si basa su una riflessione di
quarant’anni circa, ma che ha lì il suo punto di partenza. 1
1. Una nota sul contesto attuale
Il lavoro intellettuale del teologo non ha luogo in un ambiente asettico. Egli vive nel tempo. Ora la situazione attuale dello spirito mi sembra segnata da un
1
Un’esposizione più ampia di queste riflessioni in La verità crocifissa. Il pensiero cristiano di fronte
all’alterità, in corso di stampa presso l’editore Carocci, Roma 2007.
dato che a mio avviso va interpretato accuratamente. Infatti, accettando la sfida della nuova situazione dello spirito umano, nella seconda metà del Novecento, in molti teologi si è affermata la convinzione che il rapporto tra la fede e la ragione, o
meglio tra la razionalità tipica della fede e le razionalità che si manifestano negli
altri linguaggi umani, vada ricercata non in una “fondazione” della plausibilità della fede stessa davanti alla ragione, ma in una traduzione, in una manifestazione
concreta della razionalità credente nella misura in cui essa riesce a comunicare effettivamente con le razionalità specifiche dei vari mondi vitali, diversi da quelli del
credente. È cioè nella pratica comunicativa di se stessa che la fede mostra la sua ragione.
Non si può intendere la portata di questa convinzione senza collegarla, non
solo agli sviluppi che la teologia della prima parte del Novecento aveva operato
nella lettura della logica propria della fede (vedi il lavoro di Aubert prima citato),
ma a quanto era avvenuto come effetto delle nuove considerazioni sulla natura del
linguaggio. Con l’arbitrarietà connessa a tutte le fissazioni di un “inizio”, possiamo
fare cominciare il linguistic turnpoint, la svolta linguistica, con la pubblicazione
nel 1913, del Corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure. Da quel momento è diventato impossibile non prestare attenzione, non solo agli elementi dei
vari linguaggi umani, alle loro affermazioni di contenuto, ma soprattutto alla loro
struttura che condiziona per se stessa l’approccio ai contenuti. Al di là del campo
prettamente linguistico e di ogni ideologia “strutturalistica”, chi ha poi maggiormente sviluppato questa dimensione per le sue conseguenze sul linguaggio religioso è stato Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Nella sua fase più matura egli si è
preoccupato di mostrare come non si possa dare una lettura del linguaggio come un
tutto, giacché il linguaggio umano è un insieme di espressioni che svolgono funzioni molto diverse dipendentemente dalle rispettive pratiche, con regole che non
possono essere fissate una volta per tutte (i “giochi linguistici”).
Ma l’approccio linguistico non è il solo atto a descrivere la situazione dello
spirito contemporaneo. La filosofia di Heidegger, l’ermeneutica di Ricoeur, la logica della comunicazione di Habermas, pur nella loro irriducibilità di metodo, esprimono una convinzione: per l’uomo è ormai impossibile costruire una mathesis universale, una spiegazione “prima” che renda conto dei principi comuni a tutta la realtà. Il linguaggio religioso in tale contesto non viene respinto, ma si cerca soltanto
di coglierne le peculiarità in ciò che esso vuol dire, peculiarità che non lo rendono
omogeneo ad altri linguaggi, coerenti con altre pratiche. Per spiegare il senso di ciò
che è avvenuto con quella che abbiamo chiamato “svolta linguistica”, possiamo
semplicemente citare il fatto che per alcuni teologi ormai, nel rifiuto
dell’ermeneutica contemporanea di postulare una mathesis universalis, può essere
compito esclusivo della teologia quello di delineare una “filosofia prima” che valga a stabilire “le condizioni di possibilità, affinché affermazioni che pretendono di
essere vere e pretese che vogliono essere universalmente valide, possano essere legittimate come razionalmente valide”. 2
In buona parte della teologia contemporanea tuttavia non sembra necessario questo ricorso alla “filosofia prima”. Il famoso aforisma del mistico Johannes
Scheffler (Angelus Silesius), caro a Heidegger, caratterizza bene l’atteggiamento di
questa teologia. “La rosa è senza perché fiorisce perché fiorisce. A se stessa non
bada, che tu la guardi non chiede”. 3 Occorre afferrare il linguaggio della rosa che,
rinunciando alla fondazione razionale della fede (nel senso di una razionalità e2
H.-J. VERWEYEN, La parola definitiva di Dio. Compendio di teologia fondamentale, Brescia 2001, 218.
3
ANGELUS SILESIUS, Il pellegrino cherubico, a cura di GIOVANNA FOZZER E MARCO VANNINI, Cinisello
Balsamo 1989, 156.
2
strinseca all’esperienza di fede), cerca di mettere in luce la specificità dell’agire
cristiano in una cultura segnata dallo scambio intersoggettivo e simbolico. “Si rinunciò così alla fondazione di ragione, ma non al dibattito interno alla comunicazione attuale, che cerca di fondare le scelte per via argomentativa”. 4 Questo a mio
avviso risulta essere anche lo spirito della “nuova” teologia politica di Johann Baptist Metz, 5 preoccupata di un’ermeneutica pratica della fede cristiana che mostra la
sua rilevanza proprio attraverso l’incidenza concreta nella storia della sua “riserva
escatologica” per un verso (giacché nella tensione verso il Regno ogni fase della
storia umana appare nella sua provvisorietà) e della “memoria sovversiva” della
passione di Gesù per altro verso. Ma in una logica analoga si può anche iscrivere il
percorso atipico di un teologo come Jean-Pierre Jossua con la sua proposta di una
“teologia letteraria”. 6 Ma questi sono soltanto due nomi fra tanti.
2. Il logos della fede
La teologia non crea, né inventa la razionalità della fede. Infatti la fede
possiede una sua” ragione, con una sua” evidenza, che appare dal suo” linguaggio
nella cui struttura narrativa originaria si manifesta una pretesa veritativa. La fede
infatti anche nelle sue forme più semplici, costituisce già un evento linguistico con
un suo logos, presupposto del teologare stesso. E non mi riferisco ovviamente alle
descrizioni - anche autorevoli - della fede, come quella della costituzione Dei Filius
del Vaticano I tutta orientata all’adesione intellettuale alle verità rivelate o come
quella della Dei Verbum ben altrimenti attenta alla dimensione personalistica. E’
infatti l’esperienza della fede che rappresenta già un evento linguistico, il dirsi (legein) di un logos, l’articolarsi cioè di una “ragione” che è costituita dall’evento di
Gesù di Nazaret, visto - in qualunque modo siano posti gli accenti secondo le sensibilità, le epoche e le culture - come riferimento costitutivo della propria esistenza.
Non è una qualsiasi descrizione della fede che, sopraggiungendo, costituisca
l’evento linguistico della fede stessa. Il dirsi (legein) del logos cristiano è piuttosto
già tutto nell’esperienza originaria, nell’atto di fede, in quanto questo è accensione
di un rapporto con un evento che mi precede e che arriva a me solo nelle sue narrazioni, siano esse esplicitate, come nella predicazione, nell’annuncio, nella catechesi, siano esse semplicemente vissute senza parole, come nella testimonianza del gesto, ma rese pur sempre intelligibili grazie al loro nesso con un orizzonte di segni
altrimenti noti.
La fede - anteriormente a ogni sua descrizione o comprensione seconda – è
collocazione della propria esistenza dentro l’evento di Gesù di Nazaret che, nella
fede stessa, viene per così dire strappato alla sua singolarità per diventare evento
agglutinante di altre singolarità, capace di dare una direzione determinata ad esse.
Già dicendo “evento” e indicando con questo termine non un nudo fatto, ma un fatto significativo (ad esempio “morto per i nostri peccati”, dove quindi la morte di
Gesù acquista significanza per altri), insinuiamo quale sia il logos della fede stessa:
l’evento di Gesù di Nazaret diventa il riferimento privilegiato della mia esistenza,
si dice come fondamento di un rapporto, dicendosi si comunica nella precisa moda4
CHRISTIAN DUQUOC, voce Théologie. VII. Réflexion théologique, in Catholicisme XIV, 1042-1099, cit.
1081.
5
Cf. soprattutto: JOHANN BAPTIST METZ, La fede, nella storia e nella società. Studi per una teologia
fondamentale pratica, Brescia 1978; Sul concetto della nuova teologia politica, 1967-1997, Brescia 1998
6
Cf. la spiegazione che egli stesso dà del suo percorso intellettuale: J.-P. JOSSUA, Le combat de la
théologie, in “Con tutte le tue forze”. I nodi della fede cristiana oggi. Omaggio a Giuseppe Dossetti,
Genova 1993, 61-79.
3
lità di un fondamento (oppure, con altre metafore, di un salvatore, di un redentore,
di un liberatore e via dicendo). Nella fede si dice l’evento di Gesù di Nazaret, non
come cifra della mia esistenza, non come ipostasi di un desiderio - come potrebbe
ad esempio essere l’affermazione di Dio - ma nella sua determinatezza mediata dalle narrazioni cristiane: nato da donna, predicatore del regno, taumaturgo, messo a
morte sotto Ponzio Pilato. E questo evento si dice al tempo stesso, e non in un atto
secondo, come significativo per me. Non sono io inoltre a dirlo per la prima volta,
ma io lo ricevo attraverso una narrazione formulata da altri. Per ciò stesso la fede è
un evento linguistico acceso da un linguaggio che mi precede, il linguaggio della
tradizione cristiana. Già questo pone il problema della narrazione “originaria”, del
formarsi cioè di una narrazione “nuova” nella tradizione religiosa dell’umanità. Ma
qui possiamo omettere questo sviluppo.
Il logos del teologare
Per comprendere, rispetto al logos specifico della fede, il logos proprio della teologia, occorre anzitutto intendere il nesso tra la narrazione originaria della fede e la riflessione teologica. La teologia è infatti consegnata alla narrazione della
fede. E’ la narrazione, è il fatto che si dà (l’es gibt heideggeriano) l’evento linguistico della fede, il fondamento della teologia e non viceversa. La teologia manifesta
solo la grammatica profonda di quell’avvenimento linguistico. Essa è radicalmente
sapere subalternato, ma in questo svelamento della grammatica profonda della fede, la teologia si serve della ragione umana: theologia fit per additionem rationis
probantis fidem. La teologia è un’attività riflessa che si costituisce aggiungendo la
ragione capace di comunicare la forza della fede. Interpretando per conto nostro la
definizione bonaventuriana, potremmo dire che la ragione “aggiunta” dalla teologia, è sempre una ragione storicamente data.
Come è risaputo Bonaventura sviluppa la sua concezione della ratio teologica sia nelle prime quattro questioni premesse al suo commento al I libro delle
Sentenze, che nel Breviloquium. Ciò che colpisce, ad esempio nel proemio al
commento delle Sentenze di Pietro Lombardo è la qualifica della ratio teologica
come semplice ratio probabilitatis. Mentre infatti ciò che viene creduto ha in sé la
ratio primae veritatis e compete all’abito di fede, e mentre le auctoritates hanno in
sé una propria ratio (ratio auctoritatis) che compete alla dottrina cristiana sulla
scrittura, per il fatto che, come dice Agostino, la sua autorità è maggiore della perspicacia dell’intelletto, la teologia aggiunge invece solo una rationem probabilitatis
(In I Sent. Proœm. Q 1 concl. 5.6).
Se non fosse equivoco e origine di confusioni potremmo dire che, per Bonaventura la ragione teologica è una ragione “debole”, dove la debolezza non sta
nella debolezza della ragione, ma nella sfasatura di questa ragione rispetto all’atto
di fede e al suo linguaggio canonico. La questione che si pone è allora quella di sapere perché quest’aggiunta di ragione al logos originario della fede. La risposta,
quella che è già data con il famoso testo della 1 Pt 3, 15, è semplice: perché noi
dobbiamo essere sempre disponibili a chi ce ne chiede il motivo (e potremmo essere noi stessi, l’altro che resiste dentro il soggetto credente stesso), il logos della
speranza che è in noi.
3. Il carattere originario della comunicazione nella fede
La responsabilità della fede cristiana, il suo essere-in-dialogo, non è tuttavia un momento successivo alla costituzione stessa della fede. La fede cristiana è
infatti per sua stessa natura un’assunzione di alterità, un ri-facimento di soggettivi4
tà, uno “scambio” (2Cor 5, 18). E la fede è questo “scambio” tra due realtà radicalmente diverse, tra quella di Dio e quella dell’uomo, proprio perché il suo “fondamento” (themelios), quello laddove è stato fontalmente annodato il rapporto tra
Dio e l’uomo, è costitutivamente un’assunzione di alterità.
Sempre secondo l’“ingenuità” della narrazione biblica, Cristo infatti è stato
fatto peccato, ha assunto l’alterità della condizione umana peccatrice. In lui non c’è
quindi solo un’assunzione generica dell’alterità della natura umana, come semplice
diversità di condizione ontologica, ma c’è l’assunzione di quella alterità che per definizione è “lontananza” da Dio, anzi “assenza” di Dio: il peccato. In lui l’altro
peccatore viene scambiato/riconciliato con Dio. In lui, questo scambio/riconciliazione è anteriore alla conversione del peccatore. Infatti Dio ci ha amati per primo e il Figlio suo è morto per noi, mentre noi eravamo ancora peccatori.
Questo linguaggio originario, con la sua determinatezza, con i suoi contenuti, non può essere sublimato dalla teologia che quindi potrebbe per suo conto assorbirlo dentro concetti ad esso eterogenei di verità, di alterità, etc. L’altro che qui
viene raggiunto non è la soggettività trascendentale dell’uomo in quanto tale. Infatti non è il sì del peccatore che viene accolto. Il sì dell’uomo è successivo al sì definitivo e assoluto (cioè indipendente da quello dell’uomo) di Dio. La fede non è
“formalmente” il compimento della mia possibilità di credere; essa non è cioè l’atto
con cui, sulla base della mia capacità preesistente, integro dentro il mio equilibrio
umano un’affermazione che se non nasce da me è tuttavia adeguata alla mia disposizione interiore. Essa non è formalmente l’attuazione della mia condizione umana,
della mia potentia oboedientialis, della possibilità cioè del soggetto spirituale di ricevere da Dio una determinazione ulteriore o, secondo i termini propri di Karl Rahner, il compimento dell’apertura trascendentale dello spirito creato a un possibile
intervento di Dio nella storia. E nemmeno la fede è il compimento del desiderium
naturale videndi Deum, del desiderio esistente in ogni uomo di incontrare senza
mediazioni Dio, un desiderio concepito come struttura costitutiva dello spirito creato (De Lubac). Così può essere descritta l’elevazione dell’uomo alla condizione soprannaturale, ma non l’evento storico della comunicazione di Dio in Gesù Cristo
all’uomo peccatore. Formalmente la fede è l’accoglimento delle possibilità di Dio
nell’uomo, del Dio che è capace di risuscitare i morti ed è capace di giustificare il
peccatore. Se fosse “formalmente” l’affermazione delle condizioni trascendentali
del soggetto, essa non sarebbe la fede, giacché equivarrebbe all’autogiustificazione
del peccatore.
La fede è il sì dell’uomo, reso possibile, cronologicamente oltre che ontologicamente e logicamente, dal sì di Dio. Nella fede si ratifica il già avvenuto accoglimento da parte di Dio di un’alterità e si accetta la logica di questo accoglimento. Per quanto possa sembrare un gioco di parole, non è il logos della fede che deve
essere giustificato, ma è la fede che giustifica l’uomo, anzi l’altro. Questa esperienza, quella dell’essere accolti e giustificati da Dio, si articola in un linguaggio corrispondente che non è ancora quello della ragione teologica, ma quello
dell’annuncio, della confessione dei peccati, della lode, della testimonianza, della
misericordia e di ogni altra espressione in cui si articola la risposta dell’uomo.
Ma in questa esperienza è implicito che ogni altro linguaggio umano possa
e debba essere assunto, ogni ragione storicamente determinata possa e debba essere
“aggiunta”. Fuori di questa prassi di assunzione, di accoglienza, di “giustificazione”, non si dà giustificazione teologica della rivelazione e della fede (giacché è nella fede soltanto che la rivelazione di Dio si dà nella storia, diventa comunicabile). E
questo non per un estrinseco rinvio parenetico alla santità, alla carità etc., ma per la
natura stessa della “rivelazione” (che è comunicazione, in Cristo, di Dio all’uomo
peccatore, cioè a un “altro”). L’accoglienza dell’altro, e quindi dei suoi linguaggi,
5
delle sue rationes, è il logos stesso della “rivelazione” 7 e della fede. Non si tratta
cioè di un’assunzione di comodo, strumentale, della ragione storica, ma del ricostituirsi coerente e sempre nuovo del logos cristiano nella storia. Ogni giustificazione teologica quindi che non fosse spiegazione all’altro dell’evento già posto, del
suo accoglimento, che non fosse quindi traduzione nel suo linguaggio del linguaggio cristiano della sua “giustificazione”, sarebbe uno snaturamento del logos cristiano.
4. La ragione del teologare come traduzione della verità cristiana nella lingua
dell’altro
Come abbiamo già cercato di mostrare, lo statuto veritativo della fede si
trova già tematizzato nella narrazione cristiana originaria, cioè, per noi, nel Nuovo
Testamento e nella sua interpretazione dell’Antico. Esso è tematizzato come racconto della vicenda di Gesù di Nazaret e, in un nesso inscindibile,
dell’interpretazione che l’accompagna. Proprio perché narrazione interpretativa, essa non può essere ripresa che in una nuova interpretazione. Giacché i testimoni
hanno narrato interpretando, noi continuiamo a narrare interpretando, per gli stessi
motivi per cui loro interpretarono, cioè perché l’evento al centro della narrazione
ha come pretesa “intrinseca” di essere contemporaneo a ogni uomo, non diventa
mai un semplice passato. La teologia “riceve” questa prima tematizzazione e la articola secondo una “ratio” che ne permette il suo inserimento nel contesto delle narrazioni contemporanee. Così facendo la teologia mostra la forza di quell’evento
particolare, ma mostra questa forza (“probat”) perché piega una ragione, storicamente data, al logos della narrazione primitiva. Tuttavia occorre fare una notazione. La “prova razionale” della teologia, e in questo sta la sua differenza rispetto ad
altri registri della riflessione intellettuale, come quello filosofico, è fondamentalmente “analisi” di alcuni “principi” ricevuti, loro svolgimento e sviluppo, ma non
posizione di essi. Essa è cioè “soluzione” degli elementi costitutivi di una realtà
positivamente esistente, ma non è in grado di con-porre quegli stessi elementi se
non li ha già storicamente ricevuti. La riflessione teologica quindi aggiunge
all’avvenimento linguistico della fede concetti e figure, ma non la grammatica e la
sintassi. La nuova concettualità che quindi essa impiega, in questo impiego, assume
uno statuto particolare, che uno storico attento alla storia dei termini come il padre
Chenu, non esitava a qualificare come “pragmatismo intellettuale”. Questa concettualità viene cioè non solo assunta, ma anche trasformata, giacché viene piegata alla verità di una narrazione particolare. In qualche modo i concetti assumono in teologia sempre una funzione “predicativa”. Essi non possono cioè, autonomamente e
con il loro contenuto di origine, diventare soggetti dell’affermazione, ma restano
sempre predicati del “soggetto” concreto della narrazione biblica.
In forza del carattere finale e ultimo (escatologico) della relazione posta da
Cristo come verità di Dio e dell’uomo, l’affermazione che ogni linguaggio può essere assunto come luogo di traduzione della verità cristiana, equivale a dire implicitamente che la verità “ultima” di ogni esperienza, di ogni linguaggio, si trova in
qualche modo nel suo “possibile” rapporto con il logos dell’avvenimento cristologico. Ogni linguaggio contiene una “vocazione” divina. Questa vocazione è la re7
Uso in questo contesto il termine “rivelazione” tra virgolette per sottolineare, almeno qui, la necessaria
correzione della categoria di rivelazione, come viene comunemente intesa. Infatti, nonostante venga spesso
dichiarato il superamento del modello teoretico-istruttivo, poi spesso inavvertitamente resta esso il referente
effettivo del discorso e non ci si riferisce all’evento di grazia e di riconciliazione con il quale Dio si
comunica all’uomo. Altrove ho dichiarato la mia perplessità su questa categoria: La teologia della
rivelazione, a cura di D. VALENTINI, Padova 1996, pp. 81-105.
6
lazione di accoglimento assoluto che Dio ha posto nell’evento Gesù e che permette
quindi l’apertura di ogni linguaggio al sì di Dio, alla sua chiamata. Questa vocazione non è rivolta tuttavia primariamente al linguaggio in quanto approccio
dell’uomo alle cose, come strumento di cui l’uomo si serve per ordinare la realtà,
possederla, modificarla, ma al linguaggio come luogo in cui l’uomo si comunica a
se stesso, al linguaggio in quanto rivelazione dell’uomo. 8 Ogni linguaggio umano
non è cioè solo uno strumento per chiamare le cose, ma è l’unico modo possibile
perché avvenga il dirsi dell’ uomo a se stesso. Solo nel linguaggio l’uomo prende
coscienza di sé, nel momento stesso in cui mediante il linguaggio misura il suo
rapporto con le cose e con gli altri. La vocazione contenuta nel sì di Dio all’uomo
non è rivolta quindi al mezzo linguistico, ai significanti e ai significati dei vari linguaggi, ma all’uomo che si dice in essi, ma non si dice mai fuori di essi o mediante
essi. Mediante il linguaggio l’uomo comunica l’essere delle cose, ma non comunica
se stesso. Nel linguaggio l’uomo comunica se stesso. La vocazione del linguaggio è
che allora l’uomo si comunichi a se stesso dicendosi a Dio. Ma questa vocazione è
una disposizione fondamentale del linguaggio umano solo perché risulta
dall’accoglimento di ogni linguaggio umano (in quanto articolazione di
un’esperienza umana) nel sì di Dio in Gesù Cristo. 9
Questa disposizione di ogni linguaggio è quella che permette, sulla base
del sì di Dio in Cristo, il percorso della traduzione (e per ciò stesso
dell’interpretazione) dell’esperienza di Gesù di Nazaret nell’esperienza e nel linguaggio di fede (dai primi discepoli fino a noi, nella successione storica della testimonianza), grazie all’azione dello Spirito. Questa traduzione non appartiene come tale alla teologia ed equivale sostanzialmente a quella che il gergo biblicocristiano chiama conversione. Ma essa è anche conversione linguistica, operata secondo ritmi e tempi vari (sostanzialmente identici ai ritmi e ai tempi dell’esistenza),
nei linguaggi propri di ogni uomo, dal linguaggio quotidiano a quello più specializzato, in cui lui esprime il suo rapporto fondamentale con le cose. Essa è per ciò
stesso la prima percezione (Wahr-nehmung) della verità di Cristo. Questa percezione della verità avviene nell’esperienza consapevole del fondamentale accoglimento
della propria alterità in Gesù Cristo e, a partire da qui, nell’esperienza dei “frutti”
8
Questa “chiamata” è qui intesa in senso molto vicino a quello sviluppato da W. Benjamin nella sua
riflessione sulla lingua pura. Cfr. W. BENJAMIN, Über Sprache überhaupt und über die Sprache des
Menschen, Gesammelte Schriften II.1, Frankfurt 1977, 140-157; Die Aufgabe des Übersetzers, ivi IV.1,
Frankfurt 1981, 9-21: trad. it. Angelus novus, Torino 1962, pp. 39-70 dalla quale traiamo le citazioni qui di
seguito. Per Benjamin la lingua è la comunicabilità stessa degli esseri spirituali. Anzi: l’essenza linguistica
delle cose è la loro lingua. E quindi: l’essenza linguistica dell’uomo è la sua lingua.. Ma la lingua dell’uomo
parla in parole. E quindi l’uomo comunica la sua essenza spirituale (in quanto essa è comunicabile) dicendo
con le parole tutte le cose, dando i nomi alle cose. In ogni lingua occorre cogliere infatti la lingua pura, la
reine Sprache. Essa, che si trova inseparabilmente in ogni lingua, è il presupposto di ogni possibile
"traduzione" e "comunicazione" da una lingua all’altra. Questa pura lingua è per Benjamin un rapporto, un
Nennen, un dire il nome, e non già una definizione dell'oggetto, una circoscrizione di significato. Ora
l’uomo non comunica il suo essere spirituale mediante i nomi che dà alle cose, bensì in essi. La concezione
per cui l’uomo mediante le parole comunichi un oggetto a un altro uomo viene respinta da Benjamin.
Questa concezione può essere applicata solo alla lingua delle cose, che si comunicano attraverso il parlare
dell’uomo, mediante il suo dare un nome alle cose. Ma nella lingua dell’uomo non esiste alcun mezzo,
alcun oggetto, alcun destinatario della comunicazione, giacché “nel nome l’essere spirituale si comunica a
Dio” (trad. it. p. 57). Ancora: “Di tutti gli esseri l’uomo è il solo che nomina egli stesso i suoi simili, come è
il solo che Dio non ha nominato” (ivi p. 62). Non mi sembra arbitrario, senza alcuna pretesa di interpretare
esattamente il suo pensiero, utilizzare alcune sue riflessioni, “piegandole” al contesto teologico della
traducibilità del linguaggio di fede.
9
Resterebbe da sviluppare in che senso questa “vocazione” si distingua o sia una sola cosa con quella
posta nella creazione la quale, per la fede cristiana, sussiste non solo nella Parola eterna di Dio, ma in
questa Parola fattasi carne, crocifissa e risorta.
7
che questo accoglimento genera nel credente, come capacità di una nuova relazionalità con l’altro, con colui che De Certeau chiamava il “terzo assente”10 ,
nell’imitazione dello “scambio” operato da Gesù. E’ una conversione che è condizione di conoscenza della verità di Cristo. Parafrasando i termini di Paolo in Fil 3,
10: quando l’uomo si conforma alla morte di Cristo, traduce cioè nella propria esperienza il sì assoluto pronunciato sulla croce, allora “conosce il Cristo”; conosce
cioè “l’energia della sua risurrezione e la comunione con le sue sofferenze”. Infatti
attraverso la conversione del proprio linguaggio, reso omogeneo alla logica
dell’accoglimento dell’altro svelata sulla croce, questo linguaggio diventa
anch’esso accogliente, partecipa all’energia dell’evento cristologico, acquista capacità di comunicazione “universale”.
Nella conversione cristiana i linguaggi si “conformano” tuttavia alla narrazione cristiana, traducono la verità dell’evento cristologico, secondo percorsi molteplici, irriducibili a unità, proprio perché non si tratta “immediatamente” della
conversione dei significanti e dei significati in cui si articola ogni linguaggio, ma
dell’essenza linguistica dell’uomo che si dice, si comunica in essi. La verità accolta
nella conversione non determina quindi per se stessa la verità dei significati espressi in ogni linguaggio. Se possiamo arrischiare un esempio preciso, allora la traduzione del linguaggio di fede nel linguaggio del paleontologo Teilhard de Chardin
non implica affatto un mutamento dello statuto logico del linguaggio scientifico di
Teilhard, ma di ciò che in esso può essere comunicato (non quindi mediante esso,
per usare la distinzione di Benjamin).Questo equivale a dire che la traduzione del
linguaggio di fede nel linguaggio scientifico di Teilhard non dice ancora nulla sulla
verità “scientifica” del linguaggio stesso, del linguaggio come linguaggio mediante
cui si dicono le cose. Ma la storia mostra anche altre traduzioni, più discrete, con
modalità differenti, e persino quelle che ad esempio si esprimono come consegna
del silenzio su ciò di cui non si può parlare, su ciò che non può essere detto appunto mediante le parole.
La “creatività” della traduzione non appartiene al teologo in quanto tale. La
teologia analizza le condizioni di possibilità della traduzione analizzando le narrazioni presenti nella tradizione del linguaggio cristiano, svelandone, mediante
l’impiego della ragione, la grammatica profonda, criticandone incoerenze, aprendo
possibilità. Ma essa non offre i criteri di “verità” per la traduzione. I suoi criteri,
quelli della ratio, sono sostanzialmente due: quello della coerenza con la storia della narrazione stessa (ragione storica) e quello della coerenza interna del linguaggio
assunto (ragione critica, sia essa “filosofica”, sia essa “scientifica” etc.). Questa coerenza interna non è quella originaria del linguaggio assunto, ma è la coerenza della traduzione adottata con la logica dell’evento cristologico. Non si tratta cioè di
sapere se l’esegesi che Przywara fa di Aristotele sia filologicamente corretta o meno e mantenga il tenore originario. Una tale verifica è legittima, ma non “interessa”
il teologo. Ma si tratta di sapere se la sua traduzione del rapporto dell’uomo con
Dio, nella metafisica dell’analogia entis, rispetti il logos dell’evento cristologico,
come lo stesso autore ha cercato di mostrare con il saggio sul commercium, scritto
decine di anni dopo il saggio sull’analogia entis. Due coerenze mostra quindi la
ratio teologica applicata a ogni traduzione: quella con la storia della tradizione narrativa e quella con la logica di questa tradizione stessa.
Se la creatività della traduzione non appartiene al teologo in quanto tale,
resta non meno vero tuttavia che il teologo è un credente, ha sperimentato e speri10
Mi permetto di rimandare, per la precisazione della figura del “terzo assente”, cioè dell’altro sempre
diverso che non è ancora incluso nell’orizzonte dei nostri rapporti, all’interpretazione che, del pensiero di
De Certeau, ha fatto J. MOINGT, Une Théologie de l'exil, in CL. GEFFRE (éd), Michel de Certeau ou la
différence chrétienne. Actes du colloque "Michel de Certeau et le christianisme", Paris, l991, 129-156.
8
menta quotidianamente il sì del Padre, appartiene alla comunità confessante e opera
le sue traduzioni. Nella creatività della fede, il credente teologo assume quindi linguaggi e rationes che svelano la fecondità della verità cristiana proprio nell’ambito
della razionalità riflessa, e non solo sul piano della razionalità immediata o della
“grammatica di superficie”. La creatività dei grandi teologi, da Origene ad Agostino, da Tommaso a Cusano, da Möhler a Newman o a Barth, sta in questa simbiosi
felice tra la fede e la ratio.
5. Teologia e filosofie
Ho già accennato prima alla nuova situazione dello spirito e alla pluralità
dei linguaggi che impediscono oggi una mathesis universale. Vorrei aggiungere
tuttavia che il rifiuto di una mathesis universale, di una filosofia prima che fonda e
controlla la varietà dei linguaggi, non equivale ad un’assenza della loro istanza veritativa. Se cioè riesco a comprendere la situazione attuale dello spirito, la situazione è mutata non tanto per quanto riguarda il pluralismo delle filosofie in quanto tale, ma per la collocazione dell’istanza veritativa. La filosofia è cioè solo un percorso accanto agli altri per raggiungere la verità. Al di là della concezione della verità
stessa presente nelle varie tendenze dello spirito contemporaneo, ciò che connota
questa situazione è l’autofondazione di ogni esperienza, del linguaggio in cui si articola, del sapere che ne deriva. Per esperienza intendo, in modo molto simile a
quello elaborato da Richard Schaeffler,11 il dialogo stesso dell’uomo con la realtà,
un dialogo che ogni volta lascia emergere una pretesa della realtà che è determinata
dal modo in cui l’uomo si avvicina alla realtà stessa. L’esperienza artistica, quella
scientifica, quella etica, quella religiosa, quella filosofica, sono diverse modalità di
approccio alla realtà, sono esperienze diverse articolate in linguaggi diversi.
L’interrogativo, che a questo punto si pone, è se esista qualche esperienza
che possa comprendere le altre, non nel senso di sostituirsi ad esse, ma nel senso di
coglierne i tratti comuni, sia come condizioni trascendentali del soggetto sperimentante, sia come condizioni della conoscenza oggettiva (o sensata, o vera, secondo le
concezioni di realtà e di verità ogni volta presenti), per evitare l’“anarchia dei sistemi di orientamento”. Più spesso è il filosofo che avanza questa pretesa (per lo
più a difesa dell’unità del soggetto), meno spesso è lo scienziato (per lo più a difesa
dell’oggetto dell’esperienza stessa).
Ritengo che il teologo non possa (nel senso che non ne ha i mezzi) dirimere il dibattito, anzi che non abbia alcun interesse specifico a dirimerlo (nel senso
che non ne viene pregiudicato per nulla il problema del rapporto con i vari linguaggi, così come è inteso dentro il teologare). Il problema potrebbe “interessare”
il teologo e allora egli dovrebbe possedere in proprio i “mezzi” per risolverlo, solo
se qualche esperienza specifica potesse essere per qualche motivo esclusa dal suo
rapporto. Giacché tuttavia questo non è possibile al teologo, a lui non resta che porre, in un secondo tempo, e noi lo faremo, il problema della possibilità del rapporto
che egli nel suo teologare istaura con gli altri linguaggi. Allora egli sarà inevitabilmente portato a elaborare quella che possiamo chiamare una filosofia, dove resta
inteso che si tratterà di una filosofia teologica.
Ma adesso, se questa osservazione sulla situazione attuale dello spirito è
corretta, ci basti affermare che il problema dei rapporti tra teologia e filosofia si
11
Anche se non riesco a condividere la sua fiducia in una riflessione trascendentale, fondamentalmente
ispirata a Kant, che possa dettare le condizioni unitarie dell’esperienza stessa. Ma per lo meno la sua è una
riflessione che prende atto della nuova situazione dello spirito: R. SCHAEFFLER, Erfahrung als Dialog mit
der Wirklichkeit. Eine Untersuchung zur Logik der Erfahrung, Freiburg-München 1995.
9
pone come il problema dei rapporti tra la teologia e le differenti istanze veritative
dell’esperienza umana. Ciò potrebbe a prima vista suonare disprezzo per l’istanza
filosofica in quanto tale giacché toglie ad essa qualsiasi privilegio. Io non lo penso,
giacché ritengo che la filosofia oggi sia chiamata per parte sua a caricarsi anch’essa
della nuova situazione dello spirito. Ma in quanto teologo non posso ricadere, nella
logica del mio teologare, sotto il pregiudizio di un’acceptio personarum, giacché
non esiste nel teologare nessuna ragione per poterlo fare.
Quale è quindi il rapporto che il teologare stabilisce con le differenti e irriducibili istanze veritative dell’esperienza umana? Questo rapporto può essere pensato solo al proprio interno. Per quanto questo possa sembrare presuntuoso, dobbiamo infatti dire che non si tratta del rapporto che gli altri possono offrirmi, ma
del rapporto che io posso offrire agli altri. Non si tratta cioè di stabilire come debba
essere una filosofia perché io possa dialogare con essa, ma di chiarire se esiste in
me una capacità di dialogo con il diverso da me, se questo dialogo abbia dei limiti a
partire da me e non dall’altro. Certo gli altri debbono poter ricevere il rapporto da
me offerto, a partire da se stessi. E occorrerà quindi dopo, come ho già detto, chiarire le condizioni di possibilità del rapporto teologico con la diversità delle altre istanze veritative, in maniera tale che questa diversità non venga umiliata, ma rispettata in se stessa. Adesso tuttavia è qui necessario che io cerchi di determinare la peculiarità del rapporto stesso che il teologare stabilisce con ogni istanza veritativa
diversa da sé.
Per quanto abbiamo già detto a proposito del rapporto di subalternità tra
fede e teologia, è evidente che questo rapporto va ricercato nel logos stesso della
fede e che la teologia, da parte sua, può solo esplicitarlo mediante l’assunzione di
ulteriori linguaggi. E qui va ribadito quanto più volte ho cercato di mostrare lungo
il percorso delle riflessione precedenti: l’evento linguistico della fede contiene già,
come suo elemento costitutivo, un rapporto tra diversi, in quanto diversi. Nella fede
infatti noi accogliamo la diversità di Gesù come realtà a cui riferire noi stessi. Più
propriamente ancora, la fede costituisce l’esperienza di un lasciarsi accogliere nella
diversità di Cristo, secondo il detto paolino: non sono io che vivo è Cristo che vive
in me. Questo rapporto tra la diversità di Gesù Cristo e la mia, nella narrazione neotestamentaria dell’evento cristologico viene chiamato in modi differenti. Si usano
così le metafore del riscatto, della liberazione e via dicendo. Laddove tuttavia il
rapporto assume la sua massima intensità, per cui non c’è soltanto un operare da
parte di Cristo qualcosa nell’altro e per l’altro (riscattare, liberare etc.), e nemmeno
soltanto un generico far propria la realtà dell’altro da parte del Figlio di Dio (“divenne carne”, dove, se carne implica senz’altro debolezza e fragilità, non sembra
tuttavia contenere ancora per se stessa il peccato), ma la immedesimazione alla “ultima” diversità dell’altro, cioè al peccato (che suppone quindi una diversità alternativa, rifiutante il rapporto stesso), allora emerge la metafora dello scambio (katallage), come avviene esemplarmente in 2 Cor 5, 17-21.
Si dirà che ancorare qui il rapporto non è legittimo, perché la diversità delle istanze veritative, presenti nelle esperienze diverse da quella cristiana, non può
essere configurata come negatività e tanto meno come quella forma di negatività
che nel linguaggio cristiano è espressa nel termine peccato. Ciò è senz’altro vero.
Ma è altresì vero che collocare il problema del rapporto tra due realtà diverse non
nella loro zona di prossimità, ma in quella della estrema lontananza, fa acquistare al
discorso una radicalità particolare e, soprattutto, libera il discorso dalla sua riduzione etica. Allora soltanto infatti il rapporto non esclude nulla. Nel nostro caso, non
10
solo non esclude dal rapporto di accoglimento dell’altro una filosofia “buona”, aperta cioè all’esperienza di fede e anzi esigitiva in qualche modo di essa, e nemmeno una filosofia agnostica e quindi non racchiusa nella negazione, ma nemmeno la
negazione filosofica in quanto tale, a meno che essa non si autoponga “fuori”, dichiari cioè la propria inconciliabilità di principio con il rapporto che le viene offerto nell’evento cristologico.12
Se il logos della fede comunque è una verità essenzialmente relazionale,
nel senso che questa verità, che è l’evento cristologico stesso, avviene solo come
assunzione di alterità, allora vale che ogni filosofia, come ogni altra istanza veritativa dell’uomo nella sua concretezza storica, possa dirsi dentro la verità cristiana
senza dover rinunciare a se stessa e, all’estremo, senza dover rinunciare alla propria
negazione. Nella conclusione cercherò di giustificare questa affermazione che adesso può sembrare paradossale. Qui invece mi preme chiarire due aspetti del rapporto così delineato tra teologia e istanza veritativa presente nel filosofare.
Il primo è che questa assunzione di una filosofia determinata non va confusa con ciò che prima ho chiamato, citando il padre Chenu, un atto di prammatismo
intellettuale del teologo. Non si tratta infatti di assumere un singolo concetto, una
singola categoria, e piegarlo nella transumptio teologica a un contesto estraneo.
L’aristotelismo, il neoplatonismo, il cartesianesimo, il kantismo etc. sono pratiche
possibili - e di fatto lo sono state e lo sono ancora - all’interno dell’orizzonte credente, mantenendo le loro connotazioni specifiche, i loro paradigmi fondamentali
che non mutano equilibrio quando sperimentano aggiustamenti interpretativi. Quella singolare interpretazione kantiana del padre Maréchal, dove non è facile mostrare se il suo carattere ultimo sia appunto dato da Kant o da Tommaso, è un esempio
concreto della mia affermazione. Preferisco rimandare alla conclusione esempi meno facili, quelli cioè dove l’integrazione dentro l’orizzonte cristiano non è così
tranquilla. E comunque non vorrei che questa affermazione fosse confusa con quella sulla possibilità di una filosofia cristiana. A mio avviso la filosofia, se resta tale,
come espressione dell’istanza veritativa determinata dal filosofare, non può essere
“cristiana”. Si dà a partire dalle mie premesse una filosofia teologica, determinata
cioè nella strutturazione stessa del suo esercizio dal logos cristiano, come lo sono
ad esempio quella di Tommaso o, in tempi prossimi ai nostri quella di Przywara,
von Balthasar, Rahner, dello stesso de Lubac, ma non una filosofia cristiana. Sempre a partire da queste premesse ogni filosofia è invece possibile all’interno
dell’orizzonte credente del cristianesimo e quindi ogni filosofia può essere “cristiana”. Ma se ogni filosofia può essere cristiana è ovvio che si tratta di una affermazione senza senso.
12
E’ ovvio che il motivo dell’accoglienza risulterebbe inaccettabile se esso si configurasse come
“condiscendenza”. Esiste a dire il vero nel linguaggio cristiano questo termine, ma esso non possiede il
significato negativo che esiste nell’uso italiano attuale, dove tutto l’accento è posto nella seconda parte e
nella terza della parola composta, nel (con-)di-scendere, e implica un atto di “degnazione” per l’altro. Ma
nel termine originario (syn-katabasis) l’accento è sulla prima particella, sul “con”, sulla comunione
stabilita. Atanasio ad esempio dice che il Verbo “si rende presente (paraginetai) con-discendendo
nell’amicizia all’uomo (synkatabainôn philanthropia) e nella manifestazione ” ( De incarnatione Verbi 8.1
(Sources chrétiennes 199), pp. 288-290). In questa interpretazione atanasiana, non solo l’accento è sul syn,
sulla comunione di amicizia che la presenza della diversità divina stabilisce, ma si evidenzia che essa non è
atto estrinseco al Logos giacché, in questa “con-discendenza”, si ha la manifestazione stessa di ciò che Dio
è, la sua “epifania”. Il motivo dell’accoglienza della diversità ultima, fino alla identificazione con la
negazione di sé ( “fece peccato per noi colui che non conosceva peccato”) non è quindi un adattamento
estrinseco a un altro, ma è proprio ciò che mette allo scoperto l’identità ultima. Non voglio qui evocare
alcuna dialettica, sia essa quella dinamica di tipo hegeliano, o quella statica di tipo kierkegaardiano, mentre
mi sembra importante rispettare e lasciare intatta l’ingenuità della narrazione primitiva.
11
Il secondo aspetto attiene a quella che prima ho chiamato la dimensione
kenotica del linguaggio cristiano: il Dio di Gesù Cristo non ha parole “proprie”, ma
assume le parole degli uomini. Questo implica l’esperienza del perdersi,
dell’attraversamento di ogni percorso storico dell’uomo nella ricerca di se stesso,
sia pure lontano da Dio. Sono sempre stato impressionato dall’interpretazione barthiana della parabola del figlio prodigo. Barth introduce in quella parabola la figura
del Cristo narratore che non parla esplicitamente di se stesso, giacché scompare
completamente dietro la narrazione della vicenda tra Padre e figlio perduto e ritrovato. Il Figlio non è assente dagli avvenimenti raccontati nella parabola, ma è il
narratore non visto il quale “è proprio questo cammino nella lontananza di questa
esistenza umana perduta: il cammino lungo il quale si fa uguale e solidale proprio
con questo figlio perduto, mettendosi al suo posto totalmente e senza riserve, caricandosi del suo peccato, della sua vergogna e della sua trasgressione - come se fosse stato lui stesso a farla - e facendo come sua propria la sua miseria - come se fosse stato lui a meritarla."13 Prolungando la sua interpretazione possiamo dire non
solo che il Figlio narratore è colui che accompagna in silenzio l’allontanarsi del figlio dissipatore delle sostanze ricevute. Ma possiamo altresì dire che la sua compagnia non lascia mai sola la vicenda del figlio lontano, giacché la compagnia del
Figlio sop-porta l’assenza del Padre. Il Figlio narratore respinge invece il rifiuto del
figlio giusto e non lo lascia entrare in casa. Dentro la casa del Padre ha posto la
lontananza da Dio, mentre non ha posto il rifiuto dell’accoglienza.
Il rapporto allora che il teologare offre alle filosofie è quello di uno spazio
dell’accoglienza di ogni dirsi dell’uomo. E’ questo dirsi dell’uomo, come espressione della sua essenza spirituale, che il teologare accoglie, nel suo insopprimibile
legame con il dire dell’uomo stesso. In quanto dirsi inscindibilmente legato ad un
dire qualcosa, ogni filosofare può diventare esplicitazione della ricchezza
dell’evento cristologico, se da parte sua accetta di collocarsi nell’orizzonte della
fede. Fino a quando non accetterà di porsi in quell’orizzonte, il suo dirsi continua
tuttavia a restare già accolto dal teologo e dal credente, perché già prima è stato accolto una volta per tutte da Cristo.
L’obiezione che sorge è duplice. La prima fa leva sulla impossibilità di una
negazione esplicita all’interno della fede stessa, per cui tutto quanto ho detto si risolve in un gioco di parole senza riferimento concreto: che senso può avere il dire
che la negazione è accolta dentro ciò che viene negato? La seconda è che quello delineato non è il rapporto tra teologia e filosofia, ma tra fede e filosofia.
Vorrei rispondere alla prima con una riflessione dettata dalla grande figura
dell’unità dei due Testamenti, ma più in generale dell’unità delle Scritture. Il Nuovo Testamento, come l’evento della croce, non elimina, ma si carica della diversità
dell’Antico. Perché il canto di amore e di passione umana, che non ha mai bisogno
di nominare Dio - e il Cantico è l’unico libro della Bibbia che non contiene il nome
di Dio se non nella metafora delle “fiamme di JHWH” - può essere contenuto nel
canone delle Scritture, andando poi soggetto, lungo secoli di interpretazione rabbinica e cristiana, alla “violenza” della sua interpretazione spirituale? Noi sappiamo,
proprio dal dibattito rabbinico sulla sua ammissibilità, che esso era cantato nelle taverne. Il problema allora è può un canto di taverna entrare nella liturgia? E se lo
può perché lo può e a quali condizioni?
Può ancora il dubbio del Qohelet essere assunto nello spazio credente, sen13
Kirchliche Dogmatik IV/2, 21-25, cit a p. 23
12
za essere sciolto? La fiducia del Qohelet è che Dio ascolti il suo dubbio. Il dubbio è
portato davanti a Dio, ma il dubbio non viene mai ritirato dal Qohelet. E la questione della teodicea per eccellenza, quella del rapporto tra Dio e la sofferenza
dell’innocente, perché non viene sciolta nel libro di Giobbe, come spesso non viene
sciolta - se siamo capaci di mantenere la stessa onestà intellettuale di Giobbe nemmeno nella nostra vita di credenti? Non si risponda che la morte di Cristo è la
risposta a queste domande e a questi dubbi. Non è la morte, ma la risurrezione di
Cristo la risposta alle domande e ai dubbi. Ma allora la vera risposta è solo la fede
nel Risorto. La vera risposta sta cioè altrove: tutto può essere mantenuto, purché sia
vissuto davanti al Dio di Gesù Cristo. Che cosa poi possa accadere quando un uomo mantenga realmente tutto davanti al Dio di Gesù, quando egli accolga cioè, a
partire dal suo dirsi nel proprio dire, il rapporto che rimane eternamente offerto a
lui nel sì di Dio in Cristo, questa è la scrittura di un nuovo libro che la storia riserva
ad ognuno e che noi non possiamo prevedere.
La seconda obiezione, quella cioè che nota come noi abbiamo chiarito il
rapporto tra fede e filosofia ma non tra teologia e filosofia, può trovare una risposta
immediata qualora si ricordi quanto è stato detto sul logos della teologia. Essa è
appunto questo “chiarire”, essa non aggiunge “contenuti” nuovi quando aggiunge
ragioni alla fede, ma ne chiarisce solo la grammatica profonda, nella spiegazione
delle conseguenze dell’unico fondamento sul quale ogni teologo deve collegare le
sue rationes necessariae, cioè sulla morte di Gesù in croce.
13