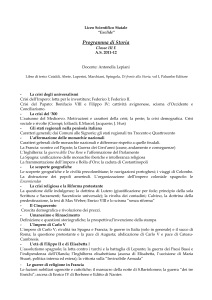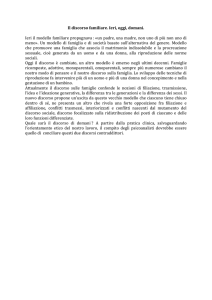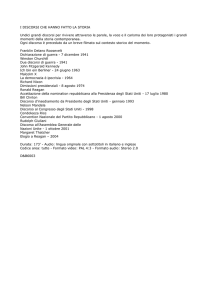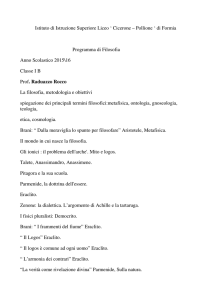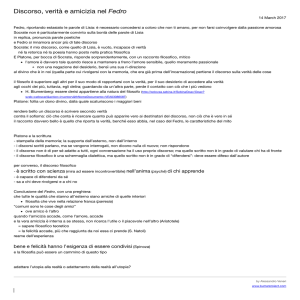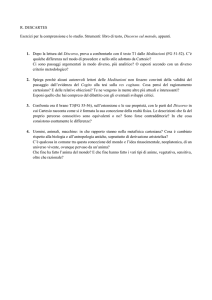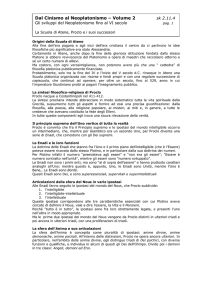Proclo Licio Diadoco
l'ultima grande voce della filosofia greca
(dispensa a cura dell'insegnante Daniele Savi)
1.
A mo' di introduzione: la vita, le opere principali, il contesto storico-culturale.
Vissuto nel V sec. (per la precisione tra il 412 e il 485) Proclo è considerabile, a buon diritto,
l'ultima grande figura nella storia del pensiero greco. È inoltre l'ultimo significativo successore di
Platone alla guida dell'Accademia ateniese, che chiuderà nel 529. La sua vita ci è tramandata dal
suo discepolo Marino di Neapoli. Questi ci riferisce che il filosofo era originario di Xanto, nella
Licia (Asia Minore). Studiò prima retorica e filosofia ad Alessandria e, successivamente, fu
discepolo ad Atene dei neoplatonici Plutarco e Siriano.
L'inquadramento cronologico è tutt'altro che marginale. La vita di Proclo si incrocia infatti con
quella di Agostino di Ippona (354-430), di cui notoriamente profondo è il debito al pensiero
neoplatonico. Agostino naturalmente non conobbe la filosofia di Proclo ma è significativo che, nello
stesso secolo, calchino la scena l'ultimo grande filosofo greco-pagano e uno dei più grandi padri
della Chiesa e del pensiero cristiano.
Una sorta di epocale passaggio di consegne pare dunque legare simbolicamente i due pensatori e
con loro due grandi tradizioni filosofiche. Il tramonto del pensiero antico e di un'intera epoca
dell'umanità cede il passo ad un mondo nuovo, che ha nel cristianesimo il proprio fulcro.
Uno degli aspetti caratterizzanti della filosofia procliana è, in questo senso, il tentativo di recuperare
e far rivivere il tradizionale pantheon greco. Naturalmente si tratta di uno sforzo di
razionalizzazione, sulla scorta di quanto già intrapreso da Plotino, degli dei olimpici. Questi
vengono interpretati quali essenze puramente intelligibili, elementi del mondo ideale che
rappresentano diversi passaggi del processo di derivazione di tutte le cose dall'Uno.
È chiaro come un tale, grandioso sforzo di vivificare il mondo degli dei sia in realtà il canto del
cigno di una religione, quella pagana, ormai sclerotizzata e priva di vitalità. Insostenibile è, infatti, il
confronto con il dinamismo e l'irresistibile forza propulsiva del cristianesimo.
Assolutamente notevole è la quantità di scritti procliani che si sono conservati fino a noi e che
eserciteranno una profonda influenza sullo sviluppo del pensiero cristiano medievale e della
filosofia moderna, come avremo modo di illustrare sinteticamente.
Tra i principali ricordiamo gli Elementi di teologia e la Teologia platonica, che costituiscono il
punto di riferimento principale per la presente esposizione del pensiero dell'autore. Da ricordare,
inoltre, i Commentari a vari dialoghi platonici, tra cui spicca senza dubbio quello al Parmenide.
Come testimonia il titolo, gli Elementi di teologia sono strutturati sul modello degli Elementi di
Euclide. L'argomentazione si sviluppa dunque come una concatenazione di deduzioni necessarie a
partire da un ristretto nucleo di assiomi o proposizioni fondamentali. Ogni enunciato è seguito da un
commento o spiegazione che ne fornisce la dimostrazione, lo illustra chiarendo il rapporto con altre
proposizioni già in precedenza dimostrate.
La Teologia platonica è un'opera in sei libri che si propone come ampia esposizione dei contenuti
fondamentali del pensiero di Platone, con continui rimandi ai suoi dialoghi, in particolare a quelli
“dialettici” (Parmenide, Filebo, Sofista). Nel solco tracciato innanzitutto da Plotino, Proclo rilegge
in tal modo la filosofia platonica in senso eminentemente teologico, ossia come discorso sulla
natura di Dio (l'Uno) e sul rapporto tra Dio, l'uomo e il mondo (la molteplicità).
2.
L'eredità platonica.
Come tutti i neoplatonici Proclo è profondamente convinto di dar voce, con il suo pensiero, alla più
genuina filosofia di Platone, riconoscendo naturalmente il contributo dei suoi più diretti
predecessori, Plotino su tutti. In questa sede è improponibile ripercorrere tutti i riferimenti ai
dialoghi platonici. Si ritiene tuttavia fondamentale riproporre alcuni luoghi tra i più cruciali e
famosi dell'intera opera di Platone, la cui interpretazione costituisce il cuore della speculazione di
Proclo e che a noi servono da punto di riferimento.
Il primo brano è tratto dalla Repubblica. Si tratta della famosa descrizione dell'idea del bene
condotta da Socrate attraverso una similitudine con il sole. Come il sole è fonte della luce che rende
possibile vedere ogni cosa, così l'idea del Bene è fonte dell'intelligibilità dell'intero mondo ideale: è
principio ad un tempo dell'essere e del conoscere. Si noti che, per parlare del principio primo della
realtà, Platone ricorre ad un linguaggio non propriamente filosofico. È una costante del pensiero del
grande filosofo: quando il pensiero argomentativo, il logos, sperimenta le più ardue difficoltà, si
apre lo spazio per il mito, per il linguaggio metaforico e allegorico. Come vedremo Bene è, per
Proclo, sinonimo di Uno e attributo del Principio.
Per forza, rispose. Ma tu ora, Socrate, dici che il bene sia scienza o piacere o qualcosa di diverso? – Oh!, caro il mio
uomo, replicai, lo sapevo bene, ed era palese da tempo che non ti avrebbe soddisfatto l’opinione degli altri a questo
proposito. – Non mi sembra giusto, Socrate, disse, che uno che da tanto tempo si occupa di questi argomenti sappia
riportare le opinioni altrui e la [c] propria no. – E ti sembra giusto, feci io, che uno parli delle cose che non sa come se le
sapesse? – Come se le sapesse, rispose, no, affatto. È giusto però voler parlare da uomo veramente convinto della sua
opinione. – E non ti sei accorto, continuai, che le opinioni non accompagnate dalla scienza sono tutte brutte? Di esse le
migliori sono cieche. Ti sembra che coloro che hanno una vera opinione su qualcosa, ma sono sprovvisti di intelletto,
presentino qualche differenza da ciechi che camminano dritto per una strada? – Nessuna differenza, rispose. Vuoi
dunque contemplare cose brutte, cieche e storte, quando ti è possibile sentirne da altri di splendide e belle? – No, per
Zeus!, Socrate, fece Glaucone, non ritirarti come se fossi alla fine. Noi ci sentiremo soddisfatti se tratterai del bene allo
stesso modo con cui hai trattato della giustizia, della temperanza e delle altre virtú. – Anch'io, risposi, mio caro amico,
ne sarò molto soddisfatto, ma temo che non ci riuscirò e che, pur mettendocela tutta, farò una brutta figura e mi esporrò
allo scherno. Su, benedetti [e] amici, lasciamo stare per il momento che cosa sia mai il bene in sé: mi sembra una cosa
troppo alta perché possiamo raggiungere ora, con lo slancio presente, il concetto che ne ho io. Invece voglio dire, se ne
siete contenti pure voi, quello che sembra la prole del bene, cui molto somiglia. Se però non ne siete contenti,
lasciamolo perdere. – Su, dillo!, fece. Pagherai il tuo debito un'altra volta, [507 a] spiegandoci che cosa è il padre. Vorrei poter pagarvelo, risposi, e che voi poteste riscuoterlo tutto, anziché, come adesso, i soli frutti. Prendetevi dunque
questo frutto e la prole del bene in sé. State però attenti che, senza volere, in qualche modo non vi imbrogli, rendendovi
falsificato il computo del frutto. - Staremo attenti, rispose, come potremo. Ma tu limitati a parlare. - Lo farò, dissi,
soltanto quando mi sarò messo d'accordo con voi e vi avrò fatto ricordare quello che s'è detto prima e quello che già s'è
detto piú volte in altre occasioni. - Che cosa?, [b] chiese. – Noi affermiamo che ci sono molte cose belle, e belle le
definiamo col nostro discorso; e diciamo che ci sono molte cose buone e cosí via. – Lo affermiamo. – E poi anche che
esistono il bello in sé e il bene in sé; e cosí tutte le cose che allora consideravamo molte, ora invece le consideriamo
ciascuna in rapporto a una idea, che diciamo una, e ciascuna chiamiamo “ciò che è”. – È cosí. – E diciamo che quelle
molte cose si vedono, ma non si colgono con l’intelletto, e che le idee invece si colgono con l’intelletto, ma non si
vedono. – Senza [c] dubbio. – Ora, qual è in noi l’organo che ci fa vedere le cose visibili? – La vista, rispose. – E,
continuai, non è l’udito che ci fa udire le cose udibili? e non sono gli altri sensi a farci sentire tutte le cose sensibili? –
Sicuramente. – Ora, hai riflettuto, feci io, quanto maggiore pregio l’artefice dei sensi abbia voluto conferire a quello di
vedere e di essere visti? – No proprio, rispose. – Ma esamina la cosa in questo modo. L’udito e la voce richiedono il
concorso di un elemento diverso, il primo per udire, la seconda per essere udita? – E se questo [d] terzo elemento non è
presente, forse che l’uno non udrà e l’altra non sarà udita? – Non richiedono il concorso di nulla, rispose. – E, credo,
feci io, nemmeno molte altre facoltà, per non dire nessuna, richiedono alcunché di simile. O ne puoi citare qualcuna? –
Io no, rispose. – Ma non pensi che lo richiede la facoltà della vista e del visibile? – Come? – Ammettiamo che negli
occhi abbia sede la vista e che chi la possiede cominci a servirsene, e che in essi si trovi il colore. Ma se non è presente
un terzo elemento, che la natura riserva proprio a questo [e] cómpito, tu ti rendi conto che la vista non vedrà nulla e che
i colori resteranno invisibili. – Qual è questo elemento di cui parli? – Quello, risposi, che tu chiami luce. – Dici la verità,
ammise. – Di una specie non insignificante sono dunque il senso della vista e la facoltà [508 a] di essere veduti, se sono
stati congiunti con un legame piú prezioso di quello che tiene insieme le altre combinazioni, a meno che non sia cosa
spregevole la luce. – Spregevole?, disse. Tutt’altro!
– A quale dunque tra gli dèi del cielo puoi attribuire questo potere? un dio la cui luce permette alla nostra vista di vedere
nel miglior modo e alle cose visibili di farsi vedere? – Quello, rispose, che tu e gli altri riconoscete: è chiaro che la tua
domanda si riferisce al sole. – Ora, il rapporto tra la vista e questo dio non è per natura cosí? – Come? – La vista, né
come facoltà in se stessa né come organo in cui ha sede e che chiamiamo [b] occhio, non è il sole. – No, certamente, –
Eppure, a mio parere, tra gli organi dei sensi è quello che piú ricorda nell’aspetto il sole. – Sí, certo. – E la facoltà di cui
dispone non l’ha perché dispensata dal sole, come un fluido che filtra in essa? – Senza dubbio. – E non è vero anche che
il sole non è la vista, ma, essendone causa, è da essa stessa veduto? – È cosí, ammise. – Puoi dir dunque, feci io, che io
chiamo il sole prole [c] del bene, generato dal bene a propria immagine. Ciò che nel mondo intelligibile il bene è
rispetto all’intelletto e agli oggetti intelligibili, nel mondo visibile è il sole rispetto alla vista e agli oggetti visibili. –
Come?, fece, ripetimelo. – Non sai, ripresi, che gli occhi, quando uno non li volge piú agli oggetti rischiarati nei loro
colori dalla luce diurna, ma a quelli rischiarati dai lumi notturni, si offuscano e sembrano quasi ciechi, come se non
fosse nitida in loro la vista? – Certamente, rispose. – Ma [d] quando, credo, uno li volge agli oggetti illuminati dal sole,
vedono distintamente e la vista, che ha sede in questi occhi medesimi, appare nitida. – Sicuro! – Allo stesso modo
considera anche il caso dell’anima, cosí come ti dico. Quando essa si fissa saldamente su ciò che è illuminato dalla
verità e dall’essere, ecco che lo coglie e lo conosce, ed è evidente la sua intelligenza; quando invece si fissa su ciò che è
misto di tenebra e che nasce e perisce, allora essa non ha che opinioni e s’offusca, rivolta in sú e in giú, mutandole, le
sue opinioni e rassomiglia a persona senza intelletto. – Le somiglia proprio. – Ora, [e] questo elemento che agli oggetti
conosciuti conferisce la verità e a chi conosce dà la facoltà di conoscere, di’ pure che è l’idea del bene; e devi pensarla
causa della scienza e della verità, in quanto conosciute. Ma benché la scienza e la verità siano entrambe così belle, farai
bene a reputarla diversa da esse e ancora più bella. Come in quel caso è giusto considerare la luce e la vista simili al
sole, ma non il sole, così in questo caso è giusto ritenere sia la scienza [509 a] sia la verità simili al bene, ma nessuna
delle due va identificata con il bene, la cui condizione dev'essere tenuta in un pregio ancora più alto. – Tu parli di una
bellezza irresistibile – disse – se procura la conoscenza e la verità, ma le supera essa stessa in bellezza; perché non stai
certo parlando del piacere! – Non proferire parole empie – replicai – : considera piuttosto la sua immagine da questo
punto di vista. [509 b] – Quale? – Tu dirai, penso, che il sole fornisce alle cose visibili non solo la facoltà di essere
vedute, ma anche la nascita, la crescita e il nutrimento, pur non essendo esso stesso principio di nascita. – Ma certo! –
Quindi dirai che le cose conoscibili ricevono dal bene non solo la facoltà di essere conosciute, ma anche l'esistenza e
l'essenza (to einai te kai ten ousian), quantunque il bene non sia l'essenza, ma per dignità e potenza la trascenda
epekeina tes ousias).
Il Parmenide è probabilmente il più difficile ed enigmatico dialogo di Platone. Nella seconda parte
del dialogo gli interlocutori, il giovane Aristotele e lo straniero di Elea, cercano di determinare lo
hen. Seguendo il tipico metodo dialettico che già conosciamo, mettono a tema della discussione una
serie di ipotesi sull'hen, in particolare se sia o non sia, deducendo tutte le necessarie conclusioni da
ognuna di esse.
Di cosa l'hen sia, tuttavia, non si fa parola.
Che significato hanno le ipotesi sull'Uno? Si tratta di un gioco – seppur serio come lo definisce
Platone – logico-dialettico che prescinde da qualsiasi riflessione sulla natura, l'intima costituzione
dell'uno di cui si parla? O piuttosto le ipotesi aprono uno squarcio anche su ciò che l'Uno è,
considerandolo dunque come primo principio metafisico della realtà, come Uno in sé?
Su questi interrogativi continuano ad arrovellarsi coloro che si cimentano con le pagine del
Parmenide, tanto da poter dire che non esiste a tutt'oggi un'interpretazione univoca.
Al fine di analizzarne, in seguito, l'interpretazione procliana fa conto riportare qui il testo della
prima ipotesi (Platone, Parmenide, 137a - 142b)
«Da dove cominceremo? E qual è la nostra prima ipotesi? Oppure volete, dato che mi sembra si giochi un gioco
alquanto serio, che cominciamo da me stesso e dall'ipotesi di me stesso, ipotizzando, intorno all'uno in sé, sia che l'uno
sia uno, sia che non lo sia, e vedere che cosa ne consegue?»
«Certamente», disse Zenone.
«Chi mi risponderà?», domandò Parmenide. «Il più giovane? Sarà meno zelante degli altri, e dirà con più spontaneità
quello che pensa, e nel contempo le sue risposte saranno per me una pausa»
«Sono pronto a fare questo, o Parmenide», disse Aristotele. «Ti riferisci a me, infatti, quando parli del più giovane. Ma
ora formula le domande, ed io rispondo».
«Bene», disse Parmenide «se l'uno è uno (ei en estin), non è vero che per nessun'altra ragione sarà molti?» «Come
potrebbe?» «Né dev'esserci una sua parte, né esso sarà un tutto». «Perché?» «La parte è parte di un tutto». «Sì». «Cos'è
il tutto? Un tutto non è ciò di cui non manca parte alcuna?» «Certo». «In un modo o nell'altro, l'uno dovrebbe essere la
risultante di parti, poiché è un tutto, ed ha parti». «Necessariamente». «In un modo o nell'altro, così, l'uno sarà molti, ma
non uno». «Vero». «Ma non deve essere molti, ma uno in sé». «Sì, dovrebbe essere così». «Non sarà un tutto, né avrà
parti, se l'uno sarà uno». «No di certo».
«Se allora non avrà parte alcuna non avrà principio né fine, ne mezzo: queste, infatti, sarebbero già parti di quello».
«Giusto». «E fine e principio sono il limite di ciascuna cosa». «E come no?». «E allora l'uno è infinito, se non ha né
principio né fine». «Infinito». «E sarà senza forma: infatti non prende parte né del circolare, né del rettilineo». «E
come?» «Circolare è ciò di cui i punti estremi sono in ogni parte ugualmente distanti dal centro». «Sì». «Rettilineo
«Rettilineo è ciò il cui centro è posto come uno schermo fra i due punti estremi». «È così ». «Dunque l'uno avrebbe
parti e sarebbe molti, se prendesse parte di una forma rettilinea o circolare». «Certamente». «Ma non è né rettilineo, né
circolare, se è vero che non ha parti». «Giusto». «E avendo tali caratteristiche, non sarà in nessun luogo: infatti non
potrà trovarsi né in altro da sé, né in se stesso». «Come?» «Se si trovasse in altro da sé, sarebbe circondato intorno da
ciò in cui si trova, e in molte parti verrebbe a contatto con esso in molti punti: ma siccome l'uno è privo di parti e non
partecipa di ciò che è circolare, è impossibile che abbia contatti intorno in molte parti». «Impossibile». «Ma essendo in
se stesso, nient'altro lo circonderebbe se non se stesso, se è vero che si trova in se stesso: sarebbe impossibile, infatti,
che qualche cosa si trovi in qualcosa che non lo circondi». «Impossibile». «Cosa diversa, dunque, sarà ciò che circonda,
preso in sé, e diverso sarà anche ciò che viene circondato: infatti ciò che è identico non potrà, nella sua totalità, fare le
due cose contemporaneamente, ovvero subire e agire; se così fosse, l'uno non sarebbe più uno, ma due». «No,
certamente». «Dunque l'uno non è in nessun luogo, non trovandosi né in se stesso, né in altro da sé». «Non è in nessun
luogo». «Considera allora se, avendolo definito in questi termini, all'uno è possibile star fermo o muoversi». «Perché
no?» «Perché muovendosi, o si sposterebbe, o diventerebbe altro da sé: questi sono i soli movimenti possibili». «Sì ».
«Diventando altro da sé, è impossibile che l'uno sia ancora uno». «Impossibile». «Esso, allora, non si muove secondo
mutamenti rispetto a se stesso». «Non risulta». [...]
«Esso non sarà identico né ad altro, né a se stesso, e, d'altro canto, non sarà neppure diverso né da se stesso, né da
altro». «Come?» «Se fosse diverso da se stesso, sarebbe diverso dall'uno e non sarebbe più uno». «Vero». «Se fosse
identico all'altro, sarebbe quell'altro, e non sarebbe più se stesso: sicché non sarebbe più così come è, cioè uno, ma
diverso dall'uno». «No, certo». «Non sarà dunque identico ad altro, o diverso da se stesso». «No». «E non sarà diverso
da altro, finché sarà uno: non spetta all'uno essere diverso da qualche cosa, ma solo all'altro essere diverso dall'altro, e a
null'altro». «Giusto». «Pertanto, in quanto è uno, non sarà affatto diverso. O come credi che sia?» «No, certo». «Ma se
per questo motivo non è diverso, non lo sarà neppure per la ragione che scaturisce da se stesso, e se non lo è per se
stesso, non lo è nemmeno esso stesso: e se esso non è diverso in nessun modo, non sarà diverso da nulla». «Giusto». «E
non sarà identico e stesso». «E come no?» «La natura dell'uno non è la stessa di quella dell'identico». «E perché?»
«Perché non in base al fatto che qualcosa diviene identico a qualcosa diventa uno». «Ma certamente». «Se diviene
identico ai molti, di necessità diviene molti, ma non uno». «Vero». «Ma se l'uno e l'identico non differiscono affatto,
quando un qualcosa diventasse identico, sempre diventerebbe uno, e quando diventasse uno, sempre diventerebbe
identico». «Certo». «Se l'uno sarà identico a se stesso, non sarà uno con se stesso: e così essendo uno, non sarà più uno.
Ma questo è impossibile: è dunque anche impossibile che l'uno sia diverso da altro, o identico a se stesso».
«Impossibile». «Così l'uno non sarà diverso o identico né a se stesso, né ad altro». «No, certamente». [...] «Se l'uno in
alcun modo partecipa di nessun tempo, non è mai diventato, mai diventava, mai era; ora non è diventato, non diventa,
non è; e neppure in futuro diventerà, né sarà diventato, né sarà». «Verissimo». «Vi è un modo per cui possa partecipare
all'essere, diverso da quelli suddetti?» «Non c'è». «Per nessuna ragione l'uno partecipa all'essere». «Pare di no». «Per
nessuna ragione l'uno esiste». «Risulta di no». «Non è tale da essere uno: lo sarebbe ormai, se avesse esistenza e
partecipasse all'essere; ma, pare, l'uno non è uno e non esiste, se si deve prestare fede a questo discorso». «Può darsi».
«Ciò che non è, può possedere, questo non essere, qualcosa di suo, o proprio di lui stesso?» «E come?» «Dunque non ha
nome, né discorso, né scienza, né sensazione, né opinione». «Risulta di no». «Non si può nominarlo, né farlo oggetto di
discorso, né di opinione, né di conoscenza, e nessuna delle cose che sono hanno sensazione di lui». «Pare di no».
«Dunque è possibile che le cose stiano in questi termini intorno all'uno?» «Mi sembra di no». «Vuoi che torniamo
nuovamente dal principio all'ipotesi, nel caso che, tornando indietro, ci risulti qualcosa di diverso?» «Certo, lo voglio».
Nel Filebo, altro dialogo della tarda maturità, Platone conduce un'indagine sulla natura del vero
bene per l'uomo e sugli elementi che concorrono a determinarlo, tra cui l'intelligenza e il piacere.
Protarco sostiene che il bene consiste nel piacere, mentre Socrate lo identifica sostanzialmente
nell'attività dell'intelligenza, nella conoscenza. Definire esattamente cosa siano piacere e
conoscenza, tuttavia, è difficile. Essi si presentano in molteplici aspetti, tutti appartenenti al
medesimo unico genere. Si avvia quindi una digressione sui temi che già conosciamo: il rapporto tra
molteplice e unità di cui sono commiste tutte le cose esistenti. Da qui parte la trattazione platonica
dei sommi generi della realtà esistente, che Platone identifica in: limite (peras); illimitato (apeiron);
misto (mikton); causa (aitia).
SOCRATE: : Cerchiamo di stare in guardia nel gettare le basi di questo discorso. PROTARCO: E quale base? S. : Tutte
le cose che ora sono nel tutto dividiamole in due parti, o, se vuoi, in tre. P.: Puoi spiegare in che modo? S.: Prendiamo
alcuni concetti dei discorsi che ora facevamo. P.: E quali? S.: Dicevamo che il dio ha indicato l'infinito delle cose, ma
anche il confine. P.: Certamente. S.: Stabiliamo che questi due siano due generi, e che vi sia un terzo genere - un'unità
anch'essa - che nasce dalla commistione di questi due. Mi sembra però di essere alquanto ridicolo dividendo e contando
secondo i generi. P.: Che dici, o carissimo? S.: Mi sembra che ci vorrà ancora un quarto genere. P.: E di quale parli? S.:
Guarda alla causa della commistione di questi gli uni verso gli altri, e aggiungi questo quarto genere a quei tre. P.: E non
avrai bisogno di un quinto che possa operare una separazione? S.: Può darsi, ma non credo per ora: se ce ne sarà
bisogno, avrai la bontà di lasciarmi perseguire anche il quinto. P.: E come? S.: Innanzitutto avendo determinato tre
generi dei quattro, facciamo un esperimento con due di questi, dopo che abbiamo osservato che l'uno e l'altro si
dividono e si lacerano in molte parti, per riportarli successivamente entrambi all'unità, e ragioniamo sul fatto che
ciascuno di essi sono unità e molteplicità. P.: Se parlassi in modo ancora più chiaro intorno a queste cose, potrei seguirti.
S.: Dico che i due generi che sottopongo all'esame sono gli stessi di un attimo fa, poiché l'uno contiene l'infinito, l'altro
il finito. Tenterò allora di spiegare come l'infinito corrisponde alla molteplicità. Quanto al finito, ci attenda un momento.
P.: Sì, ci aspetta. S.: Presta attenzione. è difficile e controverso il problema su cui chiedo la tua attenzione, tuttavia
rifletti. Pensa innanzitutto se potessi mai concepire un confine per il "più caldo" e per il "più freddo", oppure se il "più"
e il "meno" che sono insite nella loro genesi, finché vi saranno insite, impediranno che vi sia una fine: se vi fosse una
fine, anche questi due sono finiti. P.: Quello che dici è verissimo. S.: Nel "più caldo" e nel "più freddo" vi è sempre il
"più" e il "meno", noi affermiamo. P.: Certamente. S.: Sempre dunque il ragionamento ci indica che questi due non
hanno una fine, ma essendo tutti e due senza un limite sono del tutto infiniti. P.: Sono assolutamente d'accordo, Socrate.
S.: Allora, caro Protarco, hai capito bene e mi hai ricordato che anche questo "assolutamente" che hai appena fatto
risuonare e l'"un poco" hanno la stessa validità del "più" e del "meno". Dove quei due si inseriscono, non lasciano che
ciascuna cosa venga quantificata, ma introducendo di continuo l'"assolutamente" e l'"un poco" o il contrario in ogni
questione rendono il concetto di "maggiore" e di "minore", e però non ci permettono di quantificare. In base a quanto
ora detto, se non annullano la quantità, ma lasciano che essa e il grado di misurabilità si inseriscano nelle postazioni dei
"più" e dei "meno", dell'"assolutamente" e dell'"un poco", questi scorrono via dal posto in cui erano. Non avrebbero più
ragione di esistere né il concetto di "più caldo", né quello di "più freddo", se assumessero connotazione quantitativa:
infatti il "più caldo" procede di continuo innanzi e non si ferma, e parimenti il "più freddo", mentre la quantità sta ferma
e non avanza. Dunque, in base a questo ragionamento, il "più caldo", insieme al suo opposto, sarebbero l'infinito. P.: Mi
sembra così, Socrate. Come dicevi, si tratta di concetti difficili da seguire. Ma se colui che interroga e colui che è
interrogato li dicono ancora una volta e poi ancora una volta, potremmo far vedere di essere sufficientemente in
sintonia. S.: Dici bene, e allora cerchiamo di fare così. Adesso rifletti se questo potremo indicarlo come indice della
natura dell'infinito, per non dilungarci trattando ogni aspetto. P.: Quale indice? S.: Tutto quello che ci sembrerà diventi
"più" e "meno", e che accoglie il "fortemente" e il "dolcemente", il "troppo" e tutte le altre cose simili, tutto questo va
posto nella classe dell'infinito come in quella dell'unità, secondo il discorso di prima, per cui tutto ciò che era lacerato e
diviso bisognava radunarlo, conferendogli, per quanto possibile, un'unica natura, se ricordi. P.: Ricordo. S.: Dunque ciò
che non accoglie queste cose, vale a dire tutto quello che accoglie il contrario di esse, per prima cosa "l'uguale" e
"l'uguaglianza", e dopo di questo "l'uguale" e il "doppio", e tutto quello che è numero in relazione al numero e misura in
relazione alla misura, se considerassimo tutto questo all'interno del finito, ci sembrerà di agire bene? P.: Benissimo,
Socrate. S.: E sia. Quale forma diciamo che abbia questo terzo genere mescolato con gli altri due? P.: Lo dirai tu a me,
come credo. S.: No, sarà un dio, se mai un dio porge orecchio alle mie preghiere. P.: Prega e pensaci. S.: Ci penso: e mi
sembra che adesso uno di essi ci sia diventato amico. P.: Come puoi affermarlo e quale prova ne adduci? S.: Te lo
spiegherò chiaramente: e tu seguimi con il ragionamento. P.: Dimmi pure. S.: Abbiamo appena parlato di ciò che è più
caldo e di ciò che è più freddo. Giusto? P.: Certamente. S.: Aggiungi a quelli ciò che è "più secco" e il "più umido", e il
"maggiore" e il "minore", e ciò che è "più veloce" e "più lento", e "più grande" e "più piccolo" e quanto abbiamo prima
raccolto in unità nella natura che accoglie in sé il "più" e il "meno. P.: Alludi alla natura dell'infinito? S.: Certo. Dopo di
ciò in essa mischiavi la stirpe del finito. P.: E quale? S.: Alludo a quel genere del finito che ora non abbiamo riunito,
dovendo invece farlo così come avevamo fatto con la natura dell'infinito raccogliendola in uno. Ma forse anche ora si
farà la stessa cosa, se, radunando quei due, anch'essa diventerà evidente. P.: Di quale parli e cosa intendi dire? S.: Si
tratta del genere di ciò che è "uguale" e di ciò che è "doppio" e di quanto fa smettere che le cose siano opposte fra di
loro e avverse, rendendole misurabili e concordi, introducendo in esse il numero. P.: Capisco. Mi sembra che tu sostieni
che, mescolando questi elementi di cui abbiamo parlato, derivi l'origine di nuove realtà per ciascuna di queste
mescolanze. S.: Mi pare che hai inteso perfettamente. P.: Dimmi allora. S.: Forse nelle malattie la corretta unione di
questi elementi dà origine alla stirpe della salute? P.: Ma certamente. S.: E in ciò che è acuto e in ciò che è grave, in ciò
che è veloce e in ciò che è lento - che sono tutti infiniti - non vi sono forse questi stessi elementi? E non portano a
compimento l'infinito rendendo nel contempo pienamente compiuta la musica? P.: Benissimo. S.: Trovandosi questa
mescolanza anche nel freddo dell'inverno e nel caldo dell'estate, sottrae ciò che è eccessivo e infinito, e realizza ciò che
è moderato e proporzionato. P.: E allora? S.: Allora le stagioni e quanti sono i beni in nostro possesso non scaturiscono
da queste cause, vale a dire dalla mescolanza dell'infinito e di ciò che è finito? P.: E come no? S.: E tralascio
innumerevoli altre cose, quali la bellezza e la forza che si trovano con la salute e altre varie e splendide qualità che si
trovano nell'anima. Questa era la dea,(5) caro Filebo, che vedendo violenza e malvagità insite in tutte le cose e
osservando che in esse non vi era limite al piacere e all'abbondanza, stabilì una legge e un ordinamento che
contenessero un limite: e tu affermi che fece solo danni, mentre al contrario io sostengo che essa è stata motivo di
salvezza. E a te, Protarco, cosa sembra? P.: Queste affermazioni mi sembrano assennate, Socrate. S.: Dunque ho parlato
di tutti questi tre generi, se hai capito. P.: Sì, credo di aver capito. Mi sembra che tu affermi che uno è l'infinito, ma uno
è anche il secondo, ovvero il finito, nelle cose che sono. Quanto al terzo, non ho perfettamente capito che cosa volevi
dire. S.: La quantità di ciò che trae origine dal terzo genere, o carissimo, ti sconvolge. Eppure molte erano le stirpi che
offriva l'infinito, tuttavia una volta contrassegnate con il genere del più e del suo contrario apparvero come un unità. P.:
Vero. S.: E non ci procurava fastidi né il fatto che l'infinito avesse molti aspetti né che fosse uno per natura. P.: E come
no? S.: Non avremmo affatto potuto. Ma tu devi affermare che ho definito questo terzo genere – considerando l'unità
come un tutto che deriva da questi elementi - come ciò che dà origine alla sostanza e che è costituito dalle misure che
realizzano il finito.
3.
Pensare l'Uno. Mistica e teologia negativa.
Come già parzialmente anticipato, tutta la filosofia neoplatonica – ma per estensione si potrebbe
dire tutta la filosofia greca – è percorsa dalla domanda sul rapporto Uno/Molti, tra la molteplicità
degli enti e l'unicità del principio. Come per Plotino così per Proclo, dunque, filosofia è
primariamente pensiero dell'Uno. Uno è Principio, è Dio e quindi il discorso sull'Uno (henologia) è
intrinsecamente teologia.
Ma cos'è più precisamente l'Uno del neoplatonismo? Principio primo di ogni realtà da cui tutto
deriva e in cui tutto ritorna1, l'Uno è innanzitutto il non-molti (a-pollon). Già questa prima
definizione orienta il nostro sguardo verso una delle caratteristiche fondamentali del principio: la
sua radicale alterità e trascendenza. In quanto non-molti, infatti, l'Uno è l' assolutamente altro
rispetto ai molteplici enti (intelligibili o sensibili che siano) che da esso hanno origine.
Probabilmente nessuno, nella storia del pensiero ma anche delle religioni, ha pensato in maniera
tanto radicale la trascendenza del Principio come i neoplatonici.
In questo senso la filosofia di Proclo si presenta, oltre che come uno stringente tentativo di
deduzione della molteplicità dalla causa prima (questo è il contenuto fondamentale degli Elementi,
come vedremo in seguito), come una ferrea giustificazione e affermazione della trascendenza
dell’Uno.
L’eredità speculativa che Proclo sviluppa nella propria henologia è, come anticipato, quella del
Parmenide platonico, che il nostro pensatore non considera certo una mera esercitazione logica, in
quanto vi vede contenuta l’intera e più perfetta formulazione della teologia di Platone2.
Nel primo libro della Teologia Proclo presenta la propria interpretazione del Parmenide, chiarendo
in particolare come egli intenda la prima ipotesi3: “se l’Uno è” (ei hen estin). Egli comprende la
prima ipotesi in senso eminentemente metafisico, quale trattazione «del Principio degli enti che
trascende l’essere, l’ineffabile, l’inconoscibile e al di là di ogni ente» 4. Come si può desumere dal
testo, dalla prima ipotesi consegue, nell’argomentazione platonica, la negazione di ogni attributo
all’hen: se l'Uno è radicalmente tale, esso si trova in nessun luogo come in nessun tempo, non
patisce mutamento alcuno, non è identico né diverso da se stesso né da altro, né simile né dissimile.
Esso insomma non è in alcun modo e quindi «non ha nome, né discorso, né scienza, né sensazione,
né opinione […] Non si può nominarlo, né farlo oggetto di discorso, né di opinione, né di
conoscenza, e nessuna delle cose che sono hanno sensazione di lui»5.
Se l'Uno è Uno, questo secondo Proclo è il significato della prima ipotesi, di esso non si può dare
alcuna predicazione categoriale: non si può insomma dire che l'Uno è questo o quello. Se si vuole
pensare il Principio nella sua radicale semplicità gli si deve negare qualsiasi attributo, anche quello
dell'essere. Quindi, propriamente, se l'Uno è (se è Uno assoluto) siamo costretti ad ammettere che
l'Uno non è (è oltre l'essere stesso, è super-essere).
L’Uno procliano è insomma trascendente anche rispetto all’essere di cui è causa: «è dunque la causa
degli enti tutti al di là dell’essere tutto quanto; separabile da ogni esseità, non possiede l’essere e
non lo possiede nemmeno come attributo; quest’aggiunta infatti è diminuzione della semplicità
dell’Uno»6.
Assolutamente semplice e scevro di determinazioni, inconoscibile ed inesprimibile è dunque l’Uno
procliano nella sua trascendenza: «e in rapporto a questo principio potrai anche dire molte cose; ma
il Principio non lo toccheranno le tue parole. E dicendo anche le cose delle quali Egli è causa, ci
1 In seguito vedremo meglio come per Proclo ogni realtà si sviluppi a partire dall'Uno per gradi progressivamente
discendenti di perfezione, mano a mano che ci si allontana dal principio. Altrettanto ogni cosa, così come proviene
dall'Uno, in esso vuole ritornare.
2 Tale lettura teologica del Parmenide, comune peraltro con Plotino, è chiaramente desumibile dal Commentario al
Parmenide, così come dalla Teologia platonica (specialmente secondo e terzo libro). Sebbene la parte del
Commentario dedicata alla seconda ipotesi sia andata perduta il suo contenuto è ricavabile dal terzo libro della
Teologia.
3 PLATONE, Parmenide, 137c 4 – 142a 8.
4 Theol. Plat., I, 10, 42 1-2; p. 38.
5 PLATONE, Parmenide, 142a 3-6.
6 Theol. Plat., II, 2.
troviamo nell’impossibilità pur sempre di dire ciò ch’Egli sia o di concepirLo con il pensiero»7.
Primo ed Ultimo, archè e telos, principio dell’essere e della determinazione degli enti, origine
eterna senza origine da cui deriva l’eterna processione del tutto e a cui tutto agogna fare ritorno,
grazie all'Uno tutto è e si conserva e senza l’Uno tutto perisce e si distrugge: «In realtà le cose tutte
sono per l’Uno, le cose che sono; e quante ne divengono, divengono per l’Uno. E assieme all’Uno
ogni singola cosa si conserva; a prescindere invece dall’Uno procede ogni cosa verso la propria
distruzione»8
La concezione procliano-neoplatonica dell’Uno è mirabilmente riassunta in un Inno variamente
attribuito a Proclo, sebbene di paternità non definitivamente certa, che fa conto riportare per esteso:
O panton epekeina:
Tu al di là di tutto! In quale altro modo è giusto cantarti?
Come devo lodare te, che sei superiore in Tutto?
Come può la parola esaltarti? Tu, infatti, non sei esprimibile con nessun
discorso,
unicamente indicibile, perché hai creato ciò che può essere detto;
Come ti potrà cogliere il pensiero? tu, infatti, non sei coglibile da nessun
pensiero.
Tutto ciò che parla e che non parla Ti chiama;
Tutto ciò che pensa e che non pensa ti fa festa.
Intorno a te si raccoglie l’anelito, il dolore di tutti gli esseri.
Tutto Ti prega, tutto Ti canta, riconoscendo i tuoi segni, un inno silenzioso.
Da Te è apparso tutto; Tu solo, invece, non sei a causa di nulla
In Te permane tutto, a Te tutto corre;
e Tu sei Fine di tutto, Tu sei Uno e Tutto,
non essendo né Uno, né Tutto.
Tu, dai molti nomi, come Ti dovrò chiamare,
se sei l’Unico Innominabile?
Quale spirito celeste entrerà nei tuoi sovra-luminosi penetrali? Sii benevolo!
O Tu che sei al di là di Tutto! In quale altro modo è giusto cantarti?
Ci troviamo ora di fronte ad una apparente contraddizione. Da una parte, infatti, abbiamo detto che
la filosofia di Proclo è un discorso sull'Uno. Dall'altra il nostro filosofo ci costringe ad ammettere
che dell'Uno non è possibile dire alcunché, anzi, non è neppure possibile pensarlo. Il tentativo di
definire il Principio si rivela dunque ad un tempo imprescindibile ed impossibile. Ma andiamo per
gradi seguendo ancora l'argomentazione della Teologia platonica.
Se dell’Uno non è possibile alcun discorso, se esso giace al di là delle possibilità della conoscenza,
Proclo contempla tuttavia una duplice possibilità di “accesso” o, meglio, di avvicinamento al
Principio, attraverso la quale il pensiero può in qualche modo accostarsi alla primigenia scaturigine
di ogni cosa, nella sua impregiudicata purezza.
Due infatti sono le vie che conducono all’Uno. La prima è la via dell’analogia, della similitudine,
per la quale il pensiero s’incammina seguendo le tracce che l’Uno lascia di sé nella molteplicità.
Percorrendo questa via, allora, riferiremo in sommo grado al Principio gli attributi che, in grado
minore, sono propri della molteplicità, mettendo in luce così, nello stesso tempo, l'affinità e
l'infinita distanza tra gli enti e la loro Causa. In tal modo, per intenderci, diremo ad esempio che il
Principio è Uno (vedi il Parmenide) perché da esso tutto promana (è causa di ogni molteplicità);
diremo che è Bene (vedi la Repubblica) perché tutto tende a ritornare verso di esso:
«E non si deve obiettarmi che quest'ineffabile sia per tal modo chiamato a nome; che così sia duplicata la fontana prima
di ogni unione; in realtà noi adoperiamo i nomi, anche in questo caso, considerando ciò che è dopo l'Uno,
considerandone le processioni da lui provenienti, o anche le cicliche vie del ritorno. E siccome, da una parte la pluralità
discende da Lui, introduciamo per Lui l'appellativo di Uno; siccome, d'altra parte, verso Lui persino le cose più oscure
si rivolgono, ecco lo chiamiamo il Bene. E anzi, per mezzo di quanto da lui proviene e per mezzo di quanto verso lui
ritorna, cerchiamo conoscere l'inconoscibile carattere del primo. E diamo opera per dare un nome all'ineffabilità di Lui.
7
8
Theol. Plat., II, 8.
Ivi, II, 1.
Oh! quel Primo non è oggetto di conoscenza per gli enti e non è pronunciabile per nessuno; ogni forma di conoscenza
egli trascende e ogni ragione; Egli è incomprensibile; da Lui procedono le conoscenze tutte quante; le cose conoscibili,
le ragioni tutte, e quante cose si comprendono, tutte da Lui procedono secondo unica causa»
È questa la via analogiae o catafatica (da kataphasis, affermazione). Teologia catafatica è dunque
un discorso su Dio di tipo affermativo: che attribuisce cioè al Principio dei nomi via eminentiae per
similitudine con la molteplicità degli enti. Quanto un discorso di tipo catafatico sull'Uno sia
inadeguato ad esprimerne l'intima essenza, tuttavia, è già chiaro dalla lettura del brano precedente:
in tal modo noi comprendiamo il Primo a partire da ciò che viene dopo di lui, e non come esso è in
se stesso.
Ecco allora che Proclo ci introduce alla seconda via di avvicinamento al Principio. È la via
negationis, o apofatica (da apophasis, negazione). Teologia apofatica o negativa è quindi il discorso
su Dio che parte dall'irriducibile alterità rispetto agli enti, rispetto ai quali esso si caratterizza come
loro nulla. È opportuno, lo sottolineo, prestare la massima attenzione all'argomentazione procliana
sulla teologia negativa. Questa avrà infatti profonda influenza sullo sviluppo della successiva
filosofia medievale, come avremo modo di vedere.
Per via apofatica, dunque, io dell'Uno dico non ciò che è, ma ciò che non è. Se in prima istanza l'ho
chiamato Bene o Uno, infatti, ora più propriamente dirò che non è Bene, non è Uno, mettendo in
luce come anche quei primi e semplicissimi nomi siano in realtà inadeguati alla natura del Principio.
A tal riguardo bisogna subito sgombrare il campo da un possibile equivoco. La negazione di cui
parla Proclo non è negazione del Principio, che al di là di tutto è anche al di là della negazione, ma
negazione del principiato, attraverso la quale solo il Principio può emergere in maniera in qualche
misura adeguata alla conoscenza concettuale. Il Principio esige infatti di essere concepito non solo
libero da qualsiasi rapporto verso una causa ulteriore, per cui esso più non sarebbe principio, ma
anche libero da qualsiasi relazione con ciò di cui esso è principio: solo così è possibile preservare
intatte la sua assoluta purezza e semplicità
Precluso un accesso diretto del pensiero al Principio insomma, non resta che la possibilità di una
sua “estrapolazione” per via negativa dalla realtà rispetto alla quale esso si configura come “nulla”.
Sulla natura della negazione giova riportare una proposizione fondamentale. Proclo afferma infatti
che le negazioni non sono semplicemente privative (steretikai), non hanno come risultato il mero
nulla, ma sono «generatrici dei contrari» (gennetikai ton oion antikeimenon) fanno cioè emergere,
seppur senza definirlo, il carattere dell'Uno.
Dire ciò che l'Uno non è, tuttavia, è altrettanto una forma di de-finizione e de-terminazione. Anche
la via apofatica allora, seppur più rispettosa della natura dell'Uno, deve essere abbandonata nella
sua irrimediabile inadeguatezza.
Ricapitoliamo. Al di là dell’essere, l’Uno sfugge a qualsiasi possibilità di determinazione del
pensiero e del linguaggio, i quali si muovono irrimediabilmente entro l’ambito del determinato,
dell’essere e quindi entro i confini di ciò che dall’Uno deriva. Al cospetto del Principio infatti
pensiero e linguaggio giungono, per Proclo, a lambire il limite estremo della propria possibilità,
finanche ad annullarsi in quanto tali: la tensione verso il Primo è imprescindibile, ma in essa
pensiero e linguaggio sperimentano la propria inadeguatezza ad esprimere l’oggetto della ricerca.
Le definizioni espresse per via catafatica ed apofatica, lungi dall’essere una forma di
“appropriazione” del Principio da parte del linguaggio, sono al contrario indice dell’inevitabile
scacco cui essi va incontro allorché tenta, in qualche modo, di imprigionare ciò che è primo
all’interno del proprio orizzonte di possibilità, limitato da ciò che rientra nel dominio della
determinazione.
Come è mai possibile, allora, accostarsi all'Uno-Principio-Dio? Quali possibilità rimangono al
pensiero? Con questi interrogativi ci introduciamo nel campo della mistica.
Per via apofatica, abbiamo detto, il pensiero nega all'Uno ogni attributo, riconoscendolo come
“nulla di tutto”. Conformemente al suo carattere “produttivo” inoltre, la negazione risulta più
adeguata quale metodo della teologia di Proclo, ma anch’essa, di fronte al Principio, deve deporre le
proprie armi e rinunciare a se stessa. Il pensiero deve allora negare, di ciò che è al di là di ogni
negazione, la negazione stessa:
«dunque tale metodo apofatico ha carattere eccezionale; è conforme alla dignità dell’Uno; la sua operazione è
principiale; remota trascende le cose tutte in inconoscibile e ineffabile eccellenza di semplicità. Ed è nostro dovere,
dopo che si attribuì al Primo Iddio tale processo d’indagine, in un secondo momento, liberarlo anche dalle apofatiche
relazioni. Infatti neppure ragione o discorso di Lui; neppur nome, dice appunto Parmenide, per nessun senso. E se
ragione o discorso nessuno, vi è di Lui, chiaro che neppure la determinazione apofatica. In realtà, ogni cosa è seconda
dopo l’Uno, e le cose note e le cognizioni e gli strumenti delle cognizioni; e tale impossibilità appare indubbiamente
chiara, una volta compiuta l’ipotesi prima. Infatti se non c’è ragione alcuna o discorso, neppure questa particolare
ragione discorsiva all’Uno si addice. Il che non ci può destar meraviglia se, nel momento in cui desideriamo conoscere
l’ineffabile con discorso, il discorso ci adduce ad impossibile meta; ogni cognizione, venendo a contatto d’un oggetto
che non è affatto conoscibile e che con lui non ha rapporto alcuno, annienta la propria efficacia»
Ciò che per via di negazione il pensiero opera, insomma, è una progressiva spoliazione da tutto ciò
che, in quanto derivato, in qualche modo occulta la natura del Principio. Questo processo mira a
ritrovare quella traccia che, in maniera inconoscibile, l’Uno lascia in ogni cosa e, per mezzo di essa,
farsi uguale ad esso, uno con l’Uno (henosis, homoiosis):
«Ciascun ente infatti, penetrando nell’arcano recesso della propria natura, trova il segno di riconoscimento
che vi pose un giorno il Padre di tutte le cose. E tutte le cose adorano, secondo propria natura, Lui; e per
mezzo del segno mistico di riconoscimento a Lui conveniente, trovano rapporto di unione, spogliandosi della
propria particolare natura e cercando, in ogni modo, d’essere soltanto il segno di Lui e partecipare di Lui
soltanto, portate da immensa brama per l’ignota natura di Lui, la fontana del bene»
L’ineffabile rapporto di unione che si realizza allorché il pensiero ha consumato tutte le possibilità
e, alla fine, rinunciato a se stesso, è l’estasi mistica, che Proclo intende quindi, conformemente al
significato del verbo greco muein9 come il tacere del pensiero, e, nel silenzio, farsi uno, con un atto
sovrarazionale, con ciò che, «più ineffabile di ogni silenzio», giace al di là di esso.
Il pensiero, come il linguaggio, esiste solo nell’ambito del molteplice e non vi può essere di ciò che
assolutamente è non-molti né discorso né apprensione concettuale. Qualsiasi cosa possa essere detta
o pensata del Principio è infatti una diminuzione della sua pura semplicità, e così qualunque
tentativo di circoscriverlo, di “afferrarlo” è un allontanamento da esso. Lo stesso definirlo Principio
è d’altronde tradire la sua essenza, legarlo al molteplice, a ciò di cui è principio. Per accedere al
Principio il pensiero deve insomma annullarsi come tale, se è vero che esso è principio del pensiero
stesso e quindi non può che precederlo, fondarne la possibilità.
Si potrebbe a questo punto essere portati a pensare che, dovendo l’uomo per farsi uguale a Dio
abbandonare il pensiero e il discorso, Proclo ponga con ciò l’inutilità del pensiero stesso, della
filosofia. Al contrario, invece, proprio solo attraverso il pensiero si rende possibile la rinuncia ad
esso, solo attraverso la consumazione di ogni discorso si fa palese la sua impossibilità dinnanzi al
Principio.
9 Muein, da cui l'italiano mistica, misticismo ma anche mistero (si pensi ai culti misterici dell'antichità) significa
appunto tacere, fare silenzio. Mistica si può dunque definire in generale, con espressione applicabile anche al
pensiero cristiano, come il tacere del proprio io, della propria personalità, condotto fino all'udire in noi stessi la voce
dell'Altro. Per Proclo e per i neoplatonici, insomma, nel silenzio si accede all'uno-che-è-in-noi (unum in nobis),
l'anima.