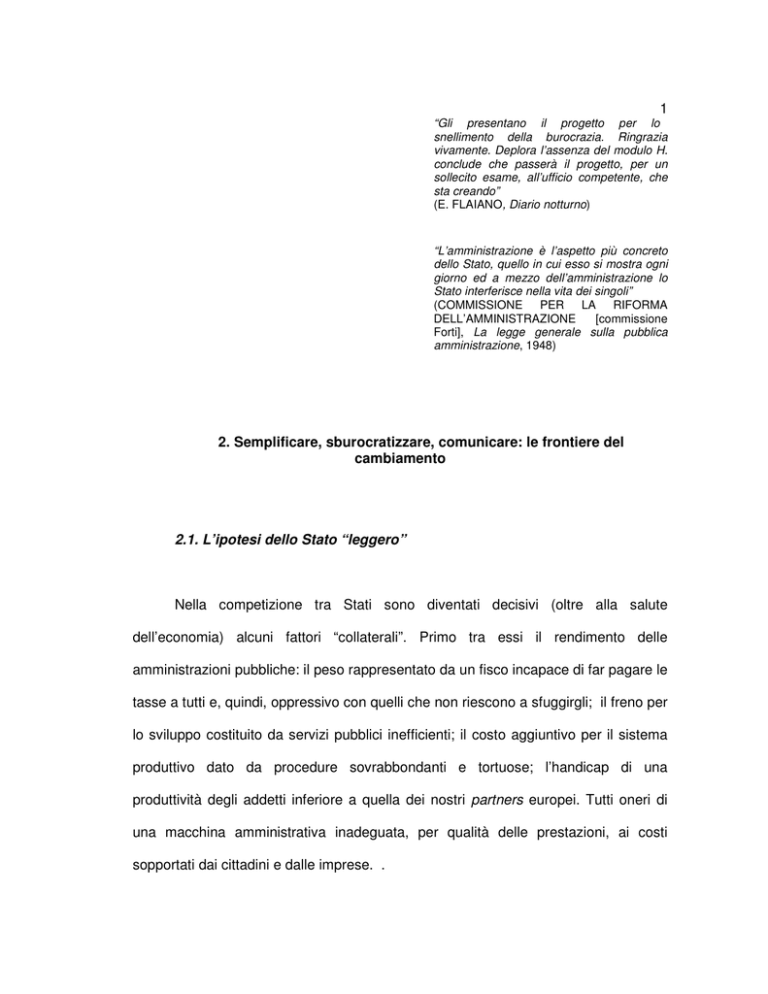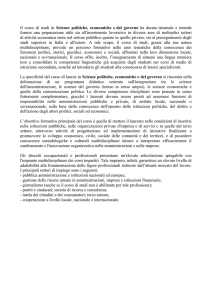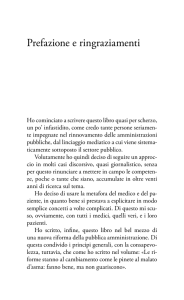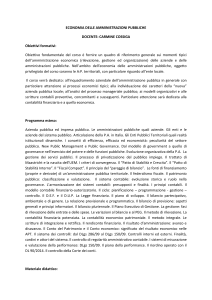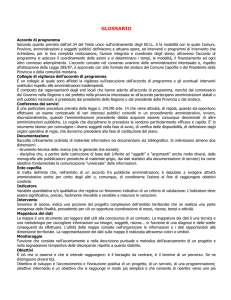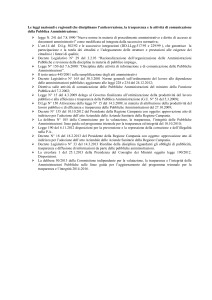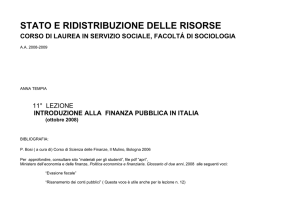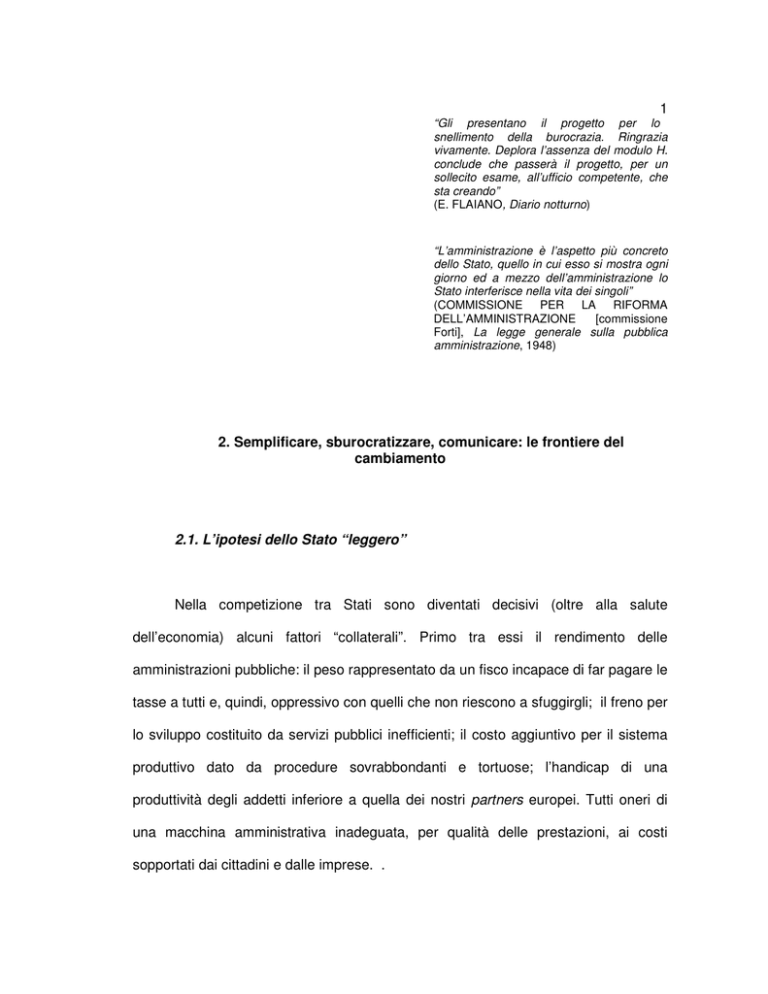
1
“Gli presentano il progetto per lo
snellimento della burocrazia. Ringrazia
vivamente. Deplora l’assenza del modulo H.
conclude che passerà il progetto, per un
sollecito esame, all’ufficio competente, che
sta creando”
(E. FLAIANO, Diario notturno)
“L’amministrazione è l’aspetto più concreto
dello Stato, quello in cui esso si mostra ogni
giorno ed a mezzo dell’amministrazione lo
Stato interferisce nella vita dei singoli”
(COMMISSIONE PER LA RIFORMA
DELL’AMMINISTRAZIONE
[commissione
Forti], La legge generale sulla pubblica
amministrazione, 1948)
2. Semplificare, sburocratizzare, comunicare: le frontiere del
cambiamento
2.1. L’ipotesi dello Stato “leggero”
Nella competizione tra Stati sono diventati decisivi (oltre alla salute
dell’economia) alcuni fattori “collaterali”. Primo tra essi il rendimento delle
amministrazioni pubbliche: il peso rappresentato da un fisco incapace di far pagare le
tasse a tutti e, quindi, oppressivo con quelli che non riescono a sfuggirgli; il freno per
lo sviluppo costituito da servizi pubblici inefficienti; il costo aggiuntivo per il sistema
produttivo dato da procedure sovrabbondanti e tortuose; l’handicap di una
produttività degli addetti inferiore a quella dei nostri partners europei. Tutti oneri di
una macchina amministrativa inadeguata, per qualità delle prestazioni, ai costi
sopportati dai cittadini e dalle imprese. .
Non a caso il tumultuoso processo di riorganizzazione degli apparati pubblici
2
- osservato nelle sue tendenze di fondo - è connotato dall’esigenza di pervenire ad
uno Stato “leggero” (che faccia meno cose, facendole meglio) ed insieme più
funzionante. Questo tentativo di superare le pesantezze tradizionali della macchina
amministrativa si incrocia con la scelta - resa politicamente attuale dalle pressioni
verso una dislocazione meno accentrata dei poteri pubblici - di pervenire alla
revisione di parti rilevanti della Carta costituzionale. Tutto il processo implica
riposizionare le amministrazioni su un diverso asse nei rapporti centro/periferia e
nazionale/locale. Ciò in un quadro di sempre più ampia globalizzazione dei mercati e
di integrazione dei paesi dell’Unione europea.
Punto d’arrivo nel gennaio 2002: l’Europa della moneta unica. Stazioni
intermedie: sfoltimento dei compiti dei poteri pubblici, decentramento delle attività
amministrative, semplificazione delle procedure. “Merce” da consegnare all’arrivo:
uno Stato leggero e, insieme, ben funzionante. Per l’Italia non aver mancato questo
appuntamento dell’ingresso nella moneta unica europea è già motivo di grande
soddisfazione. In Europa, però, oltre che esserci occorre restarci. Per farlo – anche
questo rientra tra le indispensabili ovvietà – il ruolo degli apparati pubblici è
fondamentale.
Il vero enigma presente in questo intricato puzzle è costituito dall’esigenza
inderogabile - anche se non da tutti avvertita - che i poteri pubblici non evaporino del
tutto. La progressiva privatizzazione dei grandi servizi a rete ed, in prospettiva, anche
delle piccole aziende municipalizzate; la privatizzazione dell’impiego pubblico; il
ridimensionamento (previsto) di molti apparati amministrativi sono indubbiamente
una risposta necessaria allo Stato ingombrante (ed ingombrato) che ereditiamo da
centotrent’anni di storia unitaria. Occorre, però, che l’État modeste (invocato da
Michel Crozier anni fa come paradigma dello Stato “moderno”) non diventi uno
3
Stato inesistente. Sarebbe una versione attualizzata delle pubbliche amministrazioni
dei primi decenni repubblicani tanto mastodontiche dimensionalmente quanto
evanescenti nella capacità di fornire risultati apprezzabili.
Occorre, al contrario, capire come “parametrare” al nuovo profilo dimensionale
e funzionale dei poteri pubblici una diversa collocazione della burocrazia che non ne
sacrifichi in modo irreparabile il patrimonio tradizionale, ma ne innovi l’identità. Il
problema ha assunto rilievo (ed urgenza) per due ragioni convergenti: la accresciuta
sensibilità sociale in tema di diritti e partecipazione; l’appannamento del ruolo delle
burocrazie. Il primo fenomeno si è tradotto in una costante pressione nei confronti
degli apparati e dei servizi pubblici; il secondo ha fatto perdurare la tradizionale
carenza di dialogo con la collettività. Ai cittadini che chiedono di avere “voce”
nell’amministrazione continua a “contrapporsi” un sistema amministrativo poco
abituato a dialogare e con scarsi strumenti specifici per comunicare. Alla radice di
tale impaccio vi è la tradizionale cultura del controllo che ha pervaso (ed in larga
parte pervade ancora) i modelli di comportamento delle burocrazie, alle quali è stata
quasi del tutto estranea - fino a tempi relativamente recenti - una cultura del servizio
nella quale fosse “incorporata” la capacità di comunicare e dialogare con i cittadini. Il
paradosso insito in tale situazione era già stato colto alla metà degli anni Cinquanta
da Alcide De Gasperi, il quale osservava: “Per un complesso di ragioni politiche,
sociale ed economiche, lo Stato è venuto assumendo nel corso degli ultimi decenni
una somma di funzioni che ne fanno in realtà il protagonista della vita collettiva. E’
inconcepibile che in questa condizioni esso, a differenza degli agenti privati, non sia
fornito di strumenti di comunicazione con la pubblica opinione”1.
I vizi profondi del sistema amministrativo italiano (formalismo esasperato
4
delle procedure, lentezza inusitata delle decisioni, irrazionalità organizzativa, cattiva
distribuzione geografica degli addetti, scarsa produttività media) vengono – come si
sa – da lontano. Precisamente da quella “stretta accentratrice” avutasi nell’ottobre
1861 e sancita normativamente dalla legge di unificazione amministrativa del marzo
1865. Il modello accentrato di derivazione napoleonica – basato nella capitale sui
ministeri ed in provincia sui loro uffici periferici - ha avuto numerosi rimaneggiamenti
(soprattutto in età giolittiana e durante il ventennio fascista) senza, però, perdere mai
completamente le stimmate originarie. Per oltre cento anni ad un continuo predicare
l’esigenza del decentramento facevano da contraltare scelte che confermavano (o,
addirittura, rafforzavano) il centralismo amministrativo. Così fino agli anni settanta,
allorché la nascita delle regioni a statuto ordinario rese politicamente improrogabile
un ampio decentramento di funzioni (e di poteri) alle regioni.
La regionalizzazione – avvenuta tra il 1972 ed il 1977 - è stata la prima svolta
significativa in un sistema amministrativo che era passato, senza soluzione di
continuità, dalla dittatura fascista alla democrazia. Ciò, naturalmente, fu salutato
all’epoca con grande entusiasmo ed accese molte speranze di un rapido
superamento del vecchio modello di Stato. La svolta – come si è sperimentato nei
due decenni successivi - è stata tale soltanto a metà a causa di numerose cause
concomitanti. Alle difficoltà di molte regioni di gestire in maniera adeguata i nuovi
compiti (segnatamente quelli di programmazione e di coordinamento delle attività
affidate agli enti locali) si è aggiunta la tendenza degli apparati centrali dello Stato a
“recuperare terreno” attraverso la sotterranea riconquista di attività formalmente
passate in sede locale.
Con la nascita delle regioni e con il passaggio ad esse di consistenti funzioni
5
amministrative è iniziato un processo che ha avuto la svolta nel 1990 con il nuovo
ordinamento locale. Da quel momento il ridisegno dell’amministrazione pubblica è
proseguito senza soste. In questo quadro di modifiche continue la legge 59 del 1997
ha rappresentato un evento di rilievo, poiché ha tentato di aggredire i nodi strutturali
dell’inefficienza del sistema amministrativo. L’uso, nella legge, del termine
“conferimento” implica, di per sé, uno spostamento di visuale rispetto alle riforme
degli anni settanta. Nel “modello” Bassanini il criterio della sussidiarietà diventa il
punto focale della riorganizzazione delle funzioni pubbliche. “Per la prima volta dopo
centotrenta anni – dichiarava il ministro nelle relazione presentata al governo nel
giugno 1997 – il Parlamento italiano ha rovesciato il principio fondamentale sul quale
si regge il nostro sistema amministrativo. Siamo passati cioè, con largo consenso, da
un sistema amministrativo poggiante essenzialmente sull’amministrazione statale a
un sistema che, all’opposto, poggia essenzialmente sulle regioni e sulla autonomie
locali”.
Sulla scorta delle deleghe concesse dal Parlamento c’è stato un intenso
lavorio che ha portato all’approvazione sia dei decreti delegati per il trasferimento
delle funzioni a regioni ed enti locali, sia delle norme che hanno completato il
processo di privatizzazione dell’impiego nelle pubbliche amministrazioni. Nel
frattempo, è continuata l’attività di snellimento delle singole procedure e
l‘individuazione delle ulteriori semplificazioni da realizzare.
Al momento si può dire completata l’opera di impianto delle regole
fondamentali. Abbastanza si è fatto per provvedere con norme di dettaglio
all’individuazione dei meccanismi sui quali intervenire. Sono, invece, ancora in fase
iniziale le trasformazioni operative. La circostanza non deve meravigliare e nemmeno
deludere. Il processo di modernizzazione di una macchina complessa come quella
6
amministrativa è necessariamente lungo. I lavori sono in corso: il piano regolatore è
stato approvato, la progettazione esecutiva è a buon punto, ora occorre costruire le
case.
Con l’approvazione dei provvedimenti delegati siamo, ovviamente, soltanto al
primo (obbligatorio) passaggio verso lo Stato “leggero” evocato più volte da Franco
Bassanini. Altri passi – indispensabili – occorrerà fare. Ma questo è noto, non
soltanto agli addetti ai lavori. Si apre una fase delicatissima, nella quale sarà
necessario che regioni ed enti locali siano messi in grado di “reggere” l’impatto delle
nuove funzioni e gli apparati centrali siano ridisegnati, conferendo loro compiti di
indirizzo e coordinamento. Facile da dire, molto meno da fare. Soprattutto perché
non mancheranno le controspinte (delle quali si sono già avute delle avvisaglie).
Molti enti locali rischiano, infatti, di soccombere al peso delle funzioni da svolgere. Di
contro, la possibilità che lo snellimento degli apparati centrali si riveli soltanto fittizio
non è del tutto irrealistica. Decisive, in questo passaggio, si riveleranno, da un lato, la
“maturità” autoregolativa delle regioni e dei enti locali e, dall’altro, la capacità delle
burocrazie statali di non ostacolare il processo di decentramento.
L’attenzione ora dovrà essere necessariamente puntata sulla “fase due” del
processo di modernizzazione. Il primo passaggio è stato contrassegnato in questi
anni (a partire dalla legge-delega varata dal governo Amato) da una forte iniziativa di
governo. Abbiamo avuto un periodo “giacobino” nel quale l’esecutivo si è assunto
l’onere di predisporre un disegno generale di riforma e sottoporlo alle Camere. Ora
occorre ottenere la più alta partecipazione nell’opera di attuazione delle leggi che
hanno ridisegnato il sistema amministrativo. Per evitare la resistenza
delle
burocrazie pubbliche è indispensabile coinvolgerle il più possibile nei processi di
modernizzazione. Anche per averne “in cambio” un prezioso contributo di
7
esperienze e di conoscenza.
2. 2. Misurare, confrontare, migliorare
400 milioni di certificati, in buona parte per adempimenti fiscali. Una spesa di
23.000 miliardi. In queste cifre, poco più di un anno fa, Confidustria riassumeva il
costo per le imprese dei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Una “tassa
occulta” – si è detto più volte – che penalizza il sistema produttivo rispetto a quello di
altri paesi. Ma anche – occorre aggiungere – costi, in qualche misura, dovuti per
garanzia della legalità. Il mondo delle imprese, non da oggi, lamenta la eccessiva
gravosità dei cosi sopportati per far fronte agli adempimenti amministrativi previsti
dalle norme. Il presidente di Assolombarda ha indicato, nel 1999, in 150 milioni la
spesa sostenuta annualmente da un’impresa medio-piccola per i rapporti con le
pubbliche amministrazioni. Alcuni anni fa le stime del centro studi di Confindustria
facevano ascendere tali oneri al 2,24% del costo del lavoro. Proprio sulla “misura” (e,
quindi, sulla “giusta misura”) dei compliance cost di natura amministrativa (gli oneri
sostenuti dai privati per adeguarsi alle norme) che occorre interrogarsi, partendo da
un dato e da un apparente paradosso. L’elemento di fatto è costituito dalla scarsa
capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare alle imprese ed ai gestori di
attività commerciali servizi di efficienza almeno pari a quelli forniti dalle
organizzazioni omologhe di altri paesi. E, quindi, di ridurre all’indispensabile i costi
sopportati per gli adempimenti amministrativi. Con la conseguenza di creare agli
imprenditori un handicap notevole nei confronti dei competitori esteri.
Che tale situazioni debba, al più presto, essere modificata è ovvio, poiché
8
costituisce un presupposto per la competitività non soltanto delle imprese, ma del
paese. Il paradosso risiede nella circostanza che in Italia i governi hanno impegnato
risorse anche cospicue per sostenere le imprese o per incentivare la scelta ad
investire. L’intero cinquantennio repubblicano è stato costellato di interventi di varia
natura ed efficacia volti a favorire investimenti produttivi. Ciò nonostante, il sistema
amministrativo, invece di fungere da elemento di spinta, ha finito per agire come
freno allo sviluppo. Colpa, evidentemente,
dell’insufficiente rendimento delle
amministrazioni pubbliche, più abili a complicare che a semplificare gli adempimenti
richiesti alle imprese. Quindi a togliere con una mano quello che dava l’altra. Non a
caso, in un’intervista rilasciata pochi giorni dopo l’insediamento del governo D’Alema,
il presidente di Confindustria individuava nello sradicamento delle incrostazioni
burocratiche uno degli obiettivi che accomunavano l’esecutivo ed il mondo d’impresa.
La consapevolezza dell’esigenza di ricalibrare le istituzioni amministrative
sembra, al momento, l’elemento che permette di sperare in un cambio di marcia.
Due, in particolare, gli aspetti innovativi. Da alcuni anni il mondo d’impresa ha
abbandonato le posizioni di totale condanna dell’amministrazione pubblica: le
associazioni degli imprenditori hanno avviato un’attiva collaborazione con il
Dipartimento delle funzione pubblica, compiendo analisi puntuali sulle richieste e le
esigenze delle imprese rispetto al funzionamento degli uffici pubblici. Nel contempo,
le regole sono cominciate a cambiare in modo radicale: le modifiche introdotte nella
nostra legislazione dalle “leggi Bassanini” hanno inciso sul sistema di adempimenti
richiesti alle imprese, attraverso un cospicuo disboscamento normativo.
Registrare questi mutamenti è importante, non perché essi abbiano risolto i
problemi (che continuano ad essere pesanti), ma perché indicano una inversione di
rotta rispetto al passato. Ma non tutto, come è noto, dipende dal centro. La partita si
9
gioca su più tavoli ed il suo esito dipenderà in larga parte proprio dalle scelte delle
amministrazioni regionali e locali. Infatti, lo “Stato leggero” prefigurato dalle riforme in
corso tende sia a spostare in sede locale la risoluzione dei problemi, sia a diminuire
consistentemente il carico complessivo di relazioni tra amministrazione pubblica e
privati. Ciò, oltre a ridurre gli obblighi, spinge il sistema sociale e le imprese a
rafforzare la loro capacità autonoma. Spinge a fare a meno dello Stato “paterno”.
Naturalmente, le riforme non producono automaticamente cambiamento. Deve
cambiare l’atteggiamento delle amministrazioni pubbliche e deve modificarsi, nel
contempo, l’attitudine degli imprenditori. Meno certificati, procedure più snelle, tempi
accorciati – ma anche maggiore sicurezza per le imprese e le persone - favoriscono
certamente l’insediamento ed il consolidamento delle attività produttive, non lo
producono automaticamente. Sta agli imprenditori cogliere i segnali di cambiamento
per decidere le loro strategie di azione. Al riguardo il confronto tra governo,
imprenditori e sindacati dei lavoratori sul “patto sociale” ha offerto una conferma
tanto degli intendimenti di tutti a lavorare per lo sviluppo, quanto della persistenza di
diffuse preoccupazioni.
Un’amministrazione che funzioni: nel nostro paese è un auspicio che si
avvicina all’utopia. Almeno questa è l’opinione corrente. Al punto da sconfinare in
luoghi comuni: tanto abusati quanto difficili da sconfiggere. Che vi siano
amministrazioni più funzionanti di altre è circostanza nota. Altrettanto risaputo è che,
in alcune parti d’Italia, la qualità media dei servizi pubblici è largamente migliore che
in altre. In corridoi contigui di uno stesso ministero o in uffici situati in strade adiacenti
di una stessa città vi sono strutture pubbliche molto diverse tra loro per funzionalità
10
ed efficienza Le amministrazioni pubbliche, benché si tenda a dimenticarlo, sono
tutt’altro che un unicum.
Nella storia del nostro Stato unitario è sempre esistito un “filo rosso”
costituito da esperienze di grande efficienza: fu così con il “taylorismo della
scrivania”, negli anni Venti, e con la spinta alla meccanizzazione di alcune
amministrazioni negli anni Cinquanta.
Poi, come è noto, vi sono stati momenti nei
quali l’intero sistema pubblico – come, ad esempio, in età giolittiana – seppe
rispondere con efficacia alle esigenze di cambiamento della società civile. Anzi, in
alcuni casi, le anticipò o ne fu promotore. Le contrapposizioni tra cultura del controllo
e cultura del risultato, tra gestione dell’amministrazione intesa come esercizio del
potere o come etica del servizio sono una costante delle vicende dei nostri apparati
pubblici. E’ che i tentativi di innovazione e di cambiamento sono stati, alla lunga,
sempre battuti. Costituiscono da sempre la faccia nascosta della luna.
Per capire la ragioni di tale situazione occorre operare una distinzione e
fare un’ipotesi. La distinzione è elementare: una cosa sono le amministrazioni che
non funzionano, altra cosa sono le burocrazie incapaci e corrotte. Senza buone
capacità ed intelligenze gli apparati pubblici funzioneranno sempre male, ma buoni
impiegati da soli non producono buona amministrazione. L’andamento delle
organizzazioni pubbliche è, infatti, fortemente condizionato da tre fattori: qualità (e
quantità) delle leggi, livello della guida politica, status (sociale ed economico) dei
funzionari. L’ipotesi “storiografica” è che, a partire dagli anni Settanta, si sia prodotto
un rapido degrado, innescato dalla legge sull’”esodo” dell’alta dirigenza nel 1973,
dalla inefficienza di molti apparati regionali, nonché dalla esacerbata risposta delle
strutture ministeriali alla perdita di funzioni. Negli anni ottanta un comando politico
senza altro progetto che la conservazione del potere ha contribuito al declino di
funzionalità del settore pubblico (declino non soltanto di efficienza, ma anche di
11
valori etici r professionali). Il tutto mentre le rapide trasformazioni indotte dalle
tecnologie e la globalizzazione dei mercati stavano cambiando il mondo ed avevano,
più che mai, bisogno di apparati pubblici in grado di assecondare lo sviluppo sociale.
Da alcuni anni vi è stata una forte inversione negli indirizzi governativi
ed una, conseguente, radicale innovazione normativa, che ancora non si è
trasformata in miglioramenti generalizzati della qualità dell’attività delle pubbliche
amministrazioni. In siffatta situazione è ancor più meritorio che la sperimentazione,
partita in questi anni, sia stata veicolo di un modo diverso di fare (e di essere)
amministrazione pubblica. Gli insegnamenti che si possono trarre dalla vicenda sono
molteplici:
- le norme per estendere i casi di amministrazione efficiente ci sono, si tratta di
renderle operanti;
- la sperimentazione e l’emulazione si sono dimostrate un’arma vincente;
- occorre ridare fiato agli elementi migliori, svecchiando i vertici senza
decapitarli;
- è decisivo puntare sull’innovazione: tanto valendosi delle tecnologie quanto
rafforzando e presidiando funzioni e segmenti innovativi.
Il futuro – è stato osservato a proposito delle prospettive di modernizzazione
del sistema pubblico – “bussa [….] con insistenza alle porte della fortezza
amministrativa"2. L'
immagine – ancorché suggestiva – rischia di offrire una visione
unilaterale del problema: come se, di fronte a potenti processi di innovazione,
soltanto (e tutti) gli apparati pubblici fossero graniticamente immobili. Non è così.
L’amministrazione, come si è detto, sta cambiando. In più, al suo interno, sono
sempre maggiormente evidenti le diversificazioni tra segmenti che stanno
12
sperimentando il nuovo e pezzi che restano arroccati nella difesa di un vecchio
ordine (procedure, atteggiamenti, cultura). E’ un processo in chiaroscuro,
certamente. Un mosaico nel quale le vecchie tessere sono difficili da rimuovere e le
nuove non sempre si collocano bene. Nel quale è spesso difficile vedere un disegno
compiuto (o forse, più semplicemente, il disegno non c’è ancora). Ma il cambiamento
c’è ed è palpabile, specialmente se si va a guardare “dal di dentro” come funzionano
le macchine. Certe macchine. Cambiamento che avanza faticosamente, con tante
contraddizioni. Con ritorni indietro a volte preoccupanti. Con l’ovvia altalena di
esaltazioni immediate e delusioni cocenti. Ma c‘è molto fermento, molta voglia di
rendere l’amministrazione più vicina ai cittadini ed ai loro bisogni.
Cambia il sistema pubblico. Non con le leggi, che da sole non bastano. Ma
grazie alle leggi, che permettono di fare o di “stanare” quelli che si oppongono alle
innovazioni. Per cogliere il senso dei processi in atto sono indicativi alcuni esempi di
trasformazioni in corso.
Il progetto di un nuovo modello di scuola, emergente dalle riforme di questi
anni, ha come fulcro il principio dell’autonomia. Esso implica, come è noto, capacità
di gestire risorse, che verranno assegnate anche sulla base della qualità dell’attività
svolta e del numero di allievi che sceglieranno di iscriversi ai singoli istituti. A guidare
le istituzioni scolastiche presidi “dirigenti” per i quali è in corso un processo formativo
senza precedenti (per ampiezza e per quantità di risorse impegnate). La gestione
manageriale delle scuole avrà come controfaccia un’organizzazione periferica del
ministero dell’Istruzione più snella. Nel frattempo si stanno mettendo a punto
programmi più aggiornati. Il fine ultimo è un sistema scolastico in grado di formare in
maniera adeguata i giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro. Autonomia,
competitività e orientamento ai risultati sono gli elementi chiave del processo di
13
innovazione.
Il caso della scuola non è isolato: la “concorrenza” interna al sistema pubblico
sta interessando da alcuni anni anche il sistema universitario e la sanità. I risultati
sono ancora lontani da un livello medio soddisfacente, ma la strada è quella giusta.
Analogamente si può dire per la trasformazione del sistema delle Camere di
commercio, avviata negli anni ottanta e giunta a conclusione un decennio più tardi.
La
(ritrovata)
autonomia,
un
maggiore
“peso”
delle
forze
sociali,
la
responsabilizzazione operativa dell’apparato amministrativo sono i connotati delle
camere riformate: oggi esse sono, effettivamente, una delle punte avanzate del
sistema pubblico. Un modello di “nuova statualità” che facilita i rapporti tra istituzioni
ed impresa.
Non a caso sullo stesso terreno si è sviluppato uno dei processi di maggiore
interesse delle riforme in corso: la realizzazione dello sportello “unico” per le attività
produttive. L’esigenza di pervenire ad uno snellimento delle estenuanti trafile alle
quali erano costretti tutti coloro che intendevano iniziare (o modificare o chiudere)
un’attività produttiva era inderogabile. Secondo un’inchiesta promossa alla fine del
1998 dall’Anci-Ancitel3, meno del 40% dei comuni aveva attivato lo sportello unico,
ma i progetti messi in cantiere prevedono che si arrivi, entro il 1999, ad una quota
doppia rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso si tratta di un percorso
faticoso, del quale si possono tanto enfatizzare le difficoltà quanto indicare i
progressi, sia pur lenti. E’ significativo, infatti, che – mentre la metà dei comuni
interpellati riconosce di non aver avviato una riflessione sugli impatti organizzativi
dell’adozione dello sportello unico – un’analoga percentuale sottolinea l’esigenza che
esso dovrà fornire servizi non soltanto amministrativi, ma di consulenza e di
14
marketing territoriale.
Come l’innovazione proceda a salti e talvolta anche a tentoni lo dimostra il
caso della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Altra frontiera “calda” dei
rapporti tra amministrazioni locali e cittadini. I dati della Federambiente indicavano, al
1998, una situazione fortemente squilibrata. La percentuale di rifiuti a raccolta
differenziata va, infatti dal 27.8% di Ferrara all’1,8% di Palermo, dal 26,4% di Milano
al 3,7% di Roma. Assai difforme anche il gradimento dei cittadini. Due su tre gli utenti
soddisfatti a livello nazionale, ma con significative differenze per aree: mentre in
Emilia-Romagna il loro numero supera l’80% e nel nord-est il 75%, nel sud e nelle
isole la quota scende al 57,9%. Nel settore sono stati avviati tentativi per coinvolgere
gli utenti. A Padova, in un’azienda speciale del comune (AMNIUP), ogni abitante
può portare materiali ricliclabili. In cambio di una determinata quantità di rifiuti si
hanno biglietti per il cinema. Ennesima variazione del principio: se la montagna non
va a Maometto, Maometto va alla montagna. Un modo originale di coinvolgere i
cittadini, spronandoli ad avere un atteggiamento di maggiore collaborazione con
l’amministrazione locale. La logica dell’iniziativa è molto chiara, così come la sua
bontà: nessun sistema di controllo riuscirebbe a garantire che tutti separino i rifiuti
solidi prima di smaltirli. Occorre utilizzare un tasto diverso: favorire la partecipazione
dei cittadini. Per favorire il risparmio delle risorse e la tutela dell’ambiente oggi è
necessario offrire incentivi: tra qualche tempo non sarà più necessario.
I casi sopra descritti stanno tutti dentro un insieme di regole, tecniche,
processi. Le prime sono, sostanzialmente, le norme. Le seconde sono costituite,
fondamentalmente, da strumenti operativi (come le reti informatiche) e da una serie
di “indicatori” (costi/benefici, misurazione dell’attività, valutazione dei costi). A
15
presidiare l’azione di confronto e analisi vi sono sia “autorità” pubbliche (come
l’AIPA) titolari delle funzioni di coordinamento e indirizzo in materia, sia organi (come
il CNEL) che hanno attivato gruppi di lavoro per la misurazione dell’attività
amministrativa. A ciò si deve aggiungere l’apporto fornito da associazioni o da
società di consulenza che, sempre più spesso, analizzano l’andamento dei pubblici
servizi (si pensi, al riguardo, ai rapporti annuali del Censis o dell’Eurispes). I processi,
naturalmente, sono l’elemento fondamentale nel quale si collocano i tentativi di
innovazione. Il nuovo assetto delle amministrazioni regionali e locali, non meno di
quelle centrali, fa da sfondo alla sperimentazione. Del pari, l’accresciuta autonomia
decisionale dei dirigenti pubblici – unita alla maggiore discrezionalità dei politici nella
scelta dei vertici burocratici – è stato un elemento che ha favorito tanto la
differenziazione quanto la sperimentazione.
Nell’insieme il processo di cambiamento è. In questi ultimi anni, proseguito in
modo visibile (almeno agli addetti ai lavori). Una “marcia lenta ma costante”4 nella
quale è emersa una duplice modalità di risposta. Molti dirigenti (specialmente negli
apparati centrali) continuano a privilegiare la logica della “competenza” (“questo è
mio”, o “faccio soltanto quello che mi compete”). Altri – più di quanto si creda
(soprattutto in ambito locale) – hanno cominciato a ragionare in termini di risultati e di
“prodotti”. La maggiore dinamicità (media) delle amministrazioni locali si spiega con il
maggiore impatto dell’attività rispetto alle collettività. La gran parte degli apparati
centrali è, al contrario, meno esposta (almeno direttamente) alla pressione dei
cittadini. L’inerzia deriva anche da questo fattore.
Un elemento di ostacolo alla diffusione di metodi innovativi nelle gestione delle
amministrazioni pubbliche è dato dalla stessa necessità di verificare il rendimento dei
pubblici dipendenti e l’efficacia della loro azione. “controllare il rendimento – si è
16
detto – produce conflitti”5. Ciò è vero proprio nei contesti organizzativi (come le
amministrazioni pubbliche) nei quali si era tradizionalmente affermata l’assenza di
meccanismi di valutazione. Di qui non soltanto una serie di tentativi finiti
praticamente nel nulla (si pensi alla misurazione dei “carichi di lavoro”), ma anche le
difficoltà a far decollare nuovi strumenti come i nuclei di valutazione o gli uffici di
controllo interno. Mentre si tenta di calibrarne compiti e modalità di funzionamento
sono già molte le critiche che si levano sulla loro reale utilità.
2.3. Far bene e farlo sapere: l’esigenza di comunicare
Nei processi di riforma del sistema pubblico le tecniche di controllo e di
gestione, nonché i meccanismi di valutazione stanno assumendo un’importanza
sempre più ampia. In tale contesto vi è “lo spazio per collocare in una logica
funzionale il senso della comunicazione, senza la quale non si fanno servizi utili, non
si promuove accesso alle istituzioni e neppure si assicura l’efficacia dei
provvedimenti”6. La necessità di affrontare il tema della comunicazione pubblica e
istituzionale emerge, infatti, tanto in relazione alle informazioni possedute e/o
utilizzate dai poteri pubblici, quanto in rapporto all'
esigenza di favorire la
partecipazione
dei
cittadini
(consentendo
un
reale
accesso
ai
documenti
amministrativi e fornendo loro informazioni sui servizi resi dalle amministrazioni
pubbliche ed in generale sui servizi di pubblica utilità).
Sotto il primo profilo basta riflettere sulla circostanza, apparentemente
banale, che i poteri pubblici costituiscono - nelle società contemporanee - il più
mastodontico bacino di informazioni. Ciò ha molteplici ricadute nei rapporti tra i
17
cittadini e amministrazioni: molte informazioni, riguardando direttamente la sfera
personale, necessitano di particolare tutela; nel contempo, il possesso aggiornato di
tali informazioni permette ai poteri pubblici di assumere decisioni più mirate; d'
altra
parte, per gli stessi cittadini, è possibile accedere ad un gran numero di dati in
possesso delle amministrazioni pubbliche.
Quanto all'
esigenza di favorire - attraverso forme di comunicazione promosse
e/o gestite dai poteri pubblici - la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica basta
rilevare, a titolo puramente esemplificativo, due aspetti. Il principio di accesso ai
documenti amministrativi scardina il fondamento della tradizionale segretezza
dell'
azione amministrativa. La "trasparenza", come principio ispiratore della legge
241, presuppone strumenti organizzatori per renderla operante. La molteplicità delle
attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, ovvero da gestori di pubblici servizi, è
tale da rendere indispensabili specifiche azioni mirate a chiarire ai cittadini: le
modalità di esercizio e di fruizione del servizio; la sua estensione (temporale,
spaziale, ecc.).
Emerge, così, un’esigenza specifica delle amministrazioni pubbliche nel
processo di modernizzazione: migliorare il rapporto con i cittadini anche attraverso
adeguate azioni di comunicazione. Esigenza che si è modificata di pari passo con
l’evoluzione delle funzioni pubbliche. Nella seconda metà dello scorso secolo,
allorché lo Stato aveva funzioni essenzialmente “d’ordine”, il problema non si
poneva: i pubblici poteri non dialogavano con gli “amministrati” (i “sudditi”), ma
esercitavano semplicemente il loro potere di imperium. La comunicazione era,
sostanzialmente, unidirezionale e si esprimeva in ordini e divieti con relative
18
sanzioni. Il messaggio implicito era che lo Stato “sorvegliava” perché nulla
turbasse il buon andamento del vivere civile. Coerente a tale impianto delle
funzioni statali era la quasi totale assenza della comunicazione, in quanto
spiegazione dell’operato dei poteri pubblici. Il binomio logico (e normativo)
imporre/vietare aveva, infatti, come unico risvolto l’obbligo di garantire
l’informazione “legale” delle norme (gazzetta ufficiale, albo pretorio).
L’assunzione da parte dello Stato della gestione di alcuni servizi
essenziali per la collettività ha mutato il quadro di riferimento. Nei primi tre
decenni del Novecento sono nate le aziende di Stato (Ferrovie, Telefoni,
Poste) e si sono moltiplicate le aziende municipalizzate a livello locale. La
nuova frontiera dell’azione dei poteri pubblici non ha, però, condotto a
modifiche sostanziali dell’atteggiamento verso gli utenti dei servizi. Benché
emergesse l’esigenza di politiche di comunicazione ed informazione, lo Stato
ha continuato ad essere un comunicatore invisibile. O incomprensibile: si
pensi alle difficoltà di decifrare i messaggi (scarsi, peraltro) rivolti agli utenti dei
servizi di trasporto e di comunicazione. In questa fase il binomio gestione
(pubblica) fruizione (collettiva) non ha modificato in modo significativo
l’atteggiamento dei poteri pubblici che hanno continuato ad essere un
comunicatore assente.
Una radicale svolta si è avuta - come è noto - con il fascismo che ha
usato in modo massiccio la comunicazione istituzionale come strumento delle
politiche di regime. La gestione pubblica (servizi pubblici, assistenza,
previdenza) diventava veicolo di “influenza”, mentre la fruizione collettiva (in
19
quel contesto) favoriva il consenso nei confronti dell’azione di governo.
L’uso manipolativo dell’informazione di Stato ha, naturalmente, favorito la
scelta dei governi repubblicani di tenere bassa (fino alla pratica invisibilità) la
soglia della comunicazione istituzionale. Lo spettro del “minculpop” ha
impedito lo sviluppo di forme di comunicazione di pubblico interesse.
Negli ultimi decenni la prefigurazione - contenuta nell’articolo 98 della
Costituzione - di un’amministrazione al servizio dei cittadini ha ulteriormente
modificato il ruolo (possibile) della comunicazione nel settore pubblico. Le
costanti difficoltà nel tradurre in fatti l’ideale dell’amministrazione “per i
cittadini” ha contribuito a mettere questa in “mora”: la collettività chiede in
modo sempre più pressante che gli apparati pubblici sappiano fornire
informazioni e riescano a facilitare il rapporto tra i cittadini ed uffici pubblici. In
breve, che sappiano comunicare. Questa complessiva carenza è determinata
dallo scarto tra un fatto (la comunicazione è divenuta una funzione pubblica) e
la mentalità complessiva degli operatori pubblici, che non sono per lo più in
grado di far fronte a questa esigenza emergente.
L’amministrazione non sa comunicare: troppo spesso “dimentica” di
farlo, altre volte lo fa male. Corollario di questa situazione è la cattiva stampa
di cui godono gli apparati pubblici. Le non rare buone iniziative assunte dagli
uffici pubblici non trovano adeguato spazio nei mezzi di comunicazione di
massa.
La cattiva stampa della quale godono le amministrazioni pubbliche è frutto
tanto della loro scarsa funzionalità, quanto della superficialità delle opinioni espresse
dai mass-media. Il tutto tende a produrre una spirale perversa: a dispetto di
miglioramenti presenti in
20
parti del sistema pubblico e nonostante gli sforzi degli
addetti, qualunque esempio di disfunzione dell’amministrazione finisce per riprodurre
all’infinito lo stereotipo dell’inefficienza burocratica. Al riguardo occorre chiedersi
come mai l’osservazione (giusta) delle disfunzioni delle amministrazioni pubbliche
abbia condotto ad un così radicato pregiudizio contro gli impiegati pubblici. E come
mai tali giudizi negativi siano quasi sempre così generalizzati. Dall’altro, occorre
provare a individuare quali possano essere le strade per invertire la tendenza.
Il miglioramento della qualità dei servizi resi, o la semplificazione procedurale
di un adempimento, o ancora la maggiore velocità di risposta ad una richiesta (o altro
ancora, in combinazione) devono essere, ovviamente, gli elementi di partenza.
Altrettanto importante è informare in modo costante ed esauriente i cittadini.
Migliorare la soglia della qualità è il presupposto per una comunicazione efficace e
convincente. Sia gli studiosi di comunicazione, sia gli scienziati di organizzazione
hanno “codificato” i nessi, spesso particolarmente complessi, tra i due aspetti nel
rapporto tra far bene e farlo sapere. Formula, di per sé, soltanto definitoria, ma in
grado di evocare l’intreccio dei problemi.
Se si assume tale schema logico come punto di arrivo del ragionamento, si
può provare ad indicare – in via del tutto esemplificativa – due tipi di presupposti: la
cause dell’immagine degradata delle burocrazie pubbliche e del funzionamento degli
apparati; gli elementi sui quali intervenire per migliorare il giudizio degli utenti nei
riguardi del sistema pubblico.
Le
prime
–
nell’immaginario
collettivo
–
sono,
fondamentalmente,
l’inamovibilità e l’irresponsabilità dei funzionari, nonché il carattere “monopolistico” di
gran parte delle funzioni pubbliche. La sicurezza del “posto fisso”, il fatto di non
21
essere chiamati a rispondere dei risultati dell’attività svolta, la consapevolezza
della mancanza di alternative per il cittadino hanno come conseguenza la scarsa
produttività e la insoddisfacente qualità delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
Questi elementi sono stati largamente messi in discussione dalle riforme
amministrative degli ultimi anni. Dalla legge 241 del 1990 che ha determinato
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di indicare i responsabili dei procedimenti
ed ha fissato anche termini per la loro conclusione. Alla riforma del pubblico impiego
del 1993 (e le successive modifiche) che ha introdotto con forza il principio della
responsabilità gestionale per i dirigenti pubblici, inserendo anche elementi per la
valutazione delle prestazioni degli impiegati. Dalla direttiva del 1994 con la quale è
stato fissato l’obbligo per i gestori di pubblici servizi di emanare le rispettive “carte dei
servizi”, vere e proprie forme di obbligazione con determinazione degli standards
qualitativi delle prestazioni. Alle norme che cominciano a rendere possibile l’uso di
incentivi economici significativi a favore di coloro che lavorano di più e meglio.
E non si tratta soltanto di principi e regole fissati nelle leggi. Molti passi avanti
sono stati fatti – particolarmente negli enti locali – nella concreta attività quotidiana. I
comportamenti effettivi di molte amministrazioni pubbliche (o di segmenti di esse)
sono cambiati. A volte in modo radicale. La circostanza, ovviamente, rafforza –
anziché eliminare – l’esigenza di chiedersi come mai ciò non si sia tradotto (o si sia
tradotto in maniera marginale) in
miglioramento delle “quotazioni” delle
amministrazioni pubbliche.
Al riguardo, gli elementi sui quali è utile interrogarsi sono tre. Il primo è dato
dalla persistenza di un forte scarto tra livelli medi di funzionalità degli apparati
pubblici e percezione collettiva. Esso, a sua volta, tende a perpetuare la tendenza
22
alla generalizzazione nei giudizi da parte degli utenti. Entrambi, inoltre, sono
facilitati dal deficit di capacità di comunicazione da parte delle amministrazioni
pubbliche.
I tre aspetti sono, ovviamente, connessi. Il primo è determinato, in larga parte,
dalla natura stessa del “luogo comune”, tanto più difficile da debellare, quanto più ha
radici nel sentire collettivo. L’abuso di giudizi generalizzanti si spiega, a sua volta,
come prodotto di pigrizia mentale ed, insieme, come frutto di osservazione
superficiale. Infine, le carenze nella comunicazione da parte delle amministrazioni
pubbliche dipendono, come è noto, da fattori molteplici: incertezza nelle politiche di
comunicazione, conseguenti difficoltà a definire strategie, problemi di caratura
professionale,
comunicazione,
poca
attitudine
scarsa
cultura
(ed
del
abitudine)
marketing,
a
confezionare
insufficiente
prodotti
distinzione
di
tra
comunicazione politica e comunicazione di servizio.
Provare a ragionare sulle connessioni tra “opacità” dell’immagine delle
burocrazie, persistenza di stereotipi e livelli di funzionalità delle amministrazioni
pubbliche può, forse, contribuire a capire – in una fase di intensa trasformazione del
sistema amministrativo – quali strumenti e quali strategie adottare per migliorare il
rapporto (non facile) tra cittadini e pubblici poteri nel nostro paese. Come pura
indicazione di massima si può sottolineare l’esigenza di tener conto di due elementi.
Da un lato delle crescenti aspettative dei cittadini e delle imprese (sia come singoli
sia in forma organizzata): la customer satisfaction come presupposto e obiettivo
dell’attività dei pubblici servizi. E, parallelamente, della progressiva scomparsa del
carattere “autoritativo” delle attività pubbliche e della conseguente (seppur
tendenziale) parificazione tra cittadini e pubblici poteri. L’esigenza, in altri termini, di
23
far scendere lo Stato dal “piedistallo” come tratto caratteristico del nuovo rapporto
tra amministrazioni e cittadini. .
Per i pubblici funzionari l’impatto con i problemi posti dalla trasformazione
dell’amministrazione comporta – in termini di recupero di immagine – una forte
capacità di rinnovamento. Tre le frontiere sulle quali far valere una dimensione
professionale che rinnovi il profilo delle dirigenze pubbliche. Frontiere definibili in tre
endiadi:
identità/ruolo,
identificazione/visibilità,
appartenenza/consapevolezza.
Ognuna di esse rinvia, evidentemente, ad una capacità. Rispettivamente: saper
essere – sulla base della qualità delle prestazioni fornite – uno degli “attori” del
cambiamento in corso nell’amministrazione; essere “riconosciuti” come soggetti attivi
della trasformazione; fare e saper essere “corpo”.
Recuperare identità è, infatti, processo strettamente connesso all’esigenza di
rivendicare autonomia ed alla correlata necessità di assicurare responsabilizzazione.
E’ questo il circuito dal quale può emergere la capacità di collaborare in modo attivo
alla riuscita dei tentativi di modernizzare il sistema amministrativo nel nostro paese.
In tale contesto gli sforzi condotti dalla pattuglia di coloro che occupano gli
avamposti della comunicazione negli apparati pubblici hanno avuto qualcosa di
eroico. Sono a diverse migliaia gli operatori che - tra Uffici stampa ed Uffici relazioni
con il pubblico - presidiano il settore vitale del contatto diretto tra amministrazione,
cittadini e mezzi di comunicazione di massa. La crucialità del loro ruolo è tanto
evidente che non occorre sottolinearla. Può essere utile ribadire come - nel reticolo
delle ipotesi di modernizzazione del settore pubblico - le funzioni di comunicazioni
abbiano un rilievo primario per il risultato complessivo dell’operazione. Né
pleonastico sembra il richiamo ad un elemento di elevata criticità costituito
dall’incertezza che si avverte nei pubblici dipendenti. In particolare i dirigenti -
24
chiamati ad una più incisiva partecipazione - sembrano in larga parte smarriti e
poco inclini ad occupare gli “spazi” che le norme offrono. Più preoccupati che decisi a
fornire i contributi che la situazione di trasformazione esige.
A rendere ancora l’orizzonte della comunicazione pubblica è l’assenza
di un riferimento normativo che configuri meglio le funzioni delle strutture di
comunicazione (URP, uffici stampa) e, soprattutto, che focalizzi in maniera più
articolata le figure professionali necessarie per il loro funzionamento. Il tutto in
presenza di una crescente domanda da parte dei cittadini, innescata proprio
dalle iniziative meritorie sviluppate in questi ultimi anni da numerose
amministrazioni pubbliche. Di fronte alla accresciuta pressione sociale, nonché
di fronte all’obiettivo bisogno di legittimazione di tutti coloro che - a volte in
modo pionieristico e volontaristico - hanno aperto una breccia di dimensioni
consistenti nella tradizionale separatezza degli apparati pubblici rispetto ai
cittadini ed alle loro esigenze, la perdurante mancanza di una legge-quadro
sulla comunicazione pubblica costituisce indubbiamente un fatto grave.
Gli uffici relazioni con il pubblico (dove esistono) sono un avamposto
delle amministrazioni pubbliche e (dove funzionano bene) anche un reale
interlocutore dei cittadini. Ma la loro diffusione è ancora troppo limitata:
secondo i dati del dipartimento della Funzione pubblica (risalenti alla metà del
1997) essi erano stati istituiti, in meno del 15% degli apparati pubblici, con la
consueta disparità territoriale (oltre il 50% nel Nord). Alla limitata diffusione
degli uffici si aggiunge un aspetto particolarmente preoccupante (nonché
indicativo della mentalità con la quale il problema viene affrontato): ben il 40%
delle amministrazioni che aveva provveduto ad istituire l’ufficio di relazione
25
con il pubblico non ha adottato alcuna misura di pubblicizzazione
dell’iniziativa.
I rischi insiti in una situazione del genere sono evidenti. Li ha
sottolineati, nel marzo scorso, il ministro per la Funzione pubblica, Piazza, il
quale – dopo aver sottolineato che agli URP è affidato nell’amministrazione
pubblica “quel medesimo delicato compito di raccordo che nell’azienda privata
si sviluppa tra il settore commerciale e il settore della produzione” – ha
osservato: “il processo di istituzione degli URP, infatti, procede in modo lento.
Molti uffici riescono a malapena a fornire informazioni e a ‘facilitare’ il rapporto
con i cittadini. sporadiche sono le attività rivolte all’analisi e alla ricerca sulle
esigenze degli utenti. Rara è la capacità di promuovere campagne di
‘servizio’”7.
La preoccupata analisi lascia aperto il campo a molte incognite. In primo
luogo è plausibile pensare che la spinta iniziale (dovuta alle norme del decreto
legislativo 29 del 1993) sia destinata ad esaurirsi. In secondo luogo gli uffici
relazioni con il pubblico si trovano nella scomoda posizione di ricettori delle
lamentele dei cittadini senza adeguata possibilità di incidere sull’andamento
dei servizi. Se gli URP non riusciranno ad assumere un ruolo effettivo nel
favorire
il
miglioramento
degli
standards
operativi
delle
pubbliche
amministrazioni, rischia di colare a picco tutto l’impianto delle riforme tese a
rendere trasparente l’attività dei pubblici servizi. Le due gambe sulle quali esso
deve camminare sono, infatti, una di tipo procedurale (garantito dalle norme
della legge 241 del 1990) ed una di tipo strutturale, costituita da uffici che
26
sappiano essere interfaccia reale tra domande dei cittadini e risposte (in
termini di risultati) dell’organizzazione pubblica. Se cade il baluardo costituito
dagli URP, il processo di innovazione subirà impacci notevoli e forse subirà
una definitiva battuta di arresto.
La crescita professionale di quanti lavorano in strutture di comunicazione
pubblica (URP, uffici stampa) e la selezione di quanti vi accederanno nel prossimo
futuro è, con tutta evidenza, un fattore decisivo. Si tratta di un problema di non facile
soluzione che deve contemperare due esigenze: riconoscere ruolo e competenza
professionale di coloro che già operano in strutture di comunicazione (si stima che
siano tra i 15 ed i 20 mila), fornire “certezze” sui requisiti professionali necessari a
svolgere tali attività. Occorre, quindi, valutare e valorizzare competenze esistenti e,
contemporaneamente, fissare “profili” professionali nei quali inserire tutti quelli che
fanno (o dovranno fare) comunicazione. Occorre, altresì, prendere coscienza che le
pubbliche amministrazioni necessitano di professionisti della comunicazione.
Cruciale, al riguardo è il raccordo con le università in molte delle quali si è avuto un
forte sviluppo di corsi e facoltà indirizzati a queste professioni. Non meno importante
- tanto per chi già è nell’amministrazione quanto per quelli che stanno per entrarvi - è
l’azione formativa. Che deve essere mirata e non generica e deve tendere a
specializzare quadri ed operatori.
27
2.4. linguaggio e potere: oscurità delle leggi e del lessico
burocratico
Montesquieu – nel libro diciannovesimo dell’Esprit des lois - ammoniva: “le
leggi non devono essere sottili: sono fatte per individui di mediocre intelligenza; non
sono espressione dell’arte della logica, ma del semplice buon senso di un padre di
famiglia”8. L’osservazione è una metafora dell’essenza stessa del potere e del
rapporto tra questo ed i cittadini. Il tema - come è noto - ha continuato a riproporsi nel
tempo: Lenin auspicava uno Stato nel quale potesse governare anche la cuoca; nel
lessico dei nostri anni la “casalinga di Voghera” è assurta ad emblema estremo del
cittadino “medio” al quale va commisurata la comunicazione pubblica. Ciò, da un
lato, conferma quanto profondo sia stato (e sia) il solco tra istituzioni e cittadini e,
dall’altro, conduce a chiedersi quali siano i “codici” specifici della stesura dei testi
legislativi. E per quali ragioni essi siano, normalmente, poco comprensibili e, spesso,
inutilmente complicati.
In generale, esiste un rapporto preciso tra chiarezza delle norme e livello di
fiducia tra legislatore, da un lato, e giudici e funzionari, dall’altro. La “diffidenza” degli
estensori delle norme verso i suoi interpreti, conducendo ad un’esagerata
minuziosità, determina un circolo vizioso, il cui risultato ultimo è l’esasperazione dei
vincoli contenuti in ogni disposto legge. Peraltro, la richiesta di stringere le maglie
delle norme può anche provenire dagli stessi interpreti. In Italia, ad esempio, il
fenomeno è stato favorito dalla tendenza delle burocrazie pubbliche a mettersi al
riparo dalle pressioni politiche predisponendo esse stesse, negli uffici legislativi dei
ministeri, norme di dettaglio che riducessero gli spazi interpretativi e rendessero
“obbligata” una attuazione automatica della legge. La certezza del diritto (principio
28
cardine degli ordinamenti moderni) si è tramutata spesso in un groviglio fittissimo
di prescrizioni legislative, per loro natura di difficile modifica. E, quindi, in una
tendenziale paralisi operativa delle amministrazioni pubbliche.
Leggi confuse e scritte male, quindi, come causa di un disordine normativo
giunto a livelli di evidente gravità. Particolare incidenza ha, tale fenomeno, sulla
legislazione amministrativa. L’entità del fenomeno si può, a titolo di puro esempio,
desumere da due importanti leggi tese alla razionalizzazione degli apparati pubblici:
la legge 23 ottobre 1992 n. 421 e la legge 24 dicembre 1993 n. 537. La prima benché composta di pochi articoli - ha un impianto estremamente articolato, con
prescrizioni minutissime e particolareggiate, al punto che il solo articolo 2 (relativo al
pubblico impiego) occupa circa 6 pagine della Gazzetta ufficiale. Circostanza ancor
più significativa se si tien conto che - trattandosi di una legge di delega - le norme si
limitano ad indicare criteri direttivi. A sua volta la legge 537 del 1993 (Interventi
correttivi di finanza pubblica), collegata alla “legge finanziaria” del 1994, è composta
di 17 articoli e ben 331 commi. La legislazione (in particolare quella amministrativa) è
divenuta - come hanno evidenziato, con analisi comparate, numerosi giuristi sempre più caotica. Fonte, quindi, di inevitabili sovrapposizioni normative e di
crescente contenzioso, derivante dalla non facile interpretazione dei testi.
Il fenomeno ha, naturalmente, riflessi immediati sul “lessico” burocratico. Di
fronte alla impronta vagamente sociologica di molte leggi ed alla crescente tortuosità
delle norme legislative i funzionari reagiscono, rifugiandosi in paradigmi di scrittura
ancorati a schemi “tradizionali”. Tutto ciò favorisce forme di linguaggio a “circuito
chiuso “ nelle quali gli unici veri danneggiati sono i componenti della collettività.
Se l’oscurità delle leggi colpisce in maniera soltanto mediata e indiretta i
cittadini (ovvero, il danno immediato riguarda un numero solitamente circoscritto di
29
persone), la poca comprensibilità dei “messaggi” delle amministrazioni pubbliche
si traduce in un quotidiano disagio per una larga fetta della società civile, poiché le
comunicazioni predisposte dalle amministrazioni pubbliche pervengono direttamente
alla quasi totalità dei cittadini. Dal bando di concorso, alla multa, dalla bolletta
telefonica ai modelli per il pagamento delle imposte, sono assai poche le forme di
comunicazione dirette ai cittadini sufficientemente chiare ed, insieme, esaurienti. Al
riguardo poco importa, naturalmente, che esse vengano da un organo dello Stato
come il ministero delle Finanze o da una società per azioni come TELECOM, poiché
in entrambi i casi sono il riflesso di una pubblica funzione e, rispetto ad essa, i
cittadini hanno eguale diritto di pretendere chiarezza e semplicità.
Data la vastità delle comunicazioni provenienti da soggetti pubblici (o
esercenti pubblici servizi) la chiarezza si presenta, in sintesi, come un vero e proprio
diritto “di cittadinanza”. Al riguardo è auspicabile che in Italia si segua l’esempio degli
USA, che hanno - in ben 37 dei 51 Stati dell’unione - norme che fissano livelli minimi
di leggibilità delle leggi e delle altre comunicazioni dei poteri pubblici indirizzate ai
cittadini. Dato per assodato che la comprensibilità del linguaggio dei pubblici poteri è
un aspetto cruciale per migliorare i rapporti Stato/cittadini, ne deriva - come
conseguenza - che la capacità di “parlar chiaro” delle amministrazioni pubbliche è un
elemento fondamentale della loro credibilità. La chiarezza del linguaggio dei pubblici
poteri è, essa stessa, uno degli standards qualitativi del loro agire. Le
amministrazioni si giudicano, principalmente, da quel che fanno e da come lo fanno.
Ma anche da come riescono a dar conto di quello che fanno.
E’ innegabile che le pubbliche amministrazioni in Italia abbiano avuto (nel loro
insieme) notevoli difficoltà ad adottare canoni di comunicazione adeguati alle
esigenze della collettività. Il panorama è, negli ultimi tempi, in rapido mutamento. Ciò
30
nonostante, vale ancora la pena di interrogarsi sulle ragioni che hanno prodotto la
tradizionale “chiusura” del linguaggio delle burocrazie. Le ragioni di tale fenomeno
sono, sostanzialmente, di due tipi e rinviano, rispettivamente, alle logiche “autoritarie”
dei pubblici poteri ed alle basi culturali delle burocrazie pubbliche.
Il problema dello stile burocratico in Italia è stato fino ad ora largamente
sottovalutato anche a causa della tradizionale “separatezza” dell’amministrazione
pubblica rispetto ai cittadini, visti più come “sudditi” che come soggetti con i quali i
poteri pubblici devono interagire in maniera paritaria. Il linguaggio oscuro è stata una
delle conseguenze “logiche” di un’amministrazione autoritativa. A funzioni di
“controllo” degli amministrati si addiceva un vocabolario per “iniziati”. Il basso livello
di comprensione dei messaggi prodotti dagli uffici pubblici ha ricevuto, peraltro,
indiretta legittimazione dal principio - vigente sostanzialmente fino a pochissimi anni
fa nel nostro paese - della segretezza pressoché totale degli atti amministrativi.
La scarsa attitudine a scrivere in modo chiaro è stata favorita anche dai
meccanismi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nelle quali ha
largamente dominato il principio non scritto che è meglio non assumersi nessuna
responsabilità. Di fronte ad un precetto normativo poco chiaro, il funzionario che
deve predisporre una circolare o inviare una comunicazione scritta ad un cittadino
tende a riprodurre - rendendole spesso ancor più oscure - le espressioni contenute
nelle leggi. Oscurare il linguaggio serve ad oscurare le responsabilità. La burocrazia
è “tardigrafa” (secondo la penetrante espressione usata da Massimo Severo Giannini
nel suo Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione) perché ciò è coerente
con i modelli di organizzazione dell’attività. Soltanto se si incide profondamente su
questi, sarà ipotizzabile anche pervenire a modelli di comunicazione (scritta, in
questo caso) meno oscuri.
31
La “mentalità” autoritativa è l’altra causa dell’oscurità del linguaggio
burocratico. Al riguardo si può ritenere fondato che i meccanismi di comunicazione
della burocrazia obbediscano ad un preciso precetto: è bene che poche sappiano,
che pochi capiscano. Sociologicamente tale atteggiamento è spiegabile con la
sensazione dei funzionari pubblici di essere divenuti il “capro espiatorio” della crisi di
funzionalità dei servizi pubblici. La burocrazia si sente sempre più tallonata dai
cittadini e non può più far valere la tradizionale “superiorità” dell’amministrazione
sugli “amministrati”. In secondo luogo, i funzionari scrivono avendo come universo di
riferimento le norme (il “diritto positivo”) nelle quali la vita quotidiana dei cittadini - o,
meglio, degli “amministrati” - ha un ruolo meramente accidentale. L’origine di tale
mentalità è nella progressiva separatezza della burocrazia dalla società e
nell’abitudine inveterata a muoversi negli oscuri meandri dell’amministrazione. A
differenza dei funzionari francesi ed inglesi, che scrivono per il popolo - osservava
Antonio Gramsci9 - quelli italiani scrivono per i loro superiori.
Questo aspetto è, evidentemente, denso di implicazioni. Non vi è dubbio,
infatti, che lo specialismo del linguaggio usato dalla burocrazia non può essere
valutato alla stregua di uno dei tanti linguaggi “tecnici” di cui si nutrono le scienze.
Questi sono giustificati perché diretti esclusivamente (o quasi) agli addetti ai lavori.
Hanno, quindi, la funzione di dotare di astrazione e precisione analitica una
comunicazione “interna”. Molto diversa è la questione, ovviamente, quando ci si
rivolge alla generalità dei cittadini. Ancor più se essi hanno l’obbligo di
“comprendere”. E’ quest’obbligo che fa nascere il diritto (speculare) alla
comprensibilità. E, quindi, il dovere, per chi si rivolge ai cittadini-utenti, di usare un
linguaggio chiaro.
32
In questa chiave l’iniziativa - assunta dal Dipartimento della Funzione
pubblica nel dicembre 1993 - di enucleare le direttrici di un Codice di stile per le
comunicazioni scritte in uso nelle pubbliche amministrazioni è stata certamente
importante. Benché non privo di pecche (soprattutto perché sembrava tesa ad
“imporre” ai funzionari una “nuova grammatica”), il tentativo è lodevole, poiché si
connette strettamente alla filosofia generale delle riforme di questo scorcio di
decennio: dare centralità al cittadino ed ai suoi diritti nei confronti delle
amministrazioni pubbliche. Se i funzionari pubblici cominceranno ad usare un
linguaggio più comprensibile, si saranno fatti importanti passi avanti verso una
concezione autenticamente democratica del ruolo degli apparati amministrativi.
L’uso di modelli di comunicazione meno oscuri va vissuto dai funzionari
pubblici come un “dovere morale” verso se stessi. E’ un modo per riprendersi una
dignità fortemente intaccata dalla opinione corrente che i pubblici dipendenti siano,
senza esclusione, dei perdigiorno. Su questo terreno nulla può sostituire,
evidentemente, la capacità autonoma e l’azione della burocrazia tese a ripristinare
un suo maggiore prestigio sociale. Si tratta di un percorso certamente non facile e,
oltretutto, di non breve durata. Ma è l’unico percorribile. .
1
Citato in S. ROLANDO, Un’altra idea di questo Stato, Genova, Costa e Nolan, 1996, p. 34
M. FEDELE, Come cambiano, cit. p. 114
3
Ne dava notizia R. GALULLO, Due Comuni su tre ignorano l’impresa, in “Il Sole 24 Ore” del 2 novembre
1998
4
Così M. ROGARI, Un terzo della riforma giunto in porto, in “Il Sole-24 Ore”, 26 ottobre 1998
5
S. ROLANDO, La capitale umorale. Note su Milano e la Lombardia, Milano, Edizioni Milano metropoli,
1998, p. 39
2
33
6
S. ROLANDO, La capitale umorale, cit., p. 71
Cfr PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per l’informazione e l’editoria –
Dipartimento della funzione pubblica, URP 12, marzo 1999, p. 5
8
MONTESQUIEU, Le leggi della politica (a cura di A Postigliola), Roma, Editori Riuniti, 1979, p. 515
9
A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (a cura di V. Gerratana) , Torino, Einaudi, ………………..
7