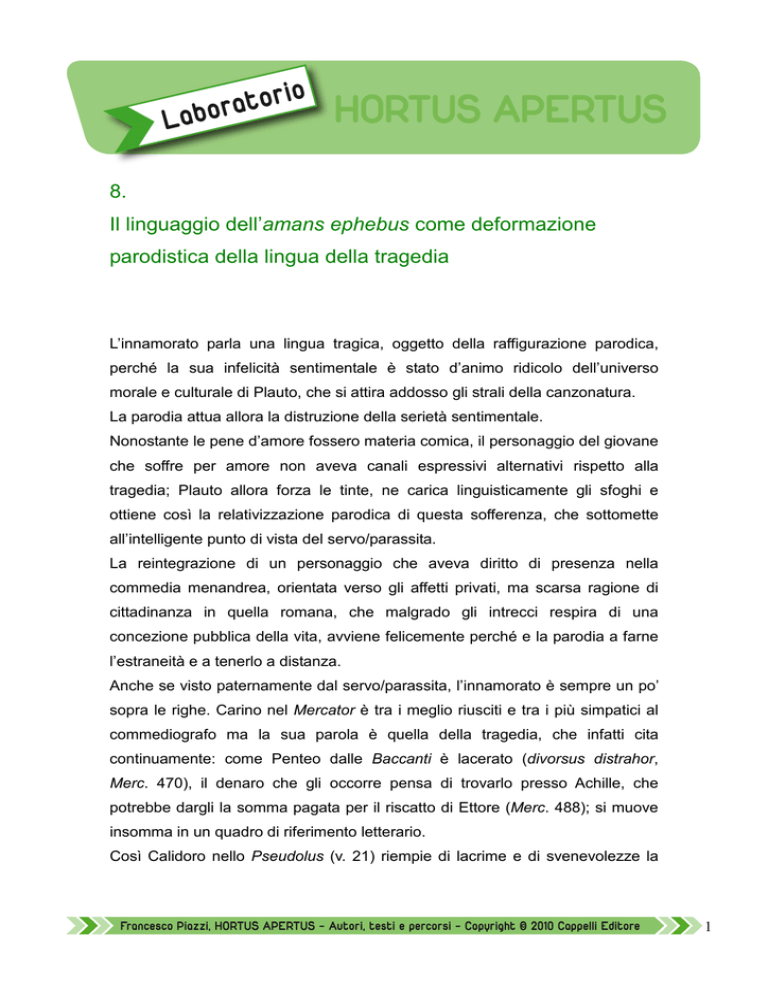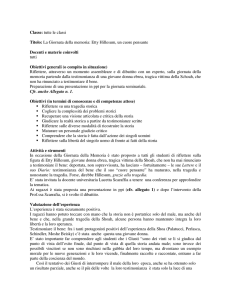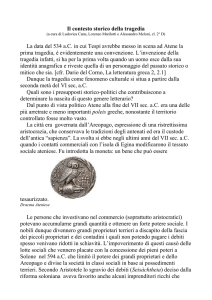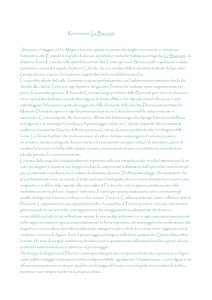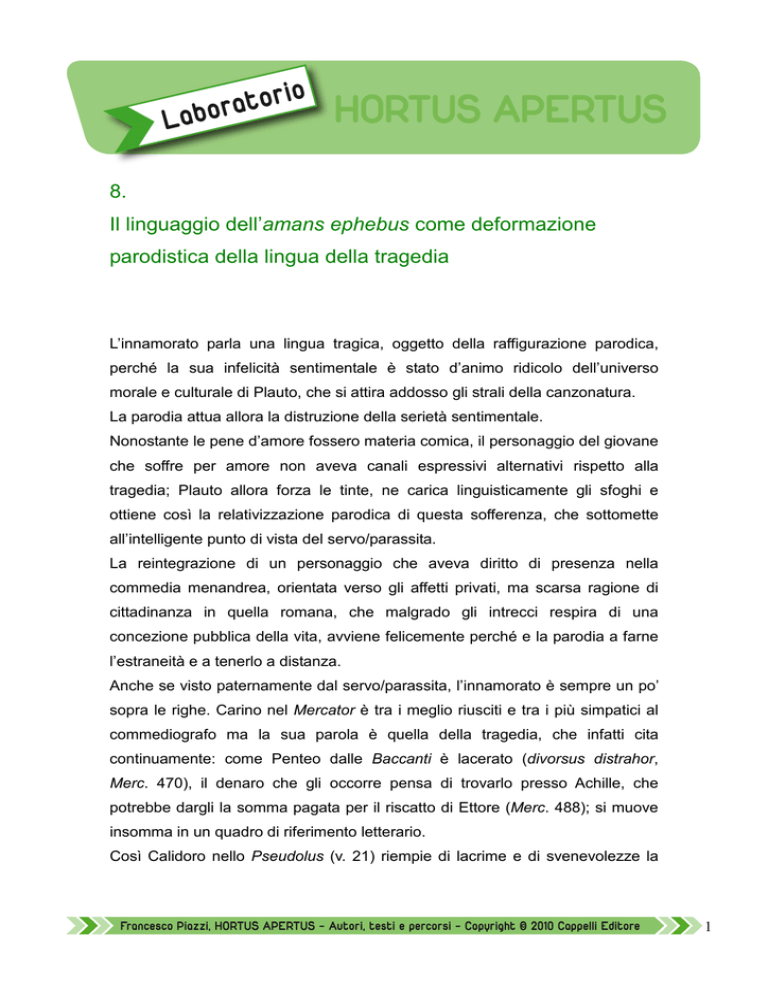
8.
Il linguaggio dell’amans ephebus come deformazione
parodistica della lingua della tragedia
L’innamorato parla una lingua tragica, oggetto della raffigurazione parodica,
perché la sua infelicità sentimentale è stato d’animo ridicolo dell’universo
morale e culturale di Plauto, che si attira addosso gli strali della canzonatura.
La parodia attua allora la distruzione della serietà sentimentale.
Nonostante le pene d’amore fossero materia comica, il personaggio del giovane
che soffre per amore non aveva canali espressivi alternativi rispetto alla
tragedia; Plauto allora forza le tinte, ne carica linguisticamente gli sfoghi e
ottiene così la relativizzazione parodica di questa sofferenza, che sottomette
all’intelligente punto di vista del servo/parassita.
La reintegrazione di un personaggio che aveva diritto di presenza nella
commedia menandrea, orientata verso gli affetti privati, ma scarsa ragione di
cittadinanza in quella romana, che malgrado gli intrecci respira di una
concezione pubblica della vita, avviene felicemente perché e la parodia a farne
l’estraneità e a tenerlo a distanza.
Anche se visto paternamente dal servo/parassita, l’innamorato è sempre un po’
sopra le righe. Carino nel Mercator è tra i meglio riusciti e tra i più simpatici al
commediografo ma la sua parola è quella della tragedia, che infatti cita
continuamente: come Penteo dalle Baccanti è lacerato (divorsus distrahor,
Merc. 470), il denaro che gli occorre pensa di trovarlo presso Achille, che
potrebbe dargli la somma pagata per il riscatto di Ettore (Merc. 488); si muove
insomma in un quadro di riferimento letterario.
Così Calidoro nello Pseudolus (v. 21) riempie di lacrime e di svenevolezze la
1
prima scena, esprimendosi in una gonfia lingua tragica: dice che la lettera
dell’amata miseria et cura contabefacit dove il verbo, metafora della
decomposizione fisica, rinvia all’ossessione della tabes [«decomposizione»]
tipica della tragedia arcaica latina, o ancora minaccia il suicidio con un verso
che sembra una citazione tragica (Ps. 90): certum est mihi ante tenebras
persequi [«È deciso, prima di notte avrò raggiunto la notte eterna»]. Ma accanto
al pianto di Calidoro, c’è la presenza di un inguariblie siccoculus [«dagli occhi
asciutti»], cui non riesce mai a dipingere, Pseudolo, ed è la sua risposta, così
polarmente contraria alle parole del giovane, a darci la retta interpretazione,
anzi quei sospiri sono il pretesto e il supporto per la manifestazione della sua
vigorosa malitia. Ma di casi di questo genere il teatro plautino è pieno.
A livello stilistico la parodia è fortemente condizionata dalle scelte linguistiche
della tragedia latina. Com’è noto, questa aveva sviluppato particolarmente il
versante formale, accentuando il pathos e l’espressività. Poiché nasceva come
traduzione di testi greci ad opera di intellettuali, la cui coscienza culturale era
penetrata da più sistemi linguistici e letterari, cioè da più sistemi ideologici, la
tragedia latina aveva abbastanza indebolito il legame tra forma e contenuto e
relativizzato la solidarietà tra tragedia e mito, ovvero il materiale tragico. Essa
nasceva già da una letteratura, la greca, che svolgeva un compito di sostegno
pari al ruolo del mito nel teatro greco. Così come l’epica omerica era per la
tragedia greca il «tesoro» di miti da portare sulla scena, in quanto comprensiva
di gran parte della mitologia, la letteratura greca era il patrimonio da cui i poeti
tragici romani traevano i loro modelli, che erano già altissima letteratura. La
tragedia latina dovette cercarsi un nuovo equilibrio poiché non rispecchiava più
valori mitici ma rappresentava miti perché questi erano già letteratura tragica.
Un centro di organicità e di unità intorno a cui si raccolse fu appunto la lingua e
lo stile, che vennero a rivestire un rilievo assoluto, perché nei valori stilistici e
2
linguistici, e non in quelli mitologici, si rifugiava la tradizione sacrale romana
(esemplare in questo senso è l’uso e il significato dell’allitterazione) e in essi si
rinserrava ogni creatività ed originalità. Questo processo in realtà accomuna
Plauto ai tragici latini, poiché entrambi concentrarono i loro sforzi sulla
formazione di una lingua originale, mentre accettavano modelli formali
prestigiosi, che limitavano l’innovazione dei contenuti. La «fantasia linguistica»
di Plauto è il prodotto di quelle stesse cause che avevano determinato nella
tragedia uno stile assai caratterizzato nel senso dell’espressività: il comico e i
tragici vanno nella stessa direzione dell’accentuazione ed esasperazione, nella
comune attività della traduzione. La ricchezza lessicale e la tumidezza stilistica
della tragedia latina erano un fatto definito ed il segno di una compattezza
raggiunta. L’arditezza dei neologismi, l’eccesso grand-guignolesco, tipici della
lingua tragica, si prestavano però troppo bene al devastante sbeffeggiamento
plautino. Allora dietro la parola composta, cervellotica e bizzarra, dietro
l’aggettivo raro e sorprendente, mai più usato e d’assurda provenienza, sta
l’osservazione
plautina
del
linguaggio
tragico,
divenuto
oggetto
di
rappresentazione parodica. Quest’ultima è una parodia letteraria.
(G. Petrone, Teatro antico e inganno: finzioni plautine, Palumbo, Palermo 1983,
pp. 185-188)
3