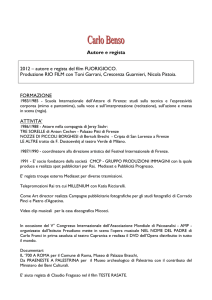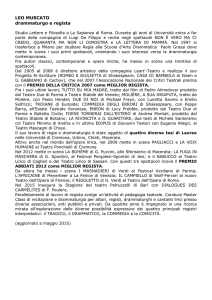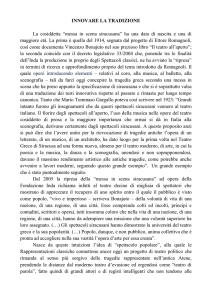asc incontri: giammello
La scena si sente
L
e cose fatte, per quanto
possano essere maestose
o profonde, vanno immediatamente superate, perché difficilmente
reggono la corsa del
tempo. Bisogna dunque aggiornarsi, affinare le ingenuità
e confrontarsi senza paura con i mille
linguaggi in cui sono scritti gli spazi
della contemporaneità. Anche dopo
trent’anni di carriera e oltre cento spettacoli teatrali costruiti assieme a personalità come Lavia, Ronconi, Missiroli,
Job, Luzzati…
È il caso di Carmelo Giammello,
scenografo cresciuto all’ interno dell’
ufficio tecnico del Teatro Stabile di
Torino, fra ingranaggi amministrativi
e sogni ingegneristici. Luca Ronconi fu
il primo a comprendere appieno la sensibilità artistica incastonata nell’ottimo direttore degli allestimenti e a lanciarlo come scenografo. Un’ intuizione
convalidata dai premi ottenuti negli
ultimi anni e dalla costante qualità
degli spettacoli firmati da Giammello.
50
di gianni sorrentino
intervista a carmelo giammello
Lo abbiamo incontrato al Teatro
Argentina durante l’allestimento di
Memorie dal sottosuolo, in scena a
fine marzo con la regia di Gabriele
Lavia.
Documentare visivamente la
storia del teatro è un antico problema irrisolto. Del vostro lavoro non
resta quasi nulla perché le immagini non riescono a restituire la forza
di uno spettacolo. Tu stesso sei più
conosciuto per un’installazione realizzata in occasione delle Olimpiadi
invernali che per trent’anni di
carriera…
È vero. Le due edizioni di Luci
d’artista mi hanno dato una visibilità, anche internazionale, maggiore
di quella avuta con anni di teatro.
Da un lato devo ringraziare Internet,
perché ha diffuso rapidamente il
nostro lavoro in tutto il mondo.
Dall’altro, mi vien da riflettere sulla
fatica che il nostro teatro compie per
raggiungere il grande pubblico.
Per quella rassegna hai portato il cielo sulla terra per le vie di
Torino…
L’evento era nato per aiutare la città da un punto di vista turistico. Una
vetrina incentrata sull’arte contemporanea di Torino, con temi molto legati
al periodo natalizio durante il quale si
svolgeva. Ho pensato così ad un cielo
stellato un po’ perché, normalmente,
in città siamo tutti distratti e non
alziamo mai la testa. E poi, se anche
la alziamo, fra nuvole e inquinamento non è che si veda un granché. Ho
così ricostruito circa 24 costellazioni
che sono state installate per oltre un
chilometro da Piazza Castello a Porta
Susa, nella prima edizione, e sui due
tronconi di via Roma nella seconda.
Al primo anno, a New York, un rivista d’arte ha dato un calendario che
aveva in copertina la mia installazione, pensa un po’…
asc incontri: giammello
Non è stato l’unico caso in cui hai scritto gli spazi
urbani torinesi. Era avvenuto anche alle Porte Palatine
assieme a Luzzati…
Realizzammo insieme un muro scenografico per la
Sindone nel 2000, in occasione della visita del Papa. C’era
un cantiere, a Porta Palazzo, sorto in una situazione un po’
degradata e fu deciso di costruire una sorta di palizzata attorno a questa piazza di fronte alle Porte Palatine. Doveva
essere una semplice staccionata ma è diventata un’opera
imponente di duecento metri, con duemila metri quadrati di materiali dipinti a mano lungo quattro facciate che
arrivavano anche a sei metri d’altezza. Il tutto si doveva
inserire ed integrare con le architetture preesistenti della
piazza. Una bella sfida.
Un modo di combattere il degrado con la fantasia che
annullava i confini fra scena e città…
Temevamo fortemente le incursioni degli squatter.
Sull’unico cartello bianco presente apparve subito una
scritta poco incoraggiante: “stronzi”. Per il resto non è
mai stato fatto uno sberleffo, nessun imbrattamento sulle
parti dipinte in oltre tre anni di permanenza. Un rispetto
che ci ha veramente stupito…
Forse un segno di riconoscenza, per quanto raro, alla
bellezza…
Il merito è di Luzzati. Una persona straordinaria dal
punto di vista umano, mai egocentrico, molto aperto e
disponibile che mi ha sempre permesso di contribuire
anche nella fase ideativa senza mai imporre le sue idee.
In quest’occasione mi commissionò un modellino che
poi rielaborò, restituendomene uno più grande con delle
immagini ritagliate da riviste, giornali, libri. Abbiamo
poi utilizzato della lamiera dapprima tagliata al laser, poi
rivestita in tela ed infine ridipinta da Fulvio Lanza, un
pittore straordinario che purtroppo è mancato. Durante
la realizzazione mi sono poi accorto che si poteva lavorare
sulla struttura dell’opera ed ho inserito più piani per creare diverse illuminazioni. È stato davvero un onore poter
collaborare con Luzzati.
Ritieni che il suo lavoro abbia influenzato la tua identità artistica?
Luzzati ha un segno molto caratteristico che sin
dall’Accademia ho studiato a fondo. I miei primi passi
nell’ambito teatrale hanno dunque tenuto conto della
sua magia anche se oggi sento la mia identità artistica
piuttosto lontana dalla sua. Non saprei darti una risposta
definitiva anche perché un po’ tutto il teatro sperimentale
della seconda metà degli anni Settanta è stato fortemente
influenzato dalla sua poetica: l’uso di materiali comuni,
gli accatastamenti, quel dare un senso nuovo agli oggetti
quotidiani che diventavano architetture fantastiche…
a fianco: immagini ritraenti il muro scenografico realizzato
insieme a Lele Luzzati alle Porte Palatine (2000).
nella pagina precedente: scenografia costruita
da Carmelo Giammello per Il sogno del principe
di Salina: l’ultimo Gattopardo (2006)
51
asc incontri: giammello
Chi ti ispirava quando facevi
l’Accademia?
Mi vengono in mente Gordon
Craig e Appiah anche se, devo dirti la verità, durante quegli anni ero
piuttosto in crisi. Inizialmente volevo fare il pittore e non pensavo proprio al teatro. Ancora prima avevo
lavorato in fabbrica e, quando potei
iscrivermi al liceo artistico, mi buttai
freneticamente nel lavoro per recuperare gli anni perduti. Avevo bisogno
di riferimenti concreti e cercavo di
acquisire al più presto una manualità
costruendo modellini su modellini,
facendo proposte agli insegnati e poi,
come è giusto, sbrigandomela un po’
da solo. I veri maestri li trovi poi sul
campo quando inizi a lavorare e a
capire la macchina teatrale, i suoi
spazi.
Raccontiamo allora questo
percorso…
Sono partito da zero. Ho cominciato con le compagnie dei ragazzi e
il massimo che potevo fare era dipingere e dare l’ignifugo. La mia fortuna è stata quella di entrare nel teatro
stabile di Torino e passare all’ufficio
tecnico dove, preparando gli allestimenti, sono entrato in contatto con
registi e scenografi. Fra questi mi piace ricordare Enrico Job che per me è
sempre stato un maestro e un punto
di riferimento importante per come
ha saputo utilizzare lo spazio scenico
e l’invenzione. Quando sono stato
nominato nella terna degli Olimpici
assieme a lui e ci siamo seduti accanto in attesa del risultato ho provato
un’emozione indescrivibile.
Al Teatro Stabile di Torino
incontri Luca Ronconi, il regista
che ti fa esordire come scenografo. Puoi descriverci la vostra
collaborazione?
Ho avuto il privilegio di lavorare con Ronconi seguendo diciotto
spettacoli come direttore degli allestimenti, di cui sei come scenografo,
fra i quali una versione del Misura
per misura che ha rappresentato la
mia prima esperienza. Dire che è un
genio è quasi superfluo ma la cosa interessante è che Ronconi è anche un
grande scenografo. Non ha bisogno
52
di disegnare perché ha sempre una
visione chiarissima dell’opera che sta
costruendo in cui ti fa entrare lentamente, non spiegandoti tutto subito.
È un procedimento molto interessante e stimolante perché ti prende
per mano e ti porta al risultato finale,
pur lasciandoti un tuo spazio creativo all’interno di questo rapporto. I
suoi spettacoli sono caratterizzati da
una ricerca estetica estrema ed hanno un’impronta e uno standard ben
definiti, chiunque sia lo scenografo.
Gli sono grato perché è il regista che
per primo mi ha aiutato a capire veramente lo spazio teatrale.
All’uscita dei suoi spettacoli,
solitamente, in molti si chiedono: “perché le sedie e i mobili si
muovevano?”…
Perché in Ronconi la scenografia
non è mai un elemento di arredamento. La scenografia è un attore e
quindi recita. È una cosa che a volte
gli rimproverano perché fa spendere
soldi e poi perché gli attori a volte si arrabbiano – è accaduto con
Albertazzi – perché secondo loro il
teatro è l’attore…
Qual è la tua opinione?
Il teatro parla della vita degli uomini. Senza scenografia si può fare,
senza l’attore no, e te lo dice uno scenografo convinto. Fare una scena per
la scena non ha senso perché la scena
deve sempre far parte di un progetto drammaturgico e deve aiutare
l’attore ad essere in un contesto. Se
il regista è debole usa l’artificio per
coprire delle carenze ma, se si parla
di Ronconi, sai perfettamente che
verrà compiuto un lavoro sull’attore
– e quindi sulla parola – estremamente rigoroso. Quando questo lavoro è
abbinato, l’artificio diventa un altro
attore o se preferisci una componente che aiuta e mette in condizioni
l’attore di dargli quella sensazione
per dire quello che sta dicendo. O
per metterlo in difficoltà. Ricordo
che ne Gli ultimi giorni dell’umanità Ronconi aveva lasciato Popolizio
appeso a sei metri su una sedia che
ogni tanto faceva capriole… serviva
per mettere l’attore in una condizione diversa, non naturalistica, per
consentirgli di trasmettere qualcosa
che in quel frangente assumeva una
forza maggiore.
Purtroppo, non sono molti i registi che sanno dare alla scenografia
quel forte taglio drammaturgico che
trovo assolutamente necessario. Un
altro è sicuramente Gabriele Lavia.
Ci puoi raccontare il suo approccio alla scenografia?
Gabriele rappresenta una genialità diversa, che si fonda su un rapporto più semplice e più schietto rispetto ad altri registi. Mi ha insegnato a
dare un po’ un’anima, un calore. Nei
suoi spettacoli la scena ha sempre un
cuore e trasmette tantissimo. La sua
esperienza gli consente delle intuizioni notevoli, spesso geniali, che
cerco di tradurre mettendo la mia
professionalità e la mia esperienza al
suo servizio. Abbiamo collaborato in
più di dieci spettacoli e non saprei da
dove partire…
asc incontri: giammello
Mi viene in mente L’avaro, in cui veniva proposta una
lettura molto intrigante del testo di Molière. Un esempio
di come le quattro pareti del teatro riescono ad aprirsi e
ad aprire gli occhi verso la società esterna…
In quel caso la scenografia cercava di contribuire al
racconto del naufragio della famiglia. L’idea che mi aveva
trasmesso Gabriele era questa: la crisi della famiglia, la
sua dispersione e disgregazione contemporanea. Per rappresentarla immaginammo una casa in bilico, destinata a
crollare in breve tempo e tanti particolari per esprimere
i concetti che ne seguivano. Esemplifica, a mio avviso, il
modo corretto d’intraprendere la progettazione di uno
spazio. Un forte significato drammaturgico ed un aiuto
all’attore per esprimere la lettura del testo. Senza dimenticare mai la forte presenza del regista. Io mi pongo solo
come un tecnico che ha una capacità e una formazione
artistica e che cerca di interpretare le intenzioni del regista. Come il regista dice le sue intenzioni all’attore così le
comunica allo scenografo, al costumista e al datore di luci.
Queste competenze, sommate, danno valore allo spettacolo di cui il regista è la componente fondamentale. Senza
di lui naufraga tutto…
Rimanendo in tema, ricordo un Edipo Re andato in
scena al Teatro Greco di Siracusa…
La scenografia esprimeva un concetto simile, seppur
in un contesto totalmente diverso, perché anche lì c’era un
edificio crollato, ricoperto di sabbia, alto quindici metri
e largo ventidue, caratterizzato una fortissima inclinazione che comunicava un disagio, un senso di vertigine che
in fase costruttiva procurò parecchi dubbi all’ingegnere
e perfino a Gabriele. C’era anche un grande sipario di
ventidue metri, seppellito nella sabbia, che nella scena finale sbucava improvvisamente, gonfiandosi ed ergendosi
a muro. In quell’occasione vidi diecimila persone alzarsi
in piedi ed applaudire, un vero stadio con tanto di ola.
Indimenticabile.
Fra gli spettacoli di maggiore impatto segnalerei anche Il misantropo…
Fu uno spettacolo notturno, marcatamente trasgressivo dal punto di vista dell’interpretazione e molto attualizzato, in grado di cogliere le nevrosi della metropoli. Un
lavoro molto complesso che fondeva luci, acqua, botole
motorizzate, materiali diversissimi come il vetrocemento
e il marmo, con cui creammo una pedana con un suo particolarissimo impatto sonoro. Può sembrare assurdo ma il
suono sta acquisendo un’importanza crescente e percepire
i passi sul marmo è molto differente dagli scricchiolii di
una pedana. Quell’esperienza mi ricordò uno dei motti di
Job: “la scena si sente, non solo si vede”…
Sta per arrivare a Roma Memorie del sottosuolo. Ce
ne puoi parlare?
È la ripresa di uno spettacolo fatto al Teatro India, dove
il sottosuolo era stato ambientato in un capannone lungo
trenta metri, annullando le volte con delle capriate per
dare maggiore profondità. Nella versione teatrale che an-
a fianco: il naufragio della famiglia interpretato
visivamente da Carmelo Giammello ne L’avaro (2003)
53
asc incontri: giammello
in alto: Misura per misura immaginato per Luca Ronconi
drà in scena all’Argentina ci siamo ovviamente accorciati e
abbiamo dato uno sfogo all’altezza, ricreando una sorta di
pozzo, un baratro dove incontriamo i personaggi…
…che sono solo tre a differenza del precedente Misura
per misura dove erano più di venti, passando dall’affresco
di una società decadente al racconto viscerale del “pozzo”
di un individuo…
Il mio compito è sempre lo stesso: comprendere le intenzioni del regista e cercare di realizzarle. È lui che detta
i limiti. Per me affrontare spazi grandi o piccolissimi è
sempre un divertimento, una sfida con lo spazio. Non trovo differenze. Una volta ho curato un monologo dove c’era
un unico oggetto meccanizzato e mi sono concentrato sui
pochi movimenti che voleva il regista. Fra l’altro lo spazio
dell’India dove abbiamo fatto Memorie dal sottosuolo era
ancora più grande dell’Argentina che ospitò il Misura per
misura…
Quest’osservazione ci fa capire quanto sia fondamentale il luogo della rappresentazione.
Il luogo è importantissimo. Ho lavorato ad uno spettacolo che aveva la prima al Teatro Verdi di Firenze e poi andava a Locarno, in uno spazio piccolo come questa stanza.
In casi come questo, dal punto di vista scenografico, i rapporti vanno a farsi friggere. Più in generale, la posizione
dello spettatore è sempre determinante nella combinazione dello spazio: se siamo in teatro sappiamo che c’è una
convenzione; all’India, ad esempio, lo spettatore vive una
sensibilità nettamente diversa. La lontananza, in molti
casi, aggiusta tutto ma, se sei vicino, devi dare agli oggetti
un valore diverso. Come nel cinema quando inquadri da
vicino e l’oggetto ripreso deve “reggere”. A teatro funziona
una convenzione che rende possibile tutto, anche che una
sedia diventi castello. Al cinema è molto più difficile, c’è
una poetica diversa che rincorre maggiormente il realismo.
In teatro, infine, hai la possibilità di vedere quello che vuoi,
il regista sei tu e dialoghi con la componente interpretativa dello spazio scenografico creato. Detta così sembro
rifuggire il cinema ma in realtà mi piacerebbe tantissimo
provare a farlo…
54
So che con Marco Tullio Giordana avete tentato un
“teatro cinematografico” portando in scena Morte di
Galeazzo Ciano di Enzo Siciliano…
Quando ci siamo incontrati, Marco mi disse: “io non
so niente di teatro e mi affido a te”. In modo incosciente ho pensato di utilizzare un concetto cinematografico
nei movimenti scenografici: tutti a vista; pareti che si
stringevano e si allargavano, tre nastri trasportatori che
permettevano l’ingresso di oggetti scenici e degli stessi
attori, grate che scendevano dall’alto, un plafone da cui
entrava la luce e via dicendo. Una vera e propria macchina
cinematografica che permetteva di passare da un tempo
presente ad uno passato con dei movimenti di scena. Un
regista di teatro avrebbe avuto paura perché l’apprensione
sarebbe stata tanta. Giordana si è affidato completamente
alla squadra tecnica nonostante avessimo poco tempo per
le prove. Da qui l’incoscienza del progetto…
C’è un regista, fra quelli con cui non hai ancora collaborato, con cui ti piacerebbe lavorare?
Lavorerei volentieri con Massimo Castri, con cui ho
collaborato solo come direttore degli allestimenti. Castri
è un regista vero, molto profondo, lavorare con lui sarebbe
un’esperienza istruttiva. Peccato che abbia già uno scenografo bravissimo come Maurizio Balò…
Vorrei infine chiederti se percepisci una disaffezione
dei più giovani verso il teatro e se puoi dargli dei buoni
motivi per tornare sui loro passi…
C’è sicuramente un problema di linguaggio che riguarda
il 90% degli spettacoli, vissuti con insofferenza dai ragazzi,
a volte molto a ragione. Ma l’altro 10% vale veramente la
pena perché a teatro trovi il momento e, in modo del tutto
affascinante, sei inconsapevolmente partecipe di quello che
sta accadendo. È un po’ un rito e questo gli attori lo sentono
molto. È un momento corale, dove spettacolo e pubblico
devono andare in simbiosi. Quando accade questo, lo spettacolo diventa un rito fondamentale, unico e irripetibile. E
poi è un fatto di cultura, come leggere un bel libro o una
poesia, un po’ per elevare sé stessi anche se è una cosa più
faticosa, che ti fa pensare e che devi capire. Per questo dico
che sei partecipe: perché il teatro non è mai passivo.