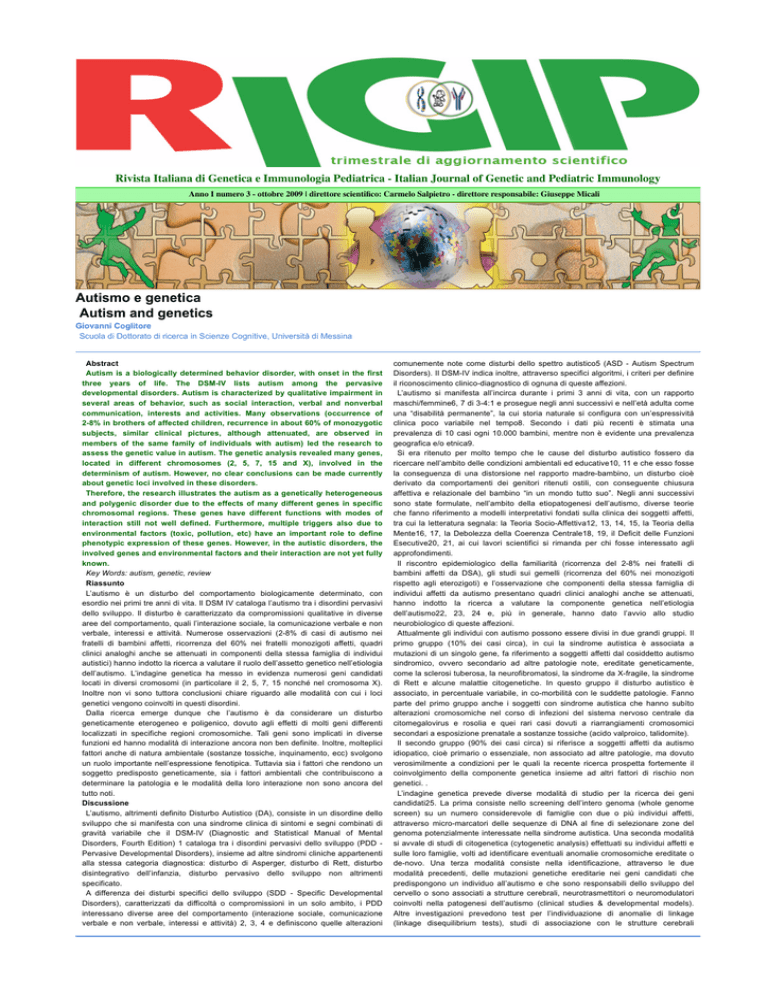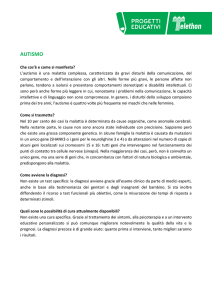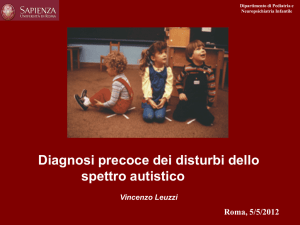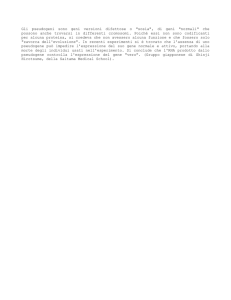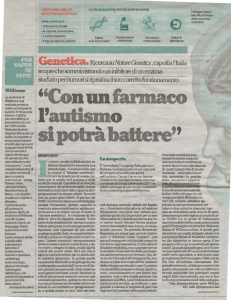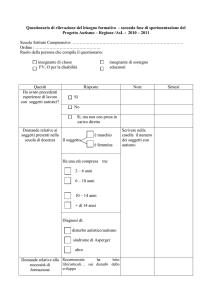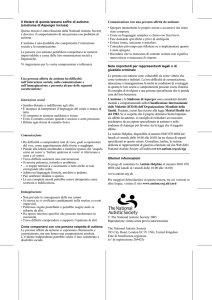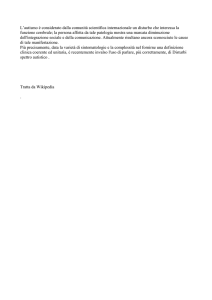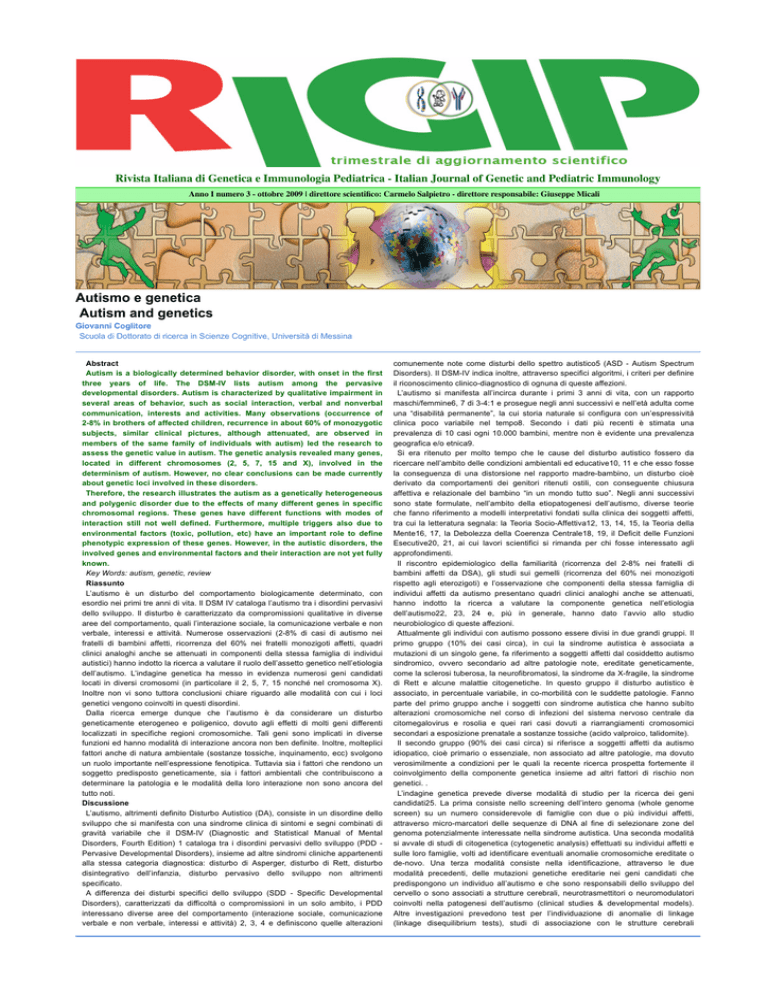
Rivista Italiana di Genetica e Immunologia Pediatrica - Italian Journal of Genetic and Pediatric Immunology
Anno I numero 3 - ottobre 2009 | direttore scientifico: Carmelo Salpietro - direttore responsabile: Giuseppe Micali
Autismo e genetica
Autism and genetics
Giovanni Coglitore
Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive, Università di Messina
Abstract
Autism is a biologically determined behavior disorder, with onset in the first
three years of life. The DSM-IV lists autism among the pervasive
developmental disorders. Autism is characterized by qualitative impairment in
several areas of behavior, such as social interaction, verbal and nonverbal
communication, interests and activities. Many observations (occurrence of
2-8% in brothers of affected children, recurrence in about 60% of monozygotic
subjects, similar clinical pictures, although attenuated, are observed in
members of the same family of individuals with autism) led the research to
assess the genetic value in autism. The genetic analysis revealed many genes,
located in different chromosomes (2, 5, 7, 15 and X), involved in the
determinism of autism. However, no clear conclusions can be made currently
about genetic loci involved in these disorders.
Therefore, the research illustrates the autism as a genetically heterogeneous
and polygenic disorder due to the effects of many different genes in specific
chromosomal regions. These genes have different functions with modes of
interaction still not well defined. Furthermore, multiple triggers also due to
environmental factors (toxic, pollution, etc) have an important role to define
phenotypic expression of these genes. However, in the autistic disorders, the
involved genes and environmental factors and their interaction are not yet fully
known.
Key Words: autism, genetic, review
Riassunto
L’autismo è un disturbo del comportamento biologicamente determinato, con
esordio nei primi tre anni di vita. Il DSM IV cataloga l’autismo tra i disordini pervasivi
dello sviluppo. Il disturbo è caratterizzato da compromissioni qualitative in diverse
aree del comportamento, quali l’interazione sociale, la comunicazione verbale e non
verbale, interessi e attività. Numerose osservazioni (2-8% di casi di autismo nei
fratelli di bambini affetti, ricorrenza del 60% nei fratelli monozigoti affetti, quadri
clinici analoghi anche se attenuati in componenti della stessa famiglia di individui
autistici) hanno indotto la ricerca a valutare il ruolo dell’assetto genetico nell’etiologia
dell’autismo. L’indagine genetica ha messo in evidenza numerosi geni candidati
locati in diversi cromosomi (in particolare il 2, 5, 7, 15 nonché nel cromosoma X).
Inoltre non vi sono tuttora conclusioni chiare riguardo alle modalità con cui i loci
genetici vengono coinvolti in questi disordini.
Dalla ricerca emerge dunque che l’autismo è da considerare un disturbo
geneticamente eterogeneo e poligenico, dovuto agli effetti di molti geni differenti
localizzati in specifiche regioni cromosomiche. Tali geni sono implicati in diverse
funzioni ed hanno modalità di interazione ancora non ben definite. Inoltre, molteplici
fattori anche di natura ambientale (sostanze tossiche, inquinamento, ecc) svolgono
un ruolo importante nell’espressione fenotipica. Tuttavia sia i fattori che rendono un
soggetto predisposto geneticamente, sia i fattori ambientali che contribuiscono a
determinare la patologia e le modalità della loro interazione non sono ancora del
tutto noti.
Discussione
L’autismo, altrimenti definito Disturbo Autistico (DA), consiste in un disordine dello
sviluppo che si manifesta con una sindrome clinica di sintomi e segni combinati di
gravità variabile che il DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth Edition) 1 cataloga tra i disordini pervasivi dello sviluppo (PDD Pervasive Developmental Disorders), insieme ad altre sindromi cliniche appartenenti
alla stessa categoria diagnostica: disturbo di Asperger, disturbo di Rett, disturbo
disintegrativo dell’infanzia, disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti
specificato.
A differenza dei disturbi specifici dello sviluppo (SDD - Specific Developmental
Disorders), caratterizzati da difficoltà o compromissioni in un solo ambito, i PDD
interessano diverse aree del comportamento (interazione sociale, comunicazione
verbale e non verbale, interessi e attività) 2, 3, 4 e definiscono quelle alterazioni
comunemente note come disturbi dello spettro autistico5 (ASD - Autism Spectrum
Disorders). Il DSM-IV indica inoltre, attraverso specifici algoritmi, i criteri per definire
il riconoscimento clinico-diagnostico di ognuna di queste affezioni.
L’autismo si manifesta all’incirca durante i primi 3 anni di vita, con un rapporto
maschi/femmine6, 7 di 3-4:1 e prosegue negli anni successivi e nell’età adulta come
una “disabilità permanente”, la cui storia naturale si configura con un’espressività
clinica poco variabile nel tempo8. Secondo i dati più recenti è stimata una
prevalenza di 10 casi ogni 10.000 bambini, mentre non è evidente una prevalenza
geografica e/o etnica9.
Si era ritenuto per molto tempo che le cause del disturbo autistico fossero da
ricercare nell’ambito delle condizioni ambientali ed educative10, 11 e che esso fosse
la conseguenza di una distorsione nel rapporto madre-bambino, un disturbo cioè
derivato da comportamenti dei genitori ritenuti ostili, con conseguente chiusura
affettiva e relazionale del bambino “in un mondo tutto suo”. Negli anni successivi
sono state formulate, nell’ambito della etiopatogenesi dell’autismo, diverse teorie
che fanno riferimento a modelli interpretativi fondati sulla clinica dei soggetti affetti,
tra cui la letteratura segnala: la Teoria Socio-Affettiva12, 13, 14, 15, la Teoria della
Mente16, 17, la Debolezza della Coerenza Centrale18, 19, il Deficit delle Funzioni
Esecutive20, 21, ai cui lavori scientifici si rimanda per chi fosse interessato agli
approfondimenti.
Il riscontro epidemiologico della familiarità (ricorrenza del 2-8% nei fratelli di
bambini affetti da DSA), gli studi sui gemelli (ricorrenza del 60% nei monozigoti
rispetto agli eterozigoti) e l’osservazione che componenti della stessa famiglia di
individui affetti da autismo presentano quadri clinici analoghi anche se attenuati,
hanno indotto la ricerca a valutare la componente genetica nell’etiologia
dell’autismo22, 23, 24 e, più in generale, hanno dato l’avvio allo studio
neurobiologico di queste affezioni.
Attualmente gli individui con autismo possono essere divisi in due grandi gruppi. Il
primo gruppo (10% dei casi circa), in cui la sindrome autistica è associata a
mutazioni di un singolo gene, fa riferimento a soggetti affetti dal cosiddetto autismo
sindromico, ovvero secondario ad altre patologie note, ereditate geneticamente,
come la sclerosi tuberosa, la neurofibromatosi, la sindrome da X-fragile, la sindrome
di Rett e alcune malattie citogenetiche. In questo gruppo il disturbo autistico è
associato, in percentuale variabile, in co-morbilità con le suddette patologie. Fanno
parte del primo gruppo anche i soggetti con sindrome autistica che hanno subìto
alterazioni cromosomiche nel corso di infezioni del sistema nervoso centrale da
citomegalovirus e rosolia e quei rari casi dovuti a riarrangiamenti cromosomici
secondari a esposizione prenatale a sostanze tossiche (acido valproico, talidomite).
Il secondo gruppo (90% dei casi circa) si riferisce a soggetti affetti da autismo
idiopatico, cioè primario o essenziale, non associato ad altre patologie, ma dovuto
verosimilmente a condizioni per le quali la recente ricerca prospetta fortemente il
coinvolgimento della componente genetica insieme ad altri fattori di rischio non
genetici. .
L’indagine genetica prevede diverse modalità di studio per la ricerca dei geni
candidati25. La prima consiste nello screening dell’intero genoma (whole genome
screen) su un numero considerevole di famiglie con due o più individui affetti,
attraverso micro-marcatori delle sequenze di DNA al fine di selezionare zone del
genoma potenzialmente interessate nella sindrome autistica. Una seconda modalità
si avvale di studi di citogenetica (cytogenetic analysis) effettuati su individui affetti e
sulle loro famiglie, volti ad identificare eventuali anomalie cromosomiche ereditate o
de-novo. Una terza modalità consiste nella identificazione, attraverso le due
modalità precedenti, delle mutazioni genetiche ereditarie nei geni candidati che
predispongono un individuo all’autismo e che sono responsabili dello sviluppo del
cervello o sono associati a strutture cerebrali, neurotrasmettitori o neuromodulatori
coinvolti nella patogenesi dell’autismo (clinical studies & developmental models).
Altre investigazioni prevedono test per l’individuazione di anomalie di linkage
(linkage disequilibrium tests), studi di associazione con le strutture cerebrali
(association studies) e studi su modelli animali (animal studies).
Fino ad oggi non è stato identificato un singolo gene capace di scatenare la
patologia né è stato messo in evidenza un unico pattern di geni la cui interazione
causa sindrome autistica in tutti i soggetti studiati. Quel che è certo allo stato attuale
è che un numero considerevole di geni sono candidati come responsabili
(co-responsabili) del manifestarsi del disturbo.
I risultati dell’indagine genetica hanno messo in evidenza numerosi geni locati su
diversi cromosomi (Tab I).
Tab. I - Principali geni candidati e locus cromosomico di appartenenza
Il locus 7q22-q33 è risultato essere un sito chiave nella predisposizione
all’autismo26, 27. In tale regione è stato identificato il gene RELN (protein reelin) che
agisce durante la migrazione cellulare nelle le fasi di sviluppo. Alterazioni del gene
RELN interessano lo sviluppo corticale e cerebellare, aree cerebrali trovate ridotte a
livello volumetrico in numerosi casi di autismo28, 29. Altre mutazioni riscontrate nel
cromosoma 7 riguardano i geni NPTX2, FOXP2, IMMPL2 e RAY1/ST7. Il gene
NPTX2, locato sul 7q22.1, è fortemente implicato nella connettività sinaptica, che
risulta anomala nei pazienti con autismo. Il FOXP230, gene regolatore locato sul
7q31, è stato identificato in una famiglia inglese nota come KE family i cui membri
presentavano gravi anomalie articolatorie del linguaggio non associate ad autismo.
In quanto l’area comunicativa è un segno clinico e diagnostico chiave nella patologia
autistica, alcuni ricercatori hanno avanzato l’idea che il gene FOXP2 e la cascata di
geni da esso regolata, possano essere implicati nella sindrome autistica. In questa
direzione sono stati compiuti diversi studi da parte di ricercatori31 che hanno
identificato un gene regolato dal FOXP2, il CNTNAP2 la cui mutazione sembra
essere correlata ad alcuni casi di disturbi specifici del linguaggio (SLI - Specific
Language Impairment) e alla sindrome autistica. Il CNTNAP2 regola la proteina
neuroxina, presente sulla superficie dei neuroni con la funzione di collegamento tra
le varie cellule ed il loro cablaggio durante le fasi di sviluppo embrionale e
largamente espressa nella corteccia cerebrale, particolarmente a livello dei lobi
frontali. Altri geni identificati nella regione 7q31-q33 sono IMMP2L, identificato come
un locus cromosomico implicato nella sindrome di Tourette e nella sindrome
autistica32 e RAY1/ST7 locus trovato interrotto da una traslocazione in alcuni
individui con autismo25.
Nella regione 15q11-q13 sono stati identificati i geni per i recettori GABRB3,
GABRA5 e GABRG3, sub-unità recettoriali del gene GABAA33, responsabili
dell’inibizione neurale al livello sinaptico e il gene UBE3A34. Tra questi, mutazioni a
carico del gene GABRB3 risultano essere correlate ad epilessia e anomalie
elettroencefalografiche, mentre il gene UBE3A, la cui espressione risulta essere
predominante per il cervello umano, sembrerebbe giocare un ruolo importante nella
Sindrome di Angelman (patologia dovuta ad un difetto nella duplicazione
cromosomica ad imprinting genetico), la cui sintomatologia è rappresentata da
ritardo mentale, difficoltà di linguaggio e anomalie facciali. Recenti ricerche
confermano che le anomalie genetiche delle regioni 15q11-q13 sono responsabili
all’incirca nell’1% dei casi di disturbi delle spettro autistico 35.
Altro locus di suscettibilità riguarda il cromosoma 2, dove sono stati individuati e
studiati diversi geni quali DLX1, DLX2, HOXD1, NR4A2, UPP2. Tra questi,
particolare attenzione meritano NR4A2 e UPP2. Il primo codifica per una proteina
coinvolta nel differenziamento di neuroni che producono dopamina,
neurotrasmettitore che interviene negli stati emozionali e nel controllo del
movimento. Mutazioni a carico di questo gene sono state associate a patologie, che
comportano disfunzioni del sistema dopaminergico, come la schizofrenia e la
sindrome maniaco-depressiva36. Il gene UPP2 codifica per la proteina uridina
fosforilasi 2, enzima che interviene nella biosintesi dei nucleotidi37. Tale enzima è
coinvolto nella regolazione del sonno e viene usato nei trattamenti delle crisi
epilettiche ed è ampiamente noto che numerosi casi di autismo sono associati a
disturbi del sonno e a fenomeni epilettici. In alcuni casi di autismo associato ad
epilessia, alcune evidenze dimostrano che la somministrazione di uridina comporta
riduzione delle crisi epilettiche e miglioramenti nella capacità linguistica38.
Ricercatori tedeschi39 nel 2006 hanno identificato in due famiglie con autismo una
mutazione genica sul cromosoma X che codifica per la proteina ribosomiale L10
(RPL10), necessaria per la traduzione dell’informazione genetica e la cui
espressione è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema limbico
implicato nelle funzioni cognitive dell’apprendimento, della memoria e delle funzioni
sociali.
Un passo importante nello studio della componente genetica dell’autismo è stato
compiuto di recente da diversi gruppi di ricerca che puntavano sull’identificazione dei
geni responsabili delle anomalie della connettività cerebrale. Attraverso la tecnica
dell’analisi degli SNP (Single Nucleotide Polymorfism), alcuni ricercatori40,
nell’ambito del Autism Genome Project Consortium, hanno scoperto una regione
cromosomica di un gene candidato, la 11p12-p13 che codifica per la
-neuressina
che con neurolignina forma una coppia di molecole responsabili della formazione
delle giunzioni sinaptiche, fondamentali per la trasmissione dei segnali chimici tra le
cellule nervose. Un’alterazione del gene codificante per tali proteine può avere
ripercussioni a livello della connettività sinaptica che risulterebbe anomala nei
soggetti autistici. Studi più recenti41, 42, pubblicati sulle riviste scientifiche Nature e
Annals of Human Genetics, hanno messo in evidenza che le mutazioni di due geni
potrebbero essere responsabili del 15% di tutti i casi della patologia. I geni mutati
sono stati trovati sul cromosoma 5 e codificano per le proteine caderina 9 (CDH9) e
caderina 10 (CDH10), indispensabili per l’adesione cellulare. Nei diversi studi sono
stati confrontati gli interi genomi di individui sani con individui affetti da autismo. Ciò
ha reso possibile isolare le mutazioni genetiche legate alla malattia. Studi di
neuroimaging hanno evidenziato come nel cervello dei soggetti autistici ci sia una
carenza dei cosidetti “ponti” tra neuroni, con conseguente rallentamento/interruzione
della trasmissione del segnale. I geni CDH9, CDH10 e altri geni sarebbero quindi
responsabili di alcune anomalie strutturali del cervello autistico che sarebbe quindi
“disconnesso” dall’interno.
La ricerca inoltre si è concentrata sullo studio dei neurotrasmettitori coinvolti nella
patogenesi del disturbo autistico. Nei soggetti autistici sono stati descritti numerose
alterazioni della concentrazione di neurotrasmettitori, che includono serotonina,
dopamina, norepinefrina, glutammato/NMDA, GABA e oppioidi. Tutti questi
neurotrasmettitori sono ben rappresentati nell'amigdala, struttura cerebrale
importante per gli aspetti dell'interazione sociale. Durante le fasi embrionali i
neurotrasmettitori agiscono come segnali di regolazione dello sviluppo e della
plasticità del sistema nervoso centrale. Studi condotti nel 1999 hanno dimostrato,
mediante l’utilizzo della PET, che nei bambini sani durante l'infanzia la capacità di
sintesi di serotonina a livello del sistema nervoso centrale è particolarmente elevata
e che questo processo è fortemente alterato nei bambini autistici43. Questi risultati
suggeriscono che il gene per il trasportatore della serotonina possa essere
considerato un buon candidato per l'autismo.
Va sottolineato che non tutti i dati della letteratura sono concordanti, sebbene i
risultati di più gruppi di ricerca puntino su quelle stesse regioni cromosomiche. Tali
discordanze sono dovute sia alla complessa definizione del fenotipo autistico che
alla moltitudine dei geni che per un motivo o per un altro possono essere considerati
implicati nel determinare la patologia.
Sulla base dei dati della ricerca emerge dunque che non esiste “il gene
dell’Autismo”, ovvero un singolo gene responsabile della etiologia di questa
affezione. Esistono invece molteplici geni implicati nel determinismo del disturbo
autistico, di diversa natura e funzioni, ognuno dei quali è responsabile di singoli e
specifici effetti fenotipici, con modalità di interazione ancora non ben definite. Inoltre
non vi sono tuttora conclusioni chiare riguardo alle modalità con cui i loci genetici
vengono coinvolti in questi disordini.
Tuttavia la sola alterazione di uno o più geni non può essere considerata la causa
diretta della patologia, in quanto avrebbe comportato il manifestarsi del disturbo
autistico in tutti i gemelli monozigoti nei quali invece la ricorrenza è soltanto del 60%
circa. Per il manifestarsi della sindrome autistica occorre dunque considerare anche
altre condizioni che svolgono il ruolo di fattori scatenanti, mentre le alterazioni
geniche assumono il significato di condizione predisponente che conferisce
vulnerabilità per il manifestarsi del disturbo.
Alcune ricerche identificano i fattori scatenanti nelle condizioni ambientali
inquinanti. In particolare vengono chiamate in causa alcune sostanze tossiche, come
i metalli pesanti (mercurio e piombo), molecole ad attività teratogena (talidomite e
l’acido
valproico),
i
pesticidi
che
agiscono
attraverso
l’inibizione
dell’acetilcolinesterasi che interviene nel metabolismo del neurotrasmettitore
acetilcolina, e altre sostanze ambientali inquinanti non meglio identificate. L’ipotesi,
su cui la ricerca sta tuttora indagando, è che l’esposizione a sostanze tossiche (a
livelli normalmente innocui per gli individui non geneticamente predisposti) possano
provocare, durante l’embriogenesi e nel corso della vita fetale e neonatale dei
soggetti con predisposizione genetica, alterazioni più o meno gravi dell’assetto
neurobiologico con esiti corrispondenti a livello clinico che si manifestano, entro i 3
anni di vita, con la sindrome autistica.
Allo stato attuale non sono ancora definiti i complessi meccanismi dell’interazione
gene-ambiente, che possono realizzarsi sia attraverso un’azione “diretta” del fattore
tossico sul genotipo, sia “indirettamente” incidendo sull’assetto neurobiologico
geneticamente predisposto e dunque vulnerabile.
L’incremento della prevalenza del disturbo autistico nella popolazione generale,
registrato nell’ultimo decennio, non sarebbe soltanto dovuto ad una migliore
definizione e accuratezza dei processi diagnostici e all’aumento del numero dei
Centri per l’Autismo istituiti sul territorio, ma vi sono evidenze che si sia verificata
una crescita reale in rapporto alle possibili cause di natura ambientale, pure in
aumento che, interagendo con il genoma, sono all’origine di questa affezione.
In conclusione, diversi dati di letteratura ipotizzano che l’autismo sia da considerare
un disturbo del comportamento geneticamente eterogeneo e poligenico, dovuto agli
effetti di molti geni differenti locati in specifiche regioni cromosomiche, di diversa
natura e funzioni, con modalità di interazione ancora non ben definite, le cui
alterazioni condizionano il terreno predisponente su cui incidono fattori scatenanti di
inquinamento ambientale, con produzione di sintomi e segni combinati di gravità
variabile fino alla piena espressività clinica del disturbo autistico. Tuttavia, sia i fattori
che rendono un soggetto predisposto geneticamente e quindi vulnerabile, sia i fattori
ambientali che contribuiscono a determinare la patologia nonchè le modalità della
loro interazione non sono ancora del tutto noti.
BIBLIOGRAFIA
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders: DSM-IV (fourth edition, text revision). (2002) Washington DC: American
Psychiatric Association.
2. Baird G. et al (2003) : Diagnosis of autism. BMJ;327:488-93.
3. Berney TP (2000) : Autism - an evolving concept. Br J Psychiatry;176:20-25.
4. Szatmari P (2003) : The causes of autism spectrum disorders. BMJ;326:173-4.
5. Wing L (2007) : The autistic spectrum. Lancet;350:1761-1766.
6. Fombonne E et al (2003) The prevalence of autism: JAMA;289:87-9.
7. Yeargin-Allsopp M, Rice C, Karapurkar T, Doernberg N, Boyle C, Murphy C
(2003) : Prevalence of autism in a US metropolitan area. JAMA;289:49-55.
8. Wing L: The continuum of autistic characteristics. In Schopler E, Mesibov G
(1988) Eds. Diagnosis and assessment in autism. New York: Plenum Press.
9. Volkmar FR et al (2004) : Autism and pervasive developmental disorders J Child
Psycology
Psychiatry; 45:135-170.
10. Piaget J (1975) : La costruzione del reale nel bambino. Ed. la Nuova Italia.
11. Wing L (1974) : I bambini autistici. Armando Editore Roma.
12. Hobson RP (1993) : Autism and the development of mind. Hove, Sussex:
Erlbaum.
13. Dawson G, Meltzoff AN, Osterling J, Rinaldi J (1998) : Neuropsychological
correlates of early symptoms of autism. Child Dev 69:1276-85.
14. Dawson G, Meltzoff AN, Osterling J, Rinaldi J, Brown E (1998) : Children with
autism fail to orient to naturally occurring social stimuli. J Autism. Dev Disord 28:
479-485.
15. Trevarthen C, Aitken KJ (2001) : Infant intersubjectivity: research, theory and
clinical applications. J Child Psychol Psychiatry 42: 3-48.
16. Baron-Cohen S et al. (2000) : Understanding other mind. Perspectives from
developmental neuroscience (2nd edn, pp. 357-388).Oxford: OxfordUniversity Press.
17. Baron-Cohen S, Ring HA, Bullmore ET, Wheelwright S, Ashwin C, Williams SC
(2000a) : The amygdala theory of autism. Neurosc Biobehav Reviews 24: 355–364.
18. Happé F, Frith U (1996) : The neuropsychology of autism. Brain 119:
1377-1400.
19. Happé F (1999) : Autism: cognitive deficit or cognitive style? Trends in
Cognitive Sciences 3: 216-222.
20. Pennington BF, Ozonoff S (1996) : Executive functions and developmental
psychopathology. J Child Psychol Psychiatry 37: 51-87.
21. Ozonoff S (1997) : Components of executive function deficits in autism and
other disorders. In J. Russel (Ed.), Autism as an executive disorder (pp. 179–211).
Oxford: Oxford University Press.
22. Korvatska E, Van de Water J, Anders TF, Gershwin ME (2002) : Genetic and
Immunologic
considerations in autism. Neurobiology of Disease; 9:107-125.
23. Bailey A et al (1996) : Autism: towards an integration of clinical, genetic,
neuropsycological and
neurobiological perspectives. J Child Psychol Psychiatry, 37:89-126.
24. Folstein SE, Rosen-Sheidley B (2001) : Genetics of autism: complex aetiology
for a
heterogeneous disorder. Nat Rev Genet 2: 943:55.
25. Muhle R, Trentacoste SV, Rapin I (2004) : The Genetics of Autism.
Pediatrics;Vol.113 No 5.
26. Ashley-Koch A, Wolpert CM, Menold MM, et al (1999) : Genetic studies of
autistic disorder
and chromosome 7. Genomics.
27. Scherer SW et al (2003) : Human chromosome 7 DNA sequence and biology.
Science.
28. Kemper TL, Bauman ML (2002) : Neuropathology of infantile autism Mol
Psychiatry.
29. Persico AM et al (2001) : Reelin gene alleles and haplotypes as a factor
predisposing to autistic
Disorder. Mol Psychiatry.
30. Lai, C.S.L., Fischer et al (2001) : A forkhead –domain gene is mutated in a
severe speech and
language disorder; “ Nature”, 413:519-523
31. Arking DE et al (2008) : A Common Genetic Variant in the Neurexin Superfamily
Member
CNTNAP2 Increases Familial Risk of Autism, The American Journal of Human
Genetics,
32. Petek E. et al (2001) : Disruption of a novel gene (IMMP2L) by a breakpoint in
7q31 associated
with Tourette syndrome. Human Genet.
33. Owrens DF, Kriegstein AR (2002) : Is there more to GABA than synaptic
inhibition? Nat Rev
Neuroscience;3:715-727.
34. Matsuura T et al (1997) : De novo truncating mutations in E6-AP ubiquitinprotein ligase gene
(UBE3A) in Angelman Syndrome. Nat. Genet.
35. Christel Depienne, Daniel Moreno-De-Luca, Delphine Heron, Delphine
Bouteiller et al (2009) :
Screening for Genomic Rearrangements and Methylation Abnormalities of the
15q11-q13
region in Autism Spectrum Disorders. Biol Psychiatry 69:349-359
36. Hering R, Petrovic S, Mietz EM, Holzmann C, Berg D, Bauer P, Woitalla D,
Muller T, Berger K, Kruger R, Riess O: (2004) : Extended mutation analysis and
association studies of Nurr1 (NR4A2) in Parkinson disease. Neurology 13; 62 (7)
:1231-2
37. Leer JC, Hammer-Jesperser K, Schwartz M (1977) : Uridine phosphorylase
from Escherichia coli. Phisical and chemical characterization. Eur J Biochem 2;75 (1)
: 217-24
38. Cao D, Leffert JJ, McCabe J, Kim B, Pizzorno G (2005) : Abnormalities in
uridine homeostatic regulation and pyrimidine nucleotide. metabolism as
consequence of the deletion of the uridine phosphorylase gene. J Biol Chem; 280
(22) :21 169-75
39. Klauck SM, Felder B, Kolb-Kokocinski A, Schuster C, Chiocchetti A, Schupp I,
Wellenreuther
R, Schmötzer G, Poustka F, Breitenbach-Koller L, Poustka A. (2006). Mutations in
the
ribosomal protein gene RPL10 suggest a novel modulating disease mechanism for
autism. Mol
Psychiatry. Dec;11 (12) :1073-84.
40. Szatmari P, Paterson AD, Zwaigenbaum L (2007) : Mapping autism risk loci
using genetic
linkage and chromosomal rearrangements. Nature Genetics;39, 319-328.
41. Wang K et al (2009) : Common genetic variants on 5p14.1 associate with
autism spectrum
disorders. Nature. Vol 459, 528-533
42. Jonathan et al (2009) : A Genome –Wide Association Study of Autism Reveals
a Common
Novel Risk Locus at 5p14.1. Annals of Human Genetics
43. Chugani DC, Muzik O, Behen M, et al (1999) : Developmental changes in brain
serotonin
synthesis capacity in autistic and nonautistic children. Ann Neurol;45:287-295.
Trimestrale di divulgazione scientifica dell'Associazione Pediatrica di Immunologia e Genetica
Legge 7 marzo 2001, n. 62 - Registro della Stampa Tribunale di Messina n. 3/09 - 11 maggio 2009
Direttore scientifico Carmelo Salpietro - Direttore responsabile Giuseppe Micali - Segreteria redazione Basilia Piraino - Piera Vicchio
Direzione-Redazione: UOC Genetica e Immunologia Pediatrica - AOU Policlicnico Messina
www.geneticapediatrica.it/rigip