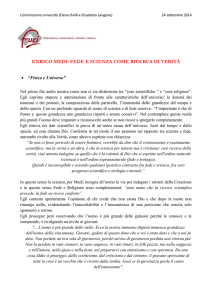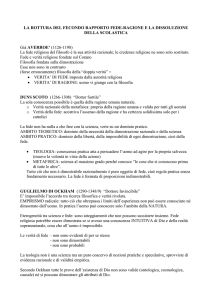caricato da
common.user16202
Filosofia Greca: Immortalità, Verità e Tecnica Moderna

«illusione dell’immortalità»: un tema su cui la filosofìa ha una sorta di prelazione. La religione lo affronta con la fede; la scienza con una logica ipotetico-probabilistica: esse si muovono in un ambito diverso e lontano da quello dove si fa innanzi l’avventura più grande dell’uomo, quella dove il popolo greco, entrando nella filosofìa, pensa il senso più radicale della «verità» - la verità, intesa come l'assolutamente e il definitivamente non smentibile. Il discorso sulla morte ha dunque timbri e toni del tutto diversi se a pronunciarlo non è la fede o la scienza, ma la filosofia. Esso coinvolge la «teologia», intesa nel suo significato originario, cioè greco, dove l’andare del lògos verso il dio, theós, cioè l’andarvi con verità, significa per il viandante andare verso la propria vera salvezza. La verità, per i Greci, non è un’erudizione (polymathia, dice Eraclito) intorno a questioni sapienziali, filosofiche e teologiche. La verità appartiene alla volontà di salvezza - alla volontà che si sprigiona dopo che tutta la poesia e parte della religione dei Greci hanno affermato il carattere effìmero dell’uomo. L’uomo greco vuole la verità perché vuole salvarsi con verità dalla morte, emissaria di tutti i dolori. Si rende conto che per questa salvezza il mito non basta più: non può bastare né la vita eterna di Dioniso, né, quando verrà alla luce, quella di Cristo. La salvezza dalla morte deve essere ormai vera salvezza, dove il pensiero vero afferma l’esistenza del vero dio, cioè dell'Essere che è sempre salvo dalla morte. È nella verità che il dio vero deve anticipare in sé e in sé conservare, proteggendolo, tutto ciò che all’uomo sta a cuore di se stesso e del proprio mondo e che tuttavia sorge a un certo punto del tempo e poco dopo svanisce. Nel Librò I della Metafisica Aristotele dice appunto che i primi pensatori affermarono un «Essere che è sempre salvo». Dal contesto appare che tale «Essere» (physis) è sempre salvo dal non essere, dal nulla. La filosofia evoca l’estremo rimedio della verità perché innanzitutto evoca il pericolo estremo del nulla. Come per prima pensa il senso assoluto della verità, così per prima pensa il senso assoluto del nulla, e che dunque la morte è andare nell’assolutamente nulla. Il senso assoluto del nulla e la morte come assoluto annientamento sono ignoti prima dei Greci. La morte non è pertanto vissuta come annientamento (e nemmeno è pensato il dio vero della verità greca). Prima dei Greci il senso della morte non è legato al nulla proprio perché prima dei Greci è assente il senso radicale dell’opposizione dell’essere e del nulla. Quando nel primo versetto del Genesi si vuole scorgere la creazione del mondo dal nulla, si opera una violenza su un testo a cui è ancora estranea quella comprensione ontologica delle cose che si fa innanzi solo con la filosofia greca (supponendo che, prima dei Greci, si possa parlare di una «filosofia»). Il pensiero dell’opposizione infinita tra l'essere e il nulla viene alla luce, nel popolo greco, insieme al pensiero che ci si possa salvare dall’annientamento, in cui la morte consiste, solo con la vera salvezza - quella che appare e si produce con l’apparire della verità. Nella verità si mostra il vero Essere che è sempre salvo dal nulla e in cui l’uomo trova la salvezza di ciò che più gli sta a cuore. Ma a un certo momento questa grandiosa intuizione del mondo e dell’uomo crolla. Si mostra incapace di mantenere le proprie promesse. Essa domina l’intera tradizione dell’Occidente. Ne domina non solo i pensieri, ma anche le opere. La sentenza di Karl Marx che sinora la filosofia ha contemplato il mondo e che ora si tratta di trasformarlo va rovesciata: dicendo che sinora la filosofia - sia quella della tradizione, sia quella del nostro tempo, che porta la tradizione al tramonto - ha trasformato il mondo, ma che rimane ancora da comprenderlo. Nella tradizione dell’Occidente la filosofia ha trasformato il mondo perché i pensieri e le opere sono cresciuti all’interno del senso che i Greci hanno assegnato alla verità; nel nostro tempo la filosofia continua a trasformare il mondo perché ha preparato il terreno in cui la tecnica può procedere senza più alcun limite alla dominazione delle cose. La filosofia non è un epifenomeno o una sovrastruttura dell’economia, della storia, della società, dell’inconscio, del cervello, della materia e del corpo, del linguaggio. Ma intanto va rilevato che se la tradizione filosofica è destinata al tramonto, esso non riguarda l’evocazione dell’opposizione infinita dell’essere e del nulla e pertanto non riguarda l’evocazione del divenire del mondo - l’evocazionè dove il divenire è inteso come oscillazione degli enti tra l’essere e il nulla. Il tramonto riguarda la verità e il dio vero che vogliono tenersi fermi al di sopra del divenire che tutto travolge. Ed è proprio sul fondamento della fede nel senso greco del divenire che il pensiero filosofico del nostro tempo vede l’impossibilità che un immutabile (del pensiero o dell’essere) sovrasti il divenire senza rimanerne travolto. Tuttavia è al di sotto della propria superfìcie che il pensiero filosofico del nostro tempo vede quella impossibilità; è nel proprio sottosuolo che esso riesce a scorgere, nel tramonto degli immutabili, un processo inevitabile. Alla propria superfìcie - cioè nella coscienza che tale pensiero ha per lo più di se stesso - appare spesso come una semplice volontà scettica, di cui è dubbia la capacità di resistere alle forme concettuali della tradizione. Scendendo nel suo sottosuolo essenziale, si tratterebbe invece di comprendere che ogni immutabile e ogni eterno - ogni verità assoluta e ogni vero dio - rendono impossibile proprio quel divenire dalla cui minaccia essi intendono salvare - e che per l’intera civiltà dell’Occidente è l’evidenza assolutamente indiscutibile a partire dalla quale si sviluppano ogni sapere e ogni opera - e dunque anche il sapere e l’operare meta-fisico che, appunto, intende salvare l’uomo andando «al di là» (meta) del divenire (physis) per incontrare l’«Essere che è sempre salvo» dal nulla (e che dunque è physis in un senso più originario della physis intesa come divenire). Per uscire dal vuoto del nulla e per ritornarvi, le cose divenienti del mondo, infatti, non possono venire a trovarsi in uno spazio già tutto pieno perché riempito dalla sostanza immutabile della verità e del divino. L’immutabilità della verità e del divino è infatti la legge di tutto: non solo delle cose esistenti, cioè del «pieno», ma anche di quelle inesistenti, che costituiscono il «vuoto» del futuro e del passato, cioè il nulla del non-ancora e del non-più. In questo modo la legge di tutto riempie ógni spazio vuoto. Ma il vuoto del nulla è indispensabile al divenire, cioè all’evidenza suprema della creatività, che è soprattutto creatività umana; dunque non può esserci alcun immutabile che con la sua presenza abbia, contro le proprie intenzioni, riempito tale vuoto. «Che cosa mai resterebbe da creare se gli dèi esistessero?!» -dice Zarathustra - «Dunque non vi sono dèi», non vi è -sono ancora parole di Zarathustra - alcun «Pieno», «Immoto», «Imperituro». L’uomo è evidentemente creatore; dunque richiede quel vuoto, reso impossibile dal Pieno assoluto, senza di cui la creazione umana sarebbe impossibile. Solo sul fondamento del sottosuolo essenziale del pensiero del nostro tempo - un sottosuolo in cui gli stessi pensatori di questo tempo sono quasi sempre incapaci di scendere - è possibile l’«onnipotenza della tecnica». Se nel pensiero e nell’essere non esiste alcun immutabile - e poiché sul fondamento della fede nel senso greco-occidentale del divenire non può esistere alcun immutabile -allora l’agire dell’uomo non può avere alcun limite assoluto. Come legge di tutto ciò che esiste, la verità e il vero dio immutabili sono infatti il limite oltre il quale nessun agire può spingersi; e poiché il sottosuolo essenziale del pensiero filosofico del nostro tempo vede che l’esistenza di quella legge è impossibile, appare che l’agire dell’uomo, e dunque e innanzitutto quella forma suprema dell’agire che è la tecnica guidata dalla scienza moderna, non possono essere arginati da alcun limite assoluto e incontrovertibile. Ogni limite (o legge) esistente è soltanto fattuale, storico, provvisorio, contingente. In tal modo, la potenza della tecnica si estende in li-nea di principio su tutto; è «onnipotenza»; può e deve estendere all’infinito il suo dominio sulle cose, cioè la sua capacità di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi - la sua capacità di allontanare la morte. La filosofia del nostro tempo sancisce e benedice questa dominazione onnipotente; ne è il fondamento e la legittimazione. Queste considerazioni - che richiamano per cenni quanto nei miei scritti è stato analiticamente sviluppato - consentono di rilevare l’inadeguatezza della concezione tecnico-scientifica della tecnica. La tecnica destinata alla dominazione onnipotente è infatti l'unificazione dell’apparato scientifico-tecnologico e dell’essenza del pensiero filosofico del nostro tempo. Ridotta all’immagine che essa ha oggi di se stessa ridotta cioè a quella filosofìa inadeguata in cui tale immagine consiste (e che è una delle tante forme della superficie della filosofìa contemporanea) -la tecnica non è in grado di sottrarsi alla volontà della tradizione dell’Occidente di servirsi di essa come di un semplice mezzo per la realizzazione dei valori immutabili che tale tradizione persegue. Ma è inadeguata anche ogni critica che in molti campi della cultura contemporanea viene rivolta alla tecnica. Ossia tale critica può essere adeguata - cioè vincente - rispetto alla inadeguata concezione tecnicoscientifica della tecnica, ma non rispetto alla dimensione dove la tecnica va ascoltando sempre più la voce del sottosuolo essenziale del pensiero filosofico del nostro tempo. Sul fondamento della fede nel senso greco del divenire, la tecnica, nel suo significato concreto e autentico, determinato da quell’ascolto, è destinata al dominio e all’«onnipotenza» che non si lascia ridurre a mezzo, ma all’opposto riduce le voci del passato a mezzo per l’incremento indefinito della sua capacità di realizzare scopi. Nella storia dell'Occidente, la «morte di Dio» implica la morte (dell’immortalità) dell’anima. Proprio perché non può esistere alcun imperituro al di sopra del divenire, non può esistere nemmeno quell’imperituro in cui dovrebbe consistere la vita spirituale dell’anima. L’immortalità è illusione. È illusione che un ente possegga di per se stesso il carattere dell’immortalità. E questo è certamente il risultato a cui è inevitabile che pervenga la fede nel senso greco del divenire. D’altra parte la tecnica, liberata da ogni limite - e così liberata in quanto fondata sul sottosuolo essenziale del pensiero filosofico del nostro tempo -, si propone già di prolungare il più possibile la vita dell’uomo. Questo significa che la tecnica, liberata da ogni limite assoluto, si propone di prolungare il più possibile quel divenire che anch’essa - come ogni altra forma della civiltà dell’Occidente, e innanzitutto come quella forma in cui consiste il pensiero filosofico del nostro tempo - concepisce, sia pure in modo implicito, secondo le categorie ontologiche del pensiero greco. Quest’ultimo rilievo - peraltro già preparato da quanto si è detto in precedenza - consente di rivolgere l’attenzione al tratto decisivo del nostro discorso. Lo si può esprimere dicendo che sia la tesi per la quale tutto l’uomo è mortale - tutto: corpo e anima, materia e mente -sia la tesi che sostiene la sua immortalità, o almeno l’immortalità dell’anima umana, benché apparentemente inconciliabili abitano la stessa casa, crescono sullo stesso terreno, hanno la stessa essenza e lo stesso fondamento. E ciò accade perché sia l’affermazione di un qualche Essere immutabile e divino, sia la negazione di tale Essere - sia ogni forma di teismo, sia ogni forma di ateismo - abitano la stessa casa, crescono sullo stesso terreno, hanno la stessa essenza e lo stesso fondamento. Casa, terreno, essenza e fondamento comuni che sono appunto il senso che il pensiero greco ha conferito una volta per tutte al divenire del mondo. È dominata da questo senso sia la convinzione che il mondo diveniente è prodotto da un dio immutabile, sia la convinzione che non ci sia bisogno di alcun dio perché il mondo esca dal nulla e si sviluppi; sia la convinzione che nel divenire della vita umana esista una dimensione immateriale e imperitura, sia la convinzione che anche tutto ciò che è mentale venga travolto o gettato nel nulla con l’annientamento del corpo umano. La persuasione che è comune a quelle contrapposte convinzioni è che l’essere in cui l’uomo si trova e che egli originariamente esperisce è uno sporgere provvisoriamente dal nulla. A tale comune convinzione appartiene anche la concezione cristiana che pur non si limita ad affermare l’immortalità dell’anima, ma proclama la resurrezione dei corpi. Il cristianesimo pensa infatti che alla fine dei tempi la terra e il cielo saranno «nuovi», usciti dal nulla, e che i «vecchi» saranno andati definitivamente nel nulla come nel nulla se ne sarà andato il nostro corpo attuale, cioè il «seme» (dice l’apostolo Paolo) che deve annientarsi affinché possa germogliare la pianta del nuovo corpo glorioso. La persuasione comune che l’essere del mondo proviene dal nulla e vi ritorna è la fede che sta all’origine dell’intera civiltà occidentale e che intende se stessa come evidenza assolutamente incontrovertibile. Sul fondamento di questa fede, la «morte di Dio» che è insieme la morte dell’immortalità dell’anima, è inevitabile. Sulle spalle di questa fede grava l’intera storia dell’Occidente e ormai dell’intero Pianeta. Certo, essa intende se stessa come l’evidenza suprema e insuperabile con cui l’uomo può porsi in rapporto. Ma questo suo convincimento di essere l’evidenza suprema non è forse, daccapo, la sua fede di esserlo? D’altra parte, sembra un imperdonabile azzardo porre come fede l’affermazione che le cose del mondo vanno dal non essere all’essere e viceversa; dal nulla all’essere e viceversa. Questa affermazione non è forse per davvero l’evidenza suprema? La volontà della scienza e della tecnica di prolungare il più possibile il divenire della vita umana prende significato e si fonda sull’ontologia, cioè sulla filosofìa dell'Occidente. Anche per la scienza e la tecnica, come per l’Apocalisse cristiana, il prolungamento della vita cresce sull’annientamento della vita «vecchia» dell’uomo. L’annientamento è la condizione del prolungamento dell’esistenza. Ma raramente la scienza riflette sul proprio fondamento ontologico-filosofico. Tuttavia è proprio questo fondamento a escludere che nell’uomo sia presente qualcosa di originariamente imperituro e a rendere necessario che ogni prolungamento dall’esistenza sia il contenuto di un progetto, cioè il risultato dell’agire guidato dal sapere scientifico. Alla riflessione sul proprio fondamento ontologico-fìlosofico scienza e tecnica preferiscono altre strade: quelle dove la mortalità dell’uomo è affermata in base al principio della dipendenza della vita mentale dalle sue condizioni cerebrali, neurofìsiologiche, biologiche. Ma a questo punto la scienza deve decidere se tale «dipendenza» e tali «condizioni» siano o no, riconducibili al concetto tradizionale di «causa» - cioè a un concetto che appartiene a quella dimensione della «verità», che la filosofìa greca ha dapprima evocato e la cui morte (provocata dalla filosofia del nostro tempo) sta al fondamento della morte di ogni dio. Se è in questo senso che, per la scienza, il cervello è la «causa» della mente, allora la tesi che la mente o l’anima muore perché il cervello e il corpo dell’uomo sono mortali non riesce a stare in piedi: frana con la frana del senso tradizionale della verità. Il tramonto di questo senso è il tramonto di ogni nesso necessario tra le cose, e dunque nessun «parallelismo psicofìsico» può essere una connessione causale necessaria. E se non può esserlo, allora la «dipendenza» della mente dal corpo è una semplice concomitanza fattuale di fenomeni diversi; una concomitanza che dunque lascia aperta la porta alla possibilità che la dimensione mentale dell’uomo sia indi-pendente da quella somatica. Lungo questa strada, dove si prescinde dalle categorie ontologico-fìlosofiche, che l’anima sia mortale non è dunque nulla di necessario, ma esprime soltanto le preferenze delle varie forme della cultura materialistica, che nel nostro tempo concordano nella critica del «dualismo cartesiano» di anima e corpo. E invece, all’interno della fede nel senso greco del divenire, la morte di ogni imperituro è necessaria - ed è l’unica necessità che rimane dopo la morte della forma tradizionale della verità e della necessità. L’unica necessità è la morte di ogni necessità; l’unica verità è il processo - il processo del divenire - in cui ogni verità è travolta. Criticare il «dualismo cartesiano» significa affermare l’esistenza di un nesso necessario tra il mentale e il corporeo, e un nesso necessario e un nesso incontrovertibile tra i fenomeni, un nesso che è impossibile negare, cioè la cui negazione è una falsità assoluta; dunque un nesso che daccapo pretende avere quella verità assoluta che l’essenza (il sottosuolo essenziale) della filosofìa del nostro tempo ha messo irreversibilmente da parte (togliendo così ogni limite assoluto alla tecnica). Non si deve dire allora che oggi la scienza e in particolare la neurobiologia parlano ancora con troppa disinvoltura della forma di causalità in cui consistono i condizionamenti cerebrali della mente? E che questa disinvoltura pregiudica la potenza stessa della scienza e della tecnica - visto che la loro potenza è dovuta essenzialmente all’abbandono del senso tradizionale della verità? Il «riduzionismo» (la riduzione della mente ai processi cerebrali) crede di avere - relativamente alla cultura tradizionale, «spiritualistica» - l’aspetto di un enfant terrible. E invece è ancora completamente immerso nel senso tradizionale della verità - e, anzi, della teologia). Perché come il discorso metafìsico-teologico afferma che il mondo non è autonomo ma è riducibile a Dio, che ne è la causa, allo stesso modo il riduzionismo materialistico afferma che l’anima non è autonoma, ma è riducibile al corpo, che ne è la causa. Il mondo sta a Dio come l’anima sta al cervello. Il riduzionismo scientifico-materialistico è una forma del senso tradizionale della verità e quindi è affetto dalla contraddizione consistente nell’inevitabilità che tale senso, che pur si costruisce sulla fede nell’esistenza del divenire, renda impossibile il divenire stesso. Non solo: il riduzionismo scientificomaterialistico è contraddittorio anche alla luce degli stessi parametri con cui il sapere scientifico concepisce la contraddizione. Anche il riduzionismo, infatti, riconosce la, differenza tra i fenomeni mentali e quelli cerebrali e corporei tra una sinapsi e un’immagine mentale. Infatti solo i differenti sono «riducibili» l’uno all’altro. Altrimenti ci sarebbe identità, «il loro esser lo stesso», e la scienza non si proporrebbe la «riduzione» dell’uno all’altro così come non si propone la «riduzione» di questa macchia rossa a questa macchia rossa. Ma se, data la differenza tra i fenomeni A e B, B è riducibile ad A, allora o la riduzione è totale - e allora non dovrebbe esserci quella differenza tra A e B che pur viene riconosciuta; oppure è parziale, e allora rimane in B qualcosa che non è riducibile ad A. Il riduzionismo è contraddittorio perché in esso la riduzione è identificazione, ossia perché esso afferma, insieme, la differenza e la non differenza tra i fenomeni rispetto ai quali la «riduzione» viene istituita. È contraddittorio perché afferma che i differenti sono identici (nello stesso senso in cui è contraddittorio affermare che questa macchia rossa è identica a questa macchia bianca a cui essa sarebbe «riducibile»). Lasciando ai margini il proprio fondamento ontologico, scienza e tecnica non pervengono alla dimensione in cui appare, da un lato, l’inevitabilità del tramonto del senso tradizionale della verità e, dall’altro lato, l’inevitabilità della civiltà della tecnica. Si è già sopra indicata l’essenza comune di questi due lati, cioè la fede nel senso greco del divenire, la quale concepisce se stessa come l’evidenza assoluta e originaria. Ci azzardiamo a chiamare «fede» ciò che per l’intera civiltà dell’occidente è l'evidenza suprema. La persuasione che le cose escono dal nulla e vi ritornano è il culmine della persuasione - già presente prima dell’avvento del pensiero ontologico - secondo la quale il divenire è sempre un divenir-altro. A questo punto del discorso si tratterebbe di pensare la radice di ogni radice del pensiero. Possiamo indicarla, qui, da lontano e in forma interrogativa - pur essendo, essa, la radice e il fondamento di ogni interrogare e di ogni rispondere. Così: pensare che qualcosa diventa altro non è forse pensare che essa, diventata altro, è altro? E cioè che essa, diventata altro ed essendo altro, non è ciò che tuttavia essa è? E che, essendo ciò che essa è, non è ciò che essa è? E questo pensiero, che domina sin dall’inizio l’intera vicenda dei mortali sulla terra, non è forse la Follia estrema? più originaria e radicale di ogni peccato originale, cioè di ogni alienazione religiosa, economica, psicologica, di ogni decadimento che trasforma la terra e la vita in natura lapsa? E avere come contenuto delle proprie certezze la Follia non è forse qualcosa che non può esser altro che fede? La razionalità dell’Occidente si è sempre scandalizzata della convinzione cristiana che il pane e il vino possano trasformarsi nella carne e nel sangue di Dio. Ma la più semplice e ovvia delle trasformazioni del mondo -che ad esempio la legna, bruciando, diventa cenere, o che, facendosi notte, il cielo, da chiaro, diventa scuro -non deve forse suscitare lo stesso scandalo? E anzi uno ancora maggiore, perché, mentre si è spesso sospettato della Follia della transustanziazione eucaristica, in genere non si sospetta mai la presenza della Follia estrema nella persuasione che ha come contenuto l’«ovvietà» della legna che diventa cenere e del cielo che da chiaro, diventa scuro? La fede nel senso greco del divenire non è allora il culmine della Follia estrema? L’altro, che le cose, annientandosi, diventano infatti è l’assolutamente altro dal loro essere; e l’altro che il nulla diventa, quando qualcosa incomincia ad essere è quell’assolutamente altro dal nulla che è appunto l’essere delle cose, il loro esser enti. La fede nel senso greco del divenire è il culmine della Follia estrema. E allora non dovrà esser chiamata «fede» -e anzi la forma estrema della fede - appunto perché è una persuasione che ha come contenuto là forma estrema della Follia e dell’errare? Appunto la Follia estrema è il tratto comune sia della fede nell’immortalità dell’anima (che è inseparabile dalla fede nella mortalità del corpo), sia della fede nella mortalità dell’anima; sia della fede che il diventaraltro dell’esistenza umana non intacca ciò che, lungo la storia dell’uomo, più gli preme (l’anima, il corpo risorto) - sì che nell’altro permane indefinitamente qualcosa del diveniente -, sia della fede che nel diventar-altro è intaccato e travolto tutto ciò che costituisce l’uomo, sì che l’altro, in questo diventar-altro, è il nulla della totalità dell’umano. Ma se la Follia estrema è la fede nel diventar-altro, e se la fede nel senso greco del divenire è il culmine della Follia estrema, allora la Non-follia è l’apparire dell’impossibilità, cioè della nullità assoluta del diventar-altro. La Non-follia è l’apparire - présente nel profondo di ogni uomo - della necessità dell’esser-sé da parte di ogni essente: la necessità dell’esser-sé, per la quale è impossibile il diventar altro e, diventatolo, esser altro da sé: la necessità, dunque, che essendo sé l'essente non divenga quell'assolutamente altro da sé che è il nulla: la necessità che, essendo, per ogni essente l’impossibilità di non essere, può esser chiamata «eternità» - l’eternità di ogni essente. L’essere necessariamente presso di sé, l’abitare necessariamente presso di sé senza essere esposto alla possibilità di cadere in quell’assolutamente altro da sé, che è la definizione stessa dell’eterno. Ma questa non è l’eternità di cui parla l’Occidente, l’eternità privilegiata di un Dio, di un’«anima immortale», di un corpo risorto: eterno è ogni essente, ogni stato del mondo, ogni anima e ogni corpo. Sempiterna è innanzitutto questa vita che ci sta dinanzi e in cui siamo. L’eterno non è il «Padrone» e il «Signore» del caduco, perché anche il caduco è eterno. E il divenire del mondo è il comparire e lo scomparire degli eterni. Illusione è il loro uscire e il loro ritornare nel nulla. Illusione è l’evidenza del senso greco del divenire. Il problema se l’immortalità sia o no un’illusione viene dunque lasciato alle spalle; è un dilemma fondato sulla Follia estrema. L’immortalità è illusione - ma per lo stesso motivo per cui lo è la morte; è illusione perché è la fede nella capacità dell’«anima» di sporgere, insieme ai privilegiati, al di sopra del divenire e dell’annientamento dei non privilegiati. Ma se per «immortalità» si intende il senso inaudito dell’eternità che compete a ogni essente, allora l’eternità - questo senso inaudito dell’eternità, che appare al di là del senso che la tradizione dell'Occidente ha attribuito alla verità e all’eternità -, in quanto Non-follia assoluta, è ciò che da sempre si mantiene assolutamente al di sopra di ogni illusione ed è l’autentica vittoria sulla morte.