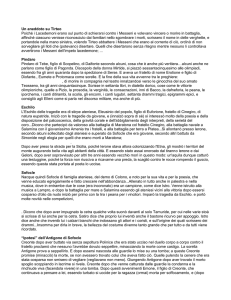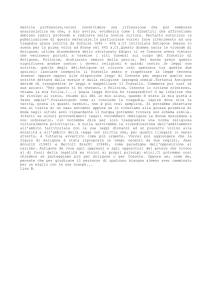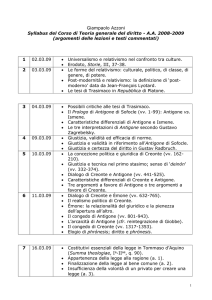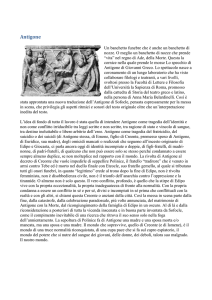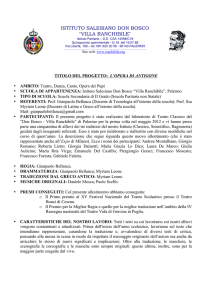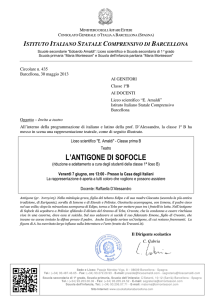LA FRAGILITÀ DEL BENE:
FORTUNA ED ETICA NELLA TRAGEDIA E NELLA FILOSOFIA GRECA
CAP. III: L’«ANTIGONE» DI SOFOCLE; CONFLITTO, VISIONE E SEMPLIFICAZIONE
0. Agamennone ed Eteocle si trovano, senza loro colpa, in una situazione nella quale il rivolgimento
improvviso dei propri sentimenti, il rimorso e il dolore del ricordo sembrano inevitabili, ma anche
appropriati. Sorge spontanea una domanda: se gli esseri umani non possono salvarsi
completamente da eventi così sfortunati e rari, possono almeno strutturare la loro vita ed i loro
principi in modo da riuscire ad evitare nella vita ordinaria i conflitti più gravi? Questo, assieme
all’interrogativo su «come eliminare il dolore?» costituisce uno dei nuclei argomentativi fondanti
della riflessione attorno al tragico. La tragedia rappresenterebbe, in questo senso, uno stadio
primitivo ed ottenebrato della vita e del pensiero etici.
L’«Antigone» è un dramma sulla ragione pratica e sul modo in cui essa ordina, decodifica,
percepisce il mondo. Inizia ponendo la domanda «Sai?» (v.2) in relazione ad una crisi pratica,
indicando il modo corretto di considerare la situazione. Termina affermando che la saggezza
pratica (to phronein) è la parte più importante del buon vivere umano (eudaimonia). È un dramma
docente: riguarda l’insegnare, ma anche l’imparare; inerisce alla possibilità – nonché necessità – di
ampliare, se non addirittura ri-considerare e mutare, la propria visione del mondo sotto la pressione
di un contesto decisionale che pone di fronte a polarità spesso tra loro inconciliabili; insegna a
perdere la presa nei confronti della verità che pare, di primo, soggettivo acchito, più sicura e ad
apprendere una tipologia di saggezza maggiormente elusiva.
Nel caso dei personaggi presi in esame, notiamo come ciascuno possieda un modello deliberativo
semplice, e come su di esso si sviluppi un insieme di interessi chiaramente ordinati; ciascuno inoltre
affronta il luogo della scelta con una sicurezza ed una stabilità inconsuete; ciascuno sembra
straordinariamente impermeabile rispetto ai danni della fortuna. Ambo i protagonisti partecipano
di una visione riduttiva, ma sono loro stessi a porre dei limiti alla propria visione; al di là di ciò, come
sostiene Hegel, la tragedia stessa riesce a travalicare i limiti stessi dei protagonisti, suggerendo la
base per una sintesi libera del conflitto tra valori opposti. Detto più semplicemente: i personaggi
risolvono le tensioni nel modo sbagliato, ma il dramma ci mostra come risolverle nel modo gusto.
Sofocle pare porsi in questo contesto come voce narrante delle avventure della ragion pratica; a tali
avventure accenna il termine deinon che, semanticamente, si trascina dietro un’ambiguità di fondo,
legata al suo molteplice significato di terrore e meraviglia (parallelo al formidable francese). Deinon
inerisce consuetamente ad una disarmonia; «molte sono le cose deina, ma nessuna/ è più deinon
dell’uomo» recita l’incipit di un’ode corale fortemente ambigua sul genere umano. Così come il
sostantivo deinon, anche l’essere umano pare costituire una vox media tra emozionante,
meraviglioso e mostruoso nella sua ineguagliabile ambizione a semplificare e controllare il mondo.
Possiamo intendere l’«Antigone» come un’indagine sul deinon in tutta la sua sfuggente
molteplicità.
1. Interrogazione sulle molteplici forme della deliberazione. Una delle figure più emblematiche, a
questo proposito, è quella del phylax, profondamente scisso tra plurali sfumature decisionali che
inglobano, in questa ampiezza prospettica, punti di vista differenti circa l’oggetto della stessa
deliberazione; è un soggetto consapevole della bilateralità prospettica che caratterizza la sfera
decisionale, ed è proprio questa caratteristica a condurre il lettore sul profondo sconforto che
normalmente caratterizza la deliberazione ordinaria. Sia Antigone che Creonte sembrano mancare
proprio di questi elementi tipici del pensiero pratico quotidiano; si allontanano talmente tanto
dall’esperienza ordinaria da approdare ad un punto di non ritorno in cui le preoccupazioni di tutti i
giorni, nonché la molteplicità dei punti di vista, paiono venire relegate ad una figura vile e comica
quale quella di un popolano, ma non di certo di un re.
2. Le prime parole di Creonte riconoscono nel coro degli anziani un gruppo di uomini rimasti fedeli
«con saldo animo», negli anni, al governo e ai suoi interessi. Come il coro e come Tiresia, anche
Creonte crede ed afferma che la cosa più importante che un uomo possa avere è la saggezza pratica,
ovvero l’eccellenza nella deliberazione, mentre la cosa più dannosa è la mancanza di saggezza.
Questa lode, paragonante la lealtà civile degli anziani alla salute della mente, non è casuale, in
quanto per egli la mente sana è quella completamente devota alla salvezza della città e al
benessere civico. L’attacco di Antigone ai valori civici viene interpretato come un segno d’infermità
mentale.
Quella di Creonte è una Weltanschaaung che non comprende la cifra (e la possibilità) della
conflittualità che può instaurarsi tra caratteri differenti del mondo etico; per uno spettatore che
abbia una visione del mondo ampia e lucida, la situazione di Creonte in questo dramma dovrebbe
far nascere alcuni urgenti interrogativi sul conflitto tra valori principali.
Il pubblico si aspetterebbe di trovare in Creonte una tensione dolorosa tra i doveri familiari
(scaturenti dal suo ruolo di zio del defunto) e il ruolo di sovrano garante della stabilità del nomos;
esso rimane invece sorpreso nel constatare la completa assenza di questa tensione o conflitto tra
parentela e legge, assicurata da una risistemazione delle valutazioni. Se esaminiamo il modo in cui
Creonte usa i termini etici fondamentali, scopriamo che egli li stravolge e sottrae al loro impiego
ordinario. Essi vengono applicati alle cose ed alle persone solamente in virtù della loro connessione
con il benessere della città, che per Creonte è il solo bene intrinseco. Egli impiega tutto lo spettro
del tradizionale vocabolario etico, ma non nel modo tradizionale; si comporta come se potesse
chiamare le cose con i nomi che più lo soddisfano, come se potesse vedere solamente quelle qualità
del mondo che il suo ethos personale richiede. Criterio di ponderazione del valore etico – e non –
degli elementi è quello del benessere della città: «mai i cattivi cittadini avranno da parte mia più
onore dei giusti; ma chi è devoto a questa città, morto o vivo ugualmente, sarà onorato da parte
mia». Nel suo discorso sul rispetto dovuto ai benefattori e ai malfattori, l’aggettivo «giusto»
(endikos) viene usato come equivalente di «devoto alla città».
«Giusto» e «buono» non sono semplicemente attributi dell’uomo, bensì dell’uomo in quanto
difensore della città; non possono sussistere indipendentemente. Solo un tipo di eccellenza umana
è degno di essere lodato: l’utilità per il benessere della città. Tutte le parole che indicano eccellenza
hanno la funzione di segnalare la presenza di questa virtù.
Ma la parte più audace della revisione intrapresa da Creonte non è la ridefinizione del giusto e del
buono, che già manifesta una forte associazione con i valori della città, bensì è la violenta
ridislocazione de valori sui quali si fondano gli oppositori della sua politica: l’amore e la pietà
religiosa.
Il termine «fratello», peculiare del lessico familiare, è impiegato da Creonte per indicare la stretta
relazione tra i decreti della città: «ed ho proclamato un bando che è fratello di quanto precedeva»;
tenta di sostituire i legami di sangue con i vincoli dell’amicizia tra concittadini. I conflitti tra famiglia
e città non possono sorgere se la città è la famiglia (Platone fu il primo ad intuire l’importanza di
questa idea per la teoria politica).
I nostri vincoli personali, siano essi legami di sangue, sentimentali o l’uno e l’altro, possono essere
riconosciuti ai fini della deliberazione solo se in qualche modo contribuiscono al bene supremo.
Secondo Creonte i philoi vengono procurati stando al servizio della città: egli riconosce meramente
i vincoli che ha scelto. Chi è «sano» (ovvero che condivide la sua prospettiva) non si lascia catturare
da nulla che possa far nascere un conflitto con il dovere verso la città, neppure dalle relazioni
sessuali (è per questo che qualsiasi sfumatura attrattiva scompare anche in una figura che può
supporsi attraente come Antigone). È questa, secondo Creonte, la saggezza pratica. Il sapiente è
colui che rifiuta di riconoscere cose che gli altri, uomini deboli, vedono tranquillamente. A suo
avviso anche le divinità devono avere la «mente sana» tipica del politico coscienzioso («dici una
cosa insopportabile pensando che gli dei si danno pensiero di questo cadavere […] hai mai visto gli
dei onorare i malvagi?»).
Creonte si è costruito un mondo della deliberazione nel quale la tragedia non può entrare. Non
possono insorgere conflitti insolubili perché c’è un solo bene supremo e tutti gli altri valori sono in
funzione di questo bene.
Il vero occhio dell’anima sana non vedrà nel nemico una persona amata, o il suo corpo abbandonato
all’empietà. L’apparente presenza di un conflitto contingente sta ad indicare che non ci siamo
impegnati a sufficienza per ottenere una visione corretta.
Egli difende la sua posizione con un argomento che deriverebbe, secondo le sue parole, dalla
conoscenza pratica: «e non mi farei mai amico un nemico della patria, poiché so […] che ci
procuriamo gli amici solo quando ne teniamo dritto il corso». Esplicito rimando alla metafora della
nave, luogo comune del patriottismo ateniese: la città, nel caso di Creonte, è una nave e senza di
lei i cittadini non possono nulla; ma chiaramente Creonte ignora che i marinai non sono sulla nave
solo per farla navigare diritta; essi hanno altri fini, ai quali la nave offre un ambiente, un mezzo di
trasporto. Non ci aspettiamo che questi fini siano definibili soltanto rispetto alla salute della nave.
Teognide, che fu tra i primi ad usare questa immagine, accenna ad una tensione tra i fini individuali
dei marinai ed il bene generale della nave. Con l’evoluzione dell’immagine il marinaio diviene
paradigmatico di qualcosa che è separabile, i cui fini sono distinti da quelli della nave, ridotta ad un
mezzo utile e necessario.
Quando Creonte afferma che la città è una condizione necessaria in vista di altri fini, egli non offre
nessuna ragione perché non si debbano considerare beni intrinseci anche quelli non legati alla città;
non ci sono pietà religiosa e giustizia al di fuori degli obblighi verso la polis.
Scopo della città è rimuovere la fortuna ingovernabile della vita umana; Creonte ed il coro, nel
primo momento di ottimismo, credono che le risorse tecnologiche dell’uomo possano vincere ogni
contingenza, esclusa la sola morte. Ma la soppressione della contingenza richiede anche una
tecnologia della natura umana, una tecnologia della ragione pratica.
Le qualità recalcitranti del mondo possono essere dominate dalla razionalità pratica ed etica: con
un riordinamento costruttivo degli interessi pratici e del linguaggio etico. Creonte effettua
abilmente questo adattamento usando la città come modello del bene. Affinché questa strategia
funzioni, però, il bene finale deve essere unico e semplice: non deve contenere conflitti od
opposizioni al proprio interno.
Il dramma tratta il fallimento di Creonte. Si conclude abbandonando questa strategia e
riconoscendo un mondo deliberativo più complesso.
Quando entra, Creonte parla subito degli affari della città; il suo discorso si articola impiegando le
particelle correlative men e de; tale struttura indica la presenza di un’opposizione, o quanto meno
sottolinea una distinzione tra la città e i cittadini del coro. Sin dall’inizio, dunque, siamo invitati a
chiederci se la città, correttamente concepita, possieda un bene semplice, come ritiene Creonte;
ma solo una concezione impoverita di città/comunità può partecipare della semplicità pretesa da
Creonte.
Creonte è implacabile nel considerare ogni oppositore della città esclusivamente come un ostacolo
da vincere; la sua concezione della moglie come un mero campo da arare, della virilità come
esercizio di potere su una materia remissiva, tende già a disumanizzare l’altro elemento della
relazione. Il piano di Creonte non permette di rispettare un oppositore in base all’umanità della
persona; un uomo (o una donna) contengono soltanto un unico valore, la capacità di produrre il
bene della città; se questa manca, la persona non merita di essere tenuta in «alcun conto».
Lavorare i metalli, domare i cavalli, possedere schiavi: per Creonte tali figure esprimono la relazione
del maschio dominante con la ragione di un oppositore ostinato; egli non considera, però, che un
essere umano è un ostacolo molto più arduo di un cavallo. Nella vita cui egli aspira ci saranno
solamente oggetti utili e non persone che rispondono; Emone gli riferisce, difatti: «tu regneresti
bene da solo su una terra deserta».
Ancora una volta la concezione di Creonte, contemplante un unico fine, gli impedisce di avere una
corretta visione della città, la quale, nella pienezza delle sue relazioni, non sembra manifestare un
unico bene.
Finale: l’amore di Creonte per il figlio morto, che non può essere più negato o adattato entro la
teoria del bene civico, lo costringe ad abbandonare tutte le sue teorie. Egli prova rimorso per le sue
deliberazioni, in particolare per la loro grettezza e povertà. La loro moneta non era una valuta
sufficiente: era un’unità di misura povera perché lasciava fuori cose di grande valore. Creonte
riconosce di aver fallito. Il suicidio della moglie Euridice (il cui nome, non casualmente, significa
«ampia giustizia») è sintomatico. Il rimorso del sovrano non riguarda solamente il suo errore
particolare, ma implica una ridislocazione generale. «Ahimè. Troppo tardi, sembra, vedesti la
giustizia» è il giudizio del coro.
3. Antigone, come Creonte, è impegnata in una spietata semplificazione del mondo dei valori, che
di fatto elimina le obbligazioni conflittuali. Come Creonte, anch’ella può essere biasimata, poiché
rifiuta di vedere.
Antigone nega ogni rilevanza alla distinzione tracciata da Creonte (nemico/amico della polis sulla
base delle azioni più o meno minatorie/agevoli nei confronti di essa). Ella, piuttosto che una linea,
traccia un cerchio attorno ai membri della sua famiglia.
«Amico» e «nemico» diventano per lei funzioni esclusive della relazione familiare. Quando afferma
«non sono nata per condividere l’odio, ma l’amore» non esprime una generale inclinazione
all’amore, ma la devozione alla philia della famiglia. Questo amore non è qualcosa che si possa
decidere; è la relazione (familiare) in se stessa a costituire una fonte di obbligazioni, senza alcuna
considerazione per i sentimenti coinvolti; è un amore «pratico» (per usare la terminologia
kantiana), distinto da quello «patologico» (fondato sulla tenerezza e sull’inclinazione).
Emone, non Antigone, appare ispirato dall’eros; Antigone, al contrario, è lontana dall’amore quanto
lo è Creonte.
Il dovere verso i morti e la famiglia rappresenta la legge più alta e la passione suprema; la sua
identificazione esclusiva con i doveri verso i morti pone una strana riorganizzazione della pietà
religiosa, come anche dell’onore e della giustizia. Antigone sembra voler fare ogni cosa per pietas
religiosa, ma la sua pietà corrisponde solamente ad una parte dei doveri religiosi stabiliti dalla
religione convenzionale.
Antigone parla della sua obbedienza a Zeus, ma rifiuta di riconoscere che quel dio è anche il
guardiano della città e difensore di Eteocle; «ma non fu per me Zeus a proclamare quel divieto»,
ella pretende dunque di poter stabilire ciò che Zeus può o non può aver decretato, proprio come
Creonte pretendeva di indicare chi fosse protetto dagli dei e chi non lo fosse.
Coro: «giunta ad estremo ardimento, contro il soglio eccelso di Dike / cozzasti o figlia fortemente»;
di conseguenza i coreuti pensano che Antigone non sia una persona pia secondo le tradizioni, ma
una persona che improvvisa la propria pietà religiosa e decide da sola che cosa sia degno di
venerazione. I coreuti le dicono apertamente che il suo rispetto religioso è incompleto.
Se l’atteggiamento di Creonte verso gli altri somiglia alla necrofilia, poiché aspira a possedere la
materia inerte e cedevole, l’asservimento di Antigone al dovere è invece il desiderio di essere un
nekros, un cadavere innamorato dei cadaveri. Né Creonte, né Antigone sono esseri appassionati o
animati dall’amore per qualcosa. Nessun dio, nessun essere umano sfugge al potere di eros,
sostiene il coro, ma questi due strani esseri inumani, apparentemente, ci riescono. Creonte vede le
persone amate in funzione del bene della città, per produrre cittadini equivalenti l’uno all’altro. Per
Antigone i cari sono morti o servi dei morti, oppure soggetti assolutamente indifferenti.
Abbiamo dunque due mondi pratici fortemente limitati, due strategie di difesa e di semplificazione:
nell’una un unico valore umano è diventato il fine ultimo (Creonte), mentre nell’altra (Antigone) un
insieme di doveri ha eclissato tutti gli altri.
Perché, dunque, ammiriamo comunque Antigone? L’irriverenza ai valori della città implicata dal
dare sepoltura ad un nemico è molto meno grave della violazione religiosa implicata nell’atto di
Creonte; Antigone mostra una comprensione più profonda della comunità e delle sue leggi di
quanto non lo faccia Creonte. La convinzione espressa da Antigone che tutti i valori siano relativi
all’utilità, che certe richieste, quando vengono trascurate, distruggano la concordia comune e il
carattere individuale, viene lasciata intatta dall’implicita critica contenuta nel dramma. Antigone
può essere stranamente lontana dal mondo, ma non fa violenza ad esso.
Questa vulnerabilità nella virtù, questa abilità a riconoscere il mondo della natura, lamentando le
costrizioni che esso impone, contribuiscono certamente a fare di Antigone il più umanamente
razionale e il più ricco dei due protagonisti. Ella è sia attiva sia ricettiva, non sfrutta gli altri, ma non
è neppure una semplice vittima.
4. Interpretazione hegeliana: «queste sono le potenze (famiglia/stato) più pure della
manifestazione tragica, in quanto l’armonia di queste due sfere e l’agire armonico entro la loro
realtà costituiscono la completa realtà dell’esistenza etica […]; il vero sviluppo consiste solo nel
superamento delle opposizioni come tali, nella conciliazione delle potenze dell’agire che si
sforzano, nel loro conflitto, di negarsi scambievolmente».
La soluzione prospettata da Hegel è dunque la rimozione del conflitto tra le due sfere di valore in
chiave sintetica; dal nostro studio, al contrario, emerge che rendere giustizia alla natura o
all’identità dei suoi valori non significa eliminarne completamente la tensione (esempio
dell’orgoglio ateniese rispetto alla figura di Pericle, la quale aveva sviluppato un ordine civico che
incorporava e rispettava le richieste delle leggi non scritte derivanti dall’obbligazione religiosa), ma
rendere giustizia alla loro differenza; significa vedere che ci sono circostanze nelle quali le sfere di
valore collidono. Essere distinti implica essere separati da, essere delimitati contro qualcosa. Ciò, a
sua volta, implica la possibilità dell’opposizione e del conflitto.
La struttura del dramma, densamente enigmatica e “oppositiva” è in stretta relazione con lo stile
complesso ed oscuro del più grande pensatore etico vissuto nel cinquantennio precedente questo
dramma, cioè con lo stile di Eraclito. Tali caratteristiche stilistiche servono per guidare
l’interpretazione, ma anche per chiarire quale concezione dell’apprendimento e della riflessione
umana sia presente in questo dramma (profondamente differente dal modello platonico). Mentre
l’anima platonica si orienta, difatti, dal particolare all’universale, la psyche eraclitea ruota attorno
alla complessità dei particolari; l’anima immaginata da Sofocle è simile a quella eraclitea: un ragno
al centro della tela, capace di sentire e di reagire ad ogni vibrazione dell’intricata, complessa
struttura; essa gira con i pensieri e l’immaginazione attorno all’enigmatica complessità dei
particolari, seduta al centro della sua trama di connessioni, sensibile all’oscillare di ogni singolo filo;
tale concezione sottende sensibilità, attenzione per la complessità, scoraggiante la ricerca della
semplicità e soprattutto della riduzione. La scelta corretta (o buona interpretazione) dipende
dall’acume e dalla flessibilità della percezione, e non dalla conformità ad un insieme di principi
semplificatori.
Infine il coro ci ricorda che per reagire correttamente ad un caso pratico che ci stia davanti è
necessaria non soltanto una valutazione dell’intelletto, ma anche un’appropriata risposta
emozionale. Infatti il coro non legge le varie situazioni in termini freddamente intellettuali; più non
posso frenare / fiotti di lacrime / quando vedo Antigone / muovere al talamo che tutti addormenta»,
afferma il coro; la sua percezione delle cose è dunque sia intellettuale che sensitivo-emozionale;
una percezione meramente intellettuale di questo evento, che non fosse accompagnata
dall’«essere tratti» e dall’erompere delle lacrime, non sarebbe un vedere naturale, o completo, o
buono. Per percepire pienamente i particolari bisogna amarli.
Spettatori: mentre esperiscono la complessità della tragedia, formano una comunità e non isolano
la loro anima da quelle di tutti i loro compagni; prestano attenzione a tutto ciò che è comune o
condiviso, si trasformano in un gruppo che reagisce tutto assieme e non raggiungono la solitaria
altezza della contemplazione, da cui si può tornare alla vita politica solamente attraverso una
discesa dolorosa. Questa esperienza accentua il valore fondamentale della comunità e
dell’amicizia: non ci consente di cercare il bene al di fuori di esse.
Ingresso del coro sulla scena; esso ricorda che il sole fu testimone della vittoria tebana e che ora ne
vede le sanguinose conseguenze fuori dalle solide porte della città. Aquila ricoperta di criniere >
anomalia della doppiezza di Polinice, corrispondente alla complessità del discorso morale su di lui.
La lirica inizia dunque con un occhio che si apre proprio come si apriva in passato e guarda una scena
che presenta elementi confusi.
Il discorso di Creonte sul vedere comporta una precisa costruzione della realtà, rifiutante gli
elementi che non si accordano con essa; egli permetti che si riveli o che diventi evidente solamente
ciò che si accorda con la sua immagine semplificata del valore. Egli invoca Zeus «che sempre vede
tutto» per difendere la sua visione esemplificata; colui che si oppone, che vede in modo diverso da
lui, manca nella sua immaginazione della vista, è quindi una persona che «trama male azioni
nell’ombra». Secondo Emone, Creonte ha un omma deinon, un occhio strano e terribile, poiché
vede solo ciò che vuole vedere e sente solo ciò che vuole sentire (anche Antigone, sebbene con
enfasi minore, insiste a guardare soltanto i mali della sua famiglia e la forza della legge dei morti).
Infine Creonte sarà punito venendo privato della vista del figlio, alle cui richieste era stato cieco. Il
giro del sole misura la sua sconfitta; con dolore egli giunge a «vedere» la morte dei membri della
sua famiglia e, alla fine, «troppo tardi a vedere la giustizia».
Questo omma deinon si oppone implicitamente all’occhio del sole, che vede la forza delle due
posizioni in conflitto. La visione di Creonte si oppone anche alla visione del coro, perché i coreuti
invocano il sole affinché li assista nella ricerca e chiedono di poter vedere ciò che lui ha visto. Essi
aspettano l’illuminazione di un occhio esterno e non controllato dall’uomo; l’occhio di Creonte è
attivo e corregge ciò che vede; allo stesso modo Creonte immagina se stesso come attivo e non
passivo: il capitano della nave che avanza nella sua rotta, il domatore di animali, il forgiatore di
metalli, il maschio. Gli uomini del coro, sin dall’inizio, vedono se stessi in modo differente. La loro
invocazione ha più il carattere di attendere che qualcosa si manifesti a loro senza pretendere che
sia proprio ciò che essi vogliono. Il coro ha, dunque, un modo differente di concepire la visione; non
presenta una visione hegeliana.
Dopo essere stati testimoni della guerra fratricida e delle sue conseguenze, gli uomini del coro
pensano che l’uomo sia una cosa deinon: un essere meraviglioso e strano, che non è a casa propria,
né in armonia nel mondo della natura; un essere naturale che strazia la natura per costruirsi una
casa e modifica la sua stessa natura per farsi delle città. Niente è più deinon, suggerisce il testo,
nemmeno gli dei, i quali hanno una vita armoniosa e controllata; essi non possono essere ammirati
come si ammirano gli esseri umani perché non hanno ostacoli da superare, né possono essere
temuti o criticati dal momento che non necessitano di allontanarsi dalla loro natura o di diventare
empi per realizzare se stessi.
Nave, aratro, compaiono come metafore politiche prima e dopo l’ode; adesso vengono citate alla
lettera come esempi dell’inventiva umana. È una ricchezza di risorse che non si limita a controllare
l’esterno; l’essere umano ha difatti creato se stesso come essere sociale, ha modellato pensieri,
emozioni, istituzioni e governato aspetti della sua vita interiore prima ingovernabili. Sembra
dunque che egli abbia una soluzione per tutto, tranne che alla morte; ma, nota il coro, molte
malattie un tempo incurabili adesso trovano cura grazie ai mezzi scoperti dagli uomini; la morte “è
stata allontanata”: forse che una creatura così ricca di risorse non potrà trovare una soluzione?
Ognuna delle conquiste menzionate implica però un problema sulla strada del progresso umano.
Ciascun elemento rivela la pluralità e la varietà dei valori umani e mette in forse il tentativo di creare
l’armonia attraverso la sintesi. Così l’ode ci porta verso una critica generale all’ambizione ad
eliminare il conflitto.
La nave descritta e metaforicamente citata può essere, però, altresì fracassata dalle tempeste e
dalle onde: queste vulnerabilità delle imprese umane, esposte agli eventi esterni, ci rimandano al
fatto che gli esseri umani sono spesso costretti a scegliere tra il valore del progresso e quello della
pietà; tra la ricerca del benessere o della salvezza, e la necessaria cura degli obblighi religiosi.
Veniamo dunque indotti a considerare il conflitto morale che sta al centro del dramma e a pensare
che esso non può essere facilmente eliminato, neppure dal miglior legislatore. Ancora una volta il
progresso entra in contraddizione/collisione con la pietà (terra “arata” martoriata dall’uomo,
Demetra; Demetra “non è amica” di Afrodite*); ancora una volta la sopravvivenza dell’uomo
dipende da una violazione. Anche il discorso di Creonte sulle miniere tradisce la determinazione a
controllare l’oggetto a spese della sua integrità e della sua particolare bellezza: l’atteggiamento del
minatore è irrimediabilmente contrapposto a quello del collezionista di pietre preziose.
*La città hegeliana è costretta a scegliere tra il matrimonio e l’eros (similitudine evocata da
Creonte, matrimonio come “campo da arare”; la sua concezione del matrimonio pretende che si
trascuri un potere, quello dell’eros, che è vincolante quasi quanto lo sono le norme etiche. La città
hegeliana è costretta a scegliere tra il matrimonio e l’eros, e deve necessariamente scegliere il
primo; deve dunque trascurare un bene e cessare di essere hegeliana.
In seguito viene lodata la parola come una grande invenzione; ma la parola, la trasformazione del
discorso etico, è lo strumento centrale nelle semplificazioni di Creonte.
Phronema, il successivo oggetto di lode, è l’inconsueta parola usata da Creonte per indicare la
mente, che, a suo avviso, deve preservare la propria salute semplificando e rifiutando. Gli «impulsi
a civili ordinamenti» sono in definitiva orge: collera ingovernabile, rabbia violenta. Così lo strano
vocabolario dell’ode ci invita a considerare che la città di Creonte è costruita propriamente sull’ira;
la collera violenta per la nostra vulnerabilità di fronte al mondo è il sentimento che, al fondo, motiva
le strategie di salvaguardia. Anche il raffinato tentativo hegeliano di costruire una città armonizzata
potrebbe essere nient’altro che un sottile ed astuto stratagemma della rivincita; l’asserzione dei
trionfi ottenuti dalla ragione umana si trasforma in un documento sintetico dei limiti, delle
trasgressioni e dei conflitti della ragione. Essa suggerisce che quanto più il nostro schema dei valori
è ricco, tanto più è difficile realizzare l’armonia al suo interno. Il prezzo dell’armonizzazione sembra
essere l’impoverimento, il prezzo della ricchezza la disarmonia. È quasi una «legge non scritta» che
«nessuna vera grandezza / viene senza sventura alla vita dei mortali»; è a questo punto che gli
uomini del coro dicono «guardo questo strano prodigio e lo considero da tutti i lati».
Ulteriore ode, esempi di alcuni esseri umani imprigionati in camere di roccia; dalla luce del sole, che
sorge su Tebe, a stanze di pietra senza aria, come una tomba; dalla esuberante leggerezza delle
navi alla schiacciante pressione della Moira. L’apertura espansiva delle liriche precedenti si è
trasformata in un’atmosfera densa e soffocante.
Esempio di Licurgo, che aveva fatto di Dioniso oggetto di disprezzo: parallelismo sia con Creonte
che con Hegel, Licurgo era apparentemente consapevole di una fede eccessiva nel progresso
umano, di un eccessivo orgoglio per la potenza della ragione e dell’ordine > alla fine giunse a
conoscere il dio che aveva disprezzato e il prezzo per questa conoscenza fu l’immobilità.
Esempio della figlia del dio dei venti, rinchiusa in una prigione perché il marito voleva sposare
un’altra donna > la matrigna, gelosa, acceca i figli della donna, i quali “con gli occhi” cercano di
vendicare la madre. La matrigna (come Creonte) doveva rendere inerte ed inespressiva
l’opposizione, perché l’umanità dei bambini era un’accusa troppo evidente contro di lei. Se lei si
fosse permessa di rispondere ai loro sguardi, sarebbe stata straziata nella lotta tra le pretese del
marito e quelle, giuste, dei figliastri > strappa via quelle richieste con il sangue (ulteriore esempio
di immobilizzazione dell’aspetto minaccioso).
Tutti gli uomini negli esempi dell’ode finiscono allo stesso modo, piegati al gioco per la loro collera
o per la loro innocenza. Dove Hegel coglie la speranza dell’armonia, il coro vede soltanto il terribile
potere di un’illimitata contingenza. Chi tenta di soggiogarla commette un’infrazione e viene
soggiogato; chi la riconosce viene distrutto.
La lirica non ci dà nessuna assicurazione sul fatto che queste opposte richieste conosceranno una
sintesi armoniosa (aspetto anti-hegeliano della lirica); ci dimostra che l’armonizzare e l’ordinare
attivamente implicano il rifiuto di qualcosa, mentre la sensibilità dello stare aperti ci allontana dal
nostro obiettivo, quello di condurre una vita normale.
L’ottimismo di Hegel non viene giustificato dalla trama delle associazioni attraverso cui ci ha
condotto la lirica.
Di diverso avviso rispetto ad Hegel è Schopenhauer, il quale pone l’accento sul sentimento di
paralisi che accompagna la visione della conoscenza che la tragedia può offrire; il sentimento di
paralisi che accompagna questa conoscenza è la reazione appropriata a questa e ad ogni altra
tragedia. «Scopo di quest’altissima creazione poetica è la rappresentazione della vita nel suo
aspetto terribile, il dolore senza nome, l’affanno dell’umanità».
5. Ma L’«Antigone non si conclude con questa visione paralizzante. Sebbene sia cieco, l’uomo che
fa il suo ingresso accompagnato dal fanciullo cammina, non è immobilizzato. Il vecchio Tiresia,
sacerdote di Apollo, viene scortato da un giovane con cui intrattiene un rapporto di stretta
complementarietà: da una parte il giovane lo sostiene nella sua cecità («vedendo in due con gli
occhi di uno, vengono insieme per la stessa via»). Da questa reciprocità scaturisce la possibilità
dell’azione. Tiresia è sacerdote di Apollo, divinità del legare e dell’ordinare; Tiresia è un uomo
dotato di arte (techne) in quanto la sua cecità gli ha donato una conoscenza inaccessibile anche ai
più fortunati: viene per insegnare, per trasmettere conoscenza mostrando i segni della sua arte.
Tiresia sostiene che l’arte di cui si occupa è quella della buona deliberazione, definita come «il
migliore dei beni». Egli incita Creonte a guarire da una malattia della ragione cui vanno soggetti
«tutti gli uomini»; questa malattia è la furia del controllo, con le sue inevitabili empietà.
Ma si può concepire la guarigione senza rinunciare del tutto alla scelta e all’azione? Tiresia sostiene
che una buona deliberazione equivale alla rinuncia alla caparbietà ostinata; equivale ad essere
flessibili; sono consigli che riprendono quelli dati precedentemente da Emone a Creonte; Creonte
avrebbe dovuto imparare a non forzarsi troppo; Emone come Tiresia riconduce questo non sforzarsi
troppo con l’abilità di imparare e con l’idea di cedere; l’indovino riporta due esempi (alberi rispetto
al torrente e metafora della nave durante la tempesta*1). Sia Emone che Tiresia stabiliscono
dunque una connessione tra imparare e cedere, tra saggezza pratica e flessibilità; essi non
accettano il suggerimento contenuto nell’ode di Danae, secondo il quale le due sole alternative
sarebbero la violenza di Creonte contro l’esterno e la passività completa davanti all’esterno. Ogni
esempio *1 di quelli citati ha, d’altronde, le proprie regole: Emone sostiene che è importante, nella
ricerca dei propri fini umani, rimanere aperti alle richieste e alle sollecitazioni dell’esterno e
coltivare una sensibilità flessibile piuttosto che una rigida durezza; egli prospetta a Creonte una
saggezza pratica che risponde alla forma del mondo naturale adattandosi alla sua complessità e
riconoscendola nel modo che le è dovuto (Aristotele userà l’immagine dell’architetto che misura
una complicata colonna con una striscia di metallo flessibile piuttosto che con una riga rigida); l’arte
deliberativa combina, nella sua sintassi più profonda, attività e passività, fluidità ai propri fini e
sensibilità verso il mondo.
L’ethos esclusivo di Creonte non è soltanto folle, ma altresì brutto e povero. Si propone come un
mezzo di civilizzazione, ma finisce per essere ferocemente incivile. Secondo il consiglio di Emone,
per essere un uomo veramente civile bisogna preservare il mistero e la particolarità del mondo
esterno, mentre si deve conservare nell’interiorità la passione che induce al mistero. Solo chi
bilancia la protezione di sé con la cedevolezza può essere un amante o un amico.
Si palesa così un conflitto tra il valore della coerenza (libertà dal conflitto) e valore della ricchezza:
una vita senza contraddizione non ha il valore e la bellezza di una vita in cui può nascere il conflitto;
lo diceva lo stesso Eraclito: la giustizia è contesa, ossia le tensioni permettono la nascita della lotta
e sono, al tempo stesso, parti costitutive dei valori. Senza la possibilità della contesa la giustizia
sarebbe distrutta. Necessità di riconoscimento della tensione, come quella dell’arco e della lira, una
“discordia concordante” > comprendere che una cosa degna di essere perseguita possiede il suo
particolare valore per il modo stesso in cui viene limitata dalle altre cose e quindi per la
disuguaglianza o l’opposizione con esse.
La cecità è, in buona misura, necessaria e giusta per equilibrare in modo appropriato la sensibilità
e l’ordine.
Il coro, in ogni caso, risponde a questa lode con un’invocazione a Dioniso, dio della duplicità,
dell’opposizione intrinseca; Dioniso nasce dalla folgore, avente genericamente forza distruttiva: è
una figura che trattiene l’ambivalenza delle polarità senza propendere per l’annientamento
dell’una piuttosto che dell’altra; nasce dall’ambigua unione di luce ed oscurità, rischio e valore; è il
dio simbolicamente rappresentante una struttura flessuosa e fluida che si muove nelle tenebre e
che da esse assume il proprio carattere; un discorso nato dall’artificio umano, e tuttavia sensibile
alla stranezza.
Ruolo terapeutico della “danza dionisiaca” > sotto questo aspetto il guarire non è mai un
conquistare, ma solamente un comune riconoscere, nel movimento e nella musica, il potere di ciò
che è strano ed improvviso. L’indissolubile intreccio di estasi e pericolo, di luce ed ombra.
Invocando Dioniso come «colui che guida il coro degli astri / spiranti fuoco», i coreuti ci
suggeriscono che anche lo spettacolo di questa tragedia è un mistero ordinato, ambizioso e
accondiscendente, una guarigione senza cure, la cui vera armonia non è la semplicità, ma la
tensione tra le forme di bellezza distinte e separate.