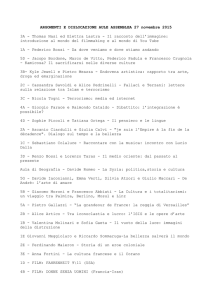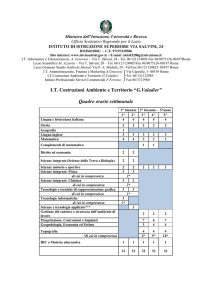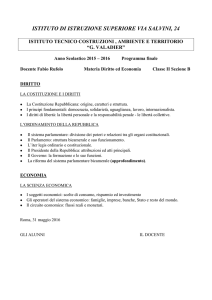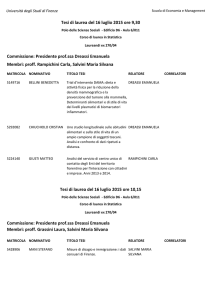caricato da
catgionny
I Demoni di Salvini: Postnazisti e la Lega

L’autore Claudio Gatti è stato corrispondente dagli Stati Uniti del settimanale «L’Europeo», vicedirettore del settimanale economico «Il Mondo», direttore del supplemento sull’Italia dell’«International Herald Tribune» e inviato speciale de «Il Sole 24 Ore». Con Roger Cohen ha pubblicato il libro In the Eye of the Storm: the Life of General H. Norman Schwarzkopf (1991). In Italia ha pubblicato Rimanga tra noi. L’America, l’Italia, la «questione comunista»: i segreti di 50 anni di storia (Leonardo 1991); Il quinto scenario (Rizzoli 1994), inchiesta sulla strage di Ustica; Fuori orario. Da testimonianze e documenti riservati le prove del disastro Fs (Chiarelettere 2009); Il sottobosco. Berlusconiani, dalemiani, centristi uniti nel nome degli affari (con Ferruccio Sansa, Chiarelettere 2012) ed Enigate: i documenti esclusivi sulle tangenti internazionali che l’ente petrolifero è accusato di aver pagato (Paper First 2018). https://marapcana.icu Inchieste e reportage ««www.chiarelettere.it»» https://marapcana.icu © Chiarelettere editore srl Soci: Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Lorenzo Fazio (direttore editoriale) Sandro Parenzo Guido Roberto Vitale (con Paolonia Immobiliare S.p.A.) Sede: corso Sempione, 2 - Milano ISBN 978-88-3296-231-4 Copertina Art director: Giacomo Callo Graphic designer: Marina Pezzotta Nessun albero è stato abbattuto per la realizzazione di questo eBook Cura editoriale di Maria Cristina Olati Prima edizione digitale: maggio 2019 https://marapcana.icu Sommario L’autore Pagina di copyright Frontespizio Questo libro La maschera leghista La grande macchinazione Controcanto Nei cieli della Padania e dell’Ucraina Langhe piemontesi, provincia di Cuneo Località italiana non conosciuta Cieli dell’Ucraina Milano, letteralmente dietro l’angolo di via Bellerio, sede storica della Lega Parlamento europeo, Bruxelles Il Cuore del Mondo, blog di Marcello Foa «Il Giardino del Tango», Roma Il primo vagito La folgorazione del «giovane» Bossi Il magma dottrinale La Jeune Europe Il fronte culturale della destra padana Il mito delle Waffen SS Il nazismo aggiornato di «Orion» e «Ideogramma» Maurizio Murelli, il Sommo Suggeritore Il gruppo di Saluzzo Le simpatie ultraradicali di Borghezio Il nazismo deve rinascere Dieci, cento, mille Mario Borghezio Ordine nuovo e l’omicidio Occorsio L’incontro al Novotel di Nizza La nascita del Fronte nazionale La «grande confusione» di Bossi Matteo Salvini e l’amico fascista Gli anni del liceo La leggenda del Leoncavallo Da tifoso a leghista I dubbi sull’Olocausto I nazional-bolscevichi di Mosca con i postnazisti di Saluzzo Il programma euroasiatico L’antimondialismo di Dugin Il postnazismo di Steuckers e De Benoist Lotta comune all’imperialismo americano Il Sole delle Alpi e la svolta celtica della Lega La prima poltrona di Salvini Il grande ribaltone Oneto, ideatore dell’identità padana Per volere di Dio, alle sorgenti del Po «Io me ne fotto. A me interessa fare carriera» Il comunista padano La parentesi giornalistica La palestra radiofonica Un bossiano di ferro Il lupo compositore Savoini, il terzo «infiltrato» La contiguità con la destra milanese Il circolo Ideogramma Nella neonazista «Padania» Vestivamo all’hitleriana Da «la Padania» all’ufficio stampa della Lega Dalle Alpi alla svastica La prima svolta postnazista In difesa del popolo padano e di tutti i popoli L’avvicinamento alla Russia Bossi e Haider contro il male Dopo la pausa, la ripartenza Il vuoto emotivo dell’era Maroni Il revival postnazista di Salvini L’alleanza con CasaPound Seminare diffidenza e paura Il Talebano e altri laboratori politico-culturali Mascetti all’origine della stirpe Contro il Piano Kalergi e la sostituzione dei popoli Il complotto come arma di corruzione di massa Trovare il nemico per sopravvivere al caos Antisemitismo accettabile Soros, nemico perfetto Lo stregone delle notizie Giornalismo e spin Aiutare il pubblico a capire L’impronta cospirazionista Il pluralismo al tempo di Foa Putin e la militarizzazione dell’informazione Una nuova Guerra fredda Le campagne di disinformazione del Cremlino Bugie strategiche: Crimea e Ucraina Gli attacchi chimici in Siria Putin, tutta la vita Savoini agente d’influenza del Cremlino Salvini e la causa putiniana Contro l’Onu, la Nato e Bruxelles L’accordo con Mosca Claudio D’Amico, gli Ufo e la Russia Il Piano Premyak I cinque punti Dall’Associazione Lombardia Russia all’accordo di collaborazione Solo patriottismo? Il negoziatore Giancotti Il business del petrolio Gli affari dell’oligarca Malofeev Tangenti a Mosca Affari, soldi, voti Epilogo Sdoganare il pensiero postnazista Il seme ha attecchito Non cercate il fascista in camicia nera! Ringraziamenti Seguici su IlLibraio I DEMONI DI SALVINI Questo libro La maschera leghista Chiedersi se Matteo Salvini sia fascista non è solo un esercizio inutile. È un grave errore. Non tanto perché al «Capitano», come lo chiamano i suoi fan, è sempre mancato un credo politico, quanto perché la facile smentita estinguerebbe un dibattito assolutamente necessario sulla pericolosità del ministro dell’Interno per la democrazia italiana. Salvini è a mio giudizio molto più preoccupante di un fascista. È un cinico opportunista che ha assecondato un’operazione d’infiltrazione culturale e politica da parte di un manipolo di persone classificabili come «postnazisti». E, a seguito di tale operazione, è diventato agente d’influenza di una potenza straniera, la Russia di Putin. Come Bossi prima di lui, Salvini è entrato in scena in quella che il filosofo Zygmunt Bauman ha definito la «società liquida». E in questa età postideologica il suo opportunismo si è potuto esplicitare in un modo ancora più intenso e sfacciato. La mancanza di costrizioni (o zavorre) dottrinali ha infatti favorito il successo di un’operazione che ha portato un movimento nato liberista e autonomista, quale era la Lega degli anni Ottanta, ad abbracciare cultura e scelte politiche di chiara impronta nazionalsocialista. La riuscita di questo takeover è attribuibile in parte al vuoto ideologico della nostra era. Ma ancor di più al cinismo, prima di Bossi e poi del suo giovane erede: due persone pronte a sposare qualsiasi causa e associarsi a qualsiasi persona pur di emergere e rimanere al centro dell’attenzione nazionale. Nelle pagine a seguire rivelerò l’identità e la storia dei principali protagonisti di questa trama, un manipolo di postnazisti che ha saputo trarre vantaggio da debolezze e difetti della democrazia liberale, individuando prima in Bossi e poi in Salvini i leader adatti per realizzare ciò che un comunista, Antonio Gramsci, aveva teorizzato: egemonizzare il dibattito culturale per assumere il controllo di quello politico. Se ho deciso di applicare a queste persone l’etichetta di postnazisti, non è solo per via di dichiarazioni e documenti che ho raccolto. O perché in una lunga chiacchierata con me, Robert Steuckers, loro amico e partner ideologico in Belgio, li ha definiti «nazisti evoliani». No, lo faccio a seguito di lunghe conversazioni con uno dei primattori di questo scenario, dal quale ho capito che è il termine più adatto per ricostruire un piano alla cui elaborazione e implementazione ha partecipato in prima persona. Che sia chiaro: non sto affermando che oggi Salvini, come ieri Bossi, abbia sposato la causa postnazista. E neppure che sia un burattino eterodiretto. Dico che, come il suo padre/padrino politico, Salvini è un uomo pronto a tutto. Incluso allearsi con i nemici della democrazia. Seppure la mia inchiesta dimostri come la Lega di Bossi e Salvini abbia normalizzato un costrutto culturale postnazista, sono convinto che i due leader del Carroccio lo abbiano fatto per puro e cinico calcolo politico. Di conseguenza, la sostenibilità – o provvisorietà – del complotto d’infiltrazione postnazista descritto in queste pagine è quasi irrilevante. A contare è il fatto che spregiudicatezza politica e mancanza di bussola etica hanno guidato i due leader del Carroccio in un crescendo di artifici demagogici, che nel corso di trent’anni li ha traghettati dalla xenofobia antimeridionale agli schemi culturali dei cospiratori postnazisti, oggi interamente assorbiti nella liturgia politico-culturale – ovvero «metapolitica» – della Lega. È sicuramente possibile che, essendo entrato nelle stanze dei bottoni al Viminale e a Palazzo Chigi, Salvini adesso cambi marcia. E la mancata candidatura di Mario Borghezio alle europee del maggio 2019 potrebbe essere il primo segnale. Ma poco importa. Armato di quegli schemi, Salvini è arrivato al potere alimentando, una dopo l’altra, teorie del complotto intese sia a inoculare paura e ansia nelle persone, sia a delegittimare le istituzioni italiane ed europee. Quest’operazione di manipolazione dell’opinione pubblica italiana ha avuto, come vedremo, tra i suoi protagonisti anche Marcello Foa, la persona che il ministro dell’Interno ha imposto al vertice della Rai, la più importante azienda giornalistico-culturale del paese. Come Mussolini con Hitler, Salvini ha inoltre dimostrato di essere pronto ad associarsi a chiunque, non solo in Italia ma anche all’estero. I cospiratori postnazisti gli hanno aperto le porte del Cremlino e lui si è buttato tra le braccia di Putin senza alcuna esitazione. Se il Duce impiegò anni, prima di seguire scodinzolando il Führer, il Capitano si è di fatto assoggettato all’ex spione del Kgb dal primo giorno in cui ha preso il timone dell’allora disastrato barcone leghista. L’analisi delle sue prese di posizione pubbliche dimostra infatti che, da quel lontano dicembre del 2013, Matteo Salvini ha cominciato ad agire da agente d’influenza del Cremlino. La rivista ufficiale della nostra intelligence, «Gnosis», ci spiega che l’agente d’influenza non è soltanto «un agente segreto che opera sotto mentite spoglie, diffondendo idee, sostenendo teorie, dirigendo movimenti di opinione secondo le direttive ricevute». Ma anche «colui che per convinzione personale agisce nello stesso modo, […] manipolato da altri e quindi senza rendersi conto, magari in buona fede, di operare per interessi estranei ed esterni e addirittura in contrasto con i propri e con quelli del proprio paese». La definizione continua così: «Sebbene spesso non siano legati da un rapporto organico con i servizi di intelligence, gli agenti d’influenza sono tuttavia “gestiti” e coordinati da strutture organizzate, riconducibili direttamente o indirettamente agli apparati di sicurezza e informazione o, comunque, al sistema di sicurezza e difesa di uno Stato, soprattutto nel caso di campagne d’influenza complesse, caratterizzate da un elevato livello di sofisticazione e proiettate a lungo termine». Sulla base di questa classificazione «governativa» dell’agente d’influenza, nelle pagine a seguire proverò che per anni Matteo Salvini ha operato in tale veste al servizio di un governo straniero, quello di Vladimir Putin, il più antidemocratico e aggressivo leader della storia europea contemporanea. E con lui, in quelle stesse funzioni, ha operato – e opera tuttora – un gruppetto di suoi associati, che con il nuovo governo hanno raggiunto posizioni di spicco. La grande macchinazione In quasi tutti i misteri e le trame italiane – dalla strategia della tensione alla campagna delle Brigate rosse – si rievoca l’immagine di un fantomatico «grande vecchio». Questa figura non viene però mai identificata con un nome e un cognome. Per un motivo semplice: non è mai esistito un vero e proprio burattinaio. Neppure in questa storia c’è un Grande Vecchio Burattinaio nel senso stretto del termine. Ma c’è un ispiratore, anzi un «Sommo Suggeritore». Si chiama Maurizio Murelli, ed è un ex militante di estrema destra con undici anni di galera alle spalle che nel corso di decenni ha supportato la costruzione di quell’intelaiatura cultural-politica attorno alla quale è stato costruito il successo del «fenomeno Salvini». Come sostiene Raphaël Glucksmann, promotore del movimento francese Place publique e figlio del nouveau philosophe André, «in Europa oggi la psicologia collettiva è reazionaria, alimentata da un discorso metapolitico. L’estrema destra ha vinto la battaglia culturale». Ma mentre nel resto d’Europa l’estrema destra si è affermata – o si sta affermando – con il proprio volto, in Italia vi è riuscita sotto copertura. O meglio, dietro la maschera leghista. Da un quarto di secolo, amati o disprezzati, Umberto Bossi e Matteo Salvini, con la loro Lega, hanno fatto la storia politica italiana rifuggendo da qualsiasi classificazione. Per decenni Bossi non ha mai smesso di proclamarsi antifascista, andando però al governo con gli eredi del fascismo, mentre Salvini da anni pretende di valicare la distinzione convenzionale tra destra e sinistra. Le varie mutazioni ideologiche, strategiche e tattiche, così come le tante trovate propagandistiche, hanno permesso loro di tenere in vita questa sceneggiata. A questo punto, probabilmente ognuno di voi ritiene di avere un’idea abbastanza chiara – positiva o negativa che sia – di Bossi, Salvini e la Lega. Di conseguenza ha una propria interpretazione per il successo che Salvini ha raggiunto. Ma qualsiasi spiegazione vi siate dati dovrà essere rivista per incorporare elementi e testimonianze raccolte in questo libro. Qui infatti troverete vicende personali, politiche e metapolitiche inedite che giustificheranno una revisione della storia non solo della Lega, ma della stessa politica italiana. Vicende che faranno emergere la straordinaria influenza avuta da un’area politica, quella della destra radicale, che si è quasi sempre pensata marginale ed emarginata. La sopravvivenza e la successiva affermazione di un movimento più volte dato per spacciato, quale la Lega, sono infatti attribuibili, in gran parte, a una macchinazione di quella destra. Che prosegue da decenni. Occultamente, ma sotto gli occhi di tutti. Controcanto In coda a ogni capitolo ho inserito una storia parallela, quella dei Levi-Sacerdoti, la famiglia della professoressa di matematica e fisica di Matteo Salvini, che come tutti gli ebrei italiani a partire dal 1938 furono prima discriminati e poi perseguitati dai fascisti e dai loro alleati nazisti. Il motivo è semplice: solo questa duplicità di piani può a mio giudizio conferire la completezza necessaria alla mia inchiesta. Lo scontro tra Pensiero democratico e Pensiero postnazista, e tra i Mondi e i Valori inconciliabili che ognuno di essi rappresenta, non può infatti esser capito in tutte le sue ramificazioni, se non attraverso una storia parallela a quella del protagonista che l’affianchi in una contraddittoria unitarietà. Perché le due storie non possono essere disgiunte. Le gesta di Matteo Salvini non possono essere comprese fino in fondo senza conoscere la tragedia della famiglia Levi-Sacerdoti. Per questo ho ritenuto che ogni capitolo dovesse registrare la costante presenza dei Levi-Sacerdoti. Affinché le loro esperienze di vita facciano da controcanto all’opportunistico cinismo di chi chiede di ignorare le lezioni del passato. Il rigetto della Storia da parte di Salvini è la sua maschera. Grazie alla finzione di quella maschera – al suo gioco di presenza/assenza – il Capitano può diffondere un Pensiero che spaccia come privo di Storia. I ricordi della famiglia Levi-Sacerdoti annientano quella maschera. E riportano al centro la Storia. Nei cieli della Padania e dell’Ucraina Quella del 2014 è un’estate densa di avvenimenti su fronti diversi. Senza alcun apparente collegamento tra loro. Langhe piemontesi, provincia di Cuneo Il quarantottenne ingegnere elettronico Alberto Sciandra ha da anni abbandonato la politica attiva, senza però perdere l’interesse per la cosa pubblica. Nei risultati delle recenti elezioni europee ha registrato il successo del Pd di Matteo Renzi, ma anche la buona tenuta dell’altro Matteo: Salvini, da poco divenuto leader del soggetto politico a cui lui si è dedicato, possiamo dire, anima e corpo. Sin dai giorni della preistoria leghista, quelli dell’allora Piemont autonomista, Alberto Sciandra si è infatti buttato a capofitto nel movimento che sarebbe successivamente confluito nella Lega Nord. Il suo fine era quello di plasmare il nascente Carroccio a immagine e somiglianza ideologica di quell’etnonazionalismo «guerriero» che aveva scoperto nei primi anni Ottanta al liceo e che nei successivi anni dell’università aveva passato a rielaborare assieme a Maurizio Murelli, il più incisivo dei discepoli di Franco Giorgio Freda, padre della destra eversiva italiana. «Avevamo un progetto di contaminazione. O d’inseminazione» spiega oggi Alberto Sciandra. «L’idea era quella di dare forma a un corpo che si stava creando e che poteva essere vincente perché veniva dal popolo, ma era privo d’anima, quindi facilmente influenzabile e controllabile. Anche perché ritenevamo che, nel suo profondo, quel corpo avesse esigenze ideologicamente coerenti con il pensiero della destra radicale, la nostra area di appartenenza.» In base a un piano elaborato sotto la guida spirituale di Maurizio Murelli, al fianco di Mario Borghezio, Sciandra si è «infiltrato» nella Lega. L’obiettivo era di fare del Carroccio un soggetto politico che potesse riprendere la «fiaccola metapolitica» del Terzo Reich e della Repubblica di Salò. Proprio quella contro cui suo padre Ugo aveva combattuto, scegliendo di andare in montagna, dove era rimasto per un anno e mezzo, subendo anche una ferita in uno scontro a fuoco. Colto, sveglio, intelligente e, come ogni buon ingegnere, «ben strutturato», Alberto Sciandra, figlio di un partigiano, non ha avuto difficoltà a far carriera nella Lega. Fino a diventare segretario provinciale, membro del Consiglio nazionale piemontese e organizzatore del primo giorno della più grande kermesse della storia leghista: quella iniziata il 13 settembre 1996 con la raccolta in un’ampolla delle «sacre acque del Po» e finita due giorni dopo con lo spettacolare giuramento di indipendenza della Padania fatto da Umberto Bossi a Venezia. Località italiana non conosciuta In quei caldi mesi estivi del 2014 Maurizio Murelli sta completando la sua prima opera di narrativa, un testo «semiautobiografico» intitolato Indian Summer ’70: c’era una volta San Babila. Ma è solo una digressione temporanea. La sua passione è – e rimarrà – la saggistica. La migliore ricostruzione della sua attività editoriale la offre lui stesso in un’intervista data poche settimane prima a Radio Bandiera Nera, l’emittente di CasaPound, il partito dei sedicenti «fascisti del terzo millennio». La conduttrice della trasmissione presenta la casa editrice di Murelli, Orion Libri, dicendo che «è punto di riferimento delle forze antagoniste dell’alta finanza internazionale, [… avendo] orientato con la propria rivista e i propri libri tutti coloro che si sono ribellati al dominio culturale, politico ed economico dei vincitori della Seconda guerra mondiale e dei loro lacchè nostrani». Dopodiché chiede a Murelli di spiegare il nazionalcomunismo, un progetto politico da lui diffuso e sostenuto. Murelli non si tira indietro: «È stato un tentativo di bypassare la questione fascismo/antifascismo, andando all’origine di formulazioni nate tra persone che avevano partecipato all’attività dei primi anni Settanta e che si ritrovavano, dopo il carcere e dopo varie esperienze». In pratica, dice, è un tentativo di rilanciare il fascismo rivoluzionario, quello «diciannovista» che ha preceduto il fascismo di regime, quindi non ancora «corrotto» dalle due grandi forze con cui Mussolini è dovuto scendere a patti: la Chiesa e la Corona. Murelli parla anche dell’avventura dannunziana di Fiume usando il termine «fiumanesimo», che presenta come uno di quei «giacimenti sotterranei» alla base dell’ideologia e dello spirito del fascismo della prima ora, quello che piace a lui e vuole far rivivere. Quando la conduttrice gli chiede di illustrare i progetti editoriali su cui sta lavorando per il resto del 2014, Murelli dice: «Il più topico è la riproposizione dell’intera collezione di “Gerarchia”, la rivista voluta da Mussolini, uscita per oltre vent’anni. Ho recuperato quasi tutti i numeri». Con l’audience amica di Radio Bandiera Nera, Murelli non esita a scoprirsi, spiegando che il «fiumanesimo» rimane a suo giudizio uno dei perni ideologici attorno ai quali far ripartire un’azione di lotta politica. Lo presenta infatti come antesignano del movimento antimondialista, per via della sua lotta allo «strapotere e all’arroganza della Società delle nazioni», l’organo intergovernativo precursore dell’Onu. «Lì c’è tutto quanto può essere ancora oggi di attualità. È quel fascismo solare, allegro, squadristico nel senso vitale del termine» spiega con enfasi. «Credo che lì i giovani possano trovare quella dimensione che può dare piena soddisfazione e suggerimento per una nuova elaborazione.» Quando la conduttrice lo spinge a parlare del suo ruolo nella lotta politica, inizialmente la prende alla larga: «Noi usiamo impropriamente il termine “fare politica”. Ci sono persone che sono impegnate per il mutamento, mentre fare politica significa avere la capacità – o la possibilità – di amministrare lo Stato, o la polis. In realtà noi siamo militanti impegnati per il mutamento». Nel clima gioviale e rilassato di quell’intervista, Murelli non resiste alla tentazione di essere più specifico: «Credo sia opportuno che quelli della mia età si mettano nelle retrovie e si occupino della logistica, mandando avanti i giovani. Noi mettiamo a disposizione il munizionamento. Fabbrichiamo munizioni. Che poi le usino come meglio credono». Di «munizioni» Murelli è senza dubbio un esperto. Nell’intervista radiofonica si riferisce a quelle di natura intellettuale, ma nella sua vita di «guerriero» ha maneggiato anche munizioni di genere militare. Mi riferisco al suo ruolo nel cosiddetto «giovedì nero di Milano», giorno in cui una bomba a mano uccise l’agente di polizia Antonio Marino. Non è, ovviamente, un tema di cui ama parlare. Ma se si vuole conoscere Murelli non lo si può ignorare. È il 12 aprile 1973 e il teatro è quello di Milano. Da ore nella zona tra Porta Monforte e Porta Venezia centinaia di giovani neofascisti si scontrano con reparti della Celere. Bulloni, sassi, biglie d’acciaio e bottiglie molotov contro lacrimogeni e manganelli. In via Bellotti infuria la guerriglia urbana. I suoni degli spari dei candelotti lanciati dalla polizia, il fumo irritante che acceca e prende alla gola, le urla dei dimostranti. Poi, un boato. Due poliziotti vengono travolti e gettati a terra. Uno si rialza. L’altro, Antonio Marino, no. Viene immediatamente circondato dai colleghi del Terzo Reparto Celere. Non si muove. Ha il petto squarciato e nel giro di pochi secondi si forma una pozza di sangue. Si capisce subito che non c’è niente da fare per quel giovane ventiduenne originario di Caserta. A ucciderlo è una bomba a mano di tipo Srcm lanciata da Vittorio Loi, giovane neofascista figlio del pugile Duilio Loi. Gliel’ha data Murelli, che ne ha altre due. Una l’ha lanciata lui stesso poco prima in piazza del Tricolore. «Per creare panico» scriverà il giudice. Della sua responsabilità in quell’omicidio Murelli non si è mai dichiarato pentito: «Io non credo di aver fatto nulla di sbagliato. Nel fatto specifico, è chiaro che sono dispiaciuto di essere stato coinvolto nella morte di un giovane. Questo va da sé. Ma è stata una situazione in cui non è dipeso tutto da me» mi dice quando ci parliamo telefonicamente. Gli faccio notare che ha fornito lui la bomba a mano che ha ucciso Marino. E che in quarant’anni ha avuto tutto il tempo per riconoscere perlomeno di aver fatto «un errore». Ma lui non ha detto neppure questo. Mi risponde che la responsabilità va attribuita piuttosto alla Prefettura milanese la quale, dopo aver inizialmente concesso l’autorizzazione per un comizio del Msi, nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto svolgere quel comizio, aveva ritirato il permesso: «Non si può parlare di errore. È una contingenza specifica da cui viene fuori un fatto luttuoso. C’è una repressione, c’è una reazione e ci scappa il morto. Punto. Io ero dalla parte del giusto da quel punto di vista. In un’intervista trasmessa dalla televisione, dico che sono dispiaciuto di questa cosa. Ma il vero responsabile di quella morte non sono io. A parte il fatto che non l’ho ucciso io materialmente… Tenga presente che lei parla di bomba, ma non erano bombe. Erano Srcm, che sono poco più di petardi. L’Srcm è una bomba d’assalto che non produce schegge. La sfortuna è stata che lo ha colpito sul petto. […] Ma era considerata un petardo, che ha avuto purtroppo un effetto che non doveva avere. […] Se si parte dicendo che era una bomba, chiaramente la cosa diventa pesante. Ma non è così. Furono degli scontri di piazza, nei quali furono usati dei petardi. E un petardo ha avuto un effetto letale». Non è vero. Quelle che Murelli chiama «petardi» sono infatti classificate come «bombe da addestramento». E, in un post nel blog fascinazione.info del 19 ottobre 2010, lui stesso lo ha riconosciuto, scrivendo che l’agente Marino è stato «ucciso da una Srcm, ovverosia una bomba da esercitazione». In carcere Murelli ha scoperto la «via del sacerdote». Questo lo ha portato prima ad aprire una piccola casa editrice a Saluzzo, in provincia di Cuneo, la Società Editrice Barbarossa, e poi a lanciare «Orion», una rivista «di idee e di azione». Le sue idee. Le azioni degli altri. Cieli dell’Ucraina Il 17 luglio di quell’estate del 2014, un missile abbatte un Boeing della linea aerea malese in servizio da Amsterdam a Kuala Lumpur con la sigla MH17. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio – quasi trecento persone di ogni età – perdono la vita. L’abbattimento, in una zona di scontri fra le truppe di Kiev e i secessionisti filorussi della regione orientale del Donbass, viene quasi immediatamente attribuito ai ribelli. E indirettamente alla Russia, il loro grande sponsor. Stati Uniti e Unione europea rispondono a quella tragedia deliberando una nuova e più severa tornata di sanzioni economiche contro la Russia. La situazione nella regione è infuocata da mesi, la Crimea è al centro delle tensioni tra Russia e Ucraina, soprattutto dopo che le proteste esplose a Kiev, in Majdan Nezaležnosti (piazza Indipendenza) hanno portato alla deposizione del presidente filorusso Viktor Janukovyč. Per Putin è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Deciso a reagire, ha inviato truppe in uniformi verdi sprovviste però di mostrine o bandiere che possano ricondurre al corpo o al paese d’appartenenza. Senza colpo ferire, quegli «omini verdi» hanno occupato le basi militari, l’aeroporto e il Parlamento di Sinferopoli. Il mese successivo, in un referendum organizzato in fretta e furia e condotto sotto l’occhio vigile degli omini verdi, gli abitanti della Crimea hanno votato a favore del ricongiungimento della loro regione alla Madre Russia con la percentuale bulgara di oltre il 97 per cento. Per il Cremlino è la prima vittoria ottenuta applicando la cosiddetta «dottrina Gerasimov», dal nome del generale Valery V. Gerasimov che pochi mesi prima aveva illustrato in un articolo ormai passato alla storia la sua idea di «guerra ibrida», fatta di interventi militari e azioni propagandistiche. Il meno riconoscibili e palesi possibile. Milano, letteralmente dietro l’angolo di via Bellerio, sede storica della Lega Dai nuovi uffici dell’Associazione Lombardia Russia, Gianluca Savoini, ex giornalista de «la Padania» e amico di Mario Borghezio, divenuto portavoce del nuovo segretario della Lega Matteo Salvini, posta un video di presentazione della creatura da lui costituita: «Abbiamo fondato l’associazione cinque mesi fa proprio nel momento in cui stavano esplodendo i fatti dell’Ucraina, perché abbiamo visto una certa disinformazione nei confronti di tutto ciò che riguarda la Russia e l’Ucraina. Si sta formando un’opinione pubblica in Occidente che viene addestrata a credere che gli aggrediti siano gli aggressori». E in commento sul sito aggiunge: «Per fortuna, [la gente] si sta stancando delle balle raccontate dalla propaganda mondialista. W la Russia! W la libertà! W l’Eurasia dei popoli!». Pochi giorni dopo Savoini mette in rete un nuovo video, diffuso dal ministero della Difesa russo che, a suo dire, mostra un caccia dell’esercito ucraino a tre chilometri dal Boeing nel momento dell’abbattimento. È il primo di una serie di post in cui il presidente dell’Associazione Lombardia Russia solleva dubbi, alimenta sospetti e diffonde scenari alternativi. Tutti ovviamente intesi ad assolvere Mosca. Parlamento europeo, Bruxelles Dopo aver celebrato con un post su Facebook la vittoria degli «annessionisti» al referendum sul ritorno della Crimea alla Russia, quell’estate l’europarlamentare Matteo Salvini firma un’interrogazione alla Commissione europea in cui si mette in discussione la riservatezza mantenuta sull’indagine riguardante l’MH17. Il dubbio implicito è che quel riserbo sia sospetto. Che ci sia qualcosa da nascondere e che provi che le sanzioni contro la Russia sono ingiustificate. A firmare con lui è anche Mario Borghezio, appena rieletto al Parlamento europeo. Il Cuore del Mondo, blog di Marcello Foa Ancora in quell’estate del 2014, Marcello Foa, l’ex inviato de «il Giornale» divenuto manager editoriale in Svizzera, posta un’analisi in cui rivela retroscena ignoti o, peggio, ignorati dai suoi colleghi: Sieti sicuri di aver capito cosa sta accadendo in Iraq, e perché Obama abbia dichiarato guerra all’Isis? Come sempre c’è la verità formale, quella sotto gli occhi di tutti, e quella sostanziale. È un attacco, come viene chiamato in gergo giornalistico l’inizio di un articolo, tipico di Foa, il quale da anni si propone come esperto di tecniche di manipolazione di massa. A consentirglielo, oltre alla sprovvedutezza di alcuni colleghi, è un libro da lui scritto, Gli stregoni della notizia, una mistura di banalità e risaputi principi di psicologia delle masse mescolati a granelli di verità conditi con paroline inglesi – spin, spin doctor, frame e framing – che produce un vero e proprio manuale della teoria del complotto. Continua il post di Foa: Come ampiamente dimostrato su questo blog, l’Isis non esce dal nulla ma è un «mostro» religioso e militare che proprio gli Usa e alcuni alleati strategici come il Qatar e l’Arabia Saudita hanno incoraggiato e sostenuto. […] Arabia Saudita e soprattutto Qatar hanno fornito aiuti finanziari. Gli americani, e verosimilmente i turchi, assistenza militare e fornitura d’armi. […] Una regione che fino a poco tempo fa era un baluardo di stabilità è così diventata il focolaio di crescente instabilità. Con conseguenze pesantissime per noi europei, che viviamo non lontano da quelle zone, e per tutti coloro che del petrolio mediorientale hanno bisogno. L’America invece da qui a sei-sette anni non avrà più bisogno di quel petrolio, grazie allo shale oil di cui dispone in grande quantità. Capito l’arcano? È Foa al meglio: diretto, sicuro e messaggero di retroscena tanto terribili quanto inediti. Come quelli che aveva svelato pochi mesi prima sull’Ucraina: Che cosa avete capito della crisi ucraina? Verosimilmente che il popolo ucraino si è ribellato contro un presidente arrogante e autoritario, Viktor Janukovyč, il quale ha cercato di reprimere la protesta, uccidendo decine di persone, ma che alla fine è stato destituito. La Russia si è arrabbiata e per ripicca ha invaso la Crimea. Confusamente tu, lettore, avrai capito che il popolo vuole entrare nell’Unione europea, mentre Janukovyč e, soprattutto, Mosca si oppongono. Fine. La realtà, però, è un po’ diversa e assai più interessante. Funziona così: proteste di piazza in apparenza spontanee sono in realtà pianificate con cura e guidate per il tramite di organizzazioni non governative, associazioni umanitarie e partiti politici; in un crescendo di operazioni pubbliche amplificate dai media internazionali e con appoggi all’interno delle istituzioni, in particolare dell’esercito, che finiscono per provocare la caduta del tiranno. «Il Giardino del Tango», Roma Nella grande sala aperta solitamente popolata da tangueros si celebra l’anniversario della fondazione di Avanguardia nazionale, gruppuscolo di estrema destra disciolto negli anni Settanta. Dietro al tavolo dei relatori, che indossano una maglietta dello stesso «rosso nazista» scelto per la bandiera di Avanguardia nazionale, assieme al simbolo della Runa ôþalan, nera su sfondo bianco, c’è il fondatore e leader storico, Stefano Delle Chiaie. Accanto a lui siede Bruno Di Luia, altro socio fondatore. Il quale prende il microfono. La scena viene ripresa in un video postato su YouTube. «Cameratiii» ordina Di Luia, «a-ttenti!» Avendo strappato il silenzio della sala, Di Luia continua con crescente enfasi: «Per i camerati defunti!». Tra il pubblico tutti piegano il braccio destro portando il pugno sul petto. E rispondono in coro: «Presente!». Di Luia ripete: «Per i camerati defunti!». «Presente!» Poi una terza volta, con ancor più veemenza: «Per i camerati defunti!». «Presente!» Soddisfatto, Di Luia chiude la celebrazione: «Camerati, ri-poso!». Il resto delle attività di quelle giornate è ricostruibile grazie ad altri video e alla testimonianza di un militante, anch’essa messa in rete. I lavori iniziano con la proiezione di un breve filmato su Stefano Delle Chiaie e gli altri protagonisti di Avanguardia nazionale, sulla rivolta di Reggio Calabria, la strage di piazza Fontana, il golpe Borghese, e infine la creazione di quella che solitamente viene chiamata «l’internazionale nera». Il dibattito è aperto dal professor Mario Merlino, il neofascista romano ordinovista e poi avanguardianazionalista, che due mesi prima di Piazza Fontana si rese protagonista di un’incursione politica aderendo al circolo anarchico XXII marzo, il gruppo di Pietro Valpreda, inizialmente accusato della strage. Merlino ricorda ai presenti i motivi della nascita di Avanguardia nazionale e ripercorre le date più salienti degli anni Sessanta e Settanta che lo hanno visto protagonista in prima linea, onorando anche lui «i camerati caduti in battaglia». Tra gli applausi dei presenti, il professor Merlino dà poi lettura di una missiva a lui giunta da «camerati russi e ucraini» che esortano alla «lotta unitaria per una nuova Europa dei popoli, contro il potere della finanza e dei burocrati di Bruxelles». Dopo l’intervento di Merlino, è la volta di Delle Chiaie, che sottolinea di non essere stato fascista, bensì nazionalsocialista, e ricorda con nostalgia il suo Manifesto di Pomezia: «Nel 1972 noi parlavamo di mondialismo, quando nessuno sapeva cosa era. […] Noi dicevamo quello che oggi viene detto quotidianamente». Delle Chiaie ha il tono di un combattente che ritiene di aver visto giusto, ma è deluso dai riconoscimenti ottenuti. Un combattente ormai stanco. A confortarlo si fa avanti Mario Borghezio, appena rieletto al Parlamento europeo nel collegio dell’Italia centrale, grazie proprio al supporto di quei vecchi amici. L’eurodeputato leghista cita con fervore il «nostro compito metapolitico», parla dei «nostri simboli ancestrali, della nostra etnia», e facendo riferimento alla grande bandiera di Avanguardia nazionale alle sue spalle aggiunge: «Siamo orgogliosi di essere i figli dei figli di quelli che hanno tracciato questi simboli». Rivolgendosi poi a Delle Chiaie, Borghezio chiude con apoteosi retorica: «Io ti dico: Comandante, è ora di dissotterrare l’ascia di guerra perché un popolo sente il bisogno – e oggi il nostro popolo sente questo bisogno – di una rivoluzione nazionale. Noi abbiamo semplicemente il dovere di metterci alla guida di questa rivoluzione nazionale. E questo è il compito anche tuo!». L’incontro procede con le esortazioni di altri reduci del neofascismo, da Gabriele Adinolfi ad Adriano Tilgher, a non mollare. Perché, come dice Tilgher, quella che hanno davanti «è una realtà in espansione». Nella seconda giornata della kermesse neofascista, Delle Chiaie si sente in dovere di spiegare il proprio stato d’animo: «Ieri ho sentito Borghezio e altri che hanno detto che c’era amarezza nella mia espressione. Non c’è amarezza. C’è la coscienza di essere quasi inutile». In un momento di intimismo molto poco nazionalsocialista, Delle Chiaie confessa: «Mi sento in pensione. In una strana pensione fatta di inattività, di incapacità di confrontarmi con quello che mi circonda. Abituato com’ero alla lotta politica quotidiana – serale, notturna e diurna – mi sento morire giorno per giorno. Soltanto parole. E assenza totale di azione». Sin da giovane Delle Chiaie ha intrapreso la «via del guerriero». Ha combattuto in Italia, in America Latina, in Africa. Ma, dopo decenni di lotta (peraltro macchiati da accuse di asservimento ai servizi segreti), si ritrova «in pensione» a Roma. A contare i giorni. Sicuramente non ha vinto. Ma la grande ironia è che nella sua autocommiserazione non capisce che a vincere sono stati altri camerati. Di matrice nazionalsocialista come lui, incluso quel Borghezio che il giorno prima lo ha remissivamente chiamato «Comandante». A differenza di Delle Chiaie, dopo anni di militanza «guerriera» quei camerati lì hanno infatti capito che la «via del sacerdote» – quella della guida spirituale che agisce da dietro le quinte – avrebbe pagato di più. E hanno deciso di seguire in modo più accorto il manuale di chi, dopo aver vissuto i giorni della caduta di Mussolini e Hitler, più di ogni altro si è sforzato per dare una nuova vita al pensiero mitologico illiberale, antilluminista e «fiumanista» alla base di fascismo e nazismo. Mi riferisco a Julius Evola e al suo saggio Orientamenti, pubblicato nel 1950, che dice: «Se i nostri uomini furono o no all’altezza del compito, se errori furono commessi […], non è cosa che pregiudica il significato interno della lotta che fu combattuta. […] Il problema da porsi è: esistono ancora uomini in piedi in mezzo a queste rovine? E che cosa debbono, che cosa possono essi ancora fare?». Evola suggerisce di non pensare a un nuovo «partito», ma concentrarsi «piuttosto su una rivoluzione silenziosa, procedente in profondità, che si deve propiziare, a che siano create prima all’interno e nel singolo le premesse di quell’ordine, che poi dovrà affermarsi anche all’esterno, soppiantando fulmineamente, nel momento giusto, le forme e le forze di un mondo di sovversione». Affinché «la gioventù riprenda la fiaccola, imparando dagli errori del passato». Il fatto che quella fiaccola fosse stata inizialmente ripresa da figure compromesse con il passato e legate a schemi «partitici» come il repubblichino Pino Rauti o suoi seguaci quali Delle Chiaie & Co., ha portato istituzioni, media e analisti democratici a focalizzarsi su quelle frange estremiste e sulle rappresentazioni politiche da loro create. Nessuno ha invece notato che, mentre i neofascisti dichiarati – da Stefano Delle Chiaie ad Adriano Tilgher, da Gabriele Adinolfi a Roberto Fiore – erano circoscrivibili, in quanto identificabili e associabili al passato da dimenticare, camerati più evoliani ed evoluti di loro lavoravano sottotraccia per dare continuità storica all’«essenza» dell’ideologia nazionalsocialista, cioè la sua anima tradizionalista, gerarchica, razzista e, ovviamente, antigiudaica. Agendo nell’ombra questi «camerati» hanno capito che occorreva puntare su un veicolo nuovo, al quale non potesse essere imputata alcuna delle tragedie indifendibili – Olocausto in primis – degli anni Trenta e Quaranta; sulle facce pulite e insospettabili di Umberto Bossi e Matteo Salvini, bersagli ideali in quanto spregiudicati leader di quello che Alberto Sciandra definisce «un corpo senz’anima». Quindi contaminabile. E che, come vedremo, col tempo è stato contaminato da agenti invisibili ingaggiati dal Sommo Suggeritore. *** La mamma mi raccontava che mio nonno materno, Leone Levi, che non ho mai conosciuto perché morì nel 1921, soleva dire alle sue figlie: «Siete fortunate perché l’era dei ghetti è passata. Voi siete libere di studiare, di inserirvi in una società senza pregiudizi». Si sbagliava. Dalle memorie di Silvana Sacerdoti Il primo vagito La folgorazione del «giovane» Bossi La Lega non è mai stata un vero partito. Dal suo primo vagito è sempre rimasta il veicolo del suo leader. Per questo la sua storia segue prima quella di Umberto Bossi, poi quella di Matteo Salvini. L’avventura politica di Bossi comincia – sorpresa, sorpresa – con una bugia. Seppur piccola. Oserei dire, tascabile. Siamo nel 1975 e, in seguito al golpe in Cile contro il presidente socialista Salvador Allende, «l’Umberto», come è noto agli amici, decide di iscriversi al Partito comunista, sezione di Verghera, in provincia di Varese. Accompagna il pagamento della quota di cinquemila lire con la sua prima balla legata alla politica: si dichiara medico. In realtà non è medico. Né lo diventerà mai, nonostante rimanga iscritto alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia fino alla soglia dei quarant’anni. In quello stesso anno, il 1975, si sposa con Gigliola Guidali, di undici anni più giovane. Va a vivere con lei in un trilocale al piano terra e si mantiene grazie allo stipendio di commessa della moglie e qualche aiuto della madre. «Umberto mi ha sempre riempito di inganni e di bugie. È un fannullone, caratterialmente incapace di avere un lavoro» dirà Gigliola nel 1994, nell’unica intervista da lei mai concessa, quella al settimanale «Oggi». «A quei tempi sembrava che diventare medico fosse la sua massima aspirazione.» L’aspirazione forse c’era, ma i progressi nelle aule universitarie a Pavia non arrivano. In compenso l’Umberto si diletta su altri fronti. Prima quello dell’elettronica («Aveva imparato a trafficare con i fili, le resistenze e le valvole» ha spiegato la sua ex consorte), poi quello della fotografia («Aveva comprato una Nikon, e non faceva altro che scattare»), quindi della pittura e infine della poesia dialettale. La sua vera vocazione, quella definitiva, la scopre a quasi trentotto anni, nel 1979, quando nell’atrio dell’Università di Pavia incontra Bruno Salvadori, l’autonomista valdostano che gli parla del diritto all’autodeterminazione dei popoli contro gli Stati centralisti. Folgorato dall’idea, Bossi decide di gettarsi a corpo morto nella battaglia autonomista, investendo ogni sua risorsa. In verità non solo sua. Anche di Gigliola. «Un giorno, andando in banca, scoprii che sul conto corrente non c’era più niente. Aveva preso tutto lui, fino all’ultima lira» ricorderà lei al giornalista di «Oggi». Sotto la guida di Salvadori, l’Umberto familiarizza con problematiche e teorie su cui, da Altiero Spinelli in avanti, si sono cimentati fior fiore di politologi e pensatori europei. Non ha né gli strumenti accademici né il tempo per andare troppo a fondo, ma è molto sveglio. E ha una grandissima capacità di estrapolare l’essenza «apostolica» di una dottrina, ciò che può attrarre seguaci. Tramite Salvadori viene a conoscere le idee del francese Guy Héraud, che aveva elaborato la dottrina istituzionale del «federalismo integrale», in risposta a quello che lui considerava un «processo di oppressione» delle minoranze etniche e linguistiche da parte dello Stato centralista. Più volgarmente nota come dottrina delle «Piccole patrie» o dell’«Europa dei popoli», è un’idea che si presta a un’interpretazione tanto libertariosinistreggiante, come quella data da catalani e scozzesi, quanto di estrema destra, come in voga tra i fiamminghi del Vlaams Blok. Cosa avesse in mente Bossi me lo spiega Giuseppe Leoni, l’architetto del varesotto che nel 1984 ha fondato con lui la Lega autonomista lombarda, primo nome della Lega, e nel 1987 è stato eletto in Parlamento assieme a quello che da allora diverrà noto come il Senatùr: «Io penso che nella testa di Bossi ci fosse una grande confusione. Parlava di autonomismo, di separatismo, di federalismo. Aveva delle miscele in testa. Andavano bene tutte pur di cambiare il modello che viveva in quel momento lì. Quindi poteva essere separatismo, o autonomismo o federalismo. Era una grande miscela di parole diverse che lo Stato non utilizzava». Secondo le classificazioni convenzionali, mi spiega Leoni, la Lega di quegli anni è chiaramente antifascista. «All’inizio i fascisti erano tutti delle merde, e guai a mettersi con loro» dice l’architetto senza giri di parole. Anche perché sia Bossi sia Leoni hanno una storia famigliare di lotta partigiana: «Io avevo uno zio che aveva combattuto in Val di Susa e che era anche finito a Dachau». E poi ricorda: «Sono il primo consigliere comunale della Lega a Varese e nel 1985, quando entro in consiglio, il segretario generale del Comune mi fa sedere a destra. Ma io dico: “Siamo matti? Io non sto a destra”. E mi metto al centro. Stessa cosa quando sono arrivato in Parlamento: sono sempre stato seduto in mezzo all’emiciclo». Riferendosi sempre alla metà degli anni Ottanta, quindi agli albori politici della Lega, Leoni ricorda quando sarebbe dovuto andare a Como per un comizio, ma Bossi decide di andarci al suo posto. «Va lui, esordendo con grande forza antifascista e dei tipi del Msi che erano in sala si alzano per riempirlo di botte. Lo salvano i poliziotti, quelli della Digos.» Ci sono poi le testimonianze documentali. Come un manifesto contro la destra nazionalista francese di Jean-Marie Le Pen, definita «fascista come i partiti di Roma». «Paragonare la Lega lombarda al Lepenismo» si legge nel testo «è un falso perché si tratta di movimenti politici con finalità diametralmente opposte.» E si spiega: «I movimenti autonomisti, tra cui la Lega lombarda, sono l’antitesi del fascismo perché lottano per ottenere uno Stato autonomista». Il magma dottrinale A confermare che la Lega iniziale non solo è antifascista, ma per nulla di destra è anche Marco Formentini, primo e (finora) unico sindaco leghista di Milano. «Il nostro era un movimento liberale e libertario con venature anarchiche» ricorda l’ex sindaco. «Bossi era uno spirito molto libero, sicuramente un antifascista… anzi, aveva simpatie a sinistra. Ne parlavamo, ne discutevamo. Lo ricordo perché per me quella dell’antifascismo era una condizione preliminare per un impegno politico.» Ciò non toglie che la Lega si trovi a crescere in un incestuoso magma dottrinale. Il suo grido di battaglia – e principale ragion d’essere – è infatti la differenziazione etnica, concetto d’impronta antiuniversalista che non può non attrarre chi appartiene al mondo della destra estrema. In particolare chi ha maturato la consapevolezza che le posizioni nostalgiche del Ventennio siano vicoli ciechi. Maurizio Murelli arriva a essere tra costoro solo dopo una progressione ideologica avvenuta durante gli anni del carcere, dove si era visto costretto a trovare una nuova forma di lotta. Puramente intellettuale. Ad abbandonare cioè la «via del guerriero» per intraprendere la «via del sacerdote». «L’editoria era l’unica possibilità che avevo per contribuire a quella che era un’attività di soldato politico» spiegherà nell’intervista a Radio Bandiera Nera. Fa la sua prima esperienza editoriale assieme al neofascista Mario Tuti, con il quale costituisce la redazione di «Quex» – pubblicazione il cui nome è ispirato al romanzo filonazista Der Hitlerjunge Quex (Il giovane hitleriano Quex) di Karl Aloys Schenzinger –, prodotta dal carcere grazie al supporto di un paio di militanti di Bologna. Definendosi «bollettino a diffusione interna a cura dei detenuti politici nazionalrivoluzionari», «Quex» dichiara di riconoscersi «in grandissima parte nelle posizioni rivoluzionarie espresse da Franco Freda», il capostipite della destra eversiva italiana. La rivista «Quex» propone inizialmente la costituzione di «nuclei rivoluzionari di minima entità che incentrino la loro opera sull’azione esemplare». Una di queste azioni è evidentemente quella di punire i traditori, tema al quale è dedicata una rubrica, «Écrasez l’infâme!» (Schiacciate l’infame). Nel numero del 1° marzo 1981 si addita come traditore Ermanno Buzzi, il neofascista condannato all’ergastolo per la strage di piazza della Loggia a Brescia, accusato di essere «un confidente dei carabinieri». Un mese dopo, durante l’ora d’aria, Buzzi viene strangolato. Ad assumersi la responsabilità dell’omicidio sono due detenuti dello stesso carcere, Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, di Ordine nuovo. In un comunicato ai giornali spiegheranno che la sua «turpe condotta e la provocata rovina morale e giudiziaria di diversi giovani erano per noi addebiti tali da fargli meritare la morte, a prescindere […] dalla sua attività di delatore e agente provocatore». In quello stesso numero di «Quex», l’ultimo pubblicato, esce un articolo in cui si dichiara fallita la lotta armata. Perché è venuta a mancare «la necessaria convinzione nei momenti chiave». Col tempo, Murelli affinerà la sua analisi fino a riconoscere che la lotta armata non è stata solo un fallimento, ma anche un errore: «Credere nell’efficacia del terrorismo o nella lotta armata significa credere che questo Sistema ha con il suo attuale regime partitocratico un centro vitale individuabile fisicamente e che questo centro vitale possa essere soppresso. […] In realtà sul suolo d’Italia non esiste alcun centro di potere, ma solo e unicamente terminali perfettamente sostituibili e intercambiabili. E i governanti che di volta in volta si avvicendano altro non sono che mezzadri del potere autentico che è collocato altrove. […] Un’autentica forza politico-rivoluzionaria non può prescindere dal terreno sul quale si muove. Quello sul quale ci muoviamo noi non è quello […] della Germania prenazista o dell’Italia prefascista. Quindi tutte le idealizzazioni della rivoluzione armata di fucile e pistola sono nocive e inadatte. Noi viviamo e cresciamo su un terreno che vede in atto uno scontro frontale tra vari sistemi di conduzione del potere. […] Questo scontro vede il fronteggiarsi di due bracci “armati” preferiti (massoneria e alta finanza) attraverso un’infinità di terminali, dalle banche a organizzazioni quali la Trilateral». Murelli comprende con le sue analisi che occorre ricreare l’humus culturale per propiziare quella «rivoluzione silenziosa, procedente in profondità» di cui parlava Julius Evola, lavorando a un progetto politico che non si limiti a replicare sic et simpliciter i modelli della prima metà del secolo. Si fa avanti l’idea di aprire una casa editrice. A ispirarla è Franco Giorgio Freda, che nel 1963 era stato il primo rappresentante della cosiddetta «destra antagonista» a lanciare una casa editrice, le Edizioni di Ar. Anziché esordire pubblicando «classici» come Mein Kampf o i titoli del solito Julius Evola, Freda era partito con il Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane di Arthur de Gobineau, un diplomatico e scrittore francese vissuto nella prima metà dell’Ottocento, sostenitore del cosiddetto «determinismo razziale». Nel 1969 Freda aveva poi scritto La disintegrazione del sistema, opera nella quale aveva lanciato l’idea di un’alleanza tra postfascisti e ultrasinistra finalizzata ad accelerare la fine del sistema liberalmercantilista. È lo scenario di quella «sintesi politico-culturale» che verrà patrocinata da tutti i discepoli di Freda e che i media battezzeranno sommariamente «nazimaoismo». Da dentro il carcere, con un gruppo di giovani di Saluzzo, Murelli decide di fondare la casa editrice Barbarossa, il cui primo libro, «per via delle condizioni in cui eravamo, non poteva essere marcatamente politico». La scelta cade su Crociata contro il Graal. Chi non è un fanatico del nazismo deve sapere che autore di quel libro è il tedesco Otto Rahn, che dopo aver aderito alle SS era stato assegnato all’Ahnenerbe, l’ufficiostudi delle SS incaricato di provare «scientificamente» che i tedeschi discendevano da un’antica razza ariana, biologicamente superiore a tutte le altre. Nel 1937, con l’imprimatur dell’Ahnenerbe, Rahn aveva pubblicato il suo secondo libro, La Corte di Lucifero, opera così piaciuta al capo supremo delle SS, Heinrich Himmler, che ne aveva acquistate cento copie da far rilegare in pelle, di cui una donata allo stesso Hitler. Due anni dopo, nel marzo del 1939, Rahn era morto durante un’escursione in montagna e il generale delle SS Karl Wolf aveva siglato il suo necrologio: «Durante una tempesta di neve in montagna, la SS Obersturmbannführer Otto Rahn ha tragicamente perso la vita. Noi piangiamo, in questo camerata defunto, una SS onesta e autore di eccellenti lavori storici e scientifici». La Jeune Europe Anni dopo la pubblicazione del libro di Rahn, Murelli spiegherà che l’obiettivo della sua casa editrice era quello «di coltivare soggetti che intendono impegnarsi per il mutamento, per la resistenza, per la controffensiva. Un militante culturalmente ben preparato è infatti molto efficace e ha più potenzialità di un militante che si muove dentro un linguaggio fatto solo di emblemi, parole d’ordine, simboli e slogan. Inoltre le nostre piccole case editrici hanno il compito di salvare a futura memoria il pensiero elaborato nel secolo scorso dai nostri consimili, cioè dai nostri padri e nonni». Nonni come Adolf Hitler, Julius Evola e René Guénon, il filosofo francese morto nel 1951, famoso per la sua critica alla «modernità» e la celebrazione della Tradizione, intesa come trasmissione di un patrimonio anche simbolico. Padri come il belga Jean Thiriart che, dopo essersi schierato al fianco dei nazisti durante la guerra, nei primi anni Sessanta aveva fondato Jeune Europe, quello che ritengo possa essere definito il primo movimento «postnazista» europeo. Gli affibbio questa classificazione sulla base di quello che i suoi stessi fan saluzziani hanno scritto di lui. Come questo testo: Thiriart […] che durante la Seconda guerra mondiale ha militato nell’Amis du Grand Reich Allemand, associazione favorevole all’annessione del Belgio al Terzo Reich, […] nel gennaio 1963 [fonda] Jeune Europe, organizzazione europea presente in Inghilterra, Austria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera. Molto ben strutturata, insisteva molto sulla formazione ideologica in vere e proprie scuole quadri, […] Jeune Europe voleva fondare delle Brigate rivoluzionarie europee per iniziare la lotta armata contro l’occupante americano. […] È a lui che si rifanno negli anni Settanta i militanti dell’organizzazione Lotta di Popolo in Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia. Ancora più diretto è Gabriele Adinolfi, uno dei membri fondatori di Lotta di Popolo in Italia, che in un articolo intitolato Bentornati al futuro scrive: Fascismo, Europa, Rivoluzione, gridava in piazza la Giovane Italia quando, ancora poco più che un bambino, mi lasciavo coinvolgere e travolgere dal sogno di un cambiamento assoluto, dall’entusiasmo di un vento nuovo. […] Quel triplice motto, […] di conio recente, era ispirato da un’avanguardia, la Jeune Europe di quel Jean Thiriart che, in netto anticipo sui tempi, aveva visto giusto sui problemi e sui destini della nostra civiltà. […] Questa triplice parola d’ordine aveva soprattutto un radicamento nel sangue versato, spesso gioiosamente. Il fronte culturale della destra padana Nel 1984, Maurizio Murelli ottiene lo stato di semilibertà a Saluzzo, e in quell’occasione lancia un mensile, «Orion», come il nome di una delle costellazioni più amate dai navigatori, e con un riferimento dichiarato a Julius Evola, che nel 1950 aveva intitolato Orientamenti il libretto d’istruzioni per la destra postfascio-nazista. Attorno a quella rivista, Murelli raccoglie le principali «menti» della destra antagonista, figure per lo più legate a Franco Giorgio Freda. La prima di queste è Alessandra Colla, ex collaboratrice di Freda in Edizioni di Ar, per le quali aveva anche pubblicato un saggio su Ipazia, la filosofa neoplatonica uccisa da fanatici cristiani nel 415 d.C. Murelli e Colla si conoscono prima epistolarmente. Lui è ancora in carcere quando lei recensisce Crociata contro il Graal di Otto Rahn. Poi, in seguito al regime di semilibertà di Murelli, Colla si trasferisce a Saluzzo e, poco dopo, i due si sposano. L’annuncio viene dato sulle pagine di «Orion»: «Il 15 dicembre 2737 Alessandra Colla e Maurizio Murelli hanno celebrato le loro nozze». L’anno è calcolato a partire dalla fondazione di Roma, anziché dalla nascita di Cristo. I due vanno a vivere insieme in un appartamentino che ogni sera alle ventidue lui deve lasciare per tornare a dormire in carcere. A «Orion» collaborano altre tre persone, convinte come Murelli che lo scontro politico si debba innanzitutto preparare sul fronte cultural-concettuale. Il primo è Claudio Mutti, altro discepolo di Freda, convertitosi all’Islam, che era stato membro della Jeune Europe di Thiriart, e che nella seconda metà degli anni Settanta aveva fondato la casa editrice Edizioni all’Insegna del Veltro. «Conobbi Murelli al Centro di osservazione criminale, cioè al secondo raggio del carcere di San Vittore, dove trascorsi tre mesi nell’estate del 1974» mi spiega lo stesso Mutti, che nel corso di vent’anni scriverà per «Orion» «più di un centinaio di articoli, recensioni e interviste». Il secondo è il bolognese Carlo Terracciano, anch’egli seguace di Freda, ex dirigente del Fronte della gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano. Il suo rapporto con Murelli nasce quando questi è ancora in carcere e Terracciano entra in contatto con i militanti di Bologna che sostengono la rivista «Quex». Su «Orion» si dimostrerà grande sostenitore del nazional-bolscevismo e della lotta al mondialismo (inteso come dominio della finanza internazionale di matrice giudaico-massonica). Ecco come lo ricorderà in occasione della sua morte, nel 2005, l’amico neofascista Gabriele Adinolfi: «Carlo, non c’è dubbio, era nazista ed è riuscito a morire a cinquantasei anni, alla stessa età del Führer». Il terzo, più giovane degli altri, si chiama Marco Battarra. Viene anche lui dal Fronte della gioventù, e gestisce una libreria «esoterica» milanese, La Bottega del fantastico, che fornisce l’indirizzo postale di «Orion». Lo chiamo e gli chiedo cosa lo avesse spinto a unirsi al gruppo di Saluzzo, e quale fosse il suo ruolo nel mensile. «Sono sempre stato molto, molto in sintonia con Murelli. […] Io ero un fido scudiero» mi risponde. «Le indicazioni ideologiche le dava lui, Maurizio. […] Io ho sostanzialmente tessuto una tela di contatti. Conoscendo un po’ di francese, inglese e spagnolo ho imbastito una rete di contatti culturali con le realtà che si ritenevano vicine e funzionali al progetto politico di “Orion”.» Gli domando come vorrebbe essere classificato sul piano politico. «Soldato politico nazional-rivoluzionario» replica pronto. Il termine è vago. Ma l’inquadratura ideologica la apprendo da un’intervista in cui spiega cosa lo ha spinto a lanciare una sua piccola casa editrice, sempre a Milano, le Edizioni Ritter: «Mi sono reso conto che in Italia, o per così dire “nel nostro mondo”, mancava un certo tipo di letteratura, soprattutto di quella rivolta all’epopea dei volontari europei delle Waffen SS. Una letteratura di carattere militare, ma improntata ideologicamente. […] Il primo libro che abbiamo pubblicato è stato Storia delle SS di François Duprat, libro che è andato molto bene e ha avuto diverse edizioni. Il secondo libro, I leoni morti. La battaglia di Berlino di Saint-Paulien, è divenuto il nostro cavallo di battaglia. Si tratta di uno dei libri più belli riguardanti la Divisione Charlemagne, e in particolare la difesa di Berlino nel 1945». Il mito delle Waffen SS Quella per le Waffen SS è una passione condivisa. E ripetutamente celebrata nelle pagine di «Orion». Non solo come esempio di eroismo del passato. Più ancora come modello di un’Europa «guerriera e spirituale» del futuro. Difficile da credere. Ma quei loro testi sono ancora consultabili nelle sale della Biblioteca nazionale, ed ecco quello che dicono: Le Waffen SS erano i soldati politici d’un mondo nuovo. Non erano soltanto militari, come la Wehrmacht, ma élite fisica imperniata su una grandiosa concezione del mondo. […] Le cifre sono ancora ignorate ai più: le Waffen SS riunirono un milione di volontari. Più del doppio della Grande Armata di Napoleone! Formati con durezza, sempre i primi ad attaccare, sempre gli ultimi a resistere: 402.000 cadranno da eroi per la loro fede. Ma, in mezzo a quel milione di lanzichenecchi di un mondo a venire, era davvero la nuova Europa che stava ben salda. [Nelle Waffen SS] la Germania d’un tempo era già diventata minoritaria. Seicentomila volontari delle Waffen SS erano non-tedeschi, e costituivano dunque il 60 per cento di quella formazione senza eguali. A spiegarmi come la Divisione Charlemagne delle Waffen SS potesse essere punto di riferimento – e mito – di giovani italiani è l’ex leghista di Cuneo, l’ingegnere Alberto Sciandra: «Carlo Magno è stato il primo imperatore del Sacro Romano Impero, colui che ha unito le due anime forti dell’Europa, quella latina e quella germanica, mentre le Waffen SS erano le divisioni combattenti, quelle che per noi rappresentavano l’incarnazione dell’élite guerriera, l’attualizzazione novecentesca dei cavalieri teutonici. La Divisione Charlemagne delle Waffen SS è stata quella composta da volontari francesi, ultima a difendere il bunker di Hitler. In quel mondo che aveva un po’ il mito della caduta degli dei, dell’ultima grande battaglia, che si può anche perdere, è chiaro che come nome diventa un simbolo». Non chiarissimo, ma fa niente. Sciandra aggiunge che uno dei più grandi eroi di quei cultori delle Waffen SS era Otto Skorzeny, l’ufficiale austriaco con la guancia sinistra scalfita da un colpo di fioretto durante un duello, l’uomo a capo delle più famose operazioni di commando della storia delle SS. Non ultima la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso il 12 settembre 1943: «Tra di noi lui era famoso soprattutto per aver guidato un attacco di carri armati seduto sul cannone esternamente alla torretta. Figurarsi se era vero, ma all’epoca ci pareva: cazzo che tosto, con la sua cicatrice!». Gli chiedo di ricostruire come arriva a scoprire il pensiero nazista e a conoscere Maurizio Murelli: «Il mio incontro con le idee della destra radicale avviene alla fine del 1981, a quindici anni, ironicamente in occasione di un convegno sul neofascismo organizzato dall’Istituto storico per la Resistenza di Cuneo. […] Se ci si pensa, la cosa è folle, ma così è andata: è stato un convegno contro fascismo e nazismo ad aprirmi le porte della loro cultura. E di quella che ho cominciato a vivere come una profonda ricerca spirituale». Alberto Sciandra, figlio di Ugo il partigiano, frequenta la sede del Fronte della gioventù di Cuneo, scopre Julius Evola e poi, all’inizio dell’università, attorno al 1986, conosce Stefano Nai, una persona di una decina di anni più grande proveniente dalla destra antagonista, che lo porta a Saluzzo e gli presenta Maurizio Murelli. Con Stefano Nai e un altro amico di Saluzzo, Guido Rossi, Sciandra comincia a frequentare il pregiudicato, che viene percepito come un novello Skorzeny, una figura quasi mitologica che, dopo aver maneggiato bombe a mano, aveva conosciuto l’agonia della galera. E ne era stato temprato. Come ricorda l’ingegnere, «era sceso agli inferi e ne era risalito, con un percorso tipico di un processo di iniziazione spirituale che a noi affascinava. Agli incontri partecipava anche Alessandra Colla, che ricordo ancora anche per via dei suoi capelli rossi, ma il leader riconosciuto – oserei dire il guru – era Murelli». Volendo assicurarmi che non si tratti di ricordi distorti, esagerazioni, o addirittura abbagli di una singola persona, cerco un altro testimone diretto, Stefano Nai. Lo trovo e i suoi ricordi coincidono in tutto e per tutto con quelli di Sciandra. Mi conferma di esser stato lui a introdurre il giovane studente d’Ingegneria a Murelli, spiegandomi di aver «gravitato» nell’ambiente della destra radicale e di avere un «background evoliano». «Di carisma Murelli ne ha sempre avuto da vendere. Questo è un dato di fatto. E anche Alessandra Colla era un personaggio notevole» aggiunge. Chiedo se anche lui, all’epoca, subisse il fascino della Divisione Charlemagne. Preso alla sprovvista Nai esita a rispondere, ma poi conferma: «Sì… cose del genere… agli inizi… cose di quel tipo». Ecco come mi descrive quelle serate: «Erano incontri in un contesto assolutamente informale. Inevitabilmente a Saluzzo, per la situazione di Murelli. Era un appartamentino piccolissimo, con un tinello, un cucinino e poi di fianco la camera da letto. Un salotto vero e proprio non c’era. C’era un tavolo con delle sedie e un divano, tutto nel tinello. Quindi eravamo sempre in poche persone». Stefano Nai conferma che a Saluzzo gravitano persone come Carlo Terracciano e Marco Battarra. Ma quando gli chiedo di classificarli secondo le categorie convenzionali di destra e sinistra, esita: «In quelle categorie diventa difficile, perché qualche volta la rivista ospitava gente che arrivava da tutt’altre posizioni». Gli faccio notare che l’essenza ideologica mi pare verificabile da articoli o libri pubblicati dalle loro case editrici, a partire da quelli sulle SS. «C’era un mercato per quel tipo di edizioni» risponde. «Resta il fatto che, essendo partiti da un’esperienza di destra radicale… è inutile negarlo: quel background assolutamente esisteva.» Gli faccio notare che in Italia la destra radicale è normalmente neofascista, mentre quel gruppo sembrava più prossimo al nazismo. «Sì, era più spinto su quel lato. Assolutamente» risponde. Poi aggiunge: «[La nostra] era una lettura, diciamo, aggiornata nel tempo. È chiaro poi che le basi, in un certo senso, erano quelle. È ovvio. Sarebbe anche inutile negarlo… ma forse non più legate agli anni Trenta e Quaranta». Il nazismo aggiornato di «Orion» e «Ideogramma» In realtà i legami con gli anni Trenta e Quaranta nelle pagine di «Orion» sono vivissimi. Mi limito a fornire un paio di esempi. Il numero del gennaio 1986 parla delle «valenze essenziali dell’Ordine Nuovo, cioè il progetto geopolitico e strategico che il Terzo Reich propose all’Europa», che viene definito «il realistico e lungimirante tentativo di conferire un assetto sovrano, libero e indipendente al nostro continente, aggregandone i popoli attorno ai valori della comune e originaria Civiltà Indoeuropea». Nel numero di aprile del 1989 l’intera redazione di «Orion» firma un articolo celebrativo per il centenario della nascita del Führer con queste parole: Cento anni fa nasceva Adolf Hitler. I gazzettieri si sono fatti trovare tutti allineati e in competizione per riaffermare i vari luoghi comuni: Hitler? Un folle, uno psicopatico, un criminale, un dittatore, un pervertito… Diluvi di parole sul suo antisemitismo, sulla sua natura bellicosa che ha portato alla guerra mondiale, con oltre 50 milioni di morti, le camere a gas etc. Sciocchezze su sciocchezze, dunque […] Verrà il giorno che Hitler sarà riconosciuto come un grande della storia e con ogni probabilità, se ciò avverrà con noi ancora in vita, ci ritroveremo a essere i soli e unici seri critici in un mare di estimatori del Führer. […] Pur essendo tutt’altro che nazisti o neo-nazisti, preferiamo essere definiti tali piuttosto che venir confusi con l’informe massa antinazista dei tempi ultimi. Quest’ultimo passaggio, apparentemente contraddittorio, è in realtà fondamentale nello schema di gioco di Murelli: la critica anche severa, o addirittura la sconfessione del nazismo, è infatti essenziale per andare avanti e fronteggiare gli attacchi del mondo antinazista. È sia un’opera di camuffamento ideologico sia l’asserzione di una verità: per i saluzziani Hitler e il Terzo Reich avevano infatti commesso svariati errori, che nella forma di postnazismo da loro sognata non si sarebbero dovuti ripetere. Stefano Nai conferma l’attendibilità di Alberto Sciandra, ma è chiaramente reticente. Mi rivolgo dunque a quest’ultimo per sapere se in quelle serate anche Murelli discutesse delle Waffen SS. «Non ho ricordi specifici, ma sarebbe come se tifosi della Juve si riunissero e non parlassero di Del Piero. Figurati se non ne abbiamo parlato! Erano un pilastro, l’incarnazione novecentesca dello spirito guerriero.» – Non poteva esserlo anche l’Armata rossa di Stalingrado? «No, perché lì mancava il fascino della tradizione che c’era nelle SS. Mancava il mito dell’ufficio delle SS che faceva ricerche ancestrali sulla razza ariana.» Il cuore delle riflessioni fatte in quel tinello di Saluzzo è comunque un altro. Proiettato sul futuro. «Il male aveva vinto la guerra, facendo credere a tutti di essere il bene. Questo era il nostro pensiero metapolitico, era il pensiero mitologico della destra radicale» spiega Sciandra. L’obiettivo era di trovare il modo per far rivivere il pensiero sconfitto. Ma un modo intelligente. «Il fascismo e il nazismo per noi erano fenomeni passati. Si cercava di capire cosa avevano cercato di dirci, al di là di quello che avevano fatto, ma il dibattito verteva su come meglio andare avanti. La nostra visione era: se uno si ripropone con vecchi stilemi fascisti perde tempo. Quindi non ha senso andare in giro con la camicia nera o la svastica. Anzi, è ridicolo.» Murelli, Sciandra e gli altri capiscono quindi che è bene rifuggire dalle vecchie etichette che li avrebbero immediatamente emarginati. Ovvio che nessuno parla pubblicamente di mimetizzazione politica. Si prova semmai a dimostrare che il superamento di vecchie barriere ideologiche è parte della storia facendo, per esempio, riferimento a uno dei personaggi più ambigui e controversi del Ventennio, Nicola Bombacci. Di cui Murelli dirà: «Quanti sanno che lui, compagno di battaglia nelle rivolte sindacali e socialiste di Mussolini, fu uno dei fondatori del Partito comunista italiano, fu compagno di Stalin e visse a lungo in Russia durante gli anni d’oro del fascismo, ma poi si arruolò nella Repubblica sociale italiana. E seguì Mussolini fino all’ultimo. Fino ad essere fucilato a Dongo e appeso a piazzale Loreto. I famosi dieci punti della Carta di Verona [il piano programmatico per il governo della Rsi annunciato da Mussolini il 14 novembre 1943], tanto spesso sbandierati dai fascisti intelligenti, sono in gran parte farina del sacco di Bombacci. E Bombacci non è una mosca bianca. Passando al nazional-socialismo, tutti conoscono la figura di Goebbels, ma non tutti sanno che Goebbels proveniva proprio dalle file dei nazional-bolscevichi, il cui programma sociale ed economico fu in gran parte assorbito dal regime hitleriano. […] Noi abbiamo una particolare stima verso coloro che hanno saputo riconoscere il vero nemico e hanno sempre saputo schierarsi oltre i limiti degli steccati ideologici, e ciò prescindendo dal loro complesso di idee». Sebbene la moglie di Murelli, Alessandra Colla, dica che l’idea del gruppo di «Orion» fosse «di superare quelle che erano le questioni ideologiche legate ai partiti, quindi legate alle vecchie opposizioni fascismo/antifascismo, comunismo/anticomunismo, per cercare di avere un respiro più ampio», l’anima ideologica di «Orion» non si allontanerà mai da quella fascio-nazista. Come dimostra il passaggio delle consegne editoriali del mensile a Gabriele Adinolfi, l’amico di Stefano Delle Chiaie e Roberto Fiore, cofondatore con quest’ultimo di Terza posizione e ispiratore ideologico di CasaPound. Ad ammetterlo è la stessa Colla: «Stavamo riuscendo ad andare oltre gli steccati, parlando con persone con la nostra stessa visione – gente di Prima Linea [… ma] poi è venuto il riflusso […] con la gestione Adinolfi. E ci si è ritrovati a parlare di fascismo, di squadrismo, dei compagni cattivi, dei fascisti che sono buoni, bravi, belli e puri». Che la stessa estrema destra convenzionale abbia sempre ritenuto «Orion» un’appendice del proprio mondo, seppur anomala e fuori dall’ortodossia, me lo conferma Roberto Jonghi Lavarini, uno dei più noti rappresentanti della destra meneghina. Ecco cosa mi dice quando gli chiedo quali siano stati i gruppi della destra «antagonista» milanese culturalmente più attivi tra la metà anni Ottanta e Novanta: «I due gruppi che facevano attività, diciamo, culturale e formativa erano da una parte “Orion”, con una tendenza di superamento destra/sinistra e un’impronta di fascismo di sinistra, e dall’altra “Ideogramma”, più ortodosso e oltranzista, direi neopagano, che si rifaceva alle tradizioni prenaziste dei gruppi nazionalisti tedeschi». Per il gruppo di «Orion», la via della riflessione, della lettura e del confronto cultural-spirituale, non era un’alternativa alla via della lotta e dell’azione. Non si trattava di scegliere tra le due. Sarebbero servite entrambe. «Murelli aveva deciso di fare l’editore pensando che, in quel momento, per fare aggregazione, servisse una rivista. Ma l’aggregazione aveva fini politici. O meglio, come dicevamo allora, “metapolitici”» chiarisce Sciandra. «L’obiettivo era di individuare l’essenza dello spirito guerriero che aveva animato il nazismo e trovare una nuova rappresentazione attraverso cui proporla.» – Per diffondere il pensiero postnazista? «Il pensiero di un nazismo aggiornato. Perché si voleva capire quello che c’era veramente da salvare del nazismo.» – Parliamo di trovare l’essenza del nazismo? «Sì. Per farla rivivere in qualcos’altro. Come un’anima che si deve reincarnare, cercavamo un corpo in cui farla reincarnare.» – Era questo il piano di Murelli? «Esattamente. Il nostro obiettivo era di trovare un corpo nuovo in cui far crescere l’anima antica.» Alla metà degli anni Ottanta quel corpo viene identificato da Maurizio Murelli nel nascente movimento autonomista, all’epoca ancora in stato embrionale e diviso in rivoli differenti. Nel Piemonte ne scorrono due diversi. Union piemontèisa è la creatura originale creata da Roberto Gremmo. L’altro, Piemont autonomista, è una sua derivazione voluta da Giuseppe Farassino, detto Gipo, un cantautore di Torino che, dopo esser stato vicino al Pci, se ne era allontanato. Mentre la maggior parte degli osservatori si focalizza sugli aspetti più folcloristici, Murelli vede chiari collegamenti non solo con il suo pensiero, ma addirittura con il primo autore della sua casa editrice, l’Otto Rahn della Crociata contro il Graal: Si riscoprono le origini culturali e c’è una volontà di ritorno agli usi e costumi degli antenati. […] Di questo vasto e variegato movimento etnico senza dubbio Rahn può essere considerato un pioniere. […] Si sarebbe portati a pensare che la disfatta del nazismo e la scomparsa dei grandi capi del Terzo Reich con annessi e connessi comportassero la fisiologica cessazione dell’interesse su Otto Rahn e certe teorie. Invece l’interesse per Rahn e le teorie sopra accennate è andato via via risvegliandosi. Ci sarebbe quasi da pensare che qualcuno, dietro le quinte, sia interessato a mantener desta l’attenzione sul personaggio e i fatti a esso connessi, e che effettivamente qualche organizzazione che si richiama alle teorie sviluppatesi a seguito della pubblicazione di Crociata contro il Graal esista veramente. Difficile non immaginare un sorrisetto beffardo stampato sul volto di Murelli mentre compone queste righe. *** Interrompo per un capitolo la storia della famiglia Levi-Sacerdoti, per una breve definizione del quadro storico. 12 febbraio 1938 Il ministro dell’Educazione ed ex giornalista Giuseppe Bottai chiede alle università di censire tutti gli ebrei – stranieri e italiani – nei corpi studenteschi e in quelli docenti. 17 luglio L’Ufficio centrale demografico del ministero dell’Interno cambia nome e competenze diventando Direzione generale per la demografia e la razza. 22 agosto Parte il censimento separato degli ebrei in Italia. Risulteranno risiedere nel nostro paese 48.032 ebrei italiani, pari a circa lo 0,1 per cento della popolazione. Gli ebrei stranieri, per lo più rifugiati da Germania e Austria, risulteranno essere 10.380. 5 settembre Viene pubblicato il regio decreto legge che stabilisce l’espulsione di docenti e allievi ebrei dalle scuole pubbliche e dalle università italiane. Con questo atto l’Italia è il primo paese a espellere i cittadini di religione ebraica dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché dalle università e dalle accademie. La Germania seguirà il suo esempio due mesi dopo. 23 settembre Vengono pubblicate le norme sulla creazione di scuole elementari per bambini ebrei. 6 ottobre Il Gran consiglio del fascismo adotta la Dichiarazione della razza, resa pubblica venti giorni dopo sul Foglio d’ordine del Partito nazionale fascista. 15-17 novembre Vengono approvati il testo unico e il regio decreto legge sulle norme che prevedono l’allontanamento degli ebrei da impieghi, professioni, attività culturali, posti direttivi in aziende importanti e l’obbligo di cessione della proprietà di aziende di media e grande dimensione. Nel quadro dei Provvedimenti per la difesa della razza italiana si proibisce inoltre il matrimonio tra un cittadino italiano di razza ariana e «persona appartenente ad altra razza». È il perfezionamento in chiave antigiudaica del principio razzista del regio decreto legge del 19 aprile 1937, secondo il quale: «Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d’indole coniugale con persona suddita dell’Africa Orientale Italiana […] è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Maurizio Murelli, il Sommo Suggeritore Il gruppo di Saluzzo Intorno alla metà degli anni Ottanta il corpo in cui far reincarnare l’anima antica del nazismo è dunque identificato. Non resta che avviare una vera e propria opera di infiltrazione. Il primo a muoversi è il libraio «esoterico» Marco Battarra, che ricostruisce con me il proprio ruolo agli albori del movimento autonomista nella sua città, Milano: «Quando la Lega ha fatto la prima riunione a Milano, era l’85, eravamo in nove, incluso Bossi. Due eravamo di “Orion”. Letteralmente in nove, seduti intorno a un tavolo nella casa di un medico che è stato il primo segretario della sezione di Milano». Il riferimento è al dottor Sergio Pegreffi, che all’epoca presiedeva la Commissione medica arbitrale nazionale e fu tra i primi fan di Bossi. Chiedo ragguagli all’ex leghista Giuseppe Leoni, che conferma: «Il dottor Pegreffi aveva messo a disposizione un suo appartamento in piazza Massari, a Milano – saranno stati un duecento metri quadri – per fare le nostre riunioni. E i primi uffici di segreteria furono lì. Finché non ci siamo trasferiti in via Arbe». Chiedo a Battarra come era entrato in contatto con quei sette leghisti. «[A invitarmi] è stato [Francesco] Speroni, che conoscevo perché veniva in libreria. Come cliente. È stato lui a dirmi che avrebbero fatto una riunione e mi ha proposto di partecipare. […] In quel periodo la Lega a Milano era totalmente disorganizzata. Non sapevano stampare un volantino, non sapevano attaccare manifesti. Gli abbiamo fatto un minimo di scuola di militanza. Tant’è vero che i primi volantini della Lega a Milano sono stati stampati nella tipografia di Murelli a Saluzzo. Pensi un po’!» – In altre parole, siete stati voi a fare ai leghisti un corso di formazione? «Sono arrivati i manifesti. C’era da attaccarli, e questi non sapevano neppure da che parte girarli. Allora ho detto: “Ragazzi, vi faccio vedere come si fa la colla, come si attaccano i manifesti. Usciamo insieme”. Siamo scesi con la macchina – la macchina di [Pier Gianni] Prosperini – e ho fatto vedere come si attaccavano i manifesti, che a differenza dei primi volantini arrivavano direttamente da Varese». L’opera d’infiltrazione all’inizio procede senza intoppi. Tant’è vero che Bossi decide di candidare Battarra alle imminenti elezioni locali. Me lo dice lui stesso: «Io dovevo essere capolista in un turno minore di elezioni amministrative fuori Milano, a San Donato. Ma prima che si depositasse la lista è stata fatta trovare una velina sotto forma di agenzia stampa dove c’era tutto il mio curriculum vitae, e si raccontava che i nazisti di “Orion” volevano prendere in mano la Lega. Mi chiamò Bossi e mi chiese se era vero. Io risposi che la mia storia era vera, ma non era vero quello che ci ricamavano sopra. Mi chiese cortesemente di farmi da parte, cosa che ho fatto. […] Qualcuno era andato a suggerire al grande capo che noi eravamo brutti e cattivi e il grande capo ci ha chiesto di farci da parte. A quel punto ne siamo usciti perché non c’era alcun tipo di agibilità politica. Per cui non ci interessava più». Quest’ultima affermazione non è vera. Il movimento autonomista continua a interessare. Eccome! Ma il gruppo di «Orion» è troppo marchiato politicamente per condurre la propria opera di contaminazione metapolitica senza creare problemi. Molto meglio volti giovani, puliti e senza legami visibili. Come quello dello studente del Politecnico di Torino, Alberto Sciandra. «Il punto di contatto con il nostro pensiero di destra radicale si trova nel cosiddetto etnonazionalismo, nel discorso della comunità originaria, della piccola patria» mi spiega lui. A fornire il collegamento diretto tra il pensiero della Lega e quello delle Waffen SS per l’ingegnere è una cartina dell’Europa disegnata da un ufficiale delle SS che anziché i confini nazionali ha quelli di regioni e «popoli». Non a caso la cartina viene ripetutamente pubblicata sulle pagine di «Orion». Con la seguente spiegazione: Nello spirito di questa organizzazione [le SS] ogni provincia avrebbe ricevuto una totale autonomia culturale e sarebbe rimasta dipendente dalla federazione per ciò che concerne l’economia, la politica estera e la difesa. È curioso constatare che, trent’anni dopo, alcuni movimenti che non hanno nulla di «neonazista» propongono cartine assai simili a quella qui riprodotta. L’idea di federazione succeduta ai nazionalismi storicamente fondati, ma sorpassati dall’evolversi delle diverse situazioni, fluttua nel tempo e prefigura forse delle fratture etniche più vicine alla natura degli uomini che non al mantenimento artificioso di comunità puramente linguistiche. Per Murelli e Sciandra le leghe autonomiste offrono un terreno fertile in cui inoculare il loro pensiero postnazista. «Capiamo che il mondo autonomista delle varie leghe può essere contaminato, perché in esso vediamo la radice delle nostre idee. Insomma, quel carro politico può essere strumentalizzato. Quindi vale la pena salirci.» I ricordi di Alessandra Colla, seppur meno espliciti, non si discostano di molto: «Nell’ambiente che gravitava attorno a “Orion” si guardava con molto interesse [alla Lega] perché sembrava un fenomeno nuovo, diciamo il soggetto politico in grado di sparigliare le carte, in grado di superare gli antagonismi destra/sinistra perché proponeva una cosa nuova». «Imbevuto di quei valori» prosegue Sciandra «decido che non basta più cullarsi nelle letture, nella ricerca personale e nella via sacerdotale. È ora di passare all’azione, cioè di entrare nella futura Lega, per formarla alle nostre idee, che erano chiaramente idee di estrema destra e che in qualche modo dovevano essere mimetizzate.» Del gruppetto di Saluzzo, il primo a fare quel passo è proprio lui, essendo stato contattato da alcuni suoi amici universitari legati a Piemont autonomista di Farassino. «Io sono uno che agisce più di getto e quindi mi butto, mentre Guido Rossi all’inizio è più titubante.» Poi però, si unisce. Decido di rintracciare Guido Rossi, che dopo esser stato deputato per la Lega, è oggi segretario dell’associazione dei trasportatori di Cuneo. È decisamente più restio di Sciandra a parlare delle lunghe disquisizioni spiritual-politiche in casa di Murelli e Colla. Poiché conferma però di avervi partecipato, con insistenza gli chiedo di ricordare le tematiche di quelle discussioni. «Si parlava di autonomia, di identità… queste cose qui» minimizza. – A me risulta che si parlasse anche della Divisione Charlemagne delle SS. «Bah… adesso… è roba di trent’anni fa… mi mette in difficoltà… può darsi. Può darsi.» – Come ha contribuito quell’elaborazione «metapolitica» alla sua decisione di entrare in Lega? «Bah… parzialmente… c’era un senso sicuramente di rivolta territoriale verso lo Stato… anche di senso della comunità piemontese che era stata messa nell’angolo… Sicuramente le tematiche autonomiste e identitarie nel mondo di destra c’erano, c’erano sempre state. E quelle cose si sono fuse.» Capisco che le serate da Murelli non sono argomento di cui Rossi gradisce parlare, quindi è a Sciandra che chiedo cosa li abbia spinti a aderire al gruppo preleghista di Farassino. «Quando entro nel movimento, nel 1989, lo faccio in base a valori e principi assunti in quel periodo a Saluzzo. Non ricordo se lui ci abbia detto di farlo espressamente, o più abilmente abbia seminato qua e là messaggi che poi noi abbiamo elaborato facendo quello che lui voleva senza che ce lo dicesse.» Gli chiedo di sforzarsi. «Sono sicuro che la scelta di entrare in Lega sia figlia delle riflessioni con Murelli. Di questo sono certo.» Consapevole del marchio indelebile datogli dalla sua storia di guerriero, Murelli rimane invece nelle retrovie. Anche qui segue l’insegnamento di Julius Evola, propugnatore dell’«agente» che influenza rimanendo invisibile. Sul fronte della guerra Murelli ha già dato. Bombe a mano incluse. Adesso preferisce vestire i panni del grande sacerdote. O meglio del Sommo Suggeritore. E il suo suggerimento è di infiltrare il nascente movimento autonomista. Sarà poi nelle stesse pagine di «Orion» che troverò la migliore definizione per il suo ruolo: «Il capo carismatico è l’anello di congiunzione tra il dominio metapolitico e il dominio politico, giacché non solo agisce nel politico ma si richiama a un’idea metapolitica, facendo sì che i due domini finiscano per fondersi». Le simpatie ultraradicali di Borghezio Nello stesso periodo in cui era il guru del gruppetto di giovanissimi a Saluzzo, Murelli entra in contatto con Mario Borghezio, il più noto tra gli associati italiani del primo movimento postnazista nato in Europa nel dopoguerra, la Jeune Europe di Jean Thiriart, il belga che negli anni postbellici divenne grande amico di Otto Skorzeny, il «mitico» ufficiale delle SS dal volto forgiato da una cicatrice, andato a vivere nella Spagna del Generalissimo Francisco Franco. Appassionato lettore e seguace di Evola, che conosce personalmente, Borghezio si unisce alla propaggine italiana del movimento di Thiriart, dove milita dal 1962 al 1964. In seguito si avvicina a Ordine nuovo, organizzazione neofascista alla quale negherà però sempre di aver aderito. Lo nega anche conversando con me al telefono, ammettendo solo di esser stato loro «contiguo, nel senso che mi erano simpatici». Così, anche al giovane Borghezio, Murelli fa la stessa raccomandazione: «Fui io a suggerirgli di andare nella Lega. Lui si avvicinò prima al gruppo di Gipo Farassino e poi alla Lega» mi dice. L’imbeccata di Murelli non poteva arrivare a persona meglio predisposta. Borghezio era infatti esperto d’infiltrazione politica. Me lo confessa lui stesso, quando gli domando come mai avesse chiesto l’iscrizione a una loggia massonica torinese, sebbene la Giovane Europa aborrisse la massoneria. «Fu una cosa che venne fatta da alcuni militanti… soprattutto nell’ambito di Ordine nuovo» mi dice provando a minimizzare. Non soddisfatto, chiedo maggiori dettagli. E lui, pur controvoglia, me li fornisce: «Fu una specie di esplorazione degli ambienti avversi. Non solo in quella direzione. Molti lo fecero anche con i partiti… Abbandonata l’attività “diretta”, ci fu in quel periodo un tentativo tra il serio e il faceto di esplorare questi ambienti». – E per questo successivamente si è iscritto alla Dc? «No, quello invece fu entrismo.» – Che vuol dire? «Entrismo vuol dire che ci fu il… una specie di… come dire… vogliamo dire… di… di strategia di far penetrare le nostre idee nell’ambiente dei partiti che contavano. Nessuno escluso. Quella fu una cosa seria.» – Qual era il vostro obiettivo? «Il nostro obiettivo era… diciamo che noi eravamo giovani… evidentemente qualcuno avrà elaborato questa strategia e noi l’abbiamo…» Borghezio tenta di far cadere il discorso, ma io non glielo concedo, chiedendo ulteriori spiegazioni. «La strategia era quella che le ho detto: era entrismo. Anziché fare la battaglia all’esterno contro i partiti di potere, [la modalità era quella di] entrare nei partiti di potere e cercare di influenzarli dall’interno. O comunque utilizzarli. [Con questa tecnica] alcuni arrivarono ad acquisire posizioni di rilievo. […] Fu un fenomeno abbastanza articolato.» Una di queste articolazioni è quella di cui ci stiamo occupando. Sciandra non sa che anche Borghezio è entrato in Piemont autonomista su suggerimento di Murelli e con le sue stesse intenzioni. Anche perché, proprio quando l’ingegnere decide di «infiltrarsi» nella Lega, Murelli termina di scontare la condanna, esce dal regime di semilibertà a Saluzzo e si trasferisce a Milano con la moglie. Quindi l’ingegnere perde i contatti con il suo «guru». Ma Sciandra non impiegherà molto a capire che Borghezio sta giocando la sua stessa partita. Ha la stessa matrice evoliana, gli stessi interessi culturali e soprattutto le stesse finalità: contaminare il nascente movimento con pensieri della destra ultraradicale. A facilitare il loro compito è il fatto che sul piano cultural-filosofico i «piemontesisti» di Farassino sono molto deboli. «Non c’era dubbio che Borghezio lì dentro era quello con le idee più chiare e politicamente più lucido. Anche perché gli altri erano poca cosa» ricorda l’ingegnere. A chi conosce Mario Borghezio solo per le sparate di Pontida, potrebbe apparire un giudizio eccessivamente generoso. Ma le persone che hanno avuto modo di conoscerlo mi confermano che, dietro alla macchietta folcloristica nota ai più, si nasconde una persona molto diversa. «Borghezio si è ritagliato un personaggio sopra le righe perché evidentemente gli faceva gioco. Ma è una persona di notevole cultura, oltre che un grande collezionista bibliografico» mi dice Giovanni Polli, che da giornalista de «la Padania» ha avuto modo di conoscerlo bene. È lo stesso parere di tutti gli ex colleghi de «la Padania» con i quali ho parlato. Anche quelli che non lo amavano. «Dal punto di vista politico Borghezio è molto più intelligente di quanto appaia. Gli hanno – o si è – cucito addosso il ruolo del guastatore. E non ha fatto fatica a interpretarlo. Ma è molto intelligente» mi dice Matteo Mauri. Equivalente il giudizio di Leonardo Facco, anche lui ex giornalista de «la Padania» e autore del libro Umberto Magno, la vera storia dell’imperatore della Padania: «Borghezio è una persona molto intelligente, di un’intelligenza che confina con la scaltrezza, e ha agito sempre in maniera subdola: è sempre andato a ruota del capo senza mai – assolutamente mai – dimenticare le sue origini e le sue radici. Quando serviva è stato un’icona goliardica del secessionismo leghista. Se bisognava urlare “Federalismo!”, lui lo urlava. Se occorreva urlare “Secessionismo!” lui urlava quello. Diventato parlamentare nel 1992, è stato parte della primissima nidiata leghista. È stato a Roma con Bossi da allora. Ma anche quando ne era lontano è stato il suo più grande megafono. Era il bossiano di ferro per antonomasia. Ricordo che nel 1993, da semplice militante leghista, invitai Borghezio a un convegno e capii che tra i militanti era l’uomo più amato dopo Umberto Bossi, il quale trovava in lui il perfetto colonnello: colui che eseguiva gli ordini ed esaltava il capo. Era una marionetta del capo. Perché quello era l’unico modo per farcela all’interno della Lega. Ma ideologicamente, seppur sottotraccia, era tutt’altra cosa: è sempre rimasto legato al mondo dell’estrema destra». Il più severo di tutti è stato Gilberto Oneto, fondatore dei «Quaderni Padani» e «padre» del simbolo leghista del Sole delle Alpi che, dopo la conversione al sovranismo della Lega salviniana, ha scritto: Per anni [Mario Borghezio] ha fatto il più estremista di tutti. Ha fondato la corrente indipendentista, ha rappresentato il secessionismo più estremo, ha urlato in forme spesso imbarazzanti il suo disprezzo per lo Stato, i prefetti, i terroni e gli immigrati. È stato per anni l’uomo delle posizioni impervie, dei comizi urlati e deliranti, quello che serviva a vellicare le pulsioni più belluine. In contrasto con la sua essenza di persona colta, intelligente e educata, assumeva posizioni isteriche, si trasfigurava in forme parossistiche, si gonfiava sui palchi fino quasi a esplodere. Era come il professor Immanuel Rath de L’angelo azzurro, il pacato intellettuale che per insano amore per le gambe affusolate di «Lola Lola» Marlene Dietrich si era adattato alle parti più umilianti e degradanti. […] In fondo faceva comodo, era un utile parafulmine, un simpatico fuori-di-testa su cui lasciare scaricare tutte le contumelie degli avversari. Lo sta facendo ma le sue idealità poco hanno a che vedere con la Padania e la sua indipendenza. Ha prevalso il suo più profondo animo littorio. […] Come un massone in sonno, un arabo mentitore, un infiltrato del Kgb, ha dissimulato per anni le sue vere pulsioni: chapeau! Dalle ceneri del più esagitato degli antitaliani è spuntato il patriota italianissimo. La storia conferma […] il vecchio principio che si deve sempre diffidare di chi esagera in solerzia. Sciandra mi conferma che Borghezio manifesta solerzia e disciplina sin dall’inizio anche con il capo di Piemont autonomista, Gipo Farassino. «Era molto rispettoso. Non gli ha mai fatto balenare il dubbio che potesse costituire una minaccia. Ha sempre accettato un ruolo subalterno. Sempre» osserva Sciandra. Poi aggiunge questa riflessione: «In fondo è tipico di chi sta agendo con un progetto segreto. Se voglio fare l’infiltrato cosa faccio? Mi metto dietro al numero uno, divento suo uomo di fiducia e su quello costruisco un contropotere. Quindi, direi che il comportamento è assolutamente lineare». Gli chiedo se con Borghezio ha mai apertamente discusso del piano di infiltrare la Lega. «Non in modo dichiarato, ma si diceva: “Guarda quanto spazio c’è qua per fare le cose che ci interessano”. Come me Borghezio era legato a certi temi, ma non a mettersi la camicia nera. Da questo punto di vista era assolutamente allineato ai ragionamenti fatti con Murelli.» Il nazismo deve rinascere Ancora una volta sono le pagine di «Orion» ad aiutarmi a ricostruire il pensiero di Murelli sulla Lega. In un primo articolo pubblicato nel giugno del 1987 la Lega lombarda è definita «il raggruppamento etnico-regionale che ha condotto la propria azione con maggior lucidità e con una certa approssimazione a quella che è la nostra concezione dello Stato etnocratico». Poi si aggiunge: Abbiamo sentito parlare il suo esponente on. Bossi di «Europa dei Popoli» e di concezione etnico-culturale. […] I media lo attaccano con l’accusa di razzismo e antidemocraticità, ma è anche vero che in contemporanea all’attacco i tesserati hanno cominciato ad aumentare vertiginosamente e il giornale del raggruppamento duplica di volta in volta la tiratura. Non è quindi difficile preconizzare un’onda lunga con un successo che si consoliderà. Un secondo articolo, dell’estate del 1989, approfondisce l’interesse verso le nuove formazioni politiche. Noi di «Orion» abbiamo preferito indicare ai nostri lettori (perché se ne facessero portatori nelle rispettive cerchie sociali) il voto per le leghe autonome e federaliste. La considerazione di fondo compiuta da «Orion» è la seguente: ciò che serve è un cortocircuito, e un’utilizzazione del suffragio universale sulla base di ragionamenti tattico-strategici. Il sistema liberalcapitalistico a conduzione pseudodemocratica ha come secondo orpello operativo, dopo il sistema partitico, il concetto nazionale. Le nazioni dell’Occidente non sono il contenitore di popoli omogenei dal punto di vista della stirpe, della cultura, della lingua, degli usi e dei costumi, bensì la risultante di precise alchimie fra le superpotenze planetarie. […] È in questo contesto che noi abbiamo valutato il nostro interesse verso le leghe autonome [che offrono] una buona opportunità di lavoro politico-culturale per chi, avendone voglia, ne sia anche all’altezza. Ancora più diretto è un articolo scritto qualche tempo dopo da Gualtiero Ciola, collaboratore fisso di «Orion» che si firma con lo pseudonimo di Walto Hari. Ciola pensa come Murelli a un corpo nuovo, incontaminato, e lo dice con parole ferme e sicure: La Lega resta, per ora, l’unica valida risposta anti-sistema. […] Per quanti furfanti avventurieri e profittatori ci possano essere fra i dirigenti del leghismo, meglio loro degli uomini del regime, che hanno imperversato e continuano a imperversare contro un popolo al cui interno non manca una parte sana. […] Pensiamo anche ai pochissimi che hanno letto e capito il libello di Freda, La disintegrazione del sistema. […] Quello che da tempo viene auspicato da «Orion», che ha sempre propiziato il voto alle leghe, è una maggiore incisività, un vero radicalismo che è quanto esige l’elettore «che non ne può più». «Orion» è venuto incontro all’esigenza del sacro fornendo miti e saghe della tradizione precristiana indoeuropea e celtica. Si è trattato dell’inizio di una revisione concettuale grandiosa, quanto difficile da portare avanti. Ma innegabile è il merito di averla proposta con coerenza e costanza. Come Murelli e il gruppo che ruota intorno a «Orion», anche Ciola è convinto che l’essenza del nazismo debba rinascere e che per poterlo fare è fondamentale individuare un corpo nuovo. Anche perché – e Ciola è l’unico ad affrontare la questione economica – chi finanzierebbe ex terroristi, ex militanti di estrema destra con una vita già segnata e marchiata? Meglio usare la Lega come grimaldello politico. Continua Ciola: Ciò che tarda a scomparire è il velleitarismo parolaio incitante a dar vita a movimenti che si cimentino nell’agone elettorale «per contarci». Sarebbe una conta quanto mai deludente. […] Ma quello che sarebbe da quantificare veramente è il numero delle firme e dei milioni necessari per presentare liste alle consultazioni locali e nazionali. Io non ne ho la più pallida idea, ma chi offrirebbe (butto giù una cifra) i 300 milioni tanto per cominciare? Ciola non ne ha «la più pallida idea», ma ha una certezza: la Lega è il nuovo in cui l’estrema destra italiana può riprendere il suo corso. Borghezio è evidentemente della stessa idea. Come Murelli e i suoi seguaci di «Orion», vede nella Lega il «veicolo politico nuovo» in grado di convogliare l’essenza del vecchio che gli sta a cuore. Lo spiegherà così a me: «La mia matrice ideologica era all’epoca, ed è rimasta tuttora, fondamentalmente tradizionalista. Nel segno di Guénon e di Evola. Questo per la parte dottrinaria. Per la parte politica, uno si batte con chi è più vicino alla tua visione». Borghezio capisce di aver trovato il veicolo giusto nel movimento autonomista: «L’invenzione della Padania è stato un qualche cosa di eccezionale, che coniugava modernità di azione politica – quindi nuove forme di lotta – con l’ancoramento forte alla tradizione e ai valori nei quali io mi sono sempre riconosciuto». Il suo ancoramento ideologico lo spiega così: «Io ho sempre simpatizzato per i movimenti dell’ultradestra. E posso aggiungere una cosa: non c’è movimento di estrema destra che non mi sia stato simpatico. Compreso il Fronte nazionale di Junio Valerio Borghese». Ma, come Murelli, Borghezio percorre una strada diversa da quella di Borghese e movimenti simili: «O si sceglie la via del “cavalcare la tigre” [titolo di un bestseller di Evola], quindi di portare la crisi all’estremo. Oppure si cerca di vivificare […] quegli elementi della tradizione che sono nell’identità dei popoli. Io ho scelto questa seconda via». L’occasione per perseguire quella strada gli viene offerta nella seconda metà degli anni Ottanta dal movimento autonomista, in cui lui sceglie subito di «entrare». Per spingerlo il più possibile nella direzione da lui desiderata. Non mi pare se ne sia mai pentito. Né abbia mai smesso di spingere. *** Le leggi razziali del 1938 sconvolsero la vita di tutti. Alcuni pensarono di uscire dalla Comunità ebraica battezzandosi, credendo che in questo modo tutto potesse continuare «come prima»; altri affrontarono con dignità il proprio destino. Ma neppure nelle piccole cose quotidiane niente fu più «come prima». La signora Pagliani, moglie del gerarca Franz Pagliani, ruppe l’amicizia con la mia famiglia dicendo alla mamma: «Mi dispiace per te Neny (mia mamma si chiamava Eugenia, ma veniva chiamata Neny), però per tutti gli altri ebrei questo e altro». Dalle memorie di Silvana Sacerdoti Dieci, cento, mille Mario Borghezio Ordine nuovo e l’omicidio Occorsio Nato inizialmente come centro studi, Ordine nuovo viene fondato nel 1956 dal repubblichino Pino Rauti con il supporto di Stefano Delle Chiaie. Tredici anni dopo si trasforma in movimento politico Ordine nuovo, avviando corsi di formazione ideologica basata sulla rivolta contro il mondo moderno e la plutocrazia. Suo grande ispiratore: Julius Evola. Ovviamente. La matrice apertamente fascista suscita l’interesse della magistratura, in particolare di un giudice istruttore di Roma, Vittorio Occorsio, che dopo una lunga inchiesta decide di mettere sotto accusa il gotha dell’organizzazione, con centodiciannove rinvii a giudizio. Il 21 novembre 1973 arrivano le condanne per trenta ordinovisti. Tra loro c’è Salvatore Francia, «reggente» del gruppo in Piemonte, che assieme alla sua compagna e responsabile femminile del movimento, Adriana Pontecorvo, è imputato anche a Torino in un processo promosso dall’allora giudice Luciano Violante. La sentenza di Occorsio fa scattare per la prima volta nella storia della Repubblica la cosiddetta «legge Scelba», la legge del 1952 che vieta l’apologia del regime fascista classificandola come reato, e il movimento viene dunque sciolto per decreto dal ministero dell’Interno. Ma i suoi militanti non si fermano. Salvatore Francia si dà alla latitanza oltralpe e il 19 luglio 1974 un suo camerata viene arrestato a Bardonecchia, sul confine francese, con documenti affidatigli da Adriana Pontecorvo, accusata tra l’altro di aver organizzato dei campi paramilitari in Val di Susa. Il 4 aprile 1976, con Salvatore Francia ancora latitante, la Corte d’assise di Torino condanna la Pontecorvo a tre anni e sei mesi di reclusione per cospirazione politica mediante associazione. Quando morirà di una brutta malattia, undici anni dopo, la militante ordinovista avrà un picchetto d’onore con tanto di bandiera originale della Repubblica sociale. «Orion» le renderà omaggio con questo necrologio: «Adriana, fedele militante politica e amica sincera, ci ha lasciati dopo una lunga e inesorabile malattia. Monito ed esempio a pentiti, furbi e rinnegati, la fermezza dei tuoi principi, i tuoi slanci generosi, il tuo coraggio […] vivranno sempre nel nostro ricordo». Sabato 10 luglio 1976, a Roma, un commando di militanti di Ordine nuovo intercetta la vettura del giudice Occorsio e lo massacra a colpi di mitra. La sera di quello stesso giorno, l’allora ventottenne avvocato Mario Borghezio viene fermato al valico di frontiera di Pont Saint-Louis, vicino a Ventimiglia, assieme a un amico, il maestro elementare Pier Franco Volpi. Ecco come il quotidiano torinese «Gazzetta del Popolo» ne dà notizia: La coppia è stata bloccata al valico di Ponte S. Luigi: arrivava da Mentone, dove pare avesse cenato a sbafo, senza pagare il conto. Borghezio e Volpi erano sulla Opel Rekord di quest’ultimo quando sono stati fermati dalla Guardia di finanza, alla quale era stata segnalata la «fuga» dal ristorante di due italiani. Al controllo i finanzieri hanno notato una busta bianca infilata fra altri documenti. L’hanno aperta e dentro c’era una cartolina […] indirizzata a «quel bastardo di Violante» e firmata Ordine nuovo. […] La cartolina riproduce il casinò di Montecarlo. Sul retro poche parole: «Dieci, cento, mille Occorsio». Ai lati due svastiche. La firma: Ordine nuovo. Destinatario: il giudice di Torino Luciano Violante. Il messaggio minatorio era infilato in una busta bianca su cui sarebbe stato segnato l’indirizzo del magistrato. I due neofascisti fermati sono Mario Borghezio e Pier Franco Volpi. Quando gli chiedo spiegazioni, Borghezio mi dice che la cartolina era stata scritta da Volpi e che lui non era neppure a conoscenza della sua esistenza fin quando non sono stati fermati. Volpi è morto ed è quindi impossibile verificarlo. Per giorni, sull’onda di sdegno suscitata in Italia dall’omicidio di Occorsio, i quotidiani torinesi seguono con attenzione l’appendice locale della tragedia fornendo approfondimenti sui due giovani arrestati vicino a Ventimiglia. Del maestro Volpi la «Gazzetta del Popolo» scrive che «pare non abbia mai fatto mistero delle sue simpatie neonaziste, facendosi chiamare Führer. In casa sua la polizia ha trovato il materiale più interessante e cioè una carta d’identità – proveniente dagli uffici comunali di Napoli – rozzamente contraffatta, un indirizzario e un carteggio di elementi neofascisti». A parlare delle risultanze della perquisizione in casa di Borghezio è invece «La Stampa»: «A casa di Borghezio, tra le altre cose, la polizia ha trovato una divisa da ufficiale nazista completa di spalline, mostrine e distintivi, con l’aquila nazista e una croce di ferro di terza categoria». Qualche giorno dopo la pubblicazione di quell’articolo, l’avvocato di Borghezio scrive a «La Stampa» chiedendo di precisare che il suo assistito «non è mai stato simpatizzante neofascista, in quanto iscritto alla Democrazia cristiana, in cui riveste carica direttiva a livello giovanile». La natura di quell’iscrizione ce l’ha confessata Borghezio, ma all’epoca «La Stampa» non poteva saperlo e conseguentemente asseconda la richiesta senza però mancare di domandarsi se il legale «intendesse dire che le simpatie sono in realtà neonaziste», poiché la divisa «non viene smentita». Spediti di corsa a Roma per essere interrogati dal magistrato che indaga sull’omicidio Occorsio, Borghezio e Volpi si giustificano spiegando che quella cartolina era «uno scherzo» e che non avevano mai avuto intenzione di spedirla, tanto è vero che era affrancata con un francobollo francese e loro erano stati arrestati rientrando in Italia senza averla spedita. Il caso si sgonfia e alla fine viene archiviato dal giudice Claudio Vitalone. Ma che i legami di Borghezio con il mondo di Ordine nuovo non si interrompano lì, me lo dice Maurizio Murelli: «Mario Borghezio aveva un rapporto molto buono con Salvatore Francia, che era il leader torinese di Ordine nuovo. Si relazionava in quel periodo lì con lui e Adriana Pontecorvo, frequentava il loro ufficio. Io lo conobbi quando venne a Saluzzo con Francia». Sul suo stesso mensile Murelli aveva scritto: Il lettore deve sapere che tra il 1985 e il 1990 l’onorevole Borghezio era ospite a casa mia praticamente tutte le settimane. Fu l’ideatore di «Orion Finanza», supplemento di «Orion». Allora io passavo per terrorista e più di me passava per terrorista Claudio Mutti che amorevolmente Borghezio soprannominava «Muttim» e della cui amicizia, fin dai tempi in cui erano insieme nella Giovane Europa, menava vanto. Dunque, oltre a frequentare amabilmente me, Salvatore Francia (più volte accusato di essere il terrorista numero uno di Ordine nuovo), Adriana Pontecorvo (sempre di Ordine nuovo e nei cui uffici bivaccava) […] oltre ad accompagnarsi a sedicenti «colonnelli» del fantomatico Stato del Sahara occidentale spagnolo, oltre ad essere stato accusato lui stesso […]per una lettera anonima inviata all’allora giudice di Torino, Violante; ebbene, a parte queste «pericolose» ed «equivoche» frequentazioni, ciò che lo contraddistingueva era la sua ideologia ferocemente antiamericana e soprattutto antigiudaica. Conferma anche Alessandra Colla, alla quale chiedo del supplemento finanziario coordinato da Mario Borghezio: «Avevo conosciuto Borghezio la prima volta a Torino. Poi lui venne a trovarci a Saluzzo e si parlò di questa cosa di “Orion Finanza”. L’idea era di avere un approccio all’alta finanza che fosse diverso dai soliti complottismi [dell’estrema destra], quelle cose tipo: “Ah, i Rothschild! Sono ebrei, aiutooo!”. Insomma queste cose da Francia cattolica dell’Ottocento. L’idea invece era di approcciare il capitalismo e la finanza su basi più scientifiche, più storiche». Le faccio notare che in un’intervista a «l’Unità» Murelli ha ricordato che Borghezio aveva, parole sue, «il pallino del complotto giudaico-massonico», cioè esattamente la lettura della Francia reazionaria dell’Ottocento che lei sostiene si volesse superare. Forse presa alla sprovvista, Colla non nega: «Esatto… e infatti questo fu uno dei motivi per cui poi ci staccammo». In effetti l’esperimento di «Orion Finanza» durò appena qualche mese. Insisto chiedendole che cosa facesse Borghezio con lei e Murelli «praticamente tutte le settimane». Alessandra Colla risponde con un’evidente excusatio non petita: «È passata quest’idea che Saluzzo fosse la fucina di chissà quali oscure trame. Ma io ricordo grandissime mangiate, passeggiate in montagna, chiacchierate, cazzeggio. Anche perché eravamo tutti giovani. Non si sta parlando di grandi vecchi che tessono trame». Che invece proprio di trame si tratta non è solo Murelli a riconoscerlo, quando ammette di aver esortato Borghezio a entrare nella Lega per contaminarla con le loro idee postnaziste. Seppur obliquamente, lo conferma Borghezio quando ci parla del suo «entrismo». L’incontro al Novotel di Nizza A questo proposito merita di essere segnalato un evento avvenuto il 6 settembre 2008, nella sala conferenze dell’albergo Novotel di Nizza, in occasione di un incontro di «identitari nizzardi» del gruppo postfascista francese Nissa Rebela. Incontro filmato e incluso nel documentario di Canal+ Europe: Ascenseur pour les fachos della documentarista italiana, di base a Parigi, Barbara Conforti. Invitato a parlare, Borghezio impugna il microfono e, in un buon francese, parte lancia in resta: «Io non ho paura a mettere la croce celtica nella copertina della nostra rivista». Con la mano sinistra agita una copia del suo periodico, «Idee», che reca ben visibile in copertina lo storico simbolo di Jeune Europe e dell’estrema destra neofascista italiana. Poi continua: «È il simbolo della nostra tradizione! Qualcuno mi dice che è un simbolo fascista, nazista… Io me ne frego! Non è vero». Ma qui è bene notare un dettaglio di quel diniego finale: prima di pronunciare quelle ultime tre paroline – «Non è vero» – Borghezio passa il microfono dalla mano destra, con la quale lo aveva tenuto fino ad allora, alla mano sinistra, alza il braccio destro, lo tende in avanti e si sofferma per svariati secondi in un saluto con il palmo aperto rivolto verso il basso a dita unite. Un saluto singolarmente simile a quello romano. Ancora più emblematici sono alcuni minuti filmati senza che Borghezio se ne renda conto, durante il rinfresco seguito al convegno in cui l’eurodeputato parla, sempre in francese, con tre militanti identitari nizzardi, spiegando loro come evitare il rischio dell’emarginazione politica: «Occorre entrare nelle amministrazioni locali. E dovete insistere molto sulla natura regionale del vostro movimento. È il modo migliore per non essere classificati come nostalgici fascisti, bensì essere visti come un nuovo movimento regionale… la patria, Mabire eccetera… ma sotto sotto siamo sempre gli stessi. Va fatto così». Borghezio si riferisce allo scrittore francese Jean Mabire, grande fan delle Waffen SS che dopo la guerra diventa fautore di un regionalismo fortemente identitario e nel 1969, assieme ad Alain de Benoist, fonda il Grece, il Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, l’organizzazione che, in Francia, ha dato i natali alla Nouvelle droite, che io classifico come postnazista. Chiedo conto a Borghezio di quello scambio al Novotel di Nizza. Lui lo definisce «pedagogia politica», negando che sia una lezione di «entrismo». Sostiene di aver voluto semplicemente invitare i militanti nizzardi a sottolineare la loro natura «identitaria» e rifuggire dall’etichettatura di estrema destra, «perché un identitario deve essere qualcuno che esprime qualcosa di nuovo, che supera la contrapposizione destra/sinistra». È la lezione di Thiriart, «il retaggio della Giovane Europa» che lui mi dice di non aver «mai perso». A me continua comunque a suonare come un esercizio di mimetizzazione politica. Come Murelli, Borghezio è un fedelissimo di Evola. E seguendo il suo manuale di istruzioni sa che occorre guardare avanti, pur facendo riferimento al passato. Lo chiarirà anche in un’intervista radiofonica del 2015: «Io non sono favorevole al nostalgismo. Lo ritengo una malattia infantile dell’estrema destra non solo italiana. Un conto è un giudizio storico che, soprattutto in Italia grazie a un grande storico come De Felice, ormai è a chiaroscuro – sono stati infatti accertati aspetti positivi assieme a quelli negativi –, un [altro] conto è fare politica» spiega. «Fare politica guardando indietro non solo non è positivo, ma del tutto inutile. Controproducente. E quindi, quello che spero e ho anche direttamente consigliato [a CasaPound] è di liberarsi dalle scorie del nostalgismo e diventare un movimento politico che guarda esclusivamente avanti.» Dopo essersi espresso sul fascismo, passa poi al nazismo: «Io nei confronti del nazionalsocialismo ho acquisito al 100 per cento il giudizio di Jules Evola, che considero un grande maestro. Quindi ne critico la natura profonda, una natura di sinistra. […] Ma gli aspetti positivi sono quelli meno conosciuti. Perché non c’è ancora stato un De Felice, […] non è ancora spuntata una scuola defeliciana che ci permetta di capire meglio quel periodo e tracciare meglio i chiaroscuri. Certo, la pagina dell’Olocausto, a mio avviso, resta incancellabile come fatto negativo». Quella che Borghezio chiama ricerca dei «chiaroscuri» del nazismo è il cuore del pensiero evolian-murelliano: trovare l’essenza «luminosa» liberandosi dei bubboni oscuri. Come se si potesse separare Mein Kampf dall’Olocausto. La nascita del Fronte nazionale Se nel 1989 Mario Borghezio e Alberto Sciandra, su spinta di Murelli, decidono che la Lega è il «carro» giusto su cui salire, o più precisamente «infiltrarsi», è anche per via delle ambiguità ideologiche di Bossi. Il fondatore del Carroccio si rivolge alla pancia lombardo-padana che si sente schiacciata da «Roma ladrona» con un messaggio non necessariamente di destra ma, non potendo ricorrere a una retorica di sinistra perché l’area è già occupata dal Pci e da varie formazioni più radicali, è costretto a parlare di autonomismo con una retorica della destra più xenofoba. Basti pensare al discorso che Bossi fa l’8 febbraio 1989 in apertura del Primo congresso della Lega lombarda, in pratica il suo certificato di nascita. In quell’occasione, introducendo al popolo leghista il concetto dell’etnofederalismo, Bossi parla di diritto/dovere che ogni popolo ha di essere «etnicamente omogeneo»: «La società multietnica e multirazziale è una società che, per sua natura, è contro l’uomo perché, […] distruggendo il processo di identità etnica, provoca il declino della morale […] e va incontro alla disgregazione, sviluppa comportamenti patologici dell’omosessualità, della devianza giovanile, della droga, crea condizioni psicologiche che favoriscono ad esempio la sterilità per cui non nascono più figli». Per un osservatore non consapevole di quella che, con rigore accademico, il suo amico ed ex leghista Giuseppe Leoni ha definito «la grande confusione nella testa di Bossi», quei concetti «etnico-morali» appaiono di chiara matrice nazifascista. Come peraltro quelli sull’immigrazione introdotti nella seconda parte del suo discorso programmatico: «Dietro l’immigrazione di colore non c’è solo l’interesse di una sinistra allo sbando che cerca un nuovo sottoproletariato che le dia i voti, non c’è solo la Chiesa cattolica rinchiusasi nei palazzi dell’avere che ha perso ogni credibilità. […] C’è l’interesse del Grande capitale che, attraverso l’immigrazione del Terzo mondo, scarica sui cittadini i costi del proprio sviluppo». Bossi non si limita ad agitare ambiguamente lo spauracchio del Grande capitale. Offre una lettura che come vedremo verrà ripresa successivamente dal suo erede: «Il Grande capitale ha un interesse strategico legato all’immigrazione del Terzo mondo. Esso sa infatti che nella società multirazziale si innescano tensioni tali che possono incidere profondamente nella coscienza dei cittadini. […] Ciò non è tanto finalizzato a rendere autoritari gli Stati nazionali, quanto a rendere possibile il progetto costituente di uno Stato europeo centralista […] che la massoneria si illude di poter realizzare». Ecco il sempreverde dei teorici del complotto di stampo reazionario-fascio-nazista: la lotta alle trame occulte dei massoni. Sono parole – e idee – straordinariamente simili a quelle che l’anno dopo spingono il padre della destra antagonista italiana, Franco Giorgio Freda, a tornare in campo dopo decenni di attività editoriale e svariati anni passati in carcere per i legami avuti con gruppi eversivi. Nel 1990 infatti Freda lancia il suo Fronte nazionale, di cui assume la «reggenza». Il «sostituto reggente» è Cesare Ferri, amico di Murelli dai tempi della Milano sanbabilina e successivamente suo «camerata di galera» e collaboratore di «Orion». Decido di sentirlo. «Sin dall’inizio mi ha sempre infastidito il fatto che venissero bistrattati, infamati, vilipesi gli sconfitti [della Seconda guerra mondiale]. Ho cominciato a fare politica attiva, frequentando la sede della [organizzazione legata al Msi] Giovane Italia di corso Monforte, a Milano. Poi sono stato a San Babila, dopodiché mi hanno arrestato» mi dice. Gli chiedo dettagli. «Sono stato in carcere per le Sam [le Squadre d’azione Mussolini], per il Mar [il Movimento armato rivoluzionario] e per Ordine nero, da me fondato… ho avuto un po’ di mandati di cattura, insomma. Ma sempre carcere preventivo. Mi hanno condannato solo per un attentato ad Alessandria» chiarisce. «Freda, che avevo conosciuto in carcere, mi ha parlato di questo progetto [del Fronte nazionale] e io ho inevitabilmente aderito. Dico inevitabilmente perché, dal mio punto di vista, non si poteva non aderire. Il motto del Fronte era: nessuna assimilazione, nessuna integrazione, nessun meticciato. Da qui partiva tutto: la difesa della nostra tradizione e civiltà, del nostro essere europei, era fondamentale. Di pari passo si andava formando poi un’idea della politica, in senso del superamento della destra e della sinistra in ragione della lotta contro l’immigrazione. Avendo ovviamente la consapevolezza che l’immigrazione è l’arma del mondialismo. Questo è evidente. […] Gli immigrati rappresentano il proiettile del mondialismo. L’arma la tiene in mano il mondialismo.» Gli chiedo di spiegare cosa intende per «mondialismo». «La volontà di azzerare le radici dei popoli europei in modo che si possano immettere in Europa popoli nuovi. Un po’ il “Piano Kalergi” della sostituzione dei popoli» mi dice. Ferri si riferisce a una bufala più recente ma simile a quella ottocentesca dei famosi Protocolli dei Savi di Sion secondo la quale, attraverso le migrazioni e l’abbattimento delle frontiere, la «grande finanza internazionale» fomenterebbe un piano di «sostituzione di popoli» da realizzare attraverso il «meticciato». È lo stesso concetto che Adolf Hitler propone in Mein Kampf senza ricorrere a eufemismi, all’epoca non necessari. Anziché di «grande finanza», Hitler parla più esplicitamente di «ebrei». Riferendosi alla presenza di truppe d’origine africana che alla fine della Grande guerra avevano occupato alcune regioni tedesche suscitando paura e risentimento popolare, scrive: «Sono stati gli ebrei a portare i negri nella Renania al fine di bastardizzare la razza bianca, abbassare il suo livello culturale e politico e stabilire il proprio dominio». Provo a chiedere a Cesare Ferri chi si nasconde dietro al nemico «mondialista». «Non è che posso farle nomi e cognomi» mi risponde. «È la grande finanza internazionale che ha l’interesse a tagliare le radici dei popoli, così che sia molto più facile innestare altri popoli, per esempio quello africano.» Niente nomi o cognomi, dunque. Ma impossibile non pensare alla frase di Alessandra Colla: «Ah, i Rothschild! Sono ebrei, aiutooo!». Anche perché, sul tema, Ferri si è espresso apertamente in passato. Per esempio nel suo interrogatorio dell’11 ottobre 1974: «Condanno gli ebrei filosoficamente, perché sono stati la causa della svalutazione dei valori, cioè dell’abbassamento dei valori antichi. Precisamente, con il loro comportamento hanno svalutato i concetti antichi e universali dell’Onore e della Giustizia, riducendo tutto a livello di traffici economici. Che poi Hitler si sia comportato nei loro confronti in un certo modo, a me non interessa». La «grande confusione» di Bossi Cesare Ferri mi fa notare che il Fronte nazionale è stato il primo movimento politico diffusosi in Italia attorno alla questione dell’immigrazione. L’incipit della sua piattaforma programmatica era chiaro: «L’immigrazione di africani e asiatici sta moltiplicando in Italia le tensioni sociali, […] alimentata dalla sinistra, alla ricerca di qualsiasi nuovo proletariato, e dalla Chiesa, alla ricerca di qualsiasi nuova fede». In risposta a questa minaccia, la piattaforma del Fronte nazionale prevedeva nove punti, i primi tre dei quali erano: la chiusura delle frontiere all’immigrazione extraeuropea, l’espulsione degli immigrati clandestini e l’abrogazione delle leggi che governavano, consentendola, l’immigrazione extraeuropea (altro eufemismo, ovviamente). Per queste parole e questi intenti, ma senza alcun atto di violenza, il 7 maggio 1999 la prima sezione penale della Corte di cassazione ha emesso una sentenza in via definitiva per Freda, Ferri e quaranta loro associati. Sono stati tutti riconosciuti colpevoli di «incitazione all’odio razziale», in violazione della legge Mancino (legge che da anni Matteo Salvini dichiara pubblicamente di voler abrogare). Ma se le parole e gli intenti di Freda e Ferri erano chiaramente frutto di uno sforzo, diciamo così, di «elaborazione ideologica», quelli di Bossi no. Me lo garantisce l’architetto Giuseppe Leoni, secondo il quale tutti gli elementi del discorso fatto da Bossi a quel primo congresso leghista – dall’etnonazionalismo alla massoneria – erano attribuibili, ancora una volta, alla «grande confusione» dottrinale. Perché Bossi, aggiunge, era solo «alla ricerca dei mal di pancia delle persone». In altre parole, pur di raccogliere voti, stava sparando nella mischia ideologica senza criteri né remore. E le sue scelte erano dettate esclusivamente dal bisogno di farsi notare. Il più possibile, con qualsiasi mezzo, e ispirandosi a chiunque avesse «successo di popolo». Si prenda l’idea di Pontida: Leoni mi rivela che viene a Bossi dopo aver visto Giovanni Paolo II a Santiago de Compostela, in Spagna, nell’estate del 1989, e soprattutto dopo essere stato colpito dal mare di fedeli arrivati a piedi, a cavallo e in bicicletta. «Sull’onda di quel grande successo del papa nasce l’idea di un punto di ritrovo per la nostra gente» dice l’architetto. E dopo alcuni mesi, il 20 maggio 1990, viene chiamato a raccolta il popolo leghista nel comune bergamasco di Pontida. Di quella prima kermesse leghista ho trovato in rete una foto particolarmente significativa. Si vede Bossi gongolante, in cravatta a strisce diagonali bianche e rosse davanti a un gruppo di seguaci. Uno di loro porta un grande cartello, con scritto a mano SEN. BOSSI – PREMIO NOBEL AD HONOREM CAUSA. PADANIA LIBERA. Dietro a quel cartello, alla sinistra di Bossi, si vede un giovane sorridente con al collo una sciarpa bianca e rossa, i colori della Lega di allora. Per qualche motivo nessuno lo ha mai notato, ma un suo ex compagno di scuola mi ha fatto osservare che si tratta di un giovanissimo Matteo Salvini, allora studente di prima liceo (per la precisione della I D) al Manzoni, uno dei più rinomati licei classici di Milano. *** «Che c’è, Marcello?» «C’è» rispose «che non abbiamo più il nostro padrone.» «Il nostro padrone?» Lì per lì, non avevo capito. Pensai un attimo al dottor Baruffi, nostro padrone di casa, alle cui dipendenze in fabbrica stava Marcello. «C’è che Mussolini è caduto!» Non credevo alle mie orecchie. «Mussolini caduto? E come lo sa?» «L’ha detto la radio.» Rimasi come stordita. Volevo leggere i giornali, sapere. Dovevo fare il pane, ma ero inchiodata. Era il 25 luglio 1943. La sera su per i monti si vedevano apparire da ogni parte dei grandi falò. Tutti gli abitanti erano fuori, ebbri di gioia, pensando che guerra, bombardamenti, carestia, pericoli di ogni genere, fossero finiti. Invece sbagliavamo tutti. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti Matteo Salvini e l’amico fascista Gli anni del liceo Come il suo maestro e predecessore, anche Matteo Salvini ha frequentato l’università per circa un decennio, cominciando nelle aule della facoltà di Scienze politiche della Statale di Milano e finendo in quelle di Lettere. Senza laurearsi. La sua esperienza accademica alle superiori è invece ricca e ben documentata, mentre quella del Senatùr non lo è affatto. Il sito ufficiale della Lega ci informa che Bossi ha «ottenuto la maturità scientifica», ma il nome e la località del liceo non vengono forniti. È documentato solo il fatto che, grazie alla scuola per corrispondenza Radio Elettra, Bossi ha ottenuto quello che sarebbe un insolito doppione: un diploma di perito tecnico elettronico. Su Matteo Salvini è possibile sapere molto di più. Figlio di Ettore, dirigente di un’azienda chimica fuori Milano, e di Silvana, traduttrice e interprete dal tedesco, con una sorella, Barbara, Matteo si è diplomato con 48 sessantesimi all’Alessandro Manzoni, in via Orazio, uno dei migliori licei di Milano. Dove sono stati educati Rossana Rossanda, Giorgio Falck, Enrico Mentana, Michele Serra, i tre fratelli Boeri e molti altri milanesi di nome e di successo. Quei cinque anni trascorsi nella sezione D del Manzoni sono essenziali per conoscere Salvini. Non avendo lui frequentato l’università, in quelle aule ha infatti costruito duraturi legami di amicizia. E si è formato umanamente, intellettualmente e politicamente. Lo dice lui stesso nell’autobiografia, Secondo Matteo: follia e coraggio per cambiare il paese. Quando ripenso agli anni delle scuole superiori mi prende un groppo alla gola. È stato uno dei periodi più felici e allo stesso tempo più complicati della mia vita: il passaggio dall’infanzia alla consapevolezza. La storiografia ufficiale salviniana lo presenta come appassionatissimo tifoso del Milan, grande fan di Fabrizio De André e Giorgio Gaber, fortemente leghista ma proiettato a sinistra, come provato anche dalla sua frequentazione del Leoncavallo, il famoso centro sociale meneghino. Approfondendo bene il suo passato al liceo, mi sono però reso conto che il mito della persona che supera le barriere ideologiche andando al Leoncavallo in camicia verde non è che, appunto, un mito. Trattandosi di scuola, cominciamo con i voti. Il suo primo anno di ginnasio Salvini lo passa in IV D, una classe che nella foto ufficiale mostra appena nove ragazze e sei ragazzi. La D è una sezione notoriamente «dura», con professori severi ed esigenti. Ma lui chiude l’anno alla grande, con una media del sette e mezzo. Il secondo anno di ginnasio è più difficile. Riescono a farcela solo sette femmine e quattro maschi, tanto che in prima liceo si uniscono alla loro classe anche i ragazzi provenienti dalla sezione M. Con la media però ridotta al sei e mezzo, Salvini è uno dei maschi che ce la fa. Nei tre anni del liceo la sua performance scolastica è costante, e la sua media rimane stabilmente sopra il sei e mezzo. Nella sua autobiografia Salvini si presenta quasi come una vittima di professori con idee politiche diverse dalle sue: I professori […] erano quasi tutti di sinistra. […] A causa delle mie idee non mi ero attirato le loro simpatie, fatto questo che mi viene confermato ancora oggi da molti studenti, ad esempio sul tema immigrazione: se non sono d’accordo con la professoressa di italiano passano dei brutti cinque minuti. Testimonianze e documentazioni da me raccolte dimostrano che questa supposta discriminazione di natura politica non c’è mai stata. Il giudizio con il quale viene presentato all’esame di maturità lo dipinge così: Lo studente possiede buone doti di analisi e di sintesi, espone con scioltezza e sicurezza gli argomenti a lui più congeniali, soprattutto nelle materie dell’ambito classico-letterario. È organizzato nell’elaborazione dei dati, ha dimostrato un impegno discretamente costante e ha raggiunto una preparazione discreta nel complesso. Tra i giudizi più positivi c’è quello della professoressa di greco e latino, Mariella Parravicini, apertamente di sinistra, che scrive: L’alunno è dotato di intelligenza brillante, di una buona preparazione di base, sa tradurre con perizia tecnica e notevole intuito. Ha partecipato alle lezioni in modo vivo e con interessi personali a volte anche critici. Anche l’insegnante di matematica e fisica, la professoressa Silvana Sacerdoti, si esprime positivamente. Ma con più circospezione: Il candidato è dotato di buone capacità di sintesi, ha studiato le due discipline senza particolare entusiasmo rivolgendo l’attenzione ad altre materie. Abbastanza organizzato nella rielaborazione dei dati. Lo ha dimostrato nella gara di matematica dove ha conquistato un buon secondo posto. Quest’ultimo è un riferimento alle eliminatorie interne che gli allievi dell’ultimo anno di liceo facevano per partecipare alle Olimpiadi di matematica, test nel quale Salvini era risultato secondo in tutto il Manzoni. Se il Capitano non avesse chiuso la propria campagna elettorale del 2018 brandendo il crocifisso e giurando sul Vangelo, le prime tre paroline del giudizio di presentazione dato dal professore di religione, don Luciano Spinelli – «Non si avvale» –sarebbero sicuramente meno significative. Come è noto, a norma del Concordato, la religione cattolica è una disciplina assicurata nelle scuole ma sottoposta alla scelta da parte della famiglia o dello studente, il quale deve decidere se «avvalersi» o meno dell’insegnamento di quella materia. Salvini era uno degli studenti del Manzoni che non se ne avvaleva. Segnalato questo fatto, nel suo giudizio don Luciano si sente in dovere di aggiungere: Nonostante la scelta formale, ha partecipato lungo l’anno a diverse lezioni con vivo interesse e interventi attivi pertinenti. Oggi come allora i professori da me rintracciati lo ricordano come un ragazzo non particolarmente studioso, ma sicuramente promettente. «Non era uno che si metteva in vista. Tutt’altro che adesso. Era molto riservato, timido al punto di diventare rosso. Quando lo chiamavo per un’interrogazione aveva un iniziale impaccio nel comunicare. Ma non era mai impreparato» dice la professoressa Parravicini. «L’ho preso con i calzoncini corti e l’ho avuto per cinque anni. Era un ragazzo che sapeva difendersi bene. Per questo anche la mia amica e collega di storia e filosofia, che era di sinistra e aveva spesso da discutere con lui, gli ha sempre dato voti buoni.» La professoressa in questione, Maria Adele Bertoli, conferma: «Io apprezzavo molto i ragazzi che indipendentemente dallo studio dei testi riuscivano a fare delle proprie riflessioni, e Salvini era uno di questi. Era una persona curiosa che sapeva ben esporre e anche essere simpatico». Faceva simpatia anche alla professoressa Sacerdoti che, scherzando, a volte lo chiamava con il cognome deformato. Lo rivela l’ex compagna di liceo, oggi avvocato, Maria Luisa Godino: «Con affetto gli diceva “Salvetti, Salvetti, tu sei un drittone. Farai strada”». Affetto, simpatia e stima sembrano essere i sentimenti più diffusi tra gli ex professori e compagni di classe da me rintracciati. Tutti ne apprezzavano intelligenza e personalità. E, nel caso di don Luciano, anche i principi. «Aveva dentro questa passione per il sociale e la politica fin da allora» ricorda l’ex insegnante di religione. «Era corretto nel comportamento. Non soverchiava mai gli altri compagni di classe. Era rispettoso della dinamica della classe… e mi pare che abbia conservato questa passione.» Non lo fermo, e don Luciano va avanti: «Da studente gli interessavano le cose vere, non quelle ipocrite o perbeniste e di apparenza. Mi sembrava che andasse alla sostanza delle cose. Voleva che le cose fossero giuste. Dentro e fuori della scuola. E se nel dibattito altri non rispettavano questi due criteri – verità e giustizia – lui interveniva con una certa vivacità». Non resisto e chiedo a don Luciano come ritiene si concilino quei valori con i successivi cori sui napoletani puzzolenti o gli insulti agli immigrati. «Non le sembra che voglia fare anche qualche proposta positiva?» mi risponde. Lascio cadere e torno a parlare dei giorni del liceo con gli altri compagni di classe. Ai quali chiedo che genere di studente fosse. La risposta di uno di loro è: «Per nulla secchione ma molto sveglio e in grado di far bene con sforzi limitati». Chiedo ulteriori spiegazioni. «Matteo ha due caratteristiche: la prima è una grande facoltà mnemonica. Ha una capacità impressionante di immagazzinare dati e date, sviluppata grazie alla sua passione per il calcio. Delle partite del Milan si ricordava tutto: dai minuti dei gol, alle date e i risultati. L’altra caratteristica è un’energia non dico inesauribile, ma quasi. Stare dietro ai suoi ritmi è quasi impossibile» dice l’ex compagno, che mi chiede però l’anonimato. Per quel che riguarda lo stile, mi aiuta ancora l’avvocato Godino: «Era un ragazzo molto riservato. E molto sobrio. Veniva con i mezzi pubblici, non con il vespino. Era vestito bene, ma non vanitoso». Niente prodotti di marca, da «fighetto» insomma. Lo confermano le foto di classe in cui lo si vede con jeans, magliette, pullover con collo a V o a girocollo. Quello dei quattro maschi sopravvissuti assieme al ginnasio è un gruppetto unito ma, a detta sia di insegnanti sia di alunni, gli amici più stretti di Salvini sono due: Enrico Roselli, suo compagno di banco per tutti e cinque gli anni del Manzoni, e Marco Carucci, con il quale condivide avventure di vario genere dentro e fuori la scuola. Non posso fare a meno di notare che nella sua autobiografia Salvini non cita né l’uno né l’altro. Scrive invece solo di «Raffaele, tuttora un grande amico». Ma Raffaele Rossetti è uno dei compagni di classe del ginnasio che Salvini perde al liceo, essendo stato bocciato. Non poteva quindi essere presente nella sua classe, o studiare con lui. Focalizzo dunque la mia attenzione sui due che tutti citano. «Ci siamo conosciuti e abbiamo trovato alcuni punti in comune, dal punto di vista personale. Non era persona iper-espansiva, ma molto divertente, con una bella forma di ironia. E io riconoscevo in lui miei tratti caratteriali» dice Roselli, oggi manager a Lugano. «Ci si trovava fuori di scuola due o tre volte alla settimana, […] giocavamo a Subbuteo a casa sua.» Salvini, che Roselli chiamava Matteo e Carucci più affettuosamente Teo, è stratifoso del Milan. Ma, curiosamente, nessuno dei due amici del cuore è interessato al calcio. Roselli preferisce il tennis, Carucci il rugby. Come molti giovani fascisti. E sì, perché, a partire dal ginnasio, Carucci si dichiara apertamente fascista. Lo fa tuttora, anche se da qualche anno ha lasciato Forza nuova, di cui è stato per molto tempo dirigente e portavoce a Milano. La leggenda del Leoncavallo Veniamo dunque alla politica. E all’anno in cui essa viene scoperta dal nostro. Siamo al primo liceo. Nell’autunno del 1989 Salvini inizia l’anno scolastico con un’unica fede e un unico interesse: il Milan «olandese» di Gullit, Rijkaard e Van Basten. In tutta la classe in quei giorni la politica attiva interessa solo a Marco Carucci. «Magari si partecipava alle assemblee per vedere, ma a noi non fregava niente. Ai tempi le assemblee erano di sinistra, per cui se tu avevi idee di sinistra partecipavi, altrimenti te ne fregavi» dice Robert Ranieli, il quarto dei maschi «sopravvissuti» al ginnasio. Quando capitava che ci fossero degli scioperi, i ragazzi della I D entravano comunque in classe. Sempre Ranieli spiega come: «Avevamo uno che era di estrema destra che buttava giù il picchetto, e noi entravamo in aula». Per delicatezza Ranieli si astiene dal nominare il compagno di classe in questione. È Marco Carucci. Se quest’ultimo è apertamente fascista, l’altro amico, il compagno di banco Roselli, pur non essendo un militante viene ricordato da due professoresse come «di destra». Insomma, i suoi più stretti compagni di classe erano un fascista e un ragazzo «di destra». Nella sua autobiografia, Salvini parla invece di «frequentazione di un ambiente sinistroide». Ma nessuno della dozzina di compagni di classe e docenti con cui ho parlato ha ricordo alcuno di questa cosa. A smontare il «mito del Leoncavallo», su cui moltissimo è stato ricamato dai media, non sono solo tutti i miei interlocutori, lo fa lui stesso in Secondo Matteo, quando scrive: Io nello storico centro sociale milanese avevo messo piede solo una volta in vita mia. Per un concerto. Quando la politica ancora non mi interessava. Peccato che non corrisponda a quello che ha dichiarato nel settembre del 1994, dopo alcuni scontri con la polizia avvenuti in coda a una manifestazione di protesta contro lo sgombero del centro sociale avvenuto pochi giorni prima. Nell’aula del consiglio comunale di Palazzo Marino, prendendo posizione a difesa del Leoncavallo, l’allora ventunenne consigliere leghista disse: Gli incidenti sono avvenuti per colpa di pochi violenti. […] Chi non ha mai frequentato un centro sociale? Io sì, dai sedici ai diciannove anni, mentre frequentavo il liceo. Il mio ritrovo era il Leoncavallo. Là stavo bene, mi ritrovavo in quelle idee, in quei bisogni. Con la pubblicazione di Secondo Matteo apprendiamo che non è vero niente. Non ha mai condiviso né idee né bisogni. Buono a sapersi. Veniamo alla scoperta del Carroccio, avvenuta nella primavera del 1990, come peraltro attestato dalla foto di classe. Salvini passa infatti dal pullover color crema molto British del quinto anno di ginnasio, alla maglia a girocollo verde Lega. Come avviene questa conversione al leghismo? È frutto di letture o approfondimenti filosoficoideologici? O solo della retorica dirompente dell’Umberto? Chiedo all’avvocato Ranieli, in quelle stesse aule noto per la sua passione per Cicerone, se c’era una figura ideale equivalente per Salvini. «Devo essere sincero: non me lo ricordo» mi risponde con la perizia dell’avvocato, aggiungendo poi: «Di sicuro a un certo punto lui era tutto per la Lega». Con simile diplomazia, l’amico e compagno di banco Enrico Roselli conferma: «Che avesse una formazione ideologica pregressa di letture, non credo. Sicuramente il liceo gli ha dato strumenti per fare queste letture». Domando all’avvocato Godino se Salvini aveva interessi filosofici o passioni ideologiche. «Che io sappia no» mi risponde. «Era appassionato di musica, dei cantautori. Ma che io sappia la sua filosofia era quella scolastica. Non ho mai sentito una sua partecipazione particolare per un pensatore. Non aveva infatuazioni di quel genere. Invece Bossi era per lui una specie di star. Gli brillavano gli occhi quando ne parlava. Lo amava come si ama un cantante, un attore. Con una passione e un affetto molto forte.» Da tifoso a leghista Poiché nel suo intero liceo non c’era un singolo altro leghista e nella sua classe c’era un solo alunno interessato alla politica, quell’alunno, il fascista Marco Carucci, in buona sostanza è stato il suo unico «tutore» politico. E il rapporto tra i due non si è interrotto neppure quando, ormai adulto, Carucci è diventato esponente di punta di una formazione dichiaratamente neofascista quale Forza nuova. Tanto che nel 2006, quando Carucci si è sposato, Salvini è stato suo testimone di nozze. Volendone sapere di più ho cercato – e rintracciato – anche lui. Ma a differenza di tutti gli altri non mi ha voluto rilasciare un’intervista. Come su Salvini, anche su di lui ho dunque raccolto ricordi e informazioni basate su altre fonti. Tutte certe e documentate. «Io ero abbastanza studiosa, direi una secchiona, e in seconda liceo mi hanno piazzato Carucci vicino di banco, perché io ero una brava mentre lui faceva casino» ricorda Francesca Tessore, che oggi insegna chimica all’Università di Milano. Le chiedo delle idee politiche del compagno di banco. «Non le nascondeva, non aveva problema a dichiararsi simpatizzante della destra estrema. Ma con me è sempre stato molto carino. Avevo quasi l’impressione che facesse il fascistone, ma non ne fosse veramente convinto. O perlomeno, aveva caratteristiche personali che non mi parevano compatibili con la sua visione politica. Secondo me era un bravo ragazzo. Quando ho visto che è diventato uno dei leader di Forza nuova a Milano ci sono rimasta.» È con quel «bravo ragazzo però fascista» che Salvini trascorre gli anni più formativi. Sia negli orari di scuola sia nel tempo libero. O quando marinano la scuola assieme. In seconda e terza liceo, in particolare, mi è stato riferito infatti che i due hanno una routine primaverile: vanno alla Sormani, la biblioteca a pochi passi dal Manzoni, depositano le loro cartelle e passano ore guardando film, ascoltando musica e studiando. Oppure discutendo di politica. Salvini capisce che c’è un mondo al di là del Milan e scopre la politica. Lo fa discutendone con l’unico amico che da tempo ha già lo stesso interesse. Una fonte ben informata su questo punto mi dice che tra i due si avvia «un profondo confronto non solo sull’importanza della politica, ma anche sul tipo di scelta da fare». La fonte non vuole andare oltre. E soprattutto si rifiuta di spiegarmi come mai il «confronto» con un fascista porti Salvini a scegliere la Lega. I dubbi sull’Olocausto Non citando l’esistenza di Carucci e, men che meno, il loro rapporto, nella sua autobiografia Salvini spiega così quella scelta: Con il senno del poi, posso dire che all’inizio fui attratto soprattutto dalla «trasversalità liberatoria», caratteristica principale della Lega. Poche righe più avanti aggiunge: Nel giro di pochi minuti il discorso si imbottigliava sempre in direzione di un passato troppo ingombrante: la guerra, i partigiani, gli anni di piombo, gli Inti-Illimani. […] La Lega era l’unico partito che affrontava a muso duro il presente: non poggiava su alcuna ideologia nostalgica. Nelle pagine precedenti ho spiegato come la Lega si poggiava piuttosto sulla peggiore delle ideologie «nostalgiche». Adesso apprendiamo insieme che Salvini ha scoperto la politica in ore e ore di discussione con un fautore di quella stessa ideologia. Persona che ha comodamente dimenticato di citare nelle 231 pagine della sua autobiografia. Nonostante fosse stato, e sia rimasto per decenni, suo caro amico. Non si azzarda a fare il suo nome neppure in un passaggio del tutto innocuo, quando parla della sua seconda performance in un quiz televisivo (dopo quella fatta quando era ancora alle medie). Ecco come la ricorda nel suo libro: Nel 1993 collezionai per caso la mia seconda presenza televisiva. Sempre sulle reti Mediaset. Il solito colloquio conoscitivo si tenne a Roma. […] Mi feci accompagnare all’ombra del Colosseo da un compagno di scuola. Era Carucci, ma è un dettaglio di cui non parla. Un vuoto di memoria, chiaramente attribuibile alla volontà di nascondere l’influenza politica di un fan dell’estrema destra. Non potendo negare le convinzioni fasciste dell’amico del cuore, unico mentore avuto nel momento chiave del suo avvicinamento alla politica e persona alla quale, a quattordici anni dalla fine del liceo, Salvini fa da testimone di nozze, meglio evitare di citarlo del tutto. Far finta che non esista. Come i neofascisti. O i postnazisti. Ma la realtà è diversa. Nella realtà Carucci esiste. E dagli anni in cui gli è servito da tutor politico è rimasto fortemente radicato alle proprie convinzioni fasciste. Inclusa la negazione dell’Olocausto. L’introduzione della questione ebraica non è certamente un colpo basso. Al contrario ha un motivo specifico. In prima liceo Salvini, Carucci e gli altri compagni della I D si recano in visita a Dachau, il campo di concentramento nazista appena fuori Monaco di Baviera. Un’esperienza intesa non solo a ricordare, ma soprattutto educare. Non per Carucci, che sin da quella visita si rifiuta di credere che quei forni crematori abbiano mai operato. Li ha visti con i suoi occhi assieme all’amico Salvini, ma mi viene riferito che a suo dire era «roba ricostruita e messa lì dagli americani». La Soluzione finale, intesa come metodico sterminio degli ebrei, per lui non sarebbe mai esistita. Men che meno nella forma delle camere a gas. Poiché non mi ha voluto concedere un’intervista, non posso sapere se Carucci ritiene di aver in qualche modo influenzato il pensiero di Salvini su quel tema. Ma un episodio raccontato dalla loro professoressa di storia e filosofia solleva il dubbio che ci sia riuscito. «Quando c’erano le assemblee studentesche, se c’erano ragazzi che preferivano rimanere in classe alcuni di noi insegnanti dovevano stare con loro. In una di queste occasioni toccò a me. Si parlava della Seconda guerra mondiale, in particolare della Soluzione finale. A un certo punto uno di loro è venuto fuori con questa frase: “Avranno pur fatto qualcosa gli ebrei per essere trattati in quel modo”.» – Ricorda chi fece quella domanda? «Non glielo dico… ma me lo ricordo benissimo.» – Mi viene immediatamente da sospettare che sia stato Carucci. «Non era Carucci…» – Non è stato Carucci? Insisto. Finché la professoressa non cede: «È stato… Salvini». – Non ha dubbi che a fare quella domanda sia stato Salvini? «Sì, sì.» – Intende dire che non ha dubbi? «No. Sono sicura… Anche perché ricordo la scena: ero seduta sulla sedia dietro la cattedra e i ragazzi erano sulle sedie vicine. Salvini era vicino a me.» – E ricorda che a fare la domanda è stato Salvini? «Sì, ricordo questo… Rimasi abbastanza interdetta. Ma come si può fare una domanda del genere? Era una frase che si poteva sentire per la strada. O meglio, in ambienti di estrema destra. Non è una frase che viene fuori in ambienti di studio, di riflessione come il nostro. Ho pensato di aver forse sbagliato in qualche cosa.» A venticinque anni di distanza la professoressa di filosofia e storia non ha dimenticato. «Io presuppongo che quella domanda non si faccia. Non so che significato possa avere. E allora mi meravigliai talmente che non fui neppure in grado di rispondere.» – Ne ha parlato con gli altri colleghi? «Direi di no.» – Neppure con Silvana Sacerdoti? «No, quell’episodio all’epoca non gliel’ho raccontato.» Il motivo è chiaro: la collega di matematica e fisica era sopravvissuta alla Soluzione finale. Nata nel 1932 da una famiglia ebraica, a sei anni seppe dai genitori che non avrebbe potuto continuare ad andare a scuola con le sue amichette. Cinque anni dopo, nel 1943, per sfuggire ai rastrellamenti nazisti fu nascosta in un collegio di suore sotto falso nome. «I miei genitori avevano deciso di separarsi dai figli» ricorda. «Io fui messa in collegio. Mio fratello, che era più grande di me di tre anni, andò a vivere con dei contadini sulla Linea gotica. I miei genitori invece si nascosero a Bologna, in un appartamentino del centro dove mio padre ufficialmente non risultava abitare. Quando suonavano alla porta, era costretto a salire su per la cappa del camino per nascondersi. Alla fine, però, ci siamo salvati tutti.» La professoressa ha ricostruito quella drammatica esperienza famigliare in un libricino di cui mi ha autorizzato a riprodurre alcuni estratti, quelli che trovate in fondo a ogni capitolo. Lo ha pubblicato per i suoi nipoti. Affinché sapessero quello che era successo a lei e a tutti gli ebrei italiani. A pagina 10 c’è una foto che la ritrae a quattro anni alla festa di Carnevale in cui vinse il primo premio per la miglior maschera assieme a un amichetto. Era il figlio del gerarca fascista Franz Pagliani. Arrestato il 25 luglio 1943 in seguito alla caduta del regime fascista, ma liberato dai tedeschi dopo l’8 settembre, Pagliani aderì alla Repubblica sociale italiana unendosi alla Brigata nera Attilio Pappalardo. Fece parte del Tribunale speciale di Verona condannando i firmatari del famoso «Ordine del giorno Grandi», la decisione del Gran consiglio del fascismo presentata dal gerarca Dino Grandi con la quale Benito Mussolini venne deposto dalla guida del Regno d’Italia. Catturato dagli Alleati dopo il 25 aprile 1945, fu processato e condannato a morte, ma la pena fu commutata in detenzione e dopo meno di cinque anni, nel 1950, venne scarcerato. Iscrittosi al Msi, nell’immediato dopoguerra Pagliani ne diventò un importante dirigente. Il suo passato di gerarca fascista? Tutto velocemente dimenticato. Anche volendo, a Silvana Sacerdoti non è stato invece mai concesso di dimenticare. Né da liceale, né da insegnante. «In quarta ginnasio, il professore di lettere, spiegando geografia e parlando del Nord Africa e dei suoi abitanti disse: “E poi ci sono gli ebrei”. E aggiunse: “Già, questi ebrei… sono dappertutto!”. Io mi sentii molto offesa, e imparai a starmene per conto mio.» Molto meno velato il messaggio che un giorno trovò scritto con una bomboletta spray su un muro esterno del Manzoni. La frase era di appena tre parole, ma laceranti per chi aveva vissuto due anni nascosta sotto mentite spoglie per sfuggire all’Olocausto: MORTE AGLI EBREI. «Andai dal preside e gli dissi che non sarei entrata a scuola finché c’era quella scritta. Lui mi rispose che non poteva farla cancellare perché era compito del Comune. Fu il tecnico del laboratorio, Gianni, che vedendomi molto arrabbiata mi disse: “Professoressa, vado io”. E ci scarabocchiò sopra con altra vernice.» La professoressa Sacerdoti non ricorda l’anno, ma non è difficile datare la scritta. A sinistra di quelle tre parole la stessa mano, con la stessa vernice, aveva disegnato una croce celtica, mentre a destra aveva scritto: W SADDAM. Doveva dunque trattarsi dei primi mesi del 1991, all’epoca della prima guerra del Golfo. L’associazione tra Saddam Hussein e la morte degli ebrei non poteva infatti che essere dovuta a quell’evento, quando il dittatore iracheno rispose all’attacco delle forze della coalizione impegnata nella liberazione del Kuwait lanciando missili Scud contro Israele. In altre parole la scritta sul muro del Manzoni è apparsa quando Salvini era in II D, aveva scoperto la Lega e voleva conoscere quali colpe degli ebrei giustificassero la Soluzione finale. È lo stesso frangente in cui Maurizio Murelli pubblica sulla rivista «Orion», dove la croce celtica è di casa, un lungo articolo sulla guerra tra Saddam Hussein e le forze alleate, sostenendo che «la neutralità è impossibile». Titolo a tutta pagina: Dalla parte dell’Iraq. *** In seguito al delitto Matteotti, Mario Jacchia aveva dichiarato apertamente la sua posizione antifascista e i fascisti gli saccheggiarono lo studio a Bologna, buttando tutto dalla finestra. Dopo l’8 settembre 1943, entrò in clandestinità e divenne vicecomandante militare del Comitato di liberazione nazionale. Nel sotterraneo del suo studio in via D’Azeglio realizzava documenti falsi per i partigiani e gli ebrei che dovevano nascondersi. Fu lui a portarci personalmente i nostri. Con la nuova identità ci chiamavamo Sartori ed eravamo nati a Modica, che all’epoca era già in mano agli Alleati, perciò i nostri dati anagrafici non erano controllabili. Eravamo soliti salire alla villa Torretta di Jacchia nei pomeriggi domenicali. Una volta trovammo il col. Modena, il prof. Volterra e la moglie: era una giornata brutta, e dalla vetrata dell’ampio soggiorno, che dava sulla spianata, si vedeva un cielo di nuvole nere sopra la città, solcato ogni tanto da lampeggianti saette. Anche noi eravamo neri e spaventati dalla piega degli avvenimenti, le leggi razziali del 1938 e tre anni di guerra. Noi donne guardavamo agli uomini che restavano inerti, senza cercare di agire in un qualsiasi modo. Ci voleva coraggio, molto coraggio a sapere di poter rischiare la vita nel peggiore dei modi. Senza volere, i nostri occhi si volgevano a Jacchia: lo sapevamo coraggioso e combattivo. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti I nazional-bolscevichi di Mosca con i postnazisti di Saluzzo Il programma euroasiatico Cosa c’entra un movimento autonomista come la Lega con uno Stato centralista quale la Russia, che dall’epoca degli zar conduce campagne di sopraffazione linguistica, culturale e religiosa contro le sue minoranze nazionali? Sulla carta non c’entra proprio nulla. Eppure Matteo Salvini si presenta come il governante occidentale più in sintonia con il Cremlino. Così come lo è stato Umberto Bossi vent’anni fa. Conoscendo quella che il cofondatore della Lega, Giuseppe Leoni, ha definito la «confusione» dottrinale del movimento, qualcuno potrebbe essere tentato di alzare le spalle e ritenerla una delle sue inspiegabili contraddizioni. Una spiegazione invece c’è. L’illogico allineamento politico della Lega al Cremlino è infatti uno dei risultati della campagna d’infiltrazione politica e contaminazione ideologica condotta da quelli che chiamo «i postnazisti di Saluzzo». I primi a scoprire Mosca dopo il crollo dell’Unione Sovietica sono proprio i redattori di «Orion», che, in seguito all’uscita di scena di Michail Gorbačëv, assieme ai loro confratelli francesi e belgi aprono un canale di comunicazione con chi in Russia si oppone al processo di occidentalizzazione. Dello straordinario incontro tra discepoli di Evola e nipoti dello zar è rimasta una documentazione non solo scritta ma anche fotografica. Mi riferisco a uno scatto a colori dell’estate del 1992. Seduto in prima fila, al centro della foto, spicca il grande vecchio del postnazismo europeo, il belga Jean Thiriart. In piedi, alla sua destra, si riconosce Michel Schneider, direttore della rivista francese «Nationalisme et République» ed ex consigliere politico di Jean-Marie Le Pen, padre di Marine e fondatore del Front national. Di fianco a lui i «nostri» Carlo Terracciano e Marco Battarra. Con loro ci sono quattro russi: Valentin Chikin, Eduard Volodin, Gennadij Zjuganov e Aleksandr Dugin. Chikin è un giornalista con una lunga carriera di sostenitore del regime sovietico, poi eletto deputato. Volodin, caporedattore del quotidiano «Sovetskaja Rossija», è copresidente del Fronte di salvezza nazionale, organizzazione che unisce l’estrema destra, nazional-bolscevichi e stalinisti contro l’allora presidente Boris Eltsin. Ex ideologo del Pcus e segretario del Partito comunista della Federazione russa, Zjuganov è il presidente di quel Fronte. Il personaggio per noi più significativo è il quarto russo, Aleksandr Dugin, organizzatore di quello e di altri incontri tenutisi a Mosca (con una coda milanese) tra il 1991 e il 1993 in una riedizione postsovietica del Congresso di Vienna, la storica conferenza svoltasi tra l’autunno del 1814 e l’estate del 1815, con la quale i grandi imperi europei ripristinarono princìpi e dinamiche tradizionali dopo gli sconvolgimenti della Rivoluzione francese. Se nel Congresso di Vienna vennero gettate le basi della Restaurazione antilluministica dell’ancien régime, con lo zar russo Alessandro I nelle vesti del più attivo promotore della Santa alleanza, durante le visite a Mosca dei più recenti anni Novanta viene lanciata l’idea della creazione di un grande blocco «euroasiatico» basato su una riedizione di quegli stessi valori tradizionalisti e antilluministici di Vienna. Ed è Aleksandr Dugin a svolgere lo stesso ruolo dello zar suo omonimo, con l’idea di fare della capitale russa una «Terza Roma», ovvero il centro di un impero continentale che avrebbe dovuto raccogliere eredità e testimone di quello romano e quello bizantino. Il programma «euroasiatico» lanciato da Thiriart era stato compilato proprio dai nostri amici di Saluzzo sin dalla metà degli anni Ottanta, com’è documentato dalla collezione di «Orion». Nel numero del novembre 1985 viene pubblicato un manifesto politico in cui la redazione si dichiara a favore di un impero euroasiatico che si estenda dall’oceano Pacifico a quello Atlantico, che abbia come guida spirituale e politica l’Europa. Uno «stato-impero» formato da «regioni nazionali» a conduzione organica i cui confini rispettino non gli interessi del mondialismo ma quelli delle etnie. In un numero dell’anno successivo, Murelli stesso pubblica un editoriale intitolato Usa, Urss o Eurasia?. E scrive: Oggi a cercare l’Europa è soprattutto l’Est, Mosca, giacché il centro d’Europa si è spostato proprio lì. […] Il risultato della Seconda guerra mondiale è stato quello di rendere impossibile la riunificazione dell’Europa che, se si realizzasse, tenderebbe automaticamente a ricongiungersi con l’Est. È invece possibile favorire il risucchio dell’Europa da parte di Mosca, risucchio che risulterebbe salutare da un punto di vista geopolitico, mentre risulterebbe indigesto sul piano ideologico. Lo spauracchio sovietico preoccupa i borghesi, coloro che hanno della libertà un concetto americanizzato e degradato. Viva allora Mosca contro Washington. Viva l’Eurasia! Nell’intervista concessami per questo libro, Maurizio Murelli non esita a spiegarmi queste sue piroette ideologiche: «Per certi versi l’Europa e lo spazio a Est si sono sempre cercati. Chiaramente con il segno dei tempi: Napoleone alla sua maniera, Hitler alla sua. Gli americani – e gli inglesi – hanno sempre impedito questa ricomposizione che può essere geografica, culturale, economica o artistica». Quando gli faccio notare che all’interno di un quadro imperiale euroasiatico fatico a vedere come possa esserci spazio per la sovranità dei popoli, Murelli risponde: «L’impero è rispettoso delle identità nazionali […] come lo erano anche i romani. Purché si rispettasse la legge centrale, c’era ampia autonomia e rispetto per le popolazioni sottomesse». Sottomesse, appunto. Faccio la stessa osservazione a Marco Battarra, chiedendogli come l’autodeterminazione dei popoli a lui tanto cara possa conciliarsi con una realtà storicamente oppressiva delle minoranze come è quella di Mosca. «Nella nostra visione, la mia e di Murelli, l’impero non è imperialista, ma rispetta le minoranze e le identità al suo interno» mi risponde. – Ma qual è questo impero che rispetta le minoranze? «Ah be’… certo… eh, non ci sta l’impero. Bisogna costruirlo… Certo che non ci sta… C’è stato nella Storia. E ci sono regimi che hanno un’immagine autoritaria ma che invece rispettano le minoranze. Sono stato in Iran e le posso assicurare che lì tutte le minoranze, anche quelle religiose, sono rispettate. Seppur sia una repubblica islamica. Ho anche intervistato uno dei due deputati della comunità ebraica e un rappresentante degli zoroastriani, che pur essendo in quattromila hanno un seggio in Parlamento. Non è una cosa fuori dal mondo. Se c’è la volontà si può fare.» – Mi sta dicendo che lei applicherebbe il modello iraniano all’Europa? «No. Il modello iraniano è un modello islamico. Io dico che il regime iraniano nei confronti delle proprie minoranze ha adottato un modo di agire esemplare. Io non sono musulmano e non mi interessa esportare l’Islam in Europa, ma è un dato di fatto: nei confronti delle minoranze il regime iraniano ha un atteggiamento all’avanguardia.» Carlo Terracciano è morto e quindi non posso chiedere anche a lui. Ma una definizione dell’idea euroasiatica – e delle sue radici – la fornisce un suo articolo del gennaio 1993: La sconfitta bellica dei fascismi e quella pacifica (o quasi) dei comunismi europei andava nel senso voluto dai padroni dell’usura […] del Nuovo Ordine Mondiale americanocentrico. […] L’Europa potrà esistere unitariamente solo come un grande ideale di tutti i popoli che la compongono: l’Europa delle cento bandiere di tutte le piccole patrie che rappresentano la sua grande ricchezza etnica e storica. […] Per realizzarsi questa Europa dovrà far conto su uno Stato guida, un santuario da cui parta la mobilitazione […] e siamo convinti che l’unica realtà geopolitica capace di assumersi un compito così gigantesco sia la Russia, o meglio l’ex-impero sovietico rinato sotto nuova veste e con un’altra idea-forza. O l’Eurasia sarà unificata in qualche modo da Reijkiavik a Vladivostok, da oceano a oceano, dal Polo Nord ai mari e deserti del centro Asia, oppure non esisterà. L’antimondialismo di Dugin Non tutti i protagonisti della Santa alleanza duginiana sono inclusi in quella fotografia scattata nell’agosto del 1992. Tra i non italiani mancano per esempio il francese Alain de Benoist e il belga Robert Steuckers, due dei più noti discepoli di Thiriart che dopo essere stati assieme nel Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, o Grece, sono passati alla storia come i due grandi separati in casa della Nouvelle droite europea. Esponenti di una destra che si poneva oltre i tradizionali partiti politici, lontana da rivendicazioni e nostalgie del passato, ma rivolta a elaborare una «nuova sintesi politica». Proprio quello che cercavano anche Murelli e i pensatori di «Orion». L’ex membro di Jeune Europe Claudio Mutti mi spiega di essere stato lui a presentare Dugin prima a De Benoist e poi agli amici di Saluzzo: «Dugin mi aveva avvisato che si sarebbe recato a Parigi, dove sarebbe stato ospite di alcuni amici esoteristi cristiani. Io e Dugin andammo a cena con De Benoist, che gli fece una serie di domande sulla situazione russa». Quattro mesi dopo, nell’ottobre del 1990, Mutti fa conoscere il russo ai redattori e lettori di «Orion» con un articolo intitolato A colloquio con Aleksandr Dugin. Il passaggio di quell’intervista che meglio esprime il pensiero di Dugin ritengo sia questo: La perestrojka è stata imposta con la forza, contro la volontà popolare e contro la logica stessa del sistema vigente. Il sistema brezneviano funzionava bene. Il potere del Partito era saldo. Sul piano economico si sarebbe potuto continuare così per altri cento anni. All’improvviso tutto è stato distrutto dalla volontà di Gorbačëv, o di qualcuno che si trova dietro di lui. Dietro la perestrojka si trova qualche centro di potere occulto. Alla domanda di Mutti su quale sia la forma costituzionale a suo giudizio preferibile per la Russia, Dugin risponde così: La miglior forma di governo è la monarchia. La regalità deve essere concepita però come regalità sacra, basata su un diritto d’origine soprannaturale e conferito dalla tradizione autentica. Per la Russia, la regalità è stata l’unica forma politica, la forma politica normale. L’omicidio dell’ultimo zar ha rappresentato la fine della Santa Russia. Ora, se si vuole restaurare la santità della Russia, bisogna innanzitutto pentirsi del regicidio e ritornare alla monarchia. O meglio, all’impero. La sintonia ideologica tra Dugin e i saluzziani è facilitata dalla comune radice evoliana. Ecco come la spiega il russo in un’intervista: Ho conosciuto Evola da alcuni miei maestri russi, che a loro volta hanno scoperto il pensiero tradizionalista negli anni Sessanta. L’universo descritto da Evola conteneva il miglior impianto ideale che avessi mai incontrato. Allora non riuscivo a capirne il perché […] eppure sentivo di appartenere all’universo descritto da Evola più di quanto non mi accadesse con quello in cui vivevo. I «maestri» di cui Dugin parla senza precisarli sono i membri di un circolo letterario clandestino guidato da Jewgienij Gołowin, scrittore mistico, occultista, integralista e fascionazista autoproclamatosi «Reichsführer dell’Ordine nero delle SS». La prima esperienza più direttamente politica, Dugin la fa alcuni anni dopo, quando viene eletto membro del Consiglio centrale di Pamyat, un movimento ultranazionalista che, nell’agosto del 1990, viene presentato così ai lettori di «Orion»: Il gruppo Pamyat, o Memoria, si batte per la riscoperta dell’eredità culturale russa. […] Tenne la sua prima grande manifestazione a Mosca nel 1987, con una adunata cui parteciparono decine di migliaia di persone, delle quali alcune agitavano bandiere zariste chiedendo anche cristiana sepoltura per i resti dell’ultimo zar e della sua famiglia. La sua confusa ideologia coniuga un folklore ruralista tradizionale con una aperta professione di antisemitismo. Pamyat è solo un aspetto, estremizzato e dai toni anche grossolani, del nazionalismo russo. La permanenza di Dugin in Pamyat però non dura, perché poco dopo la sua nomina al Consiglio centrale viene espulso. Apparentemente per «occultismo». Convertitosi al nazional-bolscevismo, diviene il principale promotore del «progetto geopolitico dell’Eurasia», una riedizione in chiave contemporanea, seppur fortemente tradizionalista, dell’idea imperiale bizantina. Il progetto ha un nemico mortale: il mondialismo cosmopolita, la cui manifestazione militare è rappresentata dal Patto atlantico, mentre quella politica dagli Stati Uniti d’America, considerati «terra di decadenza e morte». Ecco come Claudio Mutti definisce il progetto duginiano in un suo articolo: L’ultima generazione di eurasiatisti riprende la dicotomia tra la terra e il mare, tra potenze continentali e potenze marittime; dicotomia che è posta alla base di due atteggiamenti psichici e quindi storici assolutamente inconciliabili: da un lato lo spirito imperiale, organico e tradizionale; dall’altro lo spirito del traffico, della mobilità, del progresso; da un lato Roma (o la Terza Roma), dall’altro Cartagine (gli Stati Uniti). Il postnazismo di Steuckers e De Benoist I tre perni ideologici della visione duginiana – tradizionalismo evoliano, guerra al mondialismo e antiamericanismo – sono gli stessi attorno ai quali ruota la dottrina della destra postnazista europea elaborata da Jean Thiriart e perfezionata dai suoi discepoli Alain de Benoist e Robert Steuckers. Quest’ultimo mi ha spiegato che l’idea di Grece viene a De Benoist e a un pugno di suoi collaboratori nel febbraio del 1968. Si ispira al pensiero gramsciano dell’egemonia culturale, che De Benoist rielabora e presenta ai suoi adepti in una conferenza intitolata Pour un gramscisme de droite. Prima di sposare la visione del nazional-bolscevismo euroasiatico, a sentire il belga Steuckers, De Benoist tenta la strada dell’infiltrazione di un altro movimento ideologico di destra che stava emergendo nei primi anni Ottanta nell’Europa continentale, quello del neoliberismo monetarista thatcherian-reaganiano. In un’operazione che secondo la terminologia borgheziana si potrebbe definire «entrista», assieme a un gruppetto di adepti della nuova destra, De Benoist cerca di prendere il controllo di una conferenza internazionale neoliberista convocata a Parigi nel dicembre del 1981. Ecco come Steuckers ricostruisce l’evento: «Il suo gruppo di aspiranti Machiavelli pensò ingenuamente che nessuno avrebbe sentito odore di bruciato e si sarebbe accorto della manovra con la quale il nostro contava di rifarsi una verginità dottrinale, per non essere più preso per un “fascista” o “criptofascista”. Ma la manovra fu scoperta e De Benoist fu espulso dal pannello dei relatori della conferenza come una battona sorpresa in un hotel di lusso della riviera». Gli chiedo come fa a sapere questa cosa e Steuckers mi risponde di esserne stato testimone in prima persona. Volendo approfittare di tanta schiettezza, gli chiedo di parlarmi del gruppo di «Orion». Steuckers mi spiega di aver conosciuto inizialmente Marco Battarra. «Nei primi anni Ottanta venne da me in Belgio con un paio di altri giovani di Saluzzo» mi spiega. «Poi lo reincontrai assieme ad Alessandra Colla, in un convegno del 1989.» Robert Steuckers mi spiega di aver conosciuto anche Carlo Terracciano e Mario Borghezio in occasione di una «festa del popolo fiammingo» organizzata dal gruppo belga di estrema destra Vlaams Blok. Chiedo dettagli. «Ricordo che c’era una fiera dei libri in lingua fiamminga e lì incontrai Battarra, che era con Borghezio, e me lo presentò. C’era anche Terracciano e andammo tutti a cena insieme.» Faccio subito una verifica con Battarra: «Confermo» mi dice. «Siamo tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta a Diksmuide, paese a qualche chilometro dal mare vicino a Ypres, dove tutti gli anni viene fatta una grande manifestazione ai margini della quale si fanno iniziative gestite dai movimenti fiamminghi radicali.» La collezione di «Orion» mi aiuta a determinare la data precisa. Nel numero di ottobre del 1988 c’è infatti un articolo di Battarra che fa riferimento a quel viaggio: È a una favolosa festa – una grande kermesse – che abbiamo fraternamente partecipato. Noi – soli italiani presenti, insieme a un rappresentante della Lega Lombarda – e numerosi rappresentanti di altri gruppi, europei e sudafricani, avvolti nella sempre calorosa accoglienza dei camerati fiamminghi, nostri fratelli di lotta. Qui la birra scorre a fiotti, le fanciulle sono bionde e belle, i giovani sfilano con le bandiere al suono di trombe e tamburi. Diksmuide è il crogiolo della futura Europa dei popoli, Europa nella quale entreremo a testa alta e capelli al vento. Anche sulle proposte politiche sponsorizzate da Steuckers la migliore fonte d’informazione è la collezione di «Orion». Trovo il riferimento a un convegno intitolato L’Europa delle cento bandiere che si diceva «organizzato dall’infaticabile Robert Steuckers» l’11 marzo 1989 a Bruxelles. C’era andato il solito Marco Battarra. Noto che la copertina di «Orion» del mese successivo ha lo stesso titolo del convegno – L’Europa delle cento bandiere – e pubblica un articolo di ben sette pagine, intitolato Confederazione europea o nazione europea?. È l’ennesima apologia del Terzo Reich, precursore dell’etnonazionalismo europeo. Si legge infatti che sul finire della guerra, in Germania si immaginò di modificare la struttura interna del Reich, retrocedendo Hitler nella posizione formale di presidente e valorizzando la posizione del Reichsführer-SS, cioè di Himmler. L’Europa si sarebbe trasformata in una federazione, anzi in Confederazione europea, basata sui principi della cooperazione volontaria e della libertà delle nazioni-etnie. Domando a Steuckers come definirebbe politicamente il gruppo di «Orion». Lui risponde senza esitazione: «Erano nazisti… direi tipici nazisti italiani». Davanti a tale apertura, gli rivolgo una domanda provocatoria chiedendogli come mai una persona che si dichiara leghista quale Borghezio possa essere tanto vicino a dei nazisti. «Presuppongo che, occultamente, in Italia esista un tipo di società segreta che ruota attorno a Evola» mi risponde. «E che i suoi membri si inseriscano ovunque possono. Dove hanno possibilità di “fare cultura”.» O meglio avere presa politica su un terreno che si dimostra fertile. Lotta comune all’imperialismo americano La più evidente dimostrazione del sincretismo tra postnazisti e leghisti la trovo ancora una volta su «Orion» che pubblica, sparata su due intere pagine, una foto di uno striscione visto a Pontida. Lo slogan, a grandi lettere, dice: CENTO BANDIERE, CENTO NAZIONI, CENTO LIBERTÀ, LEGA NORD, SEZ. SALUZZO. E nella didascalia che accompagna la foto si legge: «All’interno della Lega sono riscontrabili presenze e tendenze sicuramente antimondialiste come dimostrato dallo striscione esposto sulla collina che dominava la valle e che qui riproduciamo». Ma torniamo ai viaggi a Mosca. Delle discussioni avute in quella serie di incontri che danno i natali alla Santa alleanza duginiana sono riuscito a trovare svariate testimonianze documentali. La prima viene dal testo di un intervento tenuto a Mosca da Claudio Mutti nel marzo 1993: Nel 1917 gli Stati Uniti approfittarono della guerra civile europea per inserirsi negli affari del nostro continente, per umiliare la Germania e gli altri paesi sconfitti con i trattati di pace, per creare nuove entità statali dominate dalle democrazie occidentali e per rendere così instabile e pericolosa la situazione europea. Finché la successiva guerra civile del ’39-45 fornì loro l’occasione per aggredire l’Europa, col pretesto di liberarla. [… ] Come il nostro amico Dugin sa bene, l’idea di un asse russo-tedesco come alleanza euroasiatica contro le potenze atlantiche ha costituito un leitmotiv nel pensiero della Konservative Revolution (la Rivoluzione conservatrice tedesca fornì quell’humus culturale da cui si sviluppò il nazismo. Julius Evola ne fu fortemente influenzato). Dunque è in questa direzione che bisogna agire se si vuole che l’Europa – l’impero eurosovietico da Vladivostok a Dublino, per riproporre la parola d’ordine lasciataci da Jean Thiriart – si incammini sulla strada dell’unità e dell’indipendenza. […] La stampa controllata dalla mafia sionista e le televisioni dirette dalle marionette filo-americane non aspettano altro che poter gridare al «pericolo della rinascita del nazismo» o poter agitare lo spauracchio del panslavismo. Mutti è convinto infatti che «il nemico comune di tutti gli europei – il nemico dell’Eurasia – è l’imperialismo americano e sionista, che oggi ha il nome di Nuovo Ordine Mondiale». Dello stesso tono sono le parole pronunciate nella medesima occasione da Carlo Terracciano: La nostra delegazione viene da un paese che da decenni è sottoposto all’occupazione americana. Abbiamo un governo e un Parlamento asserviti totalmente agli interessi stranieri: all’alta finanza internazionale, all’imperialismo americano, al sionismo cosmopolita, in una parola al mondialismo. Sionismo e imperialismo vogliono distruggere l’anima stessa dei popoli. E voi russi oggi state provando sulla vostra carne viva la lama sanguinaria di questi criminali: miseria, fame, disonore, corruzione, droga, alcol e criminalità, odi e divisioni nel popolo, tradimento della patria. […] Noi, eredi senza più patria di un Impero che fece la storia civile del mondo antico, chiediamo al popolo che ha raccolto l’eredità storica e spirituale di Roma e di Bisanzio: aiutateci a riscattare insieme il nostro e il vostro passato. Perché nella tradizione e nella memoria storica e ancestrale dei popoli è la chiave che apre le porte dell’avvenire. Nel caso i concetti non fossero sufficientemente chiari, appena tornato in Italia, Terracciano rivolge la stessa chiamata alle armi ai suoi lettori: L’Italia è un’oligarchia plutocratica fondata sulle baionette dell’occupante americano. Questa è, in poche parole, la realtà che tutti sanno e nessuno dice. L’8 settembre resta sempre la data di fondazione per gli uomini di questo regime; quelli in stellette e quelli in doppiopetto, quelli palesi e quelli coperti. È davvero singolare che oggi, dopo la fine dell’impero sovietico, lo smembramento dell’Urss e il ripiegamento della Russia stessa entro i propri confini, a nessuno nel Parlamento italico, sia mai venuto in mente di chiedere l’uscita dell’Italia dalla Nato e il dissolvimento stesso di quel Patto atlantico, sorto, così vollero farci credere, allo scopo di opporsi a un’invasione sovietica dell’Europa. […] Abbiamo risposto all’appello degli amici russi: patrioti di tutto il mondo, unitevi! […] Smentiamo i nefasti avvoltoi della «fine della Storia», unendoci ai fratelli in lotta dell’Est e del Sud del mondo, per dare l’assalto alla sinagoga del Grande Satana moderno: l’imperialismo americano e i suoi collaborazionisti rinnegati d’ogni paese e d’ogni parte politica. Come sempre, ai grandi appuntamenti della Storia, «Chi non è con noi, è contro di noi». E come tale sarà trattato. Pur non partecipando di persona a quelle conferenze moscovite, anche Maurizio Murelli sposa la visione euroasiatica, avviando sin da quei giorni un fruttifero rapporto di collaborazione con Aleksandr Dugin. Che annuncia in un articolo intitolato, appunto, Eurasia: Esistono idee e progetti che a prima vista appaiono utopici, irrealizzabili, impossibili, nuove sintesi ideologiche euroasiatiche […] Tutti coloro che operano oltre gli schemi ideologici per trovare un’intesa fra tutti quelli che hanno attraversato composizioni ideologiche diverse, si trovano oltre. Oltre il fascismo, oltre il neofascismo (che del fascismo, per quaranta anni, è stato la scimmia), oltre il comunismo e il neocomunismo revisionista italico (che del comunismo è stato la scimmia). Teste d’ariete come la Lega Nord stanno scompaginando l’assetto nazionale, aiutate dall’implosione dei partiti. Tutto si centrifuga e grandi sono gli spazi che si aprono. Si tratta di vuoti che vanno colmati, che possono essere colmati sviluppando nuove aggregazioni e avendo come esempio quanto appunto accade oggi in Russia. Murelli non va a nessuno degli incontri di Mosca. Ma decide di invitare Dugin in Italia. «Nel 1992 lo portai a Milano, al circolo Le Stelline. Lo contattò Battarra e poi io organizzai un convegno con lui, mia moglie, Battarra e Terracciano» mi spiega. «Da lì è cominciato un rapporto molto buono, che si è prolungato nel tempo. Intuii allora che era una mente molto brillante, con una capacità analitica superlativa. […] In quella fase lì anche lui stava sperimentando vie d’uscita dalle ortodossie ideologiche. Tant’è che con [Eduard] Limonov fece quel partito cosiddetto nazional-bolscevico. […] Cosa ne penso? Penso che è un gigante tra i pensatori e gli analisti oggi presenti nel mondo. Un punto di riferimento molto interessante, una mente notevole.» *** Una mattina, verso l’una, fui stupita nel vedere arrivare mio marito Guglielmo con una valigia abbastanza capace. Mi raccontò che, andando quella mattina a trovare Mario Jacchia nello studio di via D’Azeglio, come era solito fare, prima di entrare si vide venire incontro la dattilografa impiegata da anni da lui, gli disse: «Per carità, ingegnere, faccia dietrofront. L’avvocato è ricercato dai tedeschi e lo studio è piantonato». Guglielmo capì che era giunto il momento di rintanarsi; partì immediatamente deciso a non mettere più piede a Bologna. Pensammo di stabilirci in cima alla montagna, alle Rocche, perché con l’avvicinarsi del fronte sarebbe stato pericoloso stare a fondo valle, vicino alla strada di transito delle forze armate tedesche. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti Il Sole delle Alpi e la svolta celtica della Lega La prima poltrona di Salvini Il 20 giugno 1993, a vent’anni appena compiuti e poco dopo il diploma liceale, Matteo Salvini viene eletto nel consiglio comunale della sua città. È il primo passo di una carriera che lo porterà al Viminale e alla vicepresidenza del Consiglio. Ma in quell’occasione la scelta non è degli elettori. È Umberto Bossi a garantirgli quella prima poltroncina. Me lo dice Marco Formentini, il sindaco leghista che vinse quelle storiche elezioni: «Fu inserito nel listino del sindaco, di quelli che sarebbero stati eletti automaticamente». I suoi meriti? «Aveva idee molto allineate con il movimento. E non poneva nessun problema.» Insomma, spiega l’ex sindaco, oltre a essere «serio e impegnato», tra i suoi punti di forza c’era quello di essere «sempre disponibile». Ecco invece i ricordi di Roberto Predolin, all’epoca capogruppo della coalizione vincente a Palazzo Marino, quella del centrodestra: «Si è dimostrato sin da subito un ragazzo molto sveglio, molto veloce e con una carica personale molto forte. Ma anche molto, molto attento a come si muoveva e cosa faceva». Parlando di una «determinazione a fare carriera», Predolin lo descrive come «uno che a vent’anni entra in un consiglio comunale molto qualificato, come era quello di allora, e si avventura fin dall’inizio in aperta polemica un po’ con tutti. Vuole far conoscere le sue opinioni». Gli chiedo di sforzarsi di ricordare episodi specifici. E lui me ne cita uno: «A due giorni dal suo ingresso in aula si alza e fa un intervento. Non ricordo l’argomento, ma so che era un tema sul quale erano intervenute parecchie altre persone. Di solito quando sei un nuovo arrivato, stai in un angolo, aspetti e fai un po’ di scuola. Lui invece è intervenuto subito. In qualità di capogruppo del centrodestra gli ho detto: “Guarda, prima di dire le cose cerca di capirle meglio”. È stata la prima volta che ci siamo confrontati, ma lui è andato avanti come un treno sin da quel giorno». Combattivo e bisognoso di visibilità, ma per nulla stupido. «Così come partiva, sapeva anche fermarsi e riposizionarsi. Senza pagare dazio. Aveva la caratteristica di saper cambiare in corsa quello che poteva essere un errore» aggiunge Predolin. L’allora consigliere comunale di Rifondazione comunista, Davide Tinelli, detto Atomo, dà un giudizio decisamente meno generoso: «È sempre stato un grande arrivista. E un cinico». Anche a lui chiedo esempi concreti. «In aula spesso e volentieri faceva interventi che facevano accapponare la pelle – per esempio contro i campi nomadi – con attacchi fatti in modo becero e meschino. Poi, un’oretta dopo, davanti a una birra al bar di Palazzo Marino, rideva e scherzava dicendo: “Ma sì, lo sai che non è vero che lo penso. È che lo devo fare”. Cose che lasciano basiti. Ma come fai a essere così? Io non ce la farei mai… forse per questo non ho fatto carriera in politica.» Anche i suoi critici riconoscono però a Salvini due caratteristiche positive: una straordinaria energia e una determinazione assolutamente insolita nel battere il territorio palmo a palmo per stare a contatto con la gente. «Viveva molto fuori dalle aule istituzionali. Era sempre in giro. Il suo attivismo si è sempre espresso soprattutto sul territorio» dice Emanuele Fiano, oggi deputato del Pd, ma in passato consigliere comunale a Milano per i Ds. Predolin conferma: «Era molto preso dai rapporti con le piccole comunità. Seguiva realtà ignorate da altri, anche se elettoralmente valevano poco». Poi aggiunge: «Cercava piccole realtà da portarsi dietro, un atteggiamento abbastanza furbetto». Ma a un anno dall’avvio di una carriera politica a tempo praticamente pieno (visto che agli esami universitari dedicava molte meno energie), avviene il grande ribaltone del 1994, quando Umberto Bossi decide improvvisamente di rompere con Silvio Berlusconi e far cadere il primo governo di centrodestra. Il grande ribaltone A quel punto per il capo della Lega diventa essenziale trovare pulsioni da cavalcare che vadano oltre la battaglia per l’autonomia fiscal-amministrativa. Occorrono tematiche emotivamente più coinvolgenti. È allora che dal leggendario cavaliere lombardo Alberto da Giussano, che con il suo scudo medievale avrebbe fermato Federico Barbarossa, la Lega passa ai culti precristiani e soprattutto al mito del popolo celtico. Questa transizione, per nulla naturale, è il primo segno di quell’opera di «contaminazione culturale» avviata dal mondo della destra antagonista che aveva in Saluzzo il suo centro di elaborazione di pensiero. Ancora una volta è tutto scritto nelle pagine del mensile di Murelli: «Orion» è venuto incontro all’esigenza del sacro fornendo miti e saghe della tradizione precristiana indoeuropea e celtica, riattualizzando il politeismo pagano che esprimeva la propria religiosità nel rispetto del cosmo e nell’amore per la natura. […] Si è trattato dell’inizio di una revisione concettuale grandiosa, quanto difficile da proporre e portare avanti, ma è innegabile il merito e il coraggio di averla proposta con una coerenza e una costanza che non si è mai vista in altre pubblicazioni. Che l’assunzione di paternità non fosse infondata lo dimostrano le paginate che da anni «Orion» dedicava a miti e celebrazioni celtiche. Come quella in cui si annunciava la partecipazione alla Lugnasad, l’Assemblea di Lug, in Svizzera, la festa celtica europea tenutasi l’1 e il 2 agosto 1987: La Lugnasad è stata innanzi tutto una grande riunione comunitaria. Numerosi movimenti, circoli e associazioni erano presenti. Più di 300 amici francesi, fiamminghi, valloni, italiani, spagnoli, baschi, portoghesi, tedeschi, danesi, austriaci, irlandesi, corsi e tirolesi hanno partecipato ai pubblici festeggiamenti. L’articolo diceva anche che, oltre ai miti celtici, si era parlato di politica. Che all’assemblea dei partecipanti era stato letto un messaggio di Guillaume Faye, uno dei «grandi pensatori» della Nouvelle droite e del movimento identitario, membro del Grece assieme a De Benoist e Steuckers. E ne riportava «i punti principali»: Dopo la fase di costruzione ideologica di un progetto di alternativa al sistema occidentale, è necessario gettare concretamente le basi di un movimento europeo che non sia più limitato a Stati-Nazione, che appunto intendiamo superare. Noi non siamo di sinistra, non siamo di destra, siamo il primo fermento di un impero europeo i cui limiti orientali sono negoziabili «fino al mare», come diceva un grande imperatore corso. Sul contributo essenziale alla svolta celtica della Lega si è espresso anche il più attento e valido studioso della destra antagonista italiana ed europea, lo storico e giornalista Matteo Luca Andriola, che nel suo articolo Alle radici del fascioleghismo. Gli anni ’80: dalle leghe alla Lega parla del legame tra «padanismo» e «neocelticismo», identificando in Gualtiero Ciola, collaboratore del mensile di Murelli che si firmava con lo pseudonimo di Walto Hari, il principale patrocinatore di queste teorie. Andriola ritiene poi opportuno sottolineare che Ciola aveva anche un piede in un’altra testata, «i “Quaderni Padani” dell’ex neodestrista Gilberto Oneto». Oneto, ideatore dell’identità padana Oneto non è solo un ennesimo personaggio proveniente dal mondo identitario dell’estrema destra convertitosi al leghismo, è l’uomo che fa scoprire il Sole delle Alpi, quindi il simbolo della Lega, a Umberto Bossi. Oltre allo stesso Giuseppe Leoni, me lo conferma l’ex giornalista de «la Padania» e stretto amico di Oneto, Leonardo Facco. Ma prima di sentire le sue parole è bene fare un velocissimo ritratto del personaggio (deceduto nel novembre del 2015): negli anni Settanta, con lo pseudonimo di Gamotta, Oneto è vignettista de «La voce della fogna», foglio ideologico-satirico nato negli ambienti a destra del Movimento sociale italiano. Nei primi anni Ottanta «scopre» l’etnonazionalismo e il pensiero völkisch, cioè il calderone di credenze, paure e speranze romantiche ritenuto il più influente protagonista di quella «Rivoluzione conservatrice» che in Germania preparò il terreno cultural-ideologico al nazismo. Nel gennaio del 1992 Oneto pubblica Bandiere di libertà: simboli e vessilli dei popoli dell’Italia settentrionale, libro prontamente segnalato ai lettori di «Orion» con un articolo che cita parte della prefazione dell’allora senatore leghista, Gianfranco Miglio: Una futura Repubblica Padana non trova nel libro di Oneto soltanto la sua bandiera, bensì anche il suo stemma (o sigillo). È il «Sole delle Alpi», un fiore stilizzato di sei petali inscritto in un cerchio. Segno antichissimo, ricorre nell’iconografia popolare di una vasta area culturale che comprende le Alpi, la Padania e altre regioni dell’Europa centrale. Tre anni dopo, nel 1995, Oneto fonda la Libera compagnia padana e lancia il bimestrale «Quaderni Padani». Come simbolo per entrambi sceglie appunto il Sole delle Alpi, spiegando che «nella tradizione celtica, il sole non rappresenta solo la luce e la brillantezza, ma anche tutto ciò che è bello, piacevole e splendido». Il sole è anche uno dei simboli preferiti di Julius Evola, che nel suo saggio Che cos’è il Natale? scrive: Nel simbolismo primordiale il segno del sole, come «Vita» e «Luce delle Terre», è anche il segno dell’Uomo. E come nel suo corso annuale il sole muore e rinasce, così anche l’Uomo muore e risorge. […] È da notare che anche Roma antica conobbe un «natale solare»: proprio nella stessa data, ripresa successivamente dal cristianesimo, del 24-25 dicembre essa celebrò il Natalis Invicti, o Natalis Solis Invicti (natale del Sole invincibile). In ciò si fece valere l’influenza dell’antica tradizione iranica, avendo fatto da tramite il mitraismo, religione cara ai legionari romani, che per un certo periodo si disputò col cristianesimo il dominio spirituale dell’Occidente. E qui si hanno interessanti implicazioni, estendendosi fino ad una concezione mistica della vittoria e dell’imperium. […] Anche questa particolare concezione prese piede nella Roma imperiale, tanto che sulle sue monete, spesso ci si riferisce al «sole invincibile», e che gli attributi della forza mistica di vittoria sopra accennata si confusero non di rado con quelli dell’Imperatore. Veniamo ai ricordi del suo amico Facco: «Oneto, che era un architetto, veniva dal mondo di destra. È sempre stato un determinato secessionista, ma le radici culturali di destra non gli sono mai venute a mancare, e in un uomo di destra il concetto etnico rimane sempre nella forma mentis. È stato lui a introdurre come simbolo della Padania il Sole delle Alpi, che era originalmente di colore rosso. Mi spiego meglio: in Lega ha sempre deciso tutto Bossi, ma scegliendo i suggerimenti altrui che riteneva più utili. Senza ombra di dubbio Gilberto ha avuto una certa importanza nella primissima Lega. Era persona di cultura notevole, e in quanto tale particolarmente ascoltato da Bossi, anche se non è mai stato un suo frequentatore, né tantomeno un suo leccapiedi. Tant’è vero che non ha mai avuto incarichi o poltrone. Ma è stata l’influenza di Oneto a far sì che la Lega adottasse il Sole delle Alpi, da lui riscoperto e poi fatto conoscere a Bossi». Nella collezione dei «Quaderni Padani» ho trovato un articolo in cui Oneto stesso spiega com’è avvenuto il traghettamento nella Lega del mito celtico e del simbolo del Sole delle Alpi: Nel 1995 era stata fondata La Libera Compagnia Padana che proprio della padanità faceva una bandiera. Bossi, privo di forti e definite idealità proprie, ma estremamente attento agli umori circostanti e abilissimo nel cogliere il vento, aveva subito fiutato la possibilità di riprendere fiato e vigore cavalcando il progetto padanista. Per prima cosa si è inventato una corrente indipendentista interna, affidandola a Borghezio, Martinelli e Roscia (la cui obbedienza pronta, cieca e assoluta è scattata per l’occasione, ma per due di loro svanirà in seguito). Poi non trova nulla di meglio che far adottare loro come simbolo il Sole delle Alpi rosso che era il simbolo della Compagnia: uno scippo in piena regola di un simbolo la cui forza Bossi ha subito colto. Sempre attraverso una lettura veloce e predatoria dei «Quaderni Padani», Bossi trae anche l’idea di celticità, fino ad allora del tutto assente dal parafernale leghista, pieno di riferimenti medievali. Di celti mal digeriti comincia a farcire tutti i suoi discorsi, di citazioni raffazzonate riempie i comizi. Da allora celticità e indipendentismo vanno di pari passo nell’immaginario bossiano. C’è un altro elemento che influenza Bossi: l’uscita sugli schermi del film di Mel Gibson Braveheart, che racconta l’epica storia di un indipendentista ribelle scozzese in lotta contro il dominio inglese. Bossi ne rimane folgorato e, nel suo pensiero e nei suoi discorsi, il mito celtico prende il volo. Per volere di Dio, alle sorgenti del Po La ricostruzione dei «Quaderni Padani» continua così: Il 30 giugno del 1995 [Bossi] apre il primo Parlamento Padano di Mantova, il 9 gennaio del 1996 diffonde da Mantova il primo proclama separatista. La Lega diventa ufficialmente un partito secessionista e con questo progetto si presenta alle elezioni politiche del 21 aprile del ’96, alle quali ottiene il miglior risultato della sua storia: quasi quattro milioni di voti, oltre il 10 per cento a livello nazionale, con punte locali altissime e numerosi collegi uninominali conquistati. Il risultato accelera il processo: la secessione paga. Ai primi di maggio, al Congresso del partito annuncia le tappe del progetto indipendentista. […] Il 2 giugno, a Pontida, il Governo presta giuramento in un tripudio di folla e Bossi annuncia per la prima volta la manifestazione sul Po. […] La bandiera padana (di San Giorgio caricata nel primo quarto da un Sole delle Alpi rosso) viene rapidamente sostituita dal Sole verde in campo bianco per paura che i veneti osteggino l’adozione di un simbolo ritenuto troppo lombardo. […] La scelta del colore verde scaturisce da una lettura un po’ «baristica» del celtismo: deriva infatti dal colore della maglia di una nota squadra scozzese di calcio – il Celtic – che qualcuno indica a Bossi e che lui accetta frettolosamente per risolvere il problema con i veneti, il verde non dà fastidio a nessuno. Il 17 agosto 1996 la Lega annuncia di avere in programma per il mese successivo una tre giorni che sarebbe iniziata con una cerimonia di raccolta dell’acqua del Po, alla sorgente del Monviso, e sarebbe finita a Venezia, città simbolo di un passato regionale glorioso, non lontana dalla foce del fiume. E qui rientra in scena il primo grande «infiltrato» saluzziano, l’ingegner Alberto Sciandra. Il Monviso è infatti in provincia di Cuneo e lui nel frattempo ha fatto carriera in Lega, diventando segretario provinciale, oltre che membro del direttivo piemontese. Quindi è a lui che arriva la chiamata da via Bellerio. «Mi dissero: organizziamo questa kermesse che deve finire a Venezia con il giuramento di Bossi a conclusione di una grande operazione mediatica. L’idea fu di Bossi, ma io fui investito di questo impegno in quanto responsabile dell’area. Dovetti organizzare dalle cose più piccole, come quella di trovare un enorme fiocco rosa che simboleggiasse la nascita della Padania da spedire in cielo con dei palloni, al servizio d’ordine, dalla ristorazione a tutta la logistica. In pratica fu come organizzare un festival dell’Unità a duemila metri. Con un budget vicino allo zero.» Con lo spirito del guerriero e la tecnica dell’ingegnere, Sciandra riesce a organizzare il tutto. Venerdì 13 settembre è pronto per accogliere sia le carovane di leghisti in auto, pullman e a piedi, sia l’elicottero che avrebbe portato il capo. «Il grosso della cerimonia si svolse al Pian della Regina, che era facilmente raggiungibile in auto, dove ci fu un comizio di Bossi. Il rito dell’ampolla si tenne invece più su, al Pian del Re, il punto più alto, dove c’è la sorgente del Po» ricorda. Per Sciandra il momento di maggiore tensione è senza dubbio quello dell’arrivo di Bossi. «Le strade erano strette e intasate dalla gente che veniva su. Dopo aver individuato un punto dove far atterrare l’elicottero, avevamo segnato un’acca con la calce dentro a un grande cerchio. Lui atterrò lì senza problemi. Ma poi, per raggiungere la macchina che lo avrebbe portato più su, c’erano da percorrere un cinque-seicento metri. Io non mi ero accorto che in quel campo erano passate delle vacche. Per cui lui si trovò a pestare un po’ di merda. Un po’ la pestava, un po’ la evitava. Non fu contento.» Vacche a parte, la kermesse è uno straordinario successo d’immagine per la Lega. Per la prima volta si ha l’impressione che quel fenomeno politico possa non essere passeggero. «Una delle maggiori soddisfazioni fu quando lessi un articolo di Gad Lerner che raccontava di aver fatto un giro in elicottero con Gianni Agnelli. Dall’alto avevano visto quel serpentone di macchine che andavano su e scrisse che l’avvocato era stato impressionato dalla potenza organizzativa della Lega.» In realtà, secondo la ricostruzione di un testimone oculare super partes, la giornalista di «The Independent» Anne Hanley, quel 13 settembre 1996, a Pian del Re con Bossi ci sono appena cinquecento persone. Lo stesso Sciandra non esita ad ammettere che «dal punto di vista organizzativo fu un mezzo disastro. Ma per assurdo, proprio perché era tutto intasato, si era data l’immagine di una grande partecipazione popolare». L’altra grande soddisfazione per Sciandra arriva dalla cronaca dell’evento riportata dal quotidiano della sua regione, «La Stampa»: «La prima pagina, dedicata all’evento, aveva un articolo con un occhiello che diceva: “All’imbrunire rimane uno striscione: Dio lo vuole”. Quella era stata una mia chicca personale: era il motto delle crociate, Deus vult. Non aveva nulla di celtico, ma avevo pensato che avrebbe solleticato il pensiero mitico. Questo della forza intrinseca dei simboli è un classico del pensiero di destra, secondo il quale il pensiero mitico, come gli archetipi e la simbologia, supera la barriera razionale dell’uomo agendo più a fondo. Per me fu la riprova che tutti i ragionamenti fatti in passato, inclusi quelli di Saluzzo, funzionavano davvero». Stranamente a quella cerimonia simbolica, così importante nella storia dell’ascesa della Lega, non è presente Matteo Salvini. Nella sua autobiografia scrive: «Io partecipai alla due giorni di incontri e di festa a Pieve Porto Moroni, in provincia di Pavia, poco distante dal Po. Ci andai insieme alla mia famiglia, sorella Barbara compresa». A partecipare è invece una figura di cui parlerò a fondo nei prossimi capitoli, il giornalista Gianluca Savoini. Con il tono aulico che ha sempre contraddistinto la sua prosa, Savoini ricostruirà quella sua esperienza sui «Quaderni Padani» parlando dei «volti sereni ma determinati di centinaia di persone che […] avevano deciso di salire fino alla sorgente del Po, per poi tornare a valle o proseguire verso Venezia, portando idealmente nello zaino l’acqua del Po che diventava “sacra”, in quanto espressione delle radici profonde e di un desiderio di libertà puro e limpido». Chiuderà così il suo articolo: «Quando l’elicottero si alzò al termine del comizio di Bossi (qualcuno, senza esagerare, lo definì “una cerimonia”) il tripudio della piccola folla assiepata tra le rocce e i prati del Pian della Regina sembrava il preludio al traguardo finale: l’indipendenza della Padania». *** In cima a una rampa di scale stavano due stanze: una ampia, rettangolare, l’altra assai piccola. Scelsi quella grande. Pensai subito che avrei potuto dividere il locale con una tenda: da una parte i quattro letti, dall’altra una piccola cucina e sala. La padrona di casa, Mariuccia, mi fece salire un’altra rampa di scale per farmi vedere le due stanze abitate da loro: in quella piccola marito e moglie, nella grande i figli: le quattro ragazze e i due maschi. Era una gran bella famiglia. Noi avevamo trovato rifugio dai Mellini in cima a quel monte, ma non riuscivamo a non pensare a mia sorella Adriana, che era fuggita in Svizzera col marito, passando attraverso il monte Bisbino accompagnati da contrabbandieri, e a mia madre, rimasta sola a Cortemaggiore con mia zia molto malata. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti «Io me ne fotto. A me interessa fare carriera» Il comunista padano Il 26 ottobre 1997 si svolgono le cosiddette «elezioni padane», quelle che avrebbero eletto il Parlamento padano, altra trovata di Bossi. Ecco come ne ricorda l’origine uno dei suoi protagonisti, Angelo Alessandri, che ha ricoperto la carica di presidente federale della Lega Nord dal 2005 fino al 5 aprile 2012, quando l’ha lasciata a Umberto Bossi: «In una bella serata di fine ’96, dopo la cerimonia del Po, Bossi ebbe l’idea di fare le elezioni padane e mi chiese di costruire un paio di liste. Di inventarmele». – In che senso? «Nel Parlamento padano dovevamo avere rappresentato tutto lo spettro istituzionale. Quindi io mi inventai tre o quattro liste da aggiungere a quelle che già c’erano. Ce n’era una di Vito Gnutti, che era liberale; quella dei socialdemocratici di Formentini; una dei libertari. Io me ne inventai un’altra un po’ più spinta sulla Padania e quella dei comunisti padani. Venendo dall’Emilia era anche quasi scontato. Mi pareva carina questa cosa, con la falce e il martello. Anche per vedere chi andava a votare dei comunisti. Quando fu il momento di scegliere chi candidare, a parte i miei, scegliemmo come portavoce questo giovane ragazzo di cui a Milano parlavano tutti bene. Quindi lo misi a capo, tramite Mauro Manfredini, che era uno dei miei di Modena.» – Lo ha scelto lei? «No, io ho costruito la scatola dei comunisti padani, poi insieme decidemmo di dare spazio a questo ragazzo di Milano.» – Con quale criterio lo avete scelto? «A Milano girava voce che venisse dal Leoncavallo. Fu poi Manfredini a chiamarlo e a coinvolgerlo. Insieme a quello che era il mio autista. Lui accettò e la lista fu costruita.» – Che impressione le fece? «Furbo sicuramente. Con buone prospettive di crescita.» – Politicamente quanto colto e preparato le parve? «Poco. Poco. Ma nella media dei giovani di allora. Io l’ho sempre definito non troppo intelligente, ma molto furbo. Sicuramente aveva ambizioni e si preparava.» Nella sua autobiografia, Salvini offre una versione quasi identica: Bossi voleva rappresentare la società del Nord in tutte le sue sfaccettature. […] In lizza c’erano già i liberali di Gnutti, la destra padana del capo delle camicie verdi Enzo Flego e i laburisti di Formentini. Mancavano solo i comunisti padani. Bossi puntò su di me, un giovane con l’orecchino e i capelli da rockstar, gli sembravo l’ideale «estetico» per guidare una lista che avesse come simbolo il faccione di Che Guevara, ma in camicia verde. Accettai. Da capolista venni eletto insieme a un commerciante ambulante di Modena, Mauro Manfredini. Altro mito sfatato: quello del Salvini «comunista padano». La realtà è molto più pedestre: in quella grande fiera delle maschere padane ognuno ha un personaggio da interpretare. A Salvini viene offerta quella del «comunista», e lui, con la disciplina che lo contraddistingue, accetta di buon grado. Il seggio al Parlamento padano è però una messinscena, priva non solo di significato politico, ma anche di compensi. Nel frattempo Salvini ha perso il posto a Palazzo Marino. Le amministrative svoltesi pochi mesi prima non sono andate bene: presentatasi da sola, la Lega ha strappato appena otto consiglieri (rispetto ai trentasei di quattro anni prima). Il Capitano risulta il primo dei non eletti. Ecco come ricorda l’evento in Secondo Matteo: Una sconfitta dura da digerire. Ma non mi persi d’animo e sfruttai quel periodo di «inattività» per cominciare una nuova avventura che coniugasse le mie due grandi passioni: la politica e il giornalismo. In realtà a lanciarlo in quella nuova avventura è Bossi, con la più irresistibile delle spintarelle: dall’8 gennaio di quell’anno il capo è direttore editoriale del nuovo quotidiano della Lega, «la Padania», e in quanto tale dà ordine che si assuma quella giovane promessa. La parentesi giornalistica «Mi chiamò il direttore responsabile Gianluca Marchi e mi disse: guarda ti mando questo Salvini» dice Leonardo Facco, all’epoca responsabile della pagina della Lombardia. Nella sua autobiografia, Salvini glissa sulla questione di come sia entrato nel quotidiano. Dice solo questo: Un giorno Bossi si presentò con un regalo per me. Evento decisamente singolare, perché lui non è mai stato tipo da doni e complimenti. In effetti il «pacco», con tanto di dedica, non nascondeva un pensiero gentile: si trattava di un manuale su come svolgere al meglio la professione di giornalista. Per la serie: studia e impara. Su come e quanto abbia effettivamente «imparato» del mestiere di giornalista i ricordi di Salvini non coincidono con quelli dei suoi colleghi da me rintracciati. Scrive Salvini: La nuova sfida mi aprì orizzonti fino ad allora inesplorati, […] iniziò così la mia carriera di inviato, un incarico impegnativo: giravo per tutto il Nord a caccia d’interviste e spesso facevo capolino a Palazzo Marino. «Le notizie scritte da lui riguardavano di solito il consiglio comunale, anche perché era il periodo delle elezioni amministrative» dice Facco. «Si è occupato delle elezioni per un paio di mesi. Ma poi sono state perse ed è passato a fare il commissario politico, andando a gestire la rubrica delle lettere.» – In che senso commissario politico? «Nel senso di Mario Appelius.» Facco si riferisce al radiocommentatore fascista che durante la Seconda guerra mondiale, ripetendo il motto «Dio stramaledica gli inglesi!», s’inventava di sana pianta battaglie vittoriose per il Terzo Reich e i suoi alleati italiani. L’accusa è pesante. Chiedo dunque spiegazioni. «Alla rubrica delle lettere del giornale fino ad allora c’era stata una militante milanese, [Adele Ferrari], che cominciò a pubblicare anche le prime critiche ai comportamenti di Bossi. È stata epurata. E chi è stato messo a gestire le lettere? Salvini. Perché Salvini censurava qualsiasi lettera che avesse un tono di critica del capo. Questo è Salvini. E questo è a mio giudizio il miglior aneddoto per dare un’idea del personaggio.» I ricordi del Capitano sono diversi: In breve tempo finii a occuparmi di una rubrica particolarmente delicata: quella delle lettere. «La Padania» dava grande spazio alle opinioni dei lettori – un paio di pagine che lo stesso Bossi leggeva con attenzione. Non vi era alcuna censura: pubblicavamo di tutto anche critiche e insulti. Facco, che ha scelto di lavorare a «la Padania» convinto che «rappresentasse il giornalismo controcorrente» e tre anni dopo la lascia, «quando mi accorsi cos’era in realtà», ha questo da dire sull’interesse dimostrato da Salvini per il giornalismo: «Io gli davo istruzioni tecniche ma a lui non gliene fregava assolutamente nulla. Il ragazzo era comunque molto sveglio e un giorno gli dissi: “Secondo me tu hai delle capacità, ma devi fare una scelta: decidere se vuoi fare il giornalista o il politico, perché non sono due cose compatibili”. La sua risposta fu emblematica. Mi disse: “A me interessa fare carriera”». Il dubbio che la testimonianza di Facco sia eccessivamente di parte (avendo lui rotto sia con «la Padania» sia con la Lega) mi conduce a cercare altri colleghi. Ma sull’impegno profuso da Salvini in quella che, oltre a essere la sua unica professione al di fuori della politica, è da lui descritta come una «passione», trovo solo disapprovazione o critiche. A partire da quelle dell’allora caporedattrice Stefania Piazzo: «Era una meteora che passava la mattina, e dopo aver fatto il suo dovere alla pagina delle lettere andava a fare il politico. Lo si vedeva a volte al sabato ma era per lo più assente. Lui non c’era al giornale. Fondamentalmente è diventato giornalista occupandosi delle lettere de “la Padania”. Avrà pure scritto degli articoli però io, a memoria di donna, non ne ricordo uno. Bastava che facesse la sua pagina. Ma era la scelta della direzione e nessuno si permetteva di dire nulla. Godeva di questa corsia preferenziale: l’importante era che potesse avere il tempo per fare politica». Il primo direttore responsabile, Gianluca Marchi, è più diplomatico: «Lui era un ibrido: stava al partito e poi faceva delle cose per noi. E questo percorso gli ha permesso di andare a fare l’esame di Stato e diventare giornalista professionista». La palestra radiofonica – Ma gli interessava fare il giornalista? «Un po’…» prosegue Marchi. «Ma poi ha visto la possibilità di fare il salto. E lo ha compiuto alla radio. Perché è lì che ha costruito il suo personaggio e trovato il consenso.» – Come si passa da responsabile della pagina delle lettere, spazio fino allora gestito da una militante qualsiasi, a direttore di Radio Padania? «A quel punto la scelta di Salvini evidentemente è stata gestita dal vertice del movimento. Direi da Bossi, perché lì nulla si muoveva senza che lui volesse. Poi, negli anni in cui ha guidato la radio, ha stabilito e consolidato il suo rapporto con il pubblico leghista. Aveva chiaramente una grande abilità, che ha dimostrato a Radio Padania, di annusare, fiutare il vento. Alla radio ha sviluppato la sua capacità di rapportarsi con la gente, e impattare sulla pancia. Questo ha fatto aumentare le sue doti istintive alla scuola di Bossi. L’allievo supererà poi il maestro, seppure all’epoca lui dicesse che se Bossi gli avesse detto di camminare a testa in giù, lui lo avrebbe fatto senza problemi.» Anche su questo Facco è più severo: «Un giorno ero in mensa a mangiare e al tavolo con me c’era Salvini. Era appena stato abbandonato il discorso del secessionismo e in quel periodo Bossi stava cominciando a raccontare storie su Milošević. E io dico: “Vi rendete conto delle stronzate che sta dicendo il vostro capo? È una roba folle. Ci sono contraddizioni continue rispetto alle idee che ha sempre avuto la Lega”. E Salvini, incazzatissimo, mi dice: “Come ti permetti di mettere in discussione il capo? Il capo è tutto. Il capo è la Lega. Esiste il capo, solo il capo. E ha sempre ragione”. Visto che nel merito non si poteva ragionare, rispondo: “Scusa un attimo Matteo, se Bossi ti ordinasse di buttarti di testa dal soffitto di questa mensa, tu lo faresti?”. Pensavo di averlo messo in imbarazzo. Invece lui mi risponde: “Certo che lo farei. Quello che Bossi ordina, va fatto. Il capo è lui”. Questa è la mentalità. Non esistevano ragionamenti. L’opportunismo bossiano non poteva essere messo in discussione. Da nessuno. Se mi chiedi se ostentava il suo credo, rispondo di sì. Ma se mi chiedi se ci credeva davvero, dico di no. Salvini è il miglior allievo di Bossi: non ha mai creduto in niente. Ogni cosa che ha fatto, l’ha fatta in funzione della carriera. La mia è una valutazione etica: è l’italiano tipo, quello che pensa “con Francia o Spagna purché se magna”. Una persona senza un ideale». C’è un altro ex direttore responsabile de «la Padania» che non esita a esporsi nel criticare il Salvini giornalista. È Gigi Moncalvo, che mi rivela di averne chiesto il licenziamento: «Era redattore del giornale con la mansione di occuparsi della pagina delle lettere, ma giocava molto sul fatto che ci volevano cinque minuti a fare quella pagina. Bastava prendere un po’ di lettere, trovare un titolino a ognuna, passarle in tipografia, farle comporre ed era presto e fatto. Ne potevi fare dieci di pagine così. Non si presentava al giornale se non quando gli faceva comodo, poi si rifugiava alla radio e quindi io non riuscivo a controllare se faceva o meno il suo lavoro. A me sarebbe servito che facesse anche dell’altro, perché eravamo talmente in pochi». – Va bene, ma il licenziamento quando e perché lo ha chiesto? «Nel periodo natalizio del 2003 mi accorsi che non era in redazione. Allora scrissi all’amministrazione chiedendo il suo licenziamento. Allegai il foglio presenze, che peraltro lui compilava da solo. La lettera la indirizzai al direttore amministrativo del quotidiano Domenico Uslenghi, al senatore Stefano Stefani, responsabile dei mass media della Lega, e a Bossi, come segretario politico. Segnalai la cosa chiedendo un provvedimento che secondo me comportava la risoluzione del rapporto di lavoro. Ma non ebbi mai risposta.» Il suo predecessore Marchi mi dice che, in termini di rapporti interpersonali, ai colleghi giornalisti Salvini preferiva i Giovani padani, di cui era il capo: «Quello era il suo mondo». Moncalvo aggiunge dei particolari divertenti: «L’altro aspetto che gli consentiva di dileguarsi era il famoso Movimento giovani padani, Mgp, che per me era come i carri armati di Mussolini, il quale faceva credere di averne cinquemila quando ne aveva cinque». Chiedo lumi. E l’ex direttore li fornisce con piacere: «Ogni giorno su “la Padania” veniva pubblicato l’elenco dei comizi e degli incontri di Bossi, proprio nella pagina che curava Salvini. Quindi lui sapeva in anteprima dove si sarebbero svolti. E che faceva? Insieme ad altri tre o quattro andava su tutti i cavalcavia della zona in cui sarebbe andato Bossi e scriveva: “Padania Libera” o “Viva Bossi”, ponendo la firma del Mgp. […] Vedendo quelle scritte, Bossi aveva la sensazione che i Giovani padani fossero dappertutto. E questo gli consentiva di dare l’impressione che l’Mgp fosse una roba gigantesca. Mentre era fatta da poca gente, peraltro oggi tutti deputati. Il suo braccio destro era tale Paolo Grimoldi». Un bossiano di ferro Furbizia, opportunismo e carrierismo, oltre che una straordinaria energia, sembrano essere le caratteristiche principali dell’attuale ministro dell’Interno. Alla ricerca di conferme o smentite dalle persone che lo conoscono bene, ma non sono nel suo più stretto entourage, tento di contattare Roberto Maroni. Ho i suoi cellulari e provo a chiamarlo. Invano. Lascio svariati messaggi. Ma senza successo. Chi mi risponde è Flavio Tosi, che lo conosce dai primi anni Novanta. Non è certamente classificabile come super partes. Ma sicuramente lo conosce bene. «Con Bossi c’era chi aveva un rapporto di assoluta fiducia, come Matteo Salvini, e chi no» mi dice. «Io con Bossi ho litigato più o meno sempre. Salvini invece era un suo adepto, un bossiano di ferro.» Gli chiedo di parlarmi della sua personalità. E Tosi fa immediatamente un paragone con il capo: «Bossi era un istintivo. Salvini è più cinico come impostazione. Lui porta avanti battaglie perché sa che sono vincenti, ma non è detto che ne sia convinto. Sa che sono vincenti e quindi le cavalca. È uno che annusa l’aria – e ci indovina –, poi cavalca l’onda del momento, anche dicendo il contrario di quello che pensa. È un cinico. Un calcolatore». Come al solito chiedo episodi emblematici. «Quando divenne segretario – me lo ricordo perché c’ero anch’io… ero il segretario della Lega in Veneto, quindi uno dei massimi dirigenti – si fecero degli incontri sulla strategia. Lui ci disse: “I temi del futuro saranno l’immigrazione, la sicurezza e la battaglia contro l’Europa, e quindi noi dobbiamo portare avanti questi temi”. Ma non perché fossero i temi nei quali credeva. Solo perché pensava sarebbero stati di moda. La sua posizione fu quella: “cavalcare questa battaglia perché è vincente”. Non lo diceva perché convinto della battaglia contro l’Europa, ma perché conveniva.» – Altri episodi? «Quando ero segretario della Liga veneta al Congresso lui organizzava le sue truppe per insultarmi, perché non ero secessionista. Io sono sempre stato federalista e contro la secessione, quindi all’epoca ero un eretico. Lui mandava avanti i suoi ad attaccarmi e insultarmi pubblicamente. Come traditore della Padania. Dopodiché ha fatto una piroetta ed è diventato nazionalista.» – E secondo lei lo ha fatto per cinismo? «Certo. Se tra una settimana o tra un mese l’aria fosse diversa e convenisse cavalcare una battaglia diversa, direbbe esattamente il contrario, senza nessun problema. Salvini deve tutto a Bossi prima e a Maroni dopo, ma ha fatto fuori sia l’uno che l’altro. Per questo dico che è un cinico: ha emarginato Bossi, lo ha cancellato dalle gerarchie della Lega. E dopo esser stato tutta la vita con l’orecchino al lobo, ora indossa i giubbotti della polizia.» È anche il parere di un altro suo avversario politico che lo conosce da decenni, il deputato milanese Emanuele Fiano: «Penso che Salvini sia un grande calcolatore, che faccia scelte politiche a seconda di come percepisce l’umore del suo popolo. E riesce a essere molto simile alla gente. Sa creare molta empatia. In questo è stata fondamentale la sua esperienza in Radio Padania. Ha passato migliaia di ore ascoltando le cose anche più turpi che produceva la pancia del Nord: contro Roma, contro i meridionali, contro i comunisti e contro i “negri”. Ha capito quali erano le parole che toccavano le emozioni e le aspirazioni delle persone. Lui non ha bisogno di fare studi sociologici: li ha introiettati nel corso di dieci anni di Radio Padania. E questa cosa adesso è fatta più scientificamente, perché il suo team che studia i social – la famosa “bestia” – gli fa dire esattamente le cose che i suoi si aspettano. Lui dice esattamente le cose che le persone, identificate come bacino di voti, chiedono. Anche se è una cosa disumana al 99 per cento, lui la sposa se pensa che possa portare consensi. È questa la sua maggiore dote politica. Per esempio, lui più di Bossi ha percepito l’importanza della questione Islam. Mentre l’impegno del resto della Lega era ancora contro Roma ladrona o il Mezzogiorno zavorra del paese, lui ha sentito che il tema dell’invasione islamica sarebbe stato centrale. E che avrebbe dovuto cavalcarlo perché sarebbe stato il tema degli anni a seguire». Fiano, figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz, è stato presidente della Comunità ebraica milanese dal 1998 al 2000. Ricordandomi della domanda sulle colpe degli ebrei posta da Salvini alla professoressa del liceo, gli chiedo che sensazioni abbia avuto dal suo avversario politico su quel fronte. «Con me ha sempre detto di essere totalmente a favore di Israele. E in consiglio comunale, parlando dell’integrazione delle comunità islamiche, ha sempre citato quella ebraica come esempio di integrazione, di comunità che non ha mai dato problemi.» Il fatto stesso che Salvini parli di comunità che «non dà problemi» e sa «integrarsi» dimostra che, perlomeno nel retropensiero, il ministro consideri la realtà ebraica, presente a Milano dagli inizi dell’Ottocento, come un corpo estraneo nella sua città. *** Papà non voleva tenere me e mio fratello Giancarlo vicini a sé e alla mamma. Sosteneva che se loro due fossero stati presi, per noi ragazzi sarebbe stato più facile salvarci se fossimo stati sistemati altrove. Chiese perciò aiuto al ragionier Fiorini, persona di animo buono. Lui portò noi ragazzi a Casaglia, sopra Bologna, da un contadino parente di Maria, una giardiniera che veniva a lavorare da noi. Ma il contadino ebbe paura e così Maria ci portò a Pianoro, dove ci fermammo un mesetto. Un giorno il ragionier Fiorini raggiunse alle Rocche il papà e la mamma e disse loro che noi stavamo bene, ma che i parenti della Maria non volevano più tenerci. E siccome papà non voleva assolutamente che la famiglia stesse unita, urgeva trovare un’altra sistemazione per noi ragazzi, magari in collegio. I miei genitori pensarono di allontanare prima me, che ero la più piccola. Il ragionier Fiorini trovò per me il collegio Croce Carmine delle suore dell’ordine Serve di Maria, che, a causa dei bombardamenti, da Bologna si era traslocato a Labante. Dalle memorie di Silvana Sacerdoti Il lupo compositore Savoini, il terzo «infiltrato» È ora di presentare il terzo infiltrato postnazista nella Lega, dopo Alberto Sciandra e Mario Borghezio. L’agente postnazista la cui copertura è rimasta più segreta, quello che si è incuneato nei gangli vitali del movimento raggiungendo il massimo potere di influenza nel modo più efficace: senza farsi notare. Mi riferisco all’ispiratore occulto della prima svolta postnazista della Lega nell’era di Bossi e al manovratore della seconda, ancora più drammatica, nell’era di Salvini, di cui è diventato «uno dei fedelissimi» (classificazione dello stesso ministro). Il suo nome è Gianluca Savoini, fa il giornalista e da decenni è in contatto con Maurizio Murelli. In queste pagine ne farò il ritratto personale e politico, ma perché i suoi tratti possano essere soppesati nel giusto modo è bene prima conoscere il suo modus operandi. La migliore rappresentazione l’ho trovata nel motto di un blogger che si firma con lo pseudonimo di Der Wehrwolf: «Sarà qualcun altro a ballare, ma sono io che ho scritto la musica». Come Savoini anche Der Wehrwolf – traducibile in «armata del lupo» – è un postnazista. E non solo perché come pseudonimo ha scelto una parola tedesca che richiama sia un racconto völkisch sulla guerriglia dei contadini tedeschi durante la Guerra dei Trent’anni, sia il piano segreto studiato da Heinrich Himmler e affidato al Waffen SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, con il quale i nazisti «duri e puri» intendevano continuare a combattere gli Alleati dopo la sconfitta. Di quel piano parla lo stesso Skorzeny nella sua autobiografia: Nel novembre del 1944, appena dopo l’offensiva delle Ardenne, sono stato convocato da Himmler presso il suo nuovo Quartier generale a Hohenlychen. Ci sedemmo attorno a un grande tavolo rotondo, Himmler, il Dr Kaltenbrunner, Schellenberg, Hans-Adolf Prützmann ed io. La città di Riga era caduta in mani sovietiche il 13 ottobre. L’esercito sovietico aveva conquistato Belgrado il 21 ottobre ed era entrato in Transilvania e stava bombardando i sobborghi di Budapest. Il Reich era in pericolo. «Quello che serve è di costituire e organizzare un movimento di resistenza, al quale Martin Bormann [segretario personale di Hitler e capo della cancelleria del partito nazista] ha dato il nome di Werwolf» ci dice Himmler. Scritto senza acca, il termine vuol dire uomo lupo, o lupo mannaro. Ma il concetto è lo stesso. Cinque mesi dopo quella riunione, nella notte tra il 28 e il 29 aprile 1945 a Penzberg, una cittadina dell’alta Baviera, un commando nazista massacrò otto cittadini che avevano deposto il sindaco nazionalsocialista. Lasciando un volantino: Monito a tutti i traditori e […] coloro che favoreggiano il nemico tra i tedeschi o che minacciano o vessano chi mantiene la sua fedeltà a Adolf Hitler. Noi ammoniamo: le comunità dei villaggi che attenteranno alla vita dei nostri o esporranno la bandiera bianca, saranno prima o dopo annientati. […] La lotta continua! Il nemico non ha vinto. Con la menzogna e la sobillazione vuole confonderti. Non prestare orecchio al nemico! Sorgi e combatti! Questo accadeva mezzo secolo fa, ma torniamo a un’epoca più vicina a noi e a Savoini. Il dubbio che dietro allo pseudonimo di Der Wehrwolf si potesse nascondere proprio lui, devo ammettere di averlo avuto. Ma mi sbagliavo. Una perizia delle tracce dei metadati lasciate dai suoi post, commissionata a esperti internazionali, ha piuttosto fatto emergere un individuo che ha collegamenti con il rappresentante di un’associazione etnonazionalista völkisch. Una figura però in sintonia con Savoini. Al punto non solo da postare moltissimi suoi articoli, ma anche da perorare in più di un’occasione e in anni diversi la causa della sua nomina a direttore de «la Padania». Gianluca Savoini è nato nel 1963 ad Alassio, in provincia di Savona. Ha fatto il liceo classico nella vicina Albenga, diplomandosi nel 1982. È lì, mi raccontano i suoi amici e compagni di classe, che ha emesso i suoi primi vagiti fascisti. «La nostra era una combriccola molto agitata. Facevamo casino in classe» mi dice il professor Enrico Conserva, oggi dottore in odontoiatria e all’epoca compagno di classe di Savoini. Che aggiunge: «Eravamo un gruppo assolutamente di destra, questo glielo posso garantire. Gianluca compreso. Veramente di destra. Ci siamo presi anche provvedimenti disciplinari. Ad esempio una volta io ho disegnato una svastica sulla lavagna, tanto per farle capire il livello di deficienza. Ma è stata una provocazione, perché sapevamo che il liceo era formato da personaggi di sinistra». Un altro amico e compagno di classe, Massimo Zanelli, che oggi ha un ristorante e gestisce uno stabilimento balneare, conferma: «Lui guardava con molto più interesse di noi agli eventi della politica. Aveva una visione di certe cose un po’ estrema. Commentava fatti della politica locale in maniera molto di destra, molto estrema. […] A volte, quando lui poneva davanti alle cose il fatto della destra, noi dicevamo: “Sei un fascistone”». La contiguità con la destra milanese Uscito dal liceo, Savoini si trasferisce a Milano, dove si iscrive all’università. E qui la sua fede politica si consolida. Me lo accenna, chiedendo l’anonimato, una persona che si dichiara fascista da trent’anni: «Ci conosciamo bene da tanto tempo. Anche perché i camerati a Milano non sono un milione, ci si conosce tutti». Chiedo maggiori dettagli. «Era un mondo fatto di tanti cespugli diversi che è sempre stato un po’ sottotraccia, e ha iniziato a esprimere un orientamento sovranista» mi spiega, rifiutandosi però di dirmi se c’era un cespuglio a cui era vicino il suo amico. Decido di chiederlo allo stesso Savoini. «Io non ho mai fatto politica attiva se non nella Lega. Non mi accomuni ad ambienti che non ho mai frequentato organicamente. Se non per questioni d’interviste a personaggi della destra.» Trovare però conferma della sua contiguità politica con l’area della destra radicale non è difficile. «Gianluca è parecchio più giovane di me. Ci si conosce, ci si vede ogni tanto, quando capita» mi dice Cesare Ferri, braccio destro di Franco Freda e amico di Maurizio Murelli. «L’ho conosciuto nella seconda metà degli anni Ottanta. Aveva cominciato a venire in libreria da me e si era creato un rapporto di conoscenza» mi racconta Marco Battarra. Robert Steuckers mi dice invece di averlo conosciuto probabilmente a Varese nel 1997, in occasione di una di quelle conferenze che sin dai tempi del Grece chiamavano Università estive: «Ho ancora una foto con lui. L’ho conosciuto attraverso Battarra, che è stato il primo a venire da me in Belgio agli inizi degli anni Ottanta assieme a dei ragazzi di Saluzzo». La più pubblica delle conferme la trovo su YouTube, in un video di un dibattito organizzato da Maurizio Murelli il 28 giugno 2018 a Milano in occasione della presentazione dell’ultimo libro di Aleksandr Dugin Putin contro Putin. Davanti a qualche centinaio di persone, tra le quali Marco Battarra, c’è un pannello di relatori che include Dugin, il filosofo più apprezzato dall’area postnazista, Diego Fusaro, e Adriano Scianca, direttore de «Il Primato Nazionale», la rivista cartacea e online di CasaPound. Prima di dare spazio ai relatori, Murelli spiega al pubblico di avere «la necessità – e il dovere anche – di dare la parola a un carissimo amico, il presidente dell’Associazione Lombardia Russia, Gianluca Savoini, con cui condividiamo il nostro modo di interpretare e di leggere le cose ormai direi da trent’anni». Facendo i calcoli, i tempi coincidono con quelli dati da Battarra: la conoscenza con i saluzziani risale alla seconda metà degli anni Ottanta, proprio il periodo in cui venne messo a punto il piano di contaminazione e infiltrazione postnazista della Lega. Quando chiedo a Murelli come abbia conosciuto Savoini, lui minimizza: «Gianluca era uno dei tanti ragazzi, una delle tante persone che ho trovato nel mio percorso. […] Nei vari circoli, nelle varie situazioni ho avuto modo di conoscerlo e avere rapporti con lui. L’ambiente era talmente ristretto, non è che fossimo milioni». Savoini contesta addirittura la correttezza del termine «amico» usato da Murelli in occasione della presentazione del libro di Dugin: «Amici… vabbe’… non è che io sia un suo intimo… non è che ci vediamo a cena tutte le settimane. Capita… in queste occasioni». Qualunque sia la classificazione corretta del rapporto, ritengo certo che Savoini non abbia fatto parte del gruppo di «Orion». Ma mi incuriosisce sapere a chi si sia sentito vicino politicamente prima di scegliere di iscriversi alla Lega nel 1991. Insisto con la fonte anonima che, forse per liberarsi di me, identifica un «cespuglio»: il circolo Ideogramma, che il rappresentante della destra milanese Roberto Jonghi Lavarini considera l’unico altro «laboratorio culturale» della destra antagonista di quel periodo assieme a «Orion». Il circolo Ideogramma Cerco di documentarmi su quel circolo culturale. Alla Biblioteca nazionale trovo alcune copie dell’omonima rivista pubblicata dal gruppo, e noto subito che la seconda pagina di ogni numero riporta la stessa citazione di Julius Evola sulla costruzione di «un uomo nuovo da animare mediante un determinato spirito e una adeguata visione della vita, da fortificare mediante l’aderenza ferrea a dati principi». È tratta dal saggio Orientamenti. Ovviamente. La merce ideologica di «Ideogramma» non ha nulla di diverso da quella di «Orion»: etnonazionalismo, xenofobia e antisemitismo. Nel numero di ottobre-dicembre 1990 trovo un articolo intitolato Sangue e suolo, il motto nazista, che dice: Il binomio di sangue e di suolo si connette a quanto, nella tradizione occidentale, ebbe senso di fedeltà. Alle origini, chiarezza, semplicità, compostezza e purità [sic] incontaminata. Poche pagine più avanti un altro pezzo tratta di un fenomeno appena agli albori, quello dell’immigrazione: È ormai evidente che per chi, come noi, si batte in difesa dell’identità spirituale, culturale ed etnica della propria stirpe il problema dell’immigrazione dal Terzo mondo stia diventando di primaria importanza. Il calo demografico, la decadenza morale e la pressoché totale assenza di una coscienza di razza che caratterizzano oggi la realtà italiana ed europea giocano a favore di un processo (o progetto?) di imbastardimento indirizzato a creare un orribile «miscuglio etnico», sul modello americano anche sul suolo europeo. […] Vi sono, è vero, delle ragioni che potremmo definire meccaniche che favoriscono l’immigrazione massiccia dal Terzo mondo in Europa. Ci riferiamo alla sempre maggiore facilità di comunicazione e soprattutto di trasporto. […] Ma queste ragioni meccaniche sono assolutamente insufficienti per spiegare la massiccia immigrazione afro-asiatica nel nostro continente. Vi è dietro, ovviamente, una volontà speculativa. Mano d’opera a basso prezzo, concorrenza sindacale, base clientelare: le masse immigrate garantiscono questi vantaggi e le lobbies dell’immigrazione fanno a gara nell’importare e nel gestire il maggior numero possibile di breccia. Da noi sono alcuni partiti (Psi, Pci e Dc) e soprattutto il Vaticano, con l’impegno specifico di varie organizzazioni cattoliche, a favorire quest’operazione economica. […] Ma neanche il cinismo economico e clientelare è sufficiente a spiegare il grande sforzo che viene fatto per aumentare l’afflusso degli immigrati e, soprattutto, per evitare che tanto questi quanto gli europei possano mantenere un’identità e una cultura specifiche. La verità, come abbiamo denunciato, è che l’oligarchia cosmopolita vuole americanizzare l’Europa, cioè sradicarla, quindi, «meticciarla» a qualunque costo. È la stessa spiegazione complottistica sull’immigrazione degli articoli di «Orion». La conferma di questa convergenza la trovo nel mensile di Murelli: Noi faremo di tutto per far da cassa di risonanza al tentativo posto in essere dagli uomini di «Ideogramma» prescindendo da una totale condivisione della loro prassi. Per questa ragione «Orion» offrirà a «Ideogramma» spazio e aiuto, per ora consistente nella messa a disposizione di un direttore responsabile, affinché il giornale del gruppo medesimo possa considerarsi rispettoso delle regole del gioco. Dei rapporti di «Orion» con «Ideogramma» dà riprova un altro documento del Viminale: Il Circolo culturale Ideogramma nasce nel 1984 a Milano. […] Il simbolo è costituito da uno scudetto all’interno del quale è disegnato il simbolo runico dell’hagall. La direzione è stata affidata ad Arrighi Luciano, pseudonimo della nota Colla Alessandra. Chiedo a quest’ultima, che non solo conferma, ma arricchisce la notizia di un aneddoto: «Quelli di “Ideogramma” erano basati a Milano. Noi stavamo a Saluzzo. […] Poiché avevamo la tipografia, Murelli propose di utilizzare la macchina da stampa e dividere le spese. Della serie: noi stampiamo “Orion”, voi venite qui a stampare la vostra rivista e dividiamo le spese. Poi successe una cosa bizzarra: mi ero offerta di fare da direttore responsabile, ma fui costretta a usare uno pseudonimo maschile. Perché non potevano tollerare che una donna dirigesse il loro giornale». Scavando trovo che prima del 1991 anche Borghezio aveva avuto rapporti diretti con Ideogramma. In rete trovo la testimonianza di un cantautore della destra radicale, che ricorda la presenza dell’esponente leghista alla celebrazione del solstizio d’estate del 1986 a Tarquinia, a nord di Roma. E in un numero di «Orion» c’è un articolo, L’impegno del Sistema per uccidere il dissenso politico, che ne parla: Fuori e dentro gli «scatoloni» che il regime alimenta (come quello di Comunione e Liberazione o quello dei Verdi), i giovani tornano a ricostruire propri spazi politici. Tarquinia, Solstizio d’Estate 1986: nello stupendo borgo medioevale sono convenuti da tutte le parti d’Italia giovani soldati politici. Oltre alla celebrazione del Solstizio è stata effettuata una vendita al pubblico di pubblicazioni politico-rivoluzionarie. A illustrare l’articolo c’è una foto in bianco e nero di un banchetto con una bandiera. Di Ideogramma. Poi recupero le tracce di un «incontro-dibattito» sul tema Destra Radicale – Storia e Tradizione, organizzato sempre da Ideogramma il 24 febbraio 1990. E leggo che, in veste di rappresentante della Lega Nord, «è intervenuto Mario Borghezio». Quando chiedo a Savoini la natura dei suoi rapporti con quel circolo, lui nega fermamente: «Non ho mai avuto alcunché a che fare con Ideogramma». In effetti, sia il fondatore di Ideogramma, Giorgio Chiesa, sia uno dei suoi più stretti collaboratori, Massimiliano Sandre, detto Max, negano che Savoini sia mai stato un loro iscritto. «Dopo che ci siamo sciolti [nel 1992] frequentava qualcuno di noi [di Ideogramma] come il sottoscritto. Ma non era nel gruppo e non credo che abbia mai fatto militanza effettiva» mi dice Sandre, che lo ricorda associato alla Comunità giovanile di Busto Arsizio, un’associazione della cosiddetta «destra alternativa» col tempo associatasi alla Lega. Questo lo conferma anche Savoini: «Ci siamo conosciuti… ero insieme a tantissime persone che erano nella Lega… vicino alla Lega… C’era un locale a Varese [frequentato da gente] che veniva accusata di essere di estrema destra, ma era tutta gente della Lega». Viste le smentite, chiedo spiegazioni alla mia fonte anonima. «Io Gianluca l’ho sempre incontrato insieme a quelli di Ideogramma. Se poi lui non ne ha fatto parte… Ma tu hai presente com’era quel mondo in quegli anni?» Mi fa capire che non è un caso che lui sia disposto a parlarmi solo se gli garantisco l’anonimato, e che altri potrebbero non volermi dire niente. Nella neonazista «Padania» Chiedo alla fonte anonima come spiega il fatto che Savoini sia prima entrato nella Lega e, poi, con la nascita del quotidiano «la Padania» nel 1997, sia andato a lavorare lì. «Il fatto che nel 1997 sia andato a “la Padania” significa poco» mi risponde. «Per me era un camerata che poi ha fatto quel passo lì. Soprattutto alla luce della dispersione che c’è stata [in seguito all’applicazione della legge Mancino], un buon numero di camerati è entrato nella Lega. Ci sta che uno faccia delle scelte professionali. Ma non è che fosse una scelta di militanza. Per me rimaneva un camerata.» Il 12 luglio 2002 un’inchiesta pubblicata simultaneamente da Alessandro Calderoni su «La Stampa» e Saverio Ferrari su «Liberazione» denuncia il fatto che nella redazione de «la Padania» si annidino dei neonazisti. «Sulle pareti, sugli armadi e sulla porta della redazione politica campeggiano icone, foto e disegni nazisti» denuncia Calderoni, che da allora ha lasciato il giornalismo investigativo per diventare psicoterapeuta. Il collega Ferrari scende in particolari, parlando «di foto di Hitler, della tomba di un ufficiale tedesco decorato con la croce di guerra con a fianco la parola “Onore” vergata a mano, di simboli della Lebensrune e della Totenrune, le rune della protezione e della morte usate per le tombe delle SS nel Terzo Reich; di una riproduzione modificata dello stemma della Gestapo e dell’immagine in divisa, con tanto di elmetto, dell’ex aderente alle Waffen SS, l’Obersturmführer Pio Filippani-Ronconi, passato alle cronache ancora recentemente per aver curato la prefazione di un libro apologetico sulle SS italiane, edito da una casa editrice neonazista». Innanzitutto mi procuro gli originali a colori delle foto pubblicate in bianco e nero sui due quotidiani. E noto dettagli che nelle fotografie sgranate stampate su carta di giornale non era possibile mettere a fuoco. Per esempio, sullo schermo di un computer vedo scritta con un pennarello a inchiostro permanente nero una serie di simboli runici, i caratteri che le tribù germaniche usavano in epoca precristiana, poi adottati dalle SS. Attaccato sull’armadietto di metallo, c’è un adesivo tondo con un’aquila nera e attorno la scritta «Ich bin stolz Deutschland zu lieben», «Sono orgoglioso di amare la Germania». Sopra il computer con le rune, appena a sinistra, non mi sfugge una fotografia a colori incorniciata e appesa alla parete. Ritratti dietro a una tavola imbandita, con un sigaro a testa, sono due giornalisti de «la Padania». Quello a destra è Gianluca Savoini. Infilato all’angolo inferiore sinistro della cornice c’è il volto ritagliato di Adolf Hitler. Ma la traccia per me più significativa è quella che trovo analizzando la foto di un foglio di carta A4 con disegnata la versione modificata del simbolo della Gestapo. Perché possa capire la modifica anche chi non è un fanatico del nazismo, occorre sapere che Gestapo era l’abbreviazione di Geheime Staatspolizei, cioè polizia segreta di Stato. Il suo simbolo era un’aquila i cui artigli reggevano una corona d’alloro al centro della quale campeggiava una svastica. Nel disegno della redazione politica de «la Padania», anziché GESTAPO, la scritta dice GEPAPO, in altre parole la polizia segreta della Padania. La cosa più interessante è però al centro della corona d’alloro, dove il simbolo ufficiale della Gestapo aveva la svastica. Lì era stato inizialmente disegnato un Sole delle Alpi, che poi qualcuno, con un pennarello nero dalla punta più spessa, aveva coperto con una hagall, il simbolo runico per eccellenza, quello della «fede incrollabile fino alla morte». L’hagall rappresenta anche la acca, lettera del saluto nazista Heil Hitler. Ma soprattutto è il simbolo di Ideogramma. Fatte queste analisi mi rivolgo agli ex colleghi de «la Padania» e mi informo sulle reazioni suscitate dagli articoli dei due quotidiani, «La Stampa» e «Liberazione». «Si è riso: “Li hanno pizzicati” si è detto. Ma non ci furono riunioni del comitato di redazione. Nessuno disse che era ora di smettere. Non ci fu un sollevamento. […] Veniva fatta passare per goliardia, ma la redazione politica era una zona franca» mi dice l’allora caporedattrice Stefania Piazzo. – Una zona franca di nazisti? «Di Savoini! Non c’era nessun altro con quelle pulsioni fascistoidi-naziste» prosegue Piazzo. È la stessa cosa che mi dicono tutti gli altri colleghi, ex direttori inclusi. Il primo di loro, Gianluca Marchi, conferma che Savoini apparteneva al «filone nazionalsocialista». E quando chiedo al suo successore, Gigi Moncalvo, mi risponde secco: «La definizione esatta è “nazista”». Neppure l’ex collega della redazione politica Matteo Mauri ha dubbi: «Lui era apertamente filonazista. Ricordo le sue citazioni di Hitler, di Goebbels… Si esaltava parlando di impero, ordine e disciplina. E ricordo con assoluta certezza che rivendicava il fatto di essere orgogliosamente antitaliano. Diceva: “Io non sono mai stato fascista”». Ricordando quegli articoli di denuncia su «La Stampa» e «Liberazione», Moncalvo mi dice: «Appena uscirono andai a vedere nell’ufficio della redazione politica. Ed effettivamente […] ricordo immagini naziste, volti di gerarchi nazisti. Ed era lui che li metteva. Gli altri erano soltanto dei ragazzotti che gli andavano dietro». Moncalvo non ha dubbi: «Nella stanza erano in cinque o sei, ma se appiccicavano un poster, mettevano una scritta o muovevano foglia era lui a volerlo. Era un nazista, seppur mimetizzato da democristiano». Il riferimento, mi spiega Moncalvo, è al modo di fare e di vestire: «Era l’unico lì ad avere sempre giacca e cravatta. Con vestiti dozzinali, da impiegato. Sembrava un rappresentante di pompe funebri, con quel suo fisico minuto, vestito sempre di scuro». Sul suo modus operandi, poi aggiunge: «Fu uno dei primi che conobbi, perché faceva parte del comitato di redazione e mi volle incontrare fuori dal giornale. […] “Ti dico cosa mi interessa fare, se me lo permetti” mi disse. Voleva essere una sorta di inviato, o di articolista svincolato dagli orari di redazione… Evidentemente uno può essere filonazista e carrierista». Vestivamo all’hitleriana Sul modo di vestire di Savoini un aneddoto gustoso mi viene raccontato da un’altra ex giornalista de «la Padania», Cristina Malaguti: «La prima volta che l’ho visto ho pensato che fosse uno dei Ragazzi venuti dal Brasile; l’ho visto scendere dalle scale e gli ho detto: “Ma tu sei un ragazzo venuto dal Brasile?”» ricorda riferendosi al film del 1978 che prende spunto dagli esperimenti del medico nazista Josef Mengele fuggito in Brasile dopo la caduta del Terzo Reich. Nel film un medico ha l’idea di clonare Hitler grazie ai tessuti prelevati prima della sua morte. Fa così nascere novantaquattro bambini geneticamente identici al Führer, i suoi eredi, che affida a famiglie selezionate in vari paesi del mondo al fine di riprodurre le esatte condizioni famigliari di Hitler. «Mi ricordava quei ragazzi lì, per com’era. Perché, pur essendo giovane, aveva un abbigliamento abbastanza adulto: sempre giacca e cravatta, sempre cappotto e i capelli laccati indietro. Mi aveva colpito questa cosa: gli mancava solo il dobermann in pratica» spiega Malaguti. «Dopodiché non ha fatto mai mistero di essere un fan di [Ezra] Pound, e anche dello stesso Hitler. […] E se qualcuno lo prendeva in giro per le sue idee lui rispondeva con tacchi sbattuti e mano alzata.» Anche Leonardo Facco, altro collega de «la Padania», ha lo stesso ricordo: «Ero molto amico di Savoini, anche se sulla sua vita privata non si è sbottonato neppure una volta. Per esempio, non mi ha mai invitato a casa sua. […] Capitava che vedendomi in redazione si girasse, battesse i tacchi e con il braccio teso mi appellasse “Camerata Facco!”. Io l’ho sempre considerato un gesto goliardico, ma si sapeva che lui la pensava in quel modo». Sostenuto da queste testimonianze, dirette ed esplicite, chiedo a Savoini se si sia mai ritenuto filonazista. «Adesso non esageriamo!» mi risponde. – Non esagero affatto. È quello che ricordano di lei i colleghi. «Bei colleghi!» – Dicono che si dichiarava filonazista. «Mai detta una cosa del genere.» – È il ricordo dei suoi ex colleghi. «Io sono incensurato.» – Le ho chiesto se è stato filonazista, non se è pregiudicato. «No, non lo sono mai stato. […] Andare a tirar fuori roba di trent’anni fa. Mi sembra una roba da matti. Sono incensurato, non sono mai stato denunciato per nessun tipo di cosa.» – Stiamo parlando di pensiero politico. «Il mio pensiero è conservatore, cattolico e identitario. Fascismo, nazismo, comunismo, sono robe superate, morte da tantissimo tempo, che a me non interessano. A me interessa l’identità, il sovranismo, la difesa delle proprie radici, delle proprie tradizioni.» – Questo oggi, ma il ricordo dei suoi colleghi è che all’epoca lei fosse filonazista. «Basta che uno invece di parlare… Se uno non sa bene l’inglese e parla più il tedesco diventa filonazista. Siamo a questi livelli qui.» Può darsi. Certo è che quando andrà in Germania a un convegno del partito di estrema destra AfD, nel novembre del 2018, Savoini non darà prova di conoscere affatto il tedesco, dovendosi servire di una traduttrice. Da «la Padania» all’ufficio stampa della Lega Al primo direttore de «la Padania» Gianluca Marchi, chiedo chi glielo abbia introdotto. «Penso sia stato l’entourage di Borghezio, perché lui veniva da lì» mi risponde. Mauri, Facco e Piazzo confermano il rapporto stretto con Borghezio, che Savoini aveva conosciuto personalmente una mezza dozzina di anni prima. Facco precisa anche un altro dettaglio: «Frequentava il mondo editoriale dell’estrema destra, e citava le edizioni Barbarossa [quelle di Maurizio Murelli]. Mi ricordo bene che le citava» dice, aggiungendo: «Tentò di far avvicinare anche me al suo mondo: “Leggi Julius Evola! Leggi Ernst Jünger!”. Citava quegli autori lì. E mi parlò più volte di Dolcetta, che un giorno mi presentò anche». La persona di cui parla Facco è lo scrittore e autore televisivo Marco Dolcetta, autore del saggio Nazionalsocialismo esoterico: studi iniziatici e misticismo messianico nel regime hitleriano. Pur essendo redattore di cronaca politica, Savoini non esita a usare le pagine «culturali» de «la Padania», in quel momento gestite da Facco, per diffondere il suo pensiero e far conoscere i pensatori a lui più vicini. Partendo ovviamente da Julius Evola, di cui – sorpresa, sorpresa – recensisce il saggio Orientamenti, ripubblicato da Edizioni di Ar, quelle di Franco Giorgio Freda. Marco Dolcetta invece era anche autore di un’opera sui discorsi radiofonici di Ezra Pound, del saggio Gli spettri del Quarto Reich e del documentario Hitler in Argentina. Ho trovato un’intervista di Savoini a Dolcetta pubblicata in formato «domanda e risposta». Lo scrittore dice: «Si ciancia da mane a sera di globalizzazione e di mondialismo. Facendolo – e io lo faccio da tanto tempo – non potremo fare a meno di vedere che gli accadimenti mondiali, e i cosiddetti leader delle grandi potenze, sono attori protagonisti, quasi sempre consapevoli, di una storia scritta da altri». Savoini lo stuzzica: «Non mi parlerà mica di “Superiori Sconosciuti” o di “Uomini in Nero”? Suvvia!». E Dolcetta: «Non la metta anche lei sul ridicolo, per favore. […] La storia contemporanea procede sulla falsariga di quello che alcuni sbrigativamente definiscono “complotto”, ma che in realtà è una grande strategia di guerra. In questo caso di guerra economico-finanziaria. I quartieri generali di questi eserciti sul versante occidentale sono rappresentati dalle banche d’affari internazionali, soprattutto quelle di base a New York. Che poi sono le stesse che prima dell’avvento di Hitler erano di stanza a Berlino. Il progetto di quello che è il sistema dell’usura internazionale». Il linguaggio è in codice, ma è chiaro che si fa riferimento al complotto giudaicomassonico che anima il cosiddetto «Nuovo Ordine Mondiale». Che Dolcetta descrive così: Il Nuovo Ordine Mondiale voluto dalle grandi banche d’affari si può ottenere soltanto intervenendo sulla mentalità dei popoli, riducendo sempre più la loro reattività, confondendoli sapientemente, sovvertendo le loro tradizioni e le loro identità più profonde. Dello stesso tono è la recensione che Savoini farà del libro di Alessandro Tacchi Il colore della pelle, pubblicato da un’altra casa editrice di estrema destra, edizioni Settimo Sigillo: I mass media, intrisi di ideologia mondialista, non fanno altro che dipingere il mito di una società multirazziale dorata e gustosa come un cioccolatino. Arrivano al punto di negare l’evidenza: il rapporto criminalità-immigrazione è talmente evidente che soltanto i ciechi, gli stolti e quelli in malafede (ovvero la stragrande maggioranza dei Soloni del dogma del melting pot) cercano di negarlo. […] La morale che scaturisce dalla lettura del volume di Tacchi è una sola: la società multietnica non è quell’Eden che viene dipinto e soprattutto noi non siamo preparati all’invasione extracomunitaria. […] Il colore della pelle è un libro interessante che sicuramente potrà aprire altri squarci nel velo dell’ipocrisia (e degli interessi) che ricopre il fenomeno dell’immigrazione di massa. La matrice ideologica «murelliana-saluzziana» è fortissima. Ma le pagine in cui viene presentata non sono quelle di «Orion». O di «Ideogramma». Sono quelle delle più popolari, e meno compromesse, pubblicazioni leghiste. All’inizio Savoini è solo in questa opera di contaminazione. Poi trova un alleato ideologico in Max Ferrari, che nel 2002 diventa inviato di Telepadania. E instaura un’amicizia personale con Claudio D’Amico, militante della Lega sin dagli albori e membro della segreteria di Roberto Calderoli, di cui Savoini comincerà a seguire l’ufficio stampa. *** In collegio mi chiamavo Silvana Sartori ed ero nata a Modica. La sera, dopo le preghiere dette con tutte le ragazze, a letto, dicevo lo Shemà Israel, che la nonna paterna mi aveva insegnato. Avevo una grande nostalgia di casa, non facevo altro che sperare che la mamma tornasse presto. Anche perché non riuscivo a stringere amicizia con le altre bambine del collegio, un po’ per la mia malinconica tristezza e un po’ per paura di tradirmi per il cognome falso (i miei genitori si erano raccomandati di non svelare il mio passato). Dalle memorie di Silvana Sacerdoti Dalle Alpi alla svastica La prima svolta postnazista «Nel 1998, dall’osservatorio della caporedazione del quotidiano, mi accorgo che, passata la sbornia delle elezioni padane, Bossi ha capito che l’obiettivo secessionista non ha sbocchi» mi dice l’ex giornalista de «la Padania» Leonardo Facco. – Stai dicendo che non credeva veramente all’indipendenza della Padania? «Non lo dico io, a dimostrarlo è la sua azione politica. A partire dagli anni Ottanta non c’è mai stato nulla di più ondivago del programma elettorale della Lega: prima l’autonomia, poi il federalismo e l’Italia delle tre macroregioni, e infine il secessionismo. Che altro era rimasto da raccontare? Non c’era più nulla. Tanto è vero che, pur continuando pubblicamente a parlare di separatismo, sottobanco stava negoziando accordi per tornare al governo con Silvio Berlusconi.» È allora che in via Bellerio – nelle stanze di Bossi e in quelle della redazione politica de «la Padania» – viene partorita la prima svolta postnazista. Grazie al lavoro sottotraccia di Gianluca Savoini, spiega Facco: «Bossi aveva capito che politicamente era finita l’epoca secessionista, una pagliacciata peraltro divenuta indigesta ai veneti quando lui prese le distanze dai cosiddetti Serenissimi. Non rimanevano molte strade aperte. Allora si è fatto influenzare da chi, standogli sempre attaccato, lo pungolava. Anche perché quel gruppo fascistoide, seppur di nicchia, era ben organizzato. È in quel momento – te lo posso dare per certo – che il mondo borgheziano comincia ad avere molto più spazio». Leonardo Facco nota che Bossi comincia a passare sempre più tempo nella stanza della redazione politica. E a discutere con Savoini: «Stavano lì a parlare per ore. S’intendevano perfettamente. Tra l’altro, mentre io ho sempre mantenuto le dovute distanze dando a Bossi del lei, con Savoini si davano del tu. Lui era uno che ci sapeva fare e, avendo in testa l’idea di diventare il consigliere del re, ha cominciato a farlo». Sull’importanza della prossimità fisica dei rispettivi uffici, Facco mi dice: «Era fondamentale, senza ombra di dubbio. Ma Savoini frequentava Bossi anche fuori da via Bellerio. Se il capo andava a fare un comizio, lui lo seguiva, essendo il cronista politico. Insomma le frequentazioni erano assidue». I due ex direttori del giornale leghista, Gigi Moncalvo e Gianluca Marchi, confermano. «Quando Bossi scendeva dal secondo piano al primo, dove eravamo noi, Savoini era uno di quelli che andava subito a riverirlo e a cercare di tenerselo buono» mi dice Moncalvo. «Bossi leggeva moltissimo. Era onnivoro e aveva una grande capacità di assorbire quello che riteneva utile al suo fine. Savoini lo sapeva e gli portava quantità enormi di materiali da leggere» racconta Marchi. «Savoini ha sicuramente instillato idee in Bossi, passandogli testi del filone ideologico a cui è sempre rimasto coerente, quello nazionalsocialista. Le letture che consigliava a Bossi erano tutte di quel filone lì.» Gli chiedo della svolta. «Accantonato il progetto politico originario, la Lega doveva trasformarsi. Altrimenti tutti quelli che prima di entrare in Parlamento facevano gli scaricatori di casse di acque minerali sarebbero dovuti tornare a far quello, cosa non gradita. La deriva destrorsa comincia in quel momento, sicuramente alimentata da personaggi come Savoini» risponde Marchi. – E Borghezio? «Borghezio e Savoini erano in confidenza, li univa una lunga conoscenza. Parlare con Savoini, in un certo senso, era come parlare con Borghezio.» L’opera di «contaminazione ideologica» di Savoini procede su due fronti: quello personale, con Bossi, e quello professionale sulle pagine de «la Padania», che su sua spinta comincia a pubblicare opinioni di pensatori di matrice postnazista, come i membri del Grece, Guillaume Faye e Alain de Benoist, entrambi vicini ai «saluzziani». Simultaneamente, il belga Robert Steuckers comincia a tradurre e pubblicare gli articoli di Savoini sulle sue riviste. Quando chiedo a Steuckers se avesse negoziato – e nel caso con chi – il permesso di pubblicare articoli tratti da «la Padania», lui mi risponde: «L’ho fatto e basta. Non c’era un accordo formale. Ma a loro non dava fastidio perché era l’unica opportunità per avere quegli articoli tradotti. E l’obiettivo de “la Padania”, e soprattutto di Borghezio, era di averli in francese». – Ma a «la Padania» chi lo sapeva? «Savoini doveva saperlo.» Nel novembre del 1998 la Lega pubblica un pamphlet contro il multiculturalismo e il mondialismo – Padania, identità e società multirazziali – in cui sono riprese palesemente le tesi del francese Faye e del belga Steuckers, e si sostiene che il mondialismo non è una fase dello sviluppo della società capitalistica, bensì un complotto angloamericano animato da lobby occulte di matrice massonica (sul ruolo dei «giudei» si preferisce sorvolare). A curarlo è Giorgio Mussa, un leghista molto vicino a Borghezio. E a Steuckers. «Mussa faceva parte del giro di Borghezio. Per qualche anno è stato funzionario della Lega poi, probabilmente per affinità ideologica, si è accodato a Borghezio» ricorda il giornalista Mauri. «È andato a fare il suo assistente all’Europarlamento per diversi anni, finché non ha fatto un concorso ed è stato assunto.» Steuckers lo ricorda bene: «Ha sposato la sorella di un francese che frequentava le nostre conferenze. Ci vedevamo con lui e un gruppo di persone ogni giovedì o venerdì. O a casa mia o in un pub». Al di là della pubblicazione curata da Mussa, la pressione ideologica postnazista porta una svolta nel quotidiano leghista. La ricostruisce l’ex caposervizio de «la Padania» e conduttore di Radio Padania Libera Giovanni Polli: «Fino al 1998 la parola globalizzazione, o mondialismo, non era mai emersa negli atti della Lega. Poi il messaggio del direttore è stato: “La linea politica si amplia, non è più soltanto questione di indipendentismo, ma di analisi geopolitica. Non puntiamo più solo sul fatto che, come dice Bossi, aumenterà il numero degli Stati dell’Assemblea dell’Onu… quello, sì, continuerà a interessarci, ma adesso ci interessano anche i rapporti tra le potenze e la globalizzazione”». Chiedo cosa c’entri la globalizzazione con le istanze di autonomia, o addirittura indipendenza, per le quali era nata la Lega. «A me è stato detto – e me lo ha detto il direttore – “Devi cambiare linea sull’indipendentismo. Dobbiamo puntare sulla globalizzazione. […] La globalizzazione […] è spinta dai liberisti e mondialisti, da ambienti chiaramente americani, massonici eccetera, e tutto quello che può arrestare la globalizzazione ora diventa nostro amico”… Ma questo passaggio non è mai stato chiarito. Neppure a noi che dovevamo spiegarlo ai militanti. Io ritengo che persone come me siano rimaste sconcertate, perché si prendeva una posizione del genere senza dare una spiegazione ideologica. Questo è un fatto storico.» In effetti quella svolta non ha alcuna coerenza politica o ideologica. Perché è parte del takeover dei postnazisti. Ma questo all’epoca nessuno lo sospettava. In difesa del popolo padano e di tutti i popoli A impegnarsi nella trasmissione del nuovo messaggio è Gianluca Savoini. Il miglior esempio lo offre un suo articolo riguardante la legge sulla fecondazione assistita, pubblicato sulla prima pagina de «la Padania» il 6 febbraio 1999. Citando Bossi, Savoini scrive: «È stata la grande settimana della battaglia leghista per la famiglia e contro il progetto massonico-comunista di scardinamento dei popoli e delle tradizioni. […] I princìpi cui si ispira la massoneria sono essenzialmente: niente famiglia, niente casa, niente figli, niente religione. La massoneria è lo strumento attraverso cui la globalizzazione agisce a livello ideologico-culturale, in appoggio delle decisioni economiche». Savoini chiede chiarimenti sul ruolo della Lega. E Bossi non esita a fornirli: «Ci siamo incuneati tra il polo delle massonerie e i massoni di sinistra, facendo esplodere le contraddizioni dei due schieramenti, che per fortuna di tutti ha portato al no alla fecondazione eterologa». Con un’ingenuità che suona chiaramente artificiale a chi conosce il suo orientamento, Savoini poi domanda: «Ci sono ideologie che invece la pensano nel modo opposto, onorevole?». Bossi risponde: «L’ho già detto, ma è bene essere chiari su questo punto. Tutta l’idea della famiglia tradizionale contrasta radicalmente con la visione della massoneria americana, del tentativo di questa piovra di impadronirsi del mondo attraverso la globalizzazione. Badate bene che essa non consiste solo nello spalancare le barriere doganali (favorendo in tale maniera le grandi imprese americane che potranno strozzare tutte le altre concorrenti). La globalizzazione è anche supportata da un’ossatura culturale, altrimenti da sola non potrebbe reggere. Perciò, secondo quei massoni, bisogna scardinare la famiglia e mescolare persino le religioni, affinché l’unico dio da adorare, un dio unico per tutti, sia il dio Danaro». Reiterando la propria ingenuità, Savoini chiede: «È la massoneria il grande nemico dei popoli?». E Bossi: «È assolutamente così. L’ossatura culturale è basata sull’impianto massonico, che è di matrice americana e di rito scozzese: in entrambi i casi si tratta di capitalismo individualista anglosassone, l’esatto opposto del capitalismo europeo, che salva e garantisce le pensioni, la sanità, la società, la stessa democrazia». In quello stesso periodo, Bossi apre un altro fronte interno sposando una battaglia che da anni sta a cuore ai postnazisti: quella contro l’immigrazione. Il 6 marzo 1998 è stata approvata la legge che disciplina la materia dell’immigrazione dall’estero, la cosiddetta Turco-Napolitano, dai nomi dell’allora ministro per la Solidarietà sociale Livia Turco e dell’allora ministro dell’Interno Giorgio Napolitano. La Lega avvia una raccolta di firme per un referendum abrogativo. Partner nell’iniziativa è Forza nuova, il gruppo neofascista di Marco Carucci, amico di liceo di Matteo Salvini, che scopro essere in quel periodo anche amico di Gianluca Savoini. Seppur di natura tattica, è la prima alleanza tra la Lega e un’organizzazione della destra radicale. Merita di essere citato qui il comunicato con il quale Forza nuova ne informa i suoi associati: È sintomatico che i Comitati per il referendum raccolgano una serie di forze politiche […] che, anche se apparentemente composite ed eterogenee, hanno in comune una matrice popolare e tradizionale. Non è un caso che la componente trainante della campagna referendaria sia la Lega Nord che fino a qualche tempo fa ha rappresentato un’«energia politica» imprevedibile e incontrollabile (probabilmente per le sue radici ideologiche pressoché inesistenti) ma che ora ha cominciato a prendere posizioni chiare per quanto riguarda i problemi che minacciano sia il Popolo padano che tutti i popoli e le etnie del mondo: mondialismo, immigrazione, globalizzazione, dominio della grande finanza internazionale. La lunga marcia del nemico per annichilire la nostra civiltà è cominciata con la nostra sconfitta militare al termine dell’ultima guerra, è continuata con la sovranità limitata impostaci dagli americani fino alla caduta del Muro di Berlino, passando per l’invasione dei valori tradizionali operata dal Sessantotto con la demolizione della famiglia tramite divorzio, aborto, la legalizzazione di fatto della droga. Vi risparmio il resto. Nel 1999, per la prima volta nella sua storia, la Lega scende in piazza con forze dichiaratamente neofasciste. A febbraio è a Reggio Emilia. A marzo è a Verona e a Padova, dove partecipano anche i militanti dei cosiddetti naziskin. Ecco come viene ricordato quello storico evento nello stesso forum frequentato da Der Wehrwolf: Ai tempi [siamo nel 1999] la Lega (in compagnia allora di Movimento sociale-Fiamma tricolore e Forza nuova) lanciò la campagna contro la Turco-Napolitano. «Uomo non microbo» mi sembra si chiamasse, e nel periodo ci furono diverse manifestazioni (famosa quella di Verona organizzata da Movimento sociale-Fiamma tricolore/Veneto Fronte Skinheads/Lega del marzo 1999 e la messa in latino a Torino, in una zona occupata dai nordafricani, per non parlare delle diverse azioni congiunte Borghezio/Forza nuova) e spesso sulla «Padania» uscivano articoli anche interessanti. Ad esempio quelli poi raccolti da Lembo in un bel libricino, Mondialismo e Resistenza etnica (Edizioni di Ar). […] Della Lega di quel periodo io ero parte integrante. Tra l’altro, attorno a persone come Andrea Mascetti, Alberto Lembo, Gianluca Savoini, Max Ferrari (solo per citarne alcuni) si era creata una bellissima «comunità identitaria». C’è tutto, dal Sole delle Alpi alla svastica, passando per la Fiamma tricolore. Il 13 marzo Forza nuova organizza il dibattito Immigrazione e sopravvivenza del nostro popolo presso la sala consiliare della Zona II di Milano. L’elenco dei partecipanti, reso pubblico da un comunicato, merita di essere riportato: Il Dott. Sergio Gozzoli (direzione Forza nuova), il Dott. Gianluca Savoini («la Padania»), l’On. Mario Borghezio (Lega Nord), Samuel Maréchal (Front National – Francia), Maurizio Blondet, giornalista dell’«Avvenire», l’avvocato Andrea Mascetti della Lega Nord. La svolta postnazista non passa inosservata tra i movimenti autonomisti europei con i quali la Lega ha costruito a Bruxelles buoni rapporti. Proprio in quei giorni due parlamentari autonomisti moderati fiamminghi, Nelly Maes e Bert Anciaux, pubblicano una lettera aperta a Bossi: La crescente aggressività con cui la Lega aizza i cittadini contro gli immigrati, i volantini di stampo chiaramente razzista distribuiti dal Suo partito, la vostra alleanza con partner assai inquietanti, […] le avventate affermazioni sulla politica europea americana, e di recente la vostra collaborazione con il vecchio Msi di Rauti e addirittura con Forza nuova, oscuro gruppuscolo di stampo chiaramente nazista, sono veramente troppo. Lei sarà certamente al corrente che il Fronte nazionale di Le Pen si è schierato a favore della vostra iniziativa per un referendum contro la legge Turco-Napolitano sugli immigrati. […] E Mussa, Suo collaboratore a Bruxelles, trae la propria ispirazione da un […] covo dell’estrema destra francese, il cui presidente ha rilasciato un’intervista pubblicata su «la Padania». Potremmo continuare questa triste lista ancora a lungo ma non ne vale la pena. Di certo Lei non ha mai soppesato le Sue parole, ma adesso è diventato fin troppo brutale. […] Servirsi di esseri umani come scudo politico è per noi ingiustificabile. È immorale. Lo ha fatto anche Hitler con le ben note conseguenze. Chi non si rende conto di ciò è cieco. Il fatto che Lei non abbia reagito ai nostri discreti segnali negli ultimi tempi mostra la scarsa considerazione che ha per le nostre domande e osservazioni. Così sia. In tal modo si chiude un capitolo. Il Vlaams Blok [gli autonomisti fiamminghi di estrema destra] e Le Pen l’accoglieranno a braccia aperte. Ma i mal di pancia degli autonomisti moderati europei a Savoini fanno un baffo. Lui ha un’idea chiarissima su dove vuole portare la Lega. La esplicita in un’intervista che concede qualche mese dopo alla rivista «Margini»: Dietro il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria di massa si celano gli interessi più o meno occulti delle lobbies mondialiste. Il progetto di Governo unico mondiale verrà attuato soltanto dopo la distruzione, l’annichilimento, l’omologazione delle identità dei singoli popoli che compongono il continente europeo. Per questo motivo i potentati economici dell’Alta finanza cosmopolita si servono dell’immigrazione come arma micidiale per sovvertire gli equilibri sociali, culturali ed etnici del nostro continente. L’immigrazione non è un fenomeno inarrestabile, come propagandano gli scribacchini, i nani e le ballerine di regime. L’immigrazione può e deve essere fermata aiutando i popoli in via di sviluppo a casa loro. E i veri razzisti sono coloro che negano le differenze etniche e culturali tra i popoli. Il politically correct che domina in Occidente è oggettivamente un pensiero razzista che non tiene conto del fallimento del melting pot negli Stati Uniti, ovvero nel quartier generale del mondialismo. I padanisti, così come tutti i movimenti identitari europei, non vogliono che, in nome del mercato senza regole, alle radici tradizionali si sostituiscano falsi miti materialistici e consumistici che trasformerebbero il territorio europeo in un degradato falansterio di meticci rimbecilliti dall’ideologia del benessere materiale (che peraltro sarà goduto solo dalle élites e dai miliardari). Viva le differenze, dunque. Abbasso l’egualitarismo che, dopo la sbornia marxista-leninista, miseramente evaporata, si è reincarnato negli esegeti del mondialismo e della società multirazziale. Savoini intende ridisegnare la mappatura dei valori della Lega e se teniamo come filo «la gran confusione» di Bossi e il suo opportunismo politico, arriviamo ancora più a fondo della svolta a destra della Lega. L’avvicinamento alla Russia Sempre in quella primavera del 1999 scoppia anche la crisi del Kosovo e il capo, spiazzando tutti, si schiera con i serbi di Milošević e i loro alleati e correligionari cristiano-ortodossi al Cremlino. Per i giornalisti de «la Padania» è un altro balzo ideologico poco comprensibile. A ricordarlo è ancora Giovanni Polli: «Avendo vissuto quel momento, posso dire che quel fatto è coinciso con il passaggio della visione bossiana dall’indipendentismo duro e puro alla lotta alla globalizzazione. Io, come giornalista, vissi quella contraddizione: ma come, noi che siamo con gli indipendentisti ovunque ci schieriamo con Milošević? Quello era un dilemma che vivevo». – E che risposta si è dato? Perché non con i kosovari? «Perché, come ho capito con un po’ di ritardo, i kosovari erano uno strumento dell’alleanza atlantica per disarticolare alcuni ambienti filorussi all’interno della Serbia.» Polli ammette però che all’inizio lui stesso non riesce a non «tifare» per i kosovari: «Io ero dalla parte dell’Uck [l’organizzazione dei guerriglieri kosovari] e avevo persino appeso nella redazione una fotografia di un guerrigliero dell’Uck con il fucile in mano». – E Savoini che ne ha pensato? «Mi disse: “Ma tira via ’sta roba. Cosa metti qui questa cosa?”. Però adesso non farmelo passare come commissario politico.» Il tema «Savoini» è chiaramente delicato per un giornalista che ancora collabora per Radio Padania. Polli preferisce dunque non aggiungere altro. Che il pensiero di Savoini si affermi ai piani alti di via Bellerio, me lo conferma anche l’ex direttrice de «la Padania» Stefania Piazzo: «In quel periodo tutti capimmo che Savoini aveva messo lo zampino per cercare di allineare la Lega alla posizione di fratellanza con Milošević. C’era chi spacciava un rapporto con Bossi e chi effettivamente aveva un dialogo diretto. Lui aveva sicuramente ascendenza su Bossi». Anche Piazzo non ha dubbi su quel meccanismo di lenta «contaminazione» ideologica a cui ha accennato Marchi: «Bossi era tipo che in alcuni casi lasciava parlare, ascoltava, poi valutava il pescato della giornata di cui faceva una sintesi politica da lui rielaborata. Ma a Milošević da solo non ci sarebbe arrivato mai». – Vuoi dire che ce lo ha fatto arrivare Savoini? «Tra quelli che vedevo io lì [in via Bellerio], nessun altro avrebbe potuto farlo. […] Ci sono più indizi che portano a pensare che Savoini abbia avuto un ruolo in quel traghettamento.» Del resto a darsi il merito dell’avvicinamento di Bossi alla Russia sarà lo stesso Savoini quando, in un’intervista all’«Huffington Post», rivelerà che è stato lui a organizzare il primo viaggio a Mosca del Senatùr alla fine degli anni Novanta, quando va a incontrare Vladimir Žirinovskij, il turbonazionalista russo all’epoca vicepresidente della Duma, che era stato uno dei pochi politici internazionali a riconoscere il Parlamento padano. Savoini lo confermerà anche a me: «Con Bossi andammo assieme in Russia a un congresso del Partito liberal democratico». Come mai il suo ruolo non sia mai emerso prima, lo spiega ancora Stefania Piazzo: «Se Savoini si è mosso per perorare posizioni politiche, non l’ha fatto sicuramente gridando. Lì sta l’abilità dell’uomo: saper frequentare le stanze del potere e diventare consigliere politico. Muovendoti in quel modo, acquisti autorevolezza e un tuo margine di autonomia». Stefania Piazzo non crede che Gianluca Savoini possa aver fatto tutto da solo: «Parliamo di geopolitica. E io penso che nessuno si muova da solo. Secondo me aveva dietro una filiera, che però non conosco». La domanda se l’è posta anche il suo ex direttore, Marchi: «Un apripista Savoini deve averlo avuto. Presuppongo abbia sfruttato le aperture di qualcun altro. Mi viene in mente Borghezio, visto che lui teneva i rapporti internazionali». Ma Borghezio aveva rapporti con l’estrema destra dell’Europa occidentale. Non con i russi. Ad avere rapporti con i russi, sin dai primissimi anni Novanta, erano invece gli amici di «Orion». Mi aiuta nella ricostruzione Maurizio Murelli, il quale mi dice che nel lontano 1992 c’è anche Gianluca Savoini ad accogliere Aleksandr Dugin, il pensatore russo dell’area postnazista, da lui invitato per la prima volta a Milano, al circolo Le Stelline. A confermarmelo è lo stesso Savoini: «Ho conosciuto Dugin in quell’occasione». Un anno dopo va a Mosca e, grazie a Dugin, ha accesso diretto ai circoli nazionalisti e nazional-bolscevichi. In un’intervista che Savoini rilascia al sito sovranista Saker Italia, apprendiamo che si trovava assieme a Dugin e ad altri giornalisti «nel Parlamento russo occupato dai gruppi patriottici che venne bombardato dall’esercito per ordine di Eltsin. Era l’autunno del 1993. Era nato il Fronte di liberazione nazionale, in Occidente sbrigativamente etichettato come “rossobruno”, perché univa i nostalgici dell’Urss ai nazionalisti russi, legati al tradizionalismo ortodosso». Parlando con Borghezio scopro che anche in Italia le spinte postnaziste arrivano a rendere possibile una convergenza impensabile ai più. Del genere «russo-verde». «In quel periodo vi fu questo straordinario convergere verso la Lega di ambienti… vi furono dei progetti molto incisivi, sui quali però senza autorizzazione di Bossi…» Borghezio non finisce la frase. Aggiunge, però, che si trattava «di convergenze di paesi che vedevano nella Lega secessionista un potenziale alleato strategico». Poi ha un ripensamento: «Senza l’autorizzazione di Bossi non mi sento di entrare nei particolari. Non si è mai saputo». Ma continua come se il discorso andasse concluso: «Le posso assicurare che non erano gli Stati Uniti. Non era la Nato. Questa fase secessionista non era certamente vista bene dalla Nato o dalla Gladio». Oltre non va. Ma vuole chiaramente far intuire che Bossi abbia seriamente considerato un’operazione di rottura secessionistica appoggiata dalla Russia. Passano pochi mesi dalla guerra in Kosovo e Savoini colpisce ancora: dopo che il Fpö, il partito nazionalista di Jörg Haider, ottiene il 27 per cento dei consensi divenendo il secondo partito politico austriaco, è lui ad aprire la strada di un nuovo incontro, quello tra Haider e Bossi. Bossi e Haider contro il male Me lo dice Facco: «I contatti con Haider li aveva Savoini». Due settimane dopo il suo exploit elettorale, Haider sorprende tutti unendosi a Bossi in un comizio a Vicenza. E chi ne fa la cronaca su «la Padania»? Inutile dirlo. Ma utile pubblicare alcuni brani dell’articolo: I leader dei due partiti mitteleuropei che da anni rappresentano il volto nuovo della politica e che lottano contro l’invasione extracomunitaria, contro la burocrazia centralista, […] si sono conosciuti in una fresca serata d’ottobre. Umberto Bossi e Jörg Haider già da tempo si stimavano a vicenda, […] ma sabato sera si sono conosciuti personalmente sotto il bandierone della Padania, davanti a centinaia di padani entusiasti che si sentono affratellati a tutti gli altri popoli della vecchia e gloriosa Mitteleuropa. «Haider è un uomo che cerca di cambiare le cose in Austria» ha detto il Senatùr, a fianco del leader dell’Fpö. «Proprio come noi leghisti cerchiamo di fare qui. Per questo gli avversari dei nazional-liberali austriaci e del Carroccio ci attaccano e ci denigrano. Ma noi andiamo avanti per la nostra strada.» Nell’articolo Bossi spiega: Con Haider, dopo il comizio, abbiamo parlato del rischio che il materialismo, cioè il male, cancelli la parte spirituale dell’uomo. Lo scontro che sta avvenendo riguarda da vicino anche il Cristianesimo, cioè il bene, aggredito dal male. A questo punto del pezzo Savoini gli fa la domanda di rito: «Con che cosa coincide il “male” che minaccia le identità e le radici dei popoli?». E Bossi lo delizia con una risposta che sembra presa direttamente dalle pagine di «Orion»: Coincide con la Grande finanza che, attraverso la globalizzazione, concentra nelle sue mani il potere economico. Contro questo male è doveroso battersi. È contro l’Europa della Grande finanza e della globalizzazione, che finisce col far scomparire l’uomo e i suoi valori, che abbiamo trovato punti d’accordo. Volendolo condurre per mano attraverso tutti i capisaldi del vangelo murelliano, Savoini gli chiede: «Visto che siamo in tempi di euro e di globalizzazione, quali sono le conseguenze di tale processo in materia economica, segretario?». E Bossi: La moneta unica europea ha sicuramente una funzione dissolvente per le identità economiche. Così si attua il superamento degli Stati-nazione, che sono il contenitore storico della democrazia. Prevale la governance europea e mondiale, basata non più sulla sovranità popolare, cioè sulla democrazia, bensì sulla supremazia della magistratura e delle «purghe» che i nuovi padroni le commissionano inventando nuovi diritti da far rispettare che sono diritti artificiali e calati dall’alto e non già naturali e provenienti dal popolo. Non ancora pienamente soddisfatto, Savoini chiede quale sia lo scopo di quel processo. E il segretario lo accontenta con un linguaggio che sembra di nuovo uscito dalle pagine di «Orion»: Una nuova struttura della ricchezza, che viene dematerializzata, finanziarizzata, globalizzata. Questa struttura corrisponde alla nuova struttura del potere. Il nuovo Re ha forma smaterializzata, apolide e irresponsabile. Il nuovo Re coincide con le élites che creano e manipolano la nuova ricchezza. Attraverso i mass media queste élites fabbricano il consenso inerte delle masse. E la nuova e futura società cosmopolita non avrà più niente della vecchia e per questo motivo può essere eterodiretta. Per Savoini e i suoi partner postnazisti sembra fatta. Dico «sembra» perché non tengono conto dell’opportunismo e del cinismo di Bossi. Quella del capo della Lega non è una conversione alla fede di «Orion». Bossi ritiene semplicemente che quel messaggio possa avere presa sulla gente e colmare il vuoto creato dalla fine della «sbornia secessionista». Ma, davanti a un’offerta di seggi, poltrone e potere, il Senatùr non ha dubbio alcuno: dimentica ogni «ideale» postnazista e sceglie di tornare al governo con Berlusconi. Nel 2001 Bossi ripone la lotta al mondialismo e la guerra a Bruxelles nel cassetto ideologico. Haider è prontamente dimenticato. E i rapporti con la Russia di Putin vengono monopolizzati da Berlusconi. A Bossi lo sherpa Savoini non serve più. Per gli infiltrati di matrice «saluzziana» è l’inizio di un lungo sonno. La scelta di Bossi li costringe infatti a adattarsi alla nuova realtà governativa. Entrano in una fase, come si dice nel gergo dell’intelligence, «dormiente». Di invisibilità. Savoini stesso farà accenno a questa lunga – e disciplinatissima – fase dormiente in un’intervista rilasciata all’indomani del suo ritorno in scena a fianco del nuovo segretario della Lega, Matteo Salvini: «Bossi si concentrò su altre questioni. E per qualche anno non si parlò più della Russia in seno al partito. Io però ho sempre mantenuto i miei contatti con Mosca». *** A marzo del 1944 la mamma finalmente venne a trovarmi in collegio. Per paura dei tedeschi e dei fascisti, non percorse la strada normale. Il dottor Baruffi le aveva indicato il sentiero nel bosco. Scese dalle Rocche alla Carbona, attraversò il fiume e invece di andare verso Vergato si inoltrò nel bosco di fronte, salendo fino in cima, per poi discendere in una valle nella quale sul pendio opposto si affacciava il collegio. Fu per me una gioia immensa poter riabbracciarla. Io la incontrai in parlatorio, una stanza al piano terra con un’entrata indipendente. La mamma aveva racimolato per me un po’ di formaggio, pancetta, lardo, zucchero e frutta. Mi ricordo ancora che mangiai avidamente lo zucchero e la pancetta, mentre il resto lo portai in camerata e lo misi nella valigia sotto il letto. Dalle memorie di Silvana Sacerdoti Dopo la pausa, la ripartenza Il vuoto emotivo dell’era Maroni Con le elezioni del 13 maggio 2001, l’operazione di contaminazione politica subisce un brusco stop. Rialleatosi con Berlusconi, l’11 giugno Bossi torna al Governo nei panni di ministro per le Riforme istituzionali. Da movimento di lotta, la Lega diventa movimento di potere e di poltrone. Poco dopo sopraggiunge l’11 settembre, e con le Torri gemelle esplode anche la paura del terrorismo islamico. L’Italia, come tutta l’Europa, si schiera con lo storico nemico dei saluzziani, gli Stati Uniti di George W. Bush. Borghezio e Savoini sono costretti ad abbozzare. Savoini si defila, Borghezio si riposiziona come nuovo crociato della causa antislamica, provocando le reazioni critiche dei suoi storici associati Murelli e Mutti che, nel nome dell’antiamericanismo e per via del loro antigiudaismo, hanno posizioni filomusulmane. Poi arriva l’ictus di Bossi, che la mattina dell’11 marzo 2004 viene ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il capo è fuori gioco, e il dibattito politico all’interno della Lega è di fatto congelato. Alle politiche del 2008 il Carroccio partecipa schierato con la coalizione del centrodestra, ottenendo un risultato in netto rialzo rispetto alle precedenti votazioni: va oltre l’8 per cento sia alla Camera sia al Senato. Nel Berlusconi IV, oltre a Bossi, sono nominati ministri i leghisti Roberto Calderoli (alla Semplificazione normativa), Roberto Maroni (all’Interno) e Luca Zaia (alle Politiche agricole). Ma sono anni difficili per chi governa un paese colpito dalla crisi finanziaria internazionale di quell’anno. L’esecutivo regge solo fino all’autunno del 2011, quando a Palazzo Chigi arriva Mario Monti. Contrariamente agli ex alleati del Popolo della libertà, la Lega si colloca all’opposizione del governo tecnico, ed è l’unico partito in Parlamento a votare contro la fiducia al professor Monti. Con il movimento tornato all’opposizione sembrano riaprirsi i giochi per gli infiltrati postnazisti. Invece subentra un nuovo stop: il 15 aprile 2012 Bossi è costretto a dimettersi da segretario federale a seguito dell’inchiesta giudiziaria che lo coinvolge assieme al tesoriere del partito Francesco Belsito. Al V Congresso federale della Lega Nord, celebrato il 30 giugno e il 1° luglio 2012, Roberto Maroni, unico candidato, viene eletto segretario federale. Il Carroccio è dato per spacciato da molti analisti. Ma Savoini e Borghezio non hanno mai mollato, e non mollano neppure ora. Il loro lavorio di tessitura della tela ideologica postnazista procede a colpi di convegni e iniziative intese a tener vivi i temi a loro cari: identitarismo, sovranismo, euroasianesimo, lotta all’immigrazione e guerra al Nuovo Ordine Mondiale «finanziar-massonico». La fine politica di Bossi offre chiaramente la stessa opportunità di quando l’esaurimento dell’entusiasmo secessionistico spinse il contenitore leghista a cercare altri campi d’azione. Nella Lega di Maroni c’è un vuoto «emotivo» oltre che politico. Murelli, Borghezio e Savoini sanno come colmarlo. Hanno bisogno solo dell’occasione giusta per riprovarci. L’opportunità arriva con il passaggio di consegne tra Maroni e l’ex collega e amico di Savoini, Matteo Salvini. È l’inizio della fase 2 del piano di infiltrazione postnazista della Lega. Quella che deve portare alla presa del potere. Parlo del potere in senso rasputiniano, quello espresso dal motto di Der Wehrwolf: non quello di chi balla, bensì di chi scrive la musica. Dopo oltre un decennio di pausa, gli agenti in sonno si riattivano. L’offensiva si muove su due fronti paralleli, uno interno e uno estero. Con lo stesso obiettivo: la destabilizzazione della «cultura» democratica proeuropea nata dalla sconfitta militare e ideologica che i postnazisti non hanno mai accettato. Il revival postnazista di Salvini I primi segnali arrivano lo stesso 15 dicembre 2013, quando Salvini viene formalmente incoronato segretario federale del Carroccio al Lingotto di Torino. Lì, tra gli ospiti stranieri, spiccano Viktor Zubarev, esponente del partito putiniano Russia unita, e Alexey Komov, presidente onorario dell’Associazione Lombardia Russia. Entrambi sono stati portati da Gianluca Savoini, che oltre alla delega ai rapporti con la Russia ottiene anche la nomina a portavoce del segretario. Il discorso fatto quel giorno in jeans e camicia bianca dal più giovane leader della storia della Lega non trasmette speranza o coraggio. No, ai militanti depressi da anni di crisi, impicci e imbarazzi, Salvini fa un’incitazione alla guerra. E ai nemici – sia interni sia esterni – manda un chiaro monito. In un crescendo di retorica emotiv-aggressiva Salvini spara «contro il boia di Bruxelles e di Roma», definendo la moneta unica «un crimine contro la nostra umanità». Poi arrivano anche le minacce di olio di ricino per i nemici. Nei confronti di quelli interni sono appena velate: «D’ora in avanti non ci deve essere una virgola interna fuori posto, perché scatterà il momento delle elezioni europee e nelle sedi non deve volare una mosca». Ai nemici politici esterni arrivano minacce esplicite: «La Lega non la ferma nessuno. I nostri nemici comincino ad avere paura. […] Chi attacca la Lega, chi attacca il Nord, deve cominciare ad avere paura». Ovviamente c’è anche l’attacco ai media: «Dal prossimo appuntamento in avanti, senza voler fare liste – e lo dico da collega giornalista – chi […] dimostra obiettività e correttezza morale e professionale entra al Congresso della Lega, gli altri possono uscirsene a calci in culo. Perché di pennivendoli speculatori non abbiamo bisogno. Andate a fare i giornalisti da un’altra parte. […] Oggi facciamo le persone educate. Dalla prossima volta FUORI. […] Dico da giornalista, con tutto il rispetto per i giornalisti che fanno il loro lavoro: “Ci avete rotto i coglioni… Ci avete ufficialmente rotto i coglioni”». È il primo assaggio. In perfetto stile… diciannovista. L’alleanza con CasaPound Nei corsi di formazione dei nuovi quadri leghisti, nelle aule dei convegni, nelle pagine delle pubblicazioni amiche (non solo quindi quelle «padane», anche di quotidiani come «Libero» e «il Giornale») e in tutte le trasmissioni radiotelevisive, sotto l’attenta direzione di Gianluca Savoini, si diffonde lo stesso messaggio di matrice postnazista: occorre superare la dicotomia fascismo-antifascismo. Messaggio alla cui diffusione s’impegna Salvini in prima persona. Come in questo scambio con Corrado Formigli a Piazzapulita. «Non credo che lei abbia niente a che fare con i fascisti, anzi penso che lei sia antifascista, giusto?» dice Formigli. Salvini, come paralizzato, non risponde. Formigli insiste: «È antifascista lei?». E Salvini: «Io sono antirazzista». Formigli incalza: «No, mi dica se è antifascista». E lui: «Io sono antirazzista, e fascisti e comunisti…». Il conduttore non cede: «No, no… non faccia il furbo con me. Lei è antifascista, oppure no?». «Il fascismo e il comunismo li studio sui libri di storia.» «Questa non è una risposta. Lei mi deve rispondere se è antifascista. Lei lo sa che Bossi diceva di essere antifascista.» «Io sono contro tutte le persone che non rispettano il prossimo.» Poi aggiunge: «I ragazzi di CasaPound sono venuti a manifestare a Milano e non hanno lasciato un mozzicone di sigaretta… Per quanto mi riguarda, discutere nell’ottobre del 2014 di fascismo e comunismo significa guardare al passato.[…] Ragionare di destra o sinistra, di fascismo e comunismo mi sembra antistorico». Non è invece antistorico cogliere l’occasione dell’anniversario della nascita di Mussolini per fare, proprio dalla Romagna, terra natale del Duce, un bel tweet che ne ripete una delle massime più amate: «tanti nemici, tanto onore». Non è antistorico chiedere l’abolizione delle leggi che puniscono revanscismo fascista, razzismo, xenofobia e antisemitismo, che Salvini definisce «leggi liberticide». Né è antistorico fare l’occhiolino a chi si autodefinisce «fascista del terzo millennio». Ecco dunque che nella più importante manifestazione dell’era Salvini, quella del 25 febbraio 2015 a piazza del Popolo, a fianco – e a sostegno – del leader leghista ci sono le truppe scelte del leader romano di CasaPound, Simone Di Stefano. Che viene invitato a parlare. Ai due popoli sotto al palco – quello padano e quello imperial-romano – Di Stefano si sente in dovere di spiegare la sua presenza a fianco di una figura nata a cresciuta urlando «Roma Ladrona!»: «Ci chiedono sempre – e ci hanno chiesto mentre venivamo qua – ma perché? Perché state in piazza oggi con Matteo Salvini? Con la Lega? Perché noi condividiamo ogni singola parola del programma di Matteo Salvini». Non fa in tempo a pronunciare l’ultima sillaba che partono applausi e urla dei due popoli. Poi Di Stefano riprende il discorso: «Con i tre capisaldi fondamentali: no euro – perché questo popolo deve essere padrone e sovrano della propria moneta, non vogliamo una moneta stampata da una banca privata che si trova in un’altra nazione, vogliamo la nostra moneta e il no euro è un punto fondamentale; e stop all’immigrazione!» Giù nuovi applausi e urla. «Basta! […] Non c’è posto per nessuno!» aggiunge. Altri applausi. «E il terzo punto, per noi fondamentale: prima gli italiani! Gli italiani prima degli altri! Prima di tutti! Per cui oggi nasce un grande fronte politico che vede come leader Matteo Salvini. […] Non ce ne sono altri oggi di leader in Italia. Noi lo riconosciamo. E vogliamo sostenerlo con tutta la forza possibile. Per cui, Matteo, vai avanti così, con questo coraggio, e sono sicuro che uniti noi arriveremo presto alla vittoria. Alla vittoria!» Come disse il leader Benito da un altro palco romano: «La parola d’ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti: vincere! E vinceremo». Dopo aver pronunciato quelle nostalgiche parole, Di Stefano si avvicina a Salvini. I due si baciano, una guancia alla volta, davanti ai loro popoli e alle telecamere. Ovviamente una dimostrazione di tale vicinanza (e affetto) è sottoposta a molte critiche. Salvini le ignora e, a proposito della presenza di CasaPound alla manifestazione romana, nella sua autobiografia scrive: Siccome non potevano attaccarci per aver infranto vetrine, assaltato poliziotti, devastato automobili o aver sfilato con caschi e bastoni, non rimaneva che gridare «Fascisti!». Poveretti, come se fascismo e comunismo potessero uscire dai libri di storia e tornare fra noi. Sono periodi storici affascinanti da studiare, ma sicuramente non modelli politici che si possano riproporre. Comportamenti e pensieri che non potevano passare inosservati al guru Maurizio Murelli e ai suoi. Che non a caso accolgono con grande interesse la svolta salviniana. A manifestarlo è la moglie del pregiudicato, Alessandra Colla, che in un’intervista al periodico «Sintesi» dice: Un buon politico è in grado di capire quando è necessario cambiare tattiche e strategie. Non sta a me giudicare se Salvini sia veramente un buon politico oppure no, ma credo che la scelta di interagire con […] intellettuali ideologicamente orientati come […] De Benoist possa essere letta come un azzardo calcolato. E dove c’è calcolo, c’è progetto. Seminare diffidenza e paura Il progetto è semplice. E per nulla diverso da quello che aveva funzionato negli anni Venti e Trenta. Seminare diffidenza, alimentare ansia e paura e gettare benzina sui fuochi xenofobi di un paese che non cresce né economicamente né demograficamente e si sente minacciato da concorrenti, avversari e nemici esterni. È evidente che Salvini intende adottare lo stile retorico postnazista. Violento e complottista. Gli attacchi alle istituzioni europee nei suoi discorsi, tweet o post ne sono la prima riprova. 18 gennaio 2015 L’Europa è una gabbia da cui liberarsi il prima possibile, ridiscutendo tutti i trattati, tornando ad avere il controllo della moneta e se serve uscendone. Renzi è una pedina di quest’Europa. 25 febbraio 2015 Renzi è il servo sciocco di qualcuno che non ha nome e cognome, che da Bruxelles vuole controllare la vita di ciascuno di noi. […] A me non piace il pensiero unico. L’Europa ci sta preparando al pensiero unico. Sulla Banca centrale europea, nella sua autobiografia si esprime così: La Bce […] si arricchisce grazie alle crisi nazionali. Istituzioni anonime e misteriose, che funzionano da crocevia per gli interessi comuni di poche famiglie di ricchissimi finanzieri, banchieri, proprietari di concessioni, corporation multinazionali. Si tratta probabilmente della più grande truffa mai operata da una cerchia tanto ristretta di persone, alimentata della complicità e della piaggeria del sistema mediatico. Seppur presentato con parole sue, Salvini si riferisce al solito complotto «finanziarmassonico». E continua: Come ogni sistema totalitario anche l’Unione europea ha i suoi uffici di propaganda che promuovono l’ideologia dogmatica della finanza globale che considera l’essere umano come il prodotto finito, possibilmente standardizzato, di un processo che trasforma cittadini in consumatori. Nell’elenco dei nemici, due sono le categorie più funzionali e a portata di mano: il musulmano/terrorista e l’uomo nero. Ma nella cultura del terzo millennio razzismo e antislamismo non possono essere troppo espliciti. Devono essere in qualche modo mascherati ed espressi con eufemismi più o meno convincenti. Nessuna pretesa di superiorità religiosa o razziale. Si rovescia il tavolo: l’enfasi è sulla protezione della propria comunità, vittima della prevaricazione altrui. Gli italiani sono minacciati, non minacciano. L’ondata migratoria viene definita «invasione», quindi un atto di guerra. Gli invasori vengono ritratti come parassiti, oltre che brutti, cattivi e primitivi (quando non animaleschi). Ma lo si fa nel nome della difesa dai soprusi altrui. Oppure dagli inganni perpetrati da false vittime. Davanti al popolo leghista, con a fianco Mario Borghezio e Claudio D’Amico, Salvini parla di «finti profughi che fanno domanda d’asilo e per ringraziarci, a tempo perso, spacciano, stuprano, o scippano». Le sue dirette su Facebook sono degne del canale YouTube del Ku Klux Klan. Ne prendo una a caso. Quella di domenica 18 giugno 2017. Sentiamolo parlare ai suoi fan: Stazione di Verona: treni, autobus, taxi… prostitute e «risorse» straniere. Che in attesa di pagare le pensioni ai veronesi e agli italiani bivaccano, fanno, disfano, pisciano, spacciano. E chi più ne ha più ne metta. Vi portiamo a spasso per una decina di minuti, se avete voglia di farci compagnia per la stazione di una grande città del Nord, del Veneto evoluto. […] I residenti segnalano che qua la sera – ma non solo la sera – c’è gente varia ed eventuale. «Chi si trova?» domanda a un pretoriano che lo accompagna. E questi: «Qui normalmente si trovano drappelli di extracomunitari. E la gente – tantissima gente – non riesce a uscire la sera. Soprattutto in questi punti, per prostituzione, per droga e soprattutto per la sicurezza che manca». Riprende il Capitano: Ecco, là vediamo un po’ di «risorse», che – per carità – magari saranno bravissime persone, ma sono là abbarbicate. Ovviamente con telefonino, cuffietta e cappellino. Un po’ più tardi mi han detto che arrivano prostitute e spacciatori, per intanto però abbiamo… A quel punto Salvini incrocia un gruppetto di tre italiani che stazionano appoggiati a una ringhiera e commenta: «Loro aspettano il treno, immagino. O l’autobus». Poi punta il telefono su tre ragazzi neri e dice: «Loro aspettano di pagarci le pensioni». Li inquadra meglio e li apostrofa: «Buongiorno ragazzi, che si fa? Si lavora?». I tre continuano a dargli le spalle. E lui insiste: «Che si fa, si lavora? Si ascolta musica? Tutto bene?». Uno dei giovani inizia ad allontanarsi. «Si è scocciato… Eccolo, va a cercare di pagarci le pensioni. Però lo smartphone ce l’ha, le cuffiette anche. Adesso va. Ma sicuramente tra un po’ torna.» Salvini inquadra un sacchetto di plastica lasciato lì dal gruppetto. «Cosa ci sarà lì dentro? Chi è che tocca? Assessore alla Sanità prova a valutare?» Risatine. «Sei vaccinato? Io vaccinerei queste “risorse”… Cosa ci sarà in questo sacchetto lasciato dalle “risorse”? Amici, apriamo o non apriamo? Mah.» Altre risatine. Salvini e i suoi pretoriani incrociano un altro giovane africano. Che viene subito apostrofato: «Buongiorno!». Non ricevendo risposta, il Capitano commenta: «Questo non ha il telefonino. Questo non ha il telefonino e le cuffiette. Strano». Passano due ragazzi di colore in bicicletta. E Salvini: «Giro d’Italia, Coppi e Bartali. Si ride per non piangere, perché quelle biciclette le pagate voi». Finalmente riesce a fermare una persona. È un giovane, che però non parla italiano. Gli dice sorridente di venire dalla Nigeria: «I am from Nigeria». E Salvini: «From Boko Haram?». E il ragazzo: «No, no». Salvini gli chiede da quanto tempo sta a Verona. Lui non capisce, lo invita a parlare in inglese. Ma Salvini prosegue in italiano e chiede: «Stai bene?». Il ragazzo ripete: «Bene». E Salvini: «Lui sta bene! Ci credo che sta bene! Non fa un cazzo dalla mattina alla sera». La passeggiata prosegue. Salvini incontra altri due giovani neri, uno dei quali fermo su una bicicletta. «Va’ che bella bici! Provenienza? Lavoro? Lavoro nooo, ma che sei scemo? Lavoro: che parolaccia! Ma il telefonino non manca a nessuno. Non è per fare il populista… il solito populista… Appello al sindaco: puoi mandare due agenti della polizia locale a controllare che gente bivacca, stravacca, beve, piscia, caga!» Salvini incrocia un altro africano, e gli va dietro urlandogli: «Buongiorno!… magari sono tutti grandi lavoratori e grandi lavoratrici. Magari, ma i residenti ci segnalano spaccio e prostituzione. Perché sono populisti. Sono razzisti e un po’ leghisti… Qua ce ne sono a centinaia di “profughi” ospitati a spese dei veronesi e degli italiani… Noi stasera andremo in giro per quartieri popolari e faremo il gioco Trova l’italiano». Passano delle persone, veronesi, in un furgone che lo salutano. E lui ricambia: «Ciao ragazzi! Guarda che bello: la gente vera, bella, pulita che vorrebbe prendere il treno tranquillamente». La diretta Facebook fatta quella stessa estate da uno dei centri di assistenza per immigrati di Roma ha i medesimi toni e le medesime esternazioni: Si parla di almeno cinquecento persone che da mesi sono qua ospiti. Prima nelle tende e ora in casette di legno, probabilmente perché si avvicina la stagione autunnale. E vuoi stare senza le casette di legno??? Siamo nel centro della Croce rossa. Piccolo problema: queste centinaia di persone durante il giorno, il pomeriggio e la sera sono libere di andare, venire, fare, sporcare, disfare in giro per il quartiere, per i parchi, per i giardinetti, per i negozi. Si dice che ci sia anche qualcuno condannato per reati come spaccio di droga… Durante il giorno questi cosiddetti richiedenti asilo […] durante il giorno girano per il quartiere. Non soddisfatto, aggiunge: Possono fare l’elemosina più o meno molesta, possono fare i parcheggiatori abusivi, possono occupare parchi, parchetti, giardini e giardinetti… insomma è una presenza che non porta particolare arricchimento alla vita del quartiere. […] Dal mio punto di vista i giardinetti vanno lasciati alle nonne e ai bambini. Bianchi, ovviamente. Un giornalista gli fa notare che nella zona i parcheggiatori abusivi sono italiani. Lui risponde: «Ci sono anche stupratori italiani. Ma non mi sembra un buon motivo per arricchirsi con gli stupratori del resto del mondo». Tutto questo detto e fatto negando qualsiasi matrice xenofoba. Perché, come spiega ai suoi su Facebook: «Fascismo, razzismo? Sento tante di queste castroneria! Non torna il fascismo! Non c’è razzismo!». Negando fermamente ogni legame con il fascismo, Salvini va a occupare lo spazio politico dei neofascisti. Me lo conferma lo stesso Borghezio quando parliamo del discorso del giugno 2014 in cui lui invitò Delle Chiaie a prendere la guida di una rivoluzione nazionale: «Nel 2014 secondo me c’era un enorme spazio politico per un’azione nazional rivoluzionaria. […] Ma non avendo fatto niente, quello spazio non c’è più». – Lo spazio è stato occupato da Salvini? «Questo lo dice lei.» – No, glielo chiedo. «Ha l’abilità di leggere nel pensiero!» – Glielo sto chiedendo. «Io a questa domanda non rispondo.» – E perché? «Non le rispondo perché io sono leale.» – Con chi? «Con Salvini. Lui mi ha sempre difeso. Quindi non voglio che le mie elucubrazioni possano in alcun modo interferire con l’azione che sta svolgendo.» Il Talebano e altri laboratori politico-culturali La realtà è che a partire da quel momento, a schierarsi a fianco del Capitano è una pletora di «pensatori» identitari e sovranisti. Tutti insieme appassionatamente dietro al suono incantato dei pifferai postnazisti. Con il contributo fondamentale del portavoce Gianluca Savoini la loro operazione di contaminazione ideologica, sistematica e sempre meglio orchestrata, procede con lo sdoganamento dell’«essenza fascionazista» e la diffusione parallela del credo murelliano nel superamento dei «vecchi schemi politici». Appare in scena il giovane padano Vincenzo Sofo, che dopo esser stato militante di varie formazioni di destra-destra, assieme a Fabrizio Fratus, altro «ex camerata», organizza convegni. Attraverso il circolo culturale Il Talebano. Oltre che campagne omofobe. Da segnalare una serie di incontri in cui, sotto l’attenta regia di Savoini, il neosegretario della Lega viene introdotto al pensiero di Alain de Benoist. Come contributo al dibattito della Lega, Il Talebano offre anche un Documento di idee, la cui matrice ideologica emerge chiaramente da alcuni suoi passaggi chiave. Si parte attaccando l’Illuminismo, definito «manifesto della sovversione» e nemico della «tradizione, del passato e del sangue». Si passa a un’esaltazione del Romanticismo tedesco, che idealizzò le tradizioni, riscoprì la storia, percorse all’indietro tutte le strade lontane che davano senso al concetto di identificazione in un popolo, […] comprese che l’industrializzazione selvaggia e la massificazione dei popoli avrebbe portato al disfacimento delle identità di appartenenza [… e fornì] una nuova legittimazione nella cultura e nel sangue che prese il nome di nazione. Venendo al (quasi) presente si indica poi la strada maestra: Alcuni decenni or sono, Jean Thiriart elaborò la teoria geostorica dell’Eurasia. Il geopolitico belga era convinto che la strada da seguire fosse quella di unire le terre comprese tra Lisbona e Vladivostok in un’unica nazione, uno spazio continentale che prende ragione della sua esistenza dal momento della caduta dell’Urss. […] Noi partiamo da questa visione per proporre l’Europa delle Patrie in cui siano i popoli a decidere del loro futuro. Oltre a Sofo, Fratus e Diego Fusaro, il filosofo apprezzato da CasaPound, a firmare quel documento è un giovane giornalista freelance, Sebastiano Caputo, di cui parlerò più avanti. Assieme ai soci de Il Talebano, escono dal cono d’ombra promotori ed esponenti di altri «laboratori» politico-culturali di area postnazista. Quando più, quando meno presentabili all’elettorato. Si va da Orazio Maria Gnerre, presidente di Millenium-Pce, il cosiddetto Partito comunitarista europeo, che da un’indagine della Procura di Genova risulterà legato ai separatisti ucraini filorussi e ai foreign fighters andati a combattere al loro fianco; a Massimiliano Bastoni, detto Max, vicepresidente dell’associazione Terra e Popolo e animatore del Centro identitario di via Bassano del Grappa a Milano, molto legato a Mario Borghezio, che diverrà consigliere comunale del Carroccio con il supporto del movimento neofascista Lealtà e Azione. Un altro è Federico Prati, segretario di Identità e Tradizione, l’associazione culturale di Riva del Garda (Trento) a cui gli esperti di metadati hanno collegato il blogger che si firma Der Wehrwolf. A farli conoscere meglio è l’infaticabile Gianluca Savoini, in un articolo in cui dà la parola al segretario di Identità e Tradizione, Prati: I Poteri forti e la Finanza apolide, attraverso l’invasione extraeuropea, cercano di perseguire un vero e proprio «genocidio etnoculturale» ai danni dei Popoli d’Europa, distruggendone le identità etniche, storiche, culturali e spirituali, promuovendo l’uniformizzazione egualitaria della mentalità e omogeneizzando i costumi all’insegna dei valori edonistici, creando un vero e proprio meticciato, dove cresceranno solo i vuoti miti del capitalismo mondialista. È per dire no a tutto questo che bisogna riaffermare con forza la posizione dell’etnonazionalismo völkisch, ovvero di popolo. Parola per parola il credo di Murelli & Co. Ma a distinguersi da tutti – e giocare una partita sul tavolo «dei grandi» – è una persona molto più vicina a Savoini che a Borghezio. Mi riferisco ad Andrea Mascetti, il fondatore di Terra Insubre, ennesima associazione postnazista, ma persona sobria e osservante dell’understatement. Non a caso fa l’avvocato, con studi a Varese e a Milano. Mascetti all’origine della stirpe Con l’avvento di Matteo Salvini alla guida del Carroccio, Andrea Mascetti, che ha iniziato la propria carriera a fianco del consigliere regionale leghista Attilio Fontana, acquisisce ruoli in importanti posizioni di potere in campo finanziario. Nel giro di poco viene nominato membro della Commissione di beneficenza della Fondazione Cariplo (che guarda caso finanzia la sua stessa associazione), del cda di Intesa San Paolo Private Bank di Lugano e del cda della controllata di Banca Intesa a Mosca, istituto presieduto da uno dei pochissimi occidentali che si possa ritenere veramente «vicino» a Putin, l’ex collaboratore di Berlusconi Antonio Fallico. Questo sul piano professionale. Ma è quello ideologico che ci aiuta a capire il significato del suo ruolo. L’associazione da lui fondata, Terra Insubre, nasce con una forte matrice celto-padano-destrorsa, ed è ideologicamente molto vicina a Gilberto Oneto e ai suoi «Quaderni Padani». Come Oneto, anche Mascetti, dal mondo alla destra del Msi, sbarca su quello dell’etnonazionalismo. Con un forte elemento filogermanico. Nel febbraio del 1998, per spiegare ai lettori dei «Quaderni Padani» il legame tra i celti e la Padania, celebrando il «furor guerriero» Mascetti fa ricorso allo scrittore e filosofo prenazista tedesco Ernst Jünger: «Come in castelli frammenti di vecchie architetture, così nelle nazioni sono intessuti elementi di stirpi estinte». A proposito di origine della stirpe, Mascetti si cimenterà anche in una recensione di un libro del cristiano ortodosso francese Christophe Levalois, pubblicato da Edizioni Barbarossa, la casa editrice di Murelli: Quale è l’origine dei popoli indoeuropei? Da quali spazi giunsero i nostri antenati celti e longobardi? La risposta ce la dà un libro dello studioso francese Christophe Levalois […] che riapre il discorso sulle origini dell’Europa, le quali devono essere ricercate non nel bacino mediterraneo – come invece ci siamo spesso sentiti ripetere – ma a nord, verso quella Thule iperborea che ancor oggi, nei simboli solari della Croce celtica e del Sole delle Alpi, indica la fiaccola da seguire per tutti coloro che, ancora, si sentono dei «buoni europei». Oneto a parte, Mascetti è anche legato a Gianluca Savoini. Me lo conferma l’ex collega Leonardo Facco: «Si conoscevano bene, anche se Mascetti viveva e lavorava a Varese, quindi non frequentava la redazione con l’assiduità di altri». È Savoini a introdurre Mascetti al pensiero «euroasiatico». Che l’avvocato sposa con convinzione. Meno di sei mesi dopo l’incoronamento di Salvini al vertice della Lega, il 3 giugno 2014, il Festival Insubria Terra d’Europa viene infatti dedicato al «Continente Russia». Da padrone di casa, Mascetti avvia i lavori davanti all’allora sindaco di Varese, Attilio Fontana. Tra i relatori o i moderatori troviamo Gianluca Savoini, Max Ferrari e Marcello Foa. Evidentemente convinto, Mascetti arriverà a dichiarare pubblicamente che, in un futuro non lontano, «l’Europa e l’Italia di adesso non ci saranno più. Si deve dunque pensare a una prospettiva geopolitica che guardi da Dublino a Vladivostok. C’è da pensare ormai in termini di Eurasia». Particolarmente utile per approfondire il pensiero dell’avvocato varesino è una recente intervista al sito Pangea.news, illustrata da una fotografia di Mascetti accanto a Eduard Limonov, l’ultranazionalista russo fondatore del Partito nazional bolscevico. Nell’intervista, Mascetti spiega il suo rapporto con il potere: Ho personalmente una tendenza a osservarlo con grande sospetto. Qualcosa nella sua logica e nella sua azione nasconde sempre un tocco segreto e sinistro. Non che lo spaventi, anzi: Il potere, che sia economico o politico, minaccia costantemente il cane, contro il quale usa l’ombra e la paura. Ha qualche problema in più con il lupo che, analogamente al potere, caccia nel buio e del buio non ha paura. Poi illustra il suo modo di «fare cultura»: Mi limito semplicemente a organizzare la diffusione di idee che reputo possano essere utili ai nostri tempi. In questa azione cerco di individuare autori e pensieri che operino per preservare la conoscenza delle «radici profonde» – Jünger le chiamerebbe «le potenze primordiali». Avendone l’opportunità, non riesce a trattenere un’osservazione tipica del pensiero antilluministico della Konservative Revolution, quella che ha prodotto il nazismo e costituisce l’essenza del postnazismo odierno: Personalmente considero gli Stati giacobini nati dalle rivoluzioni borghesi come il più grande dramma che sia mai occorso all’Europa. Con due catastrofiche guerre mondiali abbiamo distrutto l’Europa, massacrato milioni di europei, con il grandioso risultato di consegnare il destino del mondo prima al sistema dualistico della Guerra fredda e oggi alle potenze emergenti extraeuropee. Venendo al presente conclude dicendo che gli strumenti monetari sono solo una sovrastruttura. Io penso che la nostra decadenza economica dipenda non tanto dal vituperato euro (che certo qualche sperequazione l’ha creata), quanto dal fatto che l’Europa non è più il centro del mondo. Insomma grande nostalgia per l’ancien régime e il periodo in cui l’Europa, con i suoi imperi e le sue colonie, era padrona indiscussa del mondo. Un modello di «idee utili ai nostri tempi» e «autori e pensieri che operano per preservare la conoscenza delle radici profonde» lo trovo in un programma dell’Università d’Estate, una rielaborazione mascettiana delle vecchie iniziative di De Benoist, Steuckers e del gruppo murelliano Sinergie europee, che Terra Insubre organizza da anni nelle montagne «padane». Tra i «pensatori» invitati a parlare c’è per esempio l’economista Massimo Lodi Rizzini, che presenta un intervento intitolato La finanza internazionale: banche, lobby e complotti contro i popoli. Non si può dire che Lodi Rizzini sia tra gli economisti più noti al mondo (o in Italia). Quello che invece si può sicuramente dire, perché lo dice lui stesso, è che appartiene a MoviSol (Movimento internazionale per i diritti civili – Solidarietà), la succursale italiana del movimento di Lyndon LaRouche, l’ex trotskista americano recentemente deceduto, diventato famoso per la sua teoria di un mondo segretamente dominato dell’oligarchia finanziaria londinese alimentata dal business della droga, il cui traffico sarebbe stato controllato dalla regina d’Inghilterra. Contro il Piano Kalergi e la sostituzione dei popoli Ma le teorie del complotto di Lyndon LaRouche sono una bazzecola preistorica rispetto a quelle che comincia, sistematicamente, a diffondere Matteo Salvini su un tema come sappiamo molto caro ai postnazisti: quello del progetto giudaico-massonico altrimenti noto come «Piano Kalergi», di cui mi ha parlato Cesare Ferri, il braccio destro di Freda. E che il 15 marzo 2019 Brenton Tarrant, il terrorista australiano che ha massacrato cinquanta fedeli di due moschee neozelandesi, ha fatto conoscere al mondo intero. Il Piano Kalergi difende la teoria per cui il fenomeno migratorio sarebbe da lungo tempo programmato, voluto e incentivato dalle «élite mondialiste» (parole in codice per indicare ebrei e massoni, o ancor meglio i massoni ebrei) al fine di giungere a un’unica razza meticcia «senza passato e senza coscienza» che sostituisca le popolazioni residenti nel continente con «greggi asservite ai poteri forti». È questo il messaggio che, dopo la sua elezione, il nuovo segretario del Carroccio comincia a diffondere. In modo martellante. Nel novembre del 2014 twitta: La sinistra, a livello mondiale, ha pianificato un’invasione, una sostituzione di popoli. Io non mi arrendo, io non ci sto. Poche settimane dopo, rincara. Agli inizi di dicembre dello stesso anno dice a Radio Anch’io: Lo ius soli in Italia non lo accetto, è una sostituzione di popoli, una immigrazione programmata. E ancora qualche giorno dopo: 82.000 italiani l’anno scorso sono scappati all’estero per lavorare, un record. Intanto quest’anno sono sbarcati quasi 150.000 immigrati, senza lavoro. È in corso un tentativo di sostituzione di popoli, ma io non mi rassegno. Il martellamento continua mese dopo mese, anno dopo anno. Il 15 agosto 2015 da Ponte di Legno, vicino a Brescia, dice ai microfoni di Rai News 24: È in corso un tentativo di genocidio delle popolazioni che abitano l’Italia da qualche secolo e che qualcuno vorrebbe soppiantare con decine di migliaia di persone che arrivano da altre parti del mondo. E l’estate successiva offre la replica ai microfoni di Rtl 102.5: Con il flusso incontrollato di migranti è in corso un tentativo di sostituzione di popoli. *** Vicino a noi era sfollata una signorina molto bionda, una bella donna, non più giovane. Aveva con sé una ragazzina che diceva di essere sua nipote, figlia di una sorella. Faceva la sarta a Bologna. Non so perché, ma ebbi timore di lei: non mi fidavo. Tutte le persone dei dintorni erano persone d’oro, che ci avrebbero protetto proprio perché sapevano la nostra vera identità. Senza il loro silenzio, vigile e complice, la falsa carta di identità non sarebbe servita a nulla. Quella signorina aveva fatto amicizia con i Vannini e così la conoscemmo anche noi. Ed ebbi modo di ricredermi. Un giorno arrivò un funzionario della Questura e subito lei, temendo che chiedesse informazioni sulla presenza di ebrei, avvertì la nipotina di non dir nulla. Così aveva fatto anche la moglie di Marcello, mettendo in guardia la sua bambina. Avevamo avuto la fortuna di essere capitati fra gente molto «umana». Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti Il complotto come arma di corruzione di massa Trovare il nemico per sopravvivere al caos Nel suo Origini del totalitarismo, Hannah Arendt scrive che «a convincere le masse non sono i fatti – neppure quelli inventati – bensì la robustezza dello schema in cui i fatti vengono inseriti». Ecco perché nel pensiero e nei piani postnazisti la teoria del complotto svolge due funzioni fondamentali. Consente di armonizzare le contraddizioni, conciliando la paura con l’illusione, l’odio con il miraggio, e permette di rafforzare le contrapposizioni: noi contro loro. Di fronte a fenomeni che spaventano per quanto sono complessi e incontrollabili, la teoria del complotto offre una chiave di lettura semplice in cui ogni dettaglio combacia, ogni pezzo del puzzle si adatta perfettamente all’altro, tutto acquisisce forma, sostanza e colore. Insomma, una visione del mondo tanto gratificante quanto rassicurante. Senza zone oscure o aree grigie. La teoria del complotto spiega inoltre che dietro a ogni male del mondo c’è sempre la stessa causa, chiara e ben definita: la macchinazione di un manipolo di cospiratori esterni. Niente intricate analisi socioeconomiche o dubbi interpretativi, nessuna situazione incontrollabile, e soprattutto nessuna responsabilità della comunità interessata: il male è il prodotto di individui malefici, che sono pochi e diversi da noi. Il che, allo stesso tempo, ci libera da ogni responsabilità e genera fiducia perché, essendo pochi, i nemici sono chiaramente sgominabili. Basta individuarli e perseguirli. In un clima di sfiducia, ansia e sospetto, la naturale tendenza umana a cercare soluzioni lineari e colpevoli esterni rende il terreno particolarmente fertile per i venditori di complotti. È accaduto negli anni Venti in Italia e nel decennio successivo in Germania. I postnazisti vogliono la terza replica. Come? Diffondendo teorie che delegittimano le istituzioni democratiche e i garanti della qualità del dibattito politico, cioè i mass media. Qualcuno potrebbe chiedersi: i fautori delle teorie del complotto, quali oggi sono i postnazisti, sono veramente convinti delle loro teorie? O piuttosto le diffondono al fine di imporre il proprio pensiero illiberale? Insomma, ci sono, o ci fanno? Io sono orientato verso la prima opzione. Perché da marito di una psicoterapeuta mi sento di poter dire che dietro al pensiero postnazista non può che esserci uno scompenso psicologico, oltre che dottrinale. Quindi una propensione a cercare soluzioni onnicomprensive che mettono a fuoco un nemico esterno a cui dare tutte le colpe. Ma forse sono troppo buono. Certo è che anche i padri del postnazismo europeo, come i loro predecessori nazisti, hanno dimostrato una propensione a vedere complotti. Prendiamo i due grandi eventi del 1968: la Primavera di Praga e il Maggio francese. Nella prima Jean Thiriart ha denunciato improbabili «intrighi sionisti». Nel secondo il suo più giovane connazionale Robert Steuckers mi ha detto di aver identificato un complotto destabilizzante della Cia per ostacolare le pulsioni centrifughe e antiamericane della Francia gaullista. Ma prima di procedere, penso sia utile un minimo di storia di teoria del complotto. Perlomeno di quella dei tempi moderni, che è figlia dell’humus culturale reazionario di cui ho già parlato: quello emerso in risposta all’Illuminismo e alla Rivoluzione francese. Secondo lo storico inglese John Roberts, «lo shock emotivo della Rivoluzione francese», aprendo un’era di trasformazioni sociali e culturali senza precedenti, aveva minacciato come mai prima i due pilastri dell’establishment europeo: il diritto divino del clero e quello ereditario di aristocratici e monarchi. Per spiegare sviluppi così imprevisti da risultare insondabili, serviva una chiave di lettura semplice ed esaustiva. A fornirla è la prima teoria del complotto. Il suo autore è un membro del clero francese, l’abate Augustin Barruel, che nel 1797 pubblica le sue Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme, in cui sostiene che la Rivoluzione francese è stata il frutto di un complotto ordito da società segrete massoniche (a partire dalla più misteriosa di tutte, quella degli Illuminati) con il supporto degli ebrei. Le menti di questo complotto volto a rovesciare trono e altare sarebbero quelle di Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu e degli altri «scrittori di questa setta che, lungi dall’illuminare il popolo, hanno contribuito solo a portarlo sulla strada dell’errore». Anzi peggio, a unirsi alla «sinagoga dell’empietà». E sì, perché quelle sette segrete erano state foraggiate e sostenute da altri traditori della Francia tradizionale: gli eredi degli assassini di Cristo, i giudei. Non c’è nulla di particolarmente originale. Certamente non lo è il complottismo. E ancor meno lo sono le accuse di tradimento rivolte agli ebrei: è dalla fine dell’impero romano, con san Crisostomo, che vengono denunciati come adoratori del demonio e assassini di bambini cristiani. Ma come ha spiegato lo psicologo inglese Rob Brotherton, la teoria dell’abate Barruel ha successo perché, nella sua semplicità onnicomprensiva, offre una spiegazione per ogni grande trasformazione sociale dell’epoca moderna, compresa la Rivoluzione francese, miscelando due elementi emotivamente esplosivi: il mistero e il nemico. Un nemico che è allo stesso tempo noto ma alieno; il peggiore dei nemici: la serpe in seno. Perché, nonostante siano passati migliaia di anni dal grande esodo della tribù di Israele, a differenza di altri popoli antichi, i giudei non si sono estinti. Hanno avuto la forza di mantenere la propria cultura e la propria religione, andando a vivere in ogni paese d’Europa. E seppur isolati, chiusi nei ghetti e privati di molti diritti, alcuni di loro sono arrivati a occupare posizioni di prestigio e di potere. Insomma, sono un corpo estraneo ma onnipresente. Evidentemente dotato di poteri sconcertanti. Oltre a questi poteri, ad alimentare l’atavico sentimento di risentimento dovuto alla crocefissione del figlio del Signore è anche il fatto che le periodiche persecuzioni e l’interdizione a detenere proprietà terriere li hanno spinti verso mestieri legati al commercio e alla finanza, due settori spesso percepiti come elitari. Se non apertamente parassitari. La stessa ideologia völkisch, su cui ho già avuto modo di soffermarmi, è intrisa di antilluminismo e antisemitismo. Si diffonde infatti in Germania durante le guerre napoleoniche, avendo come collante sia la difesa del patrio suolo contro l’invasore straniero sia la difesa di religione, tradizioni e valori germanici contro gli alfieri dell’era razional-illuminista. È quindi rigetto dell’invasore e ripudio della modernità, Rivoluzione industriale inclusa. E chi erano i principali promotori – e finanziatori – di quella modernità? I banchieri e i commercianti ebrei, naturalmente. Il successivo salto di qualità nella storia della teoria del complotto si verifica all’inizio del XIX secolo in Russia, il paese con il maggior numero di ebrei al mondo. È li che vengono partoriti i Protocolli dei Savi di Sion, un clamoroso falso storico prodotto dalla polizia zarista, che lo spaccia come manuale per la conquista del mondo nella forma di due dozzine di brevi sermoni del capo dei «Saggi di Sion», il padre dei «sionisti». Nel Mein Kampf Hitler li definisce «incomparabili» e, una volta preso il potere, ne rende la lettura obbligatoria nelle scuole. A cimentarsi sul tema è anche l’intellettuale preferito dei postnazisti, Julius Evola, che nel 1937 pubblica un saggio, La volontà di potenza ebraica e l’autenticità dei Protocolli, così pieno di inesattezze e veri e propri falsi che cinquant’anni dopo persino l’esperto di «Orion», Carlo Mattogno, si trova a doverlo definire «uno studio storico documentariamente inconsistente». Antisemitismo accettabile Ora, forse stanchi di leggere dati storici (magari non nuovi), potreste chiedervi: adesso che c’entra l’antisemitismo? Ancor più nello specifico: Salvini non è andato in Israele ad abbracciare Benjamin Netanyahu? E non ha sempre espresso il suo supporto per Israele? Eppure l’antisemitismo c’entra. Innanzitutto perché i protagonisti della nostra storia – i discepoli di Murelli – sono convinti sostenitori della teoria del complotto giudaicomassonico. Nella duplice forma con cui lo si esprima. Sia quella originale, sia quella aggiornata. Non occorre infatti essere espliciti come sono i fratelli Mattogno, Carlo e Gian Pio, entrambi collaboratori di «Orion». Carlo è il principale esponente del negazionismo dell’Olocausto in Italia, Gian Pio è studioso di «imperialismo ebraico». Gianluca Savoini, per esempio, è molto più obliquo, limitandosi a glorificare gli antisemiti. Nella sua recensione del libro sulla massoneria in Francia scritto da Bernard Fay, dopo aver presentato l’autore come «uno dei più brillanti storici della sua generazione», scrive: Con la sua opera Bernard Fay documenta il ruolo determinante della massoneria nella diffusione delle nuove idee illuministiche e nella preparazione del 1789. Egli offre in questo modo un importante contributo al dibattito storiografico sulle origini della Rivoluzione francese (ma anche americana), inserendosi a pieno titolo nel filone della migliore storiografia controrivoluzionaria che ebbe nell’abate Augustin Barruel il padre incontrastato. Savoini sta parlando dello stesso Bernard Fay che, con l’avvento del regime di Vichy, fu nominato direttore della Biblioteca nazionale a Parigi e in quelle vesti si occupò della schedatura dei massoni francesi. Tremila di questi conseguentemente persero il lavoro, mentre 989 finirono nei campi di concentramento nazisti, dai quali 549 non uscirono mai. Nel 1943 Fay produsse un film intitolato Forces occultes, che descriveva il complotto giudaico-massonico mondiale. Arrestato e messo sotto processo dopo la liberazione, fu condannato per collaborazionismo. Sempre sul tema dei massoni Savoini non si fa mancare l’opportunità di recensire un saggio intitolato La massoneria e la Rivoluzione francese, dove spiega ai suoi lettori che, sull’origine della Rivoluzione francese, il «dibattito» aperto dalla teoria del complotto di Barruel è «ancora in corso». Autore, Gian Pio Mattogno, il più antisemita degli editorialisti di «Orion». Non uso questa classificazione con leggerezza. Lo faccio sulla base di questo e altri testi di Mattogno. Come per esempio il libro Antigiudaismo nell’Antichità, che viene presentato così dal Centro Studi la Runa: Ovunque gli ebrei si siano stabiliti in comunità fra gli altri popoli, hanno suscitato sentimenti di diffidenza e di avversione. Le accuse che i popoli pagani muovevano ai giudei, oltre alla stravaganza della circoncisione, erano: il particolarismo etnico-religioso, che rendeva le comunità ebraiche un corpo estraneo rispetto al resto dell’umanità, l’ateismo, poiché gli ebrei rifiutavano di partecipare ai culti di altre divinità, e l’aspirazione al dominio mondiale che, seppur in forme embrionali, già allora cominciava a caratterizzare il popolo ebraico. La letteratura filogiudaica, ovviamente, attribuisce alla fantasia distorta e frustrata dell’antisemita i sentimenti di ostilità verso gli ebrei, insinuando l’esistenza di una presunta patologia antiebraica. Tuttavia la concomitanza delle fonti di varie culture pagane nel giudizio sugli ebrei non sembra essere casuale: in particolare la superba e inaudita pretesa di essere il popolo «eletto» ha colpito gli intellettuali pagani dell’antichità. Altrettanto illuminante è il saggio dello stesso autore intitolato Moralità giudaiche, che l’editore presenta come uno «studio frutto di pazienti ricerche dello storico controcorrente Gian Pio Mattogno». E aggiunge: Da queste pagine, il lettore apprenderà profili sconvolgenti della etica dei «pii giudei» talmudisti che giustificano e ammettono immonde pratiche bandite da tutto il genere umano, quali la pedofilia, necrofilia e zoofilia. Abissi di depravazione morale che le scuole rabbiniche hanno cercato di celare per secoli agli occhi inorriditi del genere umano. Un testo ampiamente documentato su fonti originarie e misconosciute del Talmud ebraico. Sconvolgente. Ma, parafrasando Salvini, si potrebbe dire che Mattogno sia antistorico. Perché dopo la Seconda guerra mondiale, a dichiarare apertamente il proprio antisemitismo (o «antigiudaismo» visto che, come spiegano spesso, non hanno nulla contro gli arabi), sono rimasti solo pochi «antisemiti stupidi». Dopo l’Olocausto l’antisemitismo è infatti diventato un tabù, anche se in equilibrio instabile e da alcuni anche contestato. Maurizio Murelli è tra questi: Gli ebrei atei rivendicano un’elezione attraverso il mito dell’Olocausto, […] si proclamano diversi e determinano, attraverso questa proclamazione, uno stato di superiorità […] attraverso lo straziante piagnisteo di un immaginario Olocausto. Ma Murelli è troppo intelligente per dichiarare apertamente, come fa Mattogno, il proprio antisemitismo. No, lui fa distinzioni: «Orion» ritiene di aver ben individuato all’interno del mondo ebraico quale sia lo schieramento nemico. […] È lo stesso ambiente che ha partorito l’ideologia sionista e che fa di Israele lo Stato più criminale sulla faccia della terra a pari merito con gli Usa. L’antisemita intelligente è quello che nega di odiare gli ebrei in generale. Odia solo i «sionisti». Può addirittura avere «amici ebrei». E nel Piano Kalergi non vede lo zampino delle «sette giudeo-massoniche», bensì della «finanza apolide». «Ambiguità e duplicità sono sempre stati elementi centrali del razzista e dell’antisemita del dopoguerra. Oggi lo è più che mai. Oggi anche i razzisti devono apparire presentabili, si può essere antisemiti ma pro-Israele» mi spiega Michael Billig, psicologo sociale inglese che quarant’anni fa ha scritto il più completo – e premonitore – saggio sulla psicologia dei neofascisti. «Una cosa è però certa: qualunque teoria del complotto, anche quelle che non danno alcun segno di antisemitismo, attinge all’antisemitismo e perpetua un approccio che io definisco “mitologico”.» È la stessa convinzione dell’opinionista del «New York Times» Bari Weiss, secondo la quale «l’antisemitismo non è solo un pregiudizio, è una teoria del complotto, perché conduce a credere nell’esistenza di una mano segreta che controlla il mondo, una mano giudaica. Per esempio, Trump può alimentare un’atmosfera di pensiero complottistico, come sta facendo da anni, senza essere un antisemita. Ma quando parla di “nemici del popolo” o “globalisti” quello che alcune persone sentono è “ebrei, ebrei, ebrei”». La teoria del complotto ha bisogno di avere presa sulle masse. Che non sono antisemitiche (perlomeno non consapevolmente), né vogliono diventarlo. Ma che, sotto il crescente stress socioeconomico, possono essere convertite al credo postnazista. In questo i postnazisti fanno chiara opera di manipolazione, sapendo che per riconquistare la scena politica le vecchie teorie del complotto hanno bisogno di una nuova maschera. «Se in passato fascisti, nazisti o razzisti potevano trasmettere le proprie idee apertamente, adesso, per far circolare idee con la stessa matrice, i loro eredi hanno bisogno di nascondere il pedigree e mascherare il messaggio» mi dice il professor Billig. Magari nel nome del superamento di classificazioni «antistoriche». Soros, nemico perfetto Il modo migliore per mascherare il complotto è quello di dargli una connotazione economica anziché legata all’identità religiosa dei complottisti. Trasformarlo cioè in un complotto finanziario. Anche i finanzieri sono facilmente percepibili come parassiti. E a nessuno verrebbe il dubbio che siano delle vittime. Ecco il modo per riscaldare la minestra di ieri rendendola appetibile al consumatore di oggi. Oltre al fatto che il substrato culturale rimane lo stesso, c’è un beneficio collaterale: tra i finanzieri la probabilità di trovare il giudeo è superiore rispetto alla media delle altre professioni. Non a caso il finanziere in cima alla lista degli architetti del complotto si chiama George Soros, un ebreo americano di origine ungherese. Soros costituisce il bersaglio perfetto sia negli Usa sia in Europa. Perché è un turbofinanziere con un peccato originale: si è arricchito nel 1992 con una manovra speculativa senza precedenti, costata miliardi ai contribuenti italiani e a quelli britannici. In Italia molti ricordano ancora la sua operazione speculativa contro la lira, quando puntò miliardi di dollari sul suo crollo, costringendo la Banca d’Italia a vendere 48 miliardi di dollari di riserve per cercare, invano, di sostenere il cambio della nostra valuta. Soprattutto ricordano che, alla fine, il Governo fu costretto prima a far uscire la nostra valuta dal sistema monetario europeo e poi a imporre una manovra correttiva da 93.000 miliardi. Solo tra gli addetti ai lavori c’è invece la consapevolezza che quella crisi non è ascrivibile a chi speculato, bensì a chi ha accettato un cambio che il mercato chiaramente riteneva insostenibile, sulla cui debolezza lo speculatore ha ciecamente fatto leva per far soldi. Ma queste sono disquisizioni tecniche troppo complesse per chi cerca semplicità. Dieci anni dopo essersi assicurato milioni di nemici in Europa, Soros se ne è creati altrettanti in America, quando si è prima opposto all’invasione dell’Iraq e poi è diventato un convinto finanziatore dei democratici. Come se quei nemici non fossero sufficienti, un altro duro colpo a Soros glielo ha dato Viktor Orbán, il primo ministro ungherese che a partire dalla seconda metà del 2013 ha cominciato ad accusarlo di interferenza negli affari interni del suo paese tramite il lavoro della ong Open Society e della Central European University, entrambe create e sovvenzionate dal finanziere americano. La tattica paga e Orbán vince le elezioni del 2014. Nel giro elettorale successivo decide di alzare il tiro, accusando Soros di essere il grande manovratore di un’operazione di sostituzione dei popoli che, con il supporto di Bruxelles, mira a imbastardire l’Ungheria con migranti siriani. Il 12 ottobre 2017, in un discorso a Budapest, Orbán parla del rischio che «nel giro di poche generazioni la composizione etnica e culturale del nostro continente verrà trasformata» e conseguentemente «verrà a mancare la sua identità cristiana». E spiega chi ne è responsabile: A Bruxelles è stata forgiata un’alleanza. I membri di questa alleanza sono i burocrati di Bruxelles, la loro élite politica e un sistema che può essere descritto come «l’Impero di Soros». Quest’alleanza è stata forgiata contro i popoli europei. E dobbiamo riconoscere che oggi George Soros può perseguire più facilmente gli interessi del suo impero a Bruxelles di quanto non possa farlo a Washington o a Tel Aviv. […] Esiste un Piano Soros, che lui stesso ha descritto. […] Bruxelles si sta preparando a consegnare il proprio territorio a una nuova Europa, meticcia e islamizzata. […] Noi europei possiamo sopravvivere solo se riacquistiamo la nostra sovranità dall’Impero di Soros. Mai in quel discorso, né mai in alcuno spot di quella campagna elettorale, Orbán pronuncerà la parola «ebreo». Ma come mi spiega Miklós Haraszti, che di Orbán è stato mentore universitario e politico, «se tu dici che George Soros è uno speculatore e un plutocrate che minaccia la cultura cristiana e fomenta il meticciato, non hai bisogno di dire anche che è ebreo». Meno di tre mesi prima, il 16 luglio 2017, parlando del suo progetto di Europa in una conferenza stampa tenuta nella sede dell’agenzia Tass a Mosca, Matteo Salvini è leggermente meno esplicito di Orbán: Il mio obiettivo è di […] fare un accordo tra movimenti politici liberi, non a libro paga dei Soros di turno, che mettano al centro l’interesse di 500 milioni di europei e non l’interesse di qualche banchiere, di qualche speculatore o di qualche multinazionale. […] L’Unione che omogeneizza tutto, cancella le differenze che invece ci sono nel nome del profitto e del dio denaro, non è l’Unione europea che voglio lasciare ai miei figli. Me ne parla anche Borghezio quando gli chiedo a cosa attribuisce il fenomeno dell’immigrazione. Dopo avermi fatto una raffinata analisi sulle svariate concause dei flussi migratori, non resiste alla tentazione di aggiungere l’elemento del complotto: «C’è una strana convergenza: quando vediamo per esempio che un finanziere molto sospetto come Soros, di cui tutto si può dire eccetto che sia generoso, spende cifre esorbitanti per favorire le associazioni che operano per far venire gli immigrati. Qualche dubbio anche la persona più ingenua se lo può porre». *** Dopo l’agosto del 1944 Bologna fu dichiarata città aperta. Noi non ci sentivamo più sicuri alle Rocche, sia perché conosciuti da molte persone sia perché il luogo era percorso da truppe tedesche di ogni tipo. Ci trasferimmo dunque in un appartamentino in via dell’Oro offertoci dalla famiglia Vannini. Un giorno in via dell’Oro il campanello suonò verso le cinque del pomeriggio. Chi poteva essere? Guglielmo non sapeva se nascondersi o no; rimase e io andai ad aprire. Fui stupita nel vedere, sul vano della porta, la signora Maria D’Aiutolo, sorella della Ninuccia, moglie di Mario Jacchia. Ci raccontò che Mario era stato preso mentre era in missione a Parma. L’ultima volta che lo aveva visto era stato sull’Appennino, dove si era rifugiato con la moglie e le due figlie. Disse che le era parso veramente stanco, ma non aveva smesso di dare il suo contributo al Partito d’azione; da quando lo avevano catturato non ne aveva più avuto notizia. Avevano pensato di salvarlo in cambio di un ufficiale tedesco e speravano ancora. Ma dopo esser stato sommariamente processato, Mario Jacchia venne ucciso in riva al Po. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti Lo stregone delle notizie Giornalismo e spin Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetto 34. «Gesù disse: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”.» Da cattolico praticante, immagino che Marcello Foa conosca quel versetto, e sia consapevole che non è applicabile a lui. È infatti indubbio che Foa sappia perfettamente ciò che fa. Nella veste di paladino della verità giornalistica da anni studia le tecniche di manipolazione di massa usate dai professionisti della distorsione delle notizie – i maestri dello spin – a cui lo stesso ha dedicato non uno ma due «atti» del libro Gli stregoni della notizia. Convinto che dietro le notizie «ufficiali» si nascondano spesso retroscena ignorati da giornalisti troppo creduloni, Foa ha spiegato di aver scritto quel saggio per approfondire l’uso (e l’abuso) del concetto di frame, dimostrando come sia stato impiegato per «vendere» al popolo l’euro e impedire per anni un dibattito oggettivo sugli effetti della moneta unica. O per costruire il mito del salvataggio della Grecia e quello dell’autorazzismo nei confronti della Germania. Ne Gli stregoni della notizia. Atto secondo riprendo alcuni documenti governativi, noti solo agli specialisti, sull’impressionante influenza del Pentagono su film e produzioni di Hollywood, spiego il ruolo opaco degli spin doctor e delle società di pr negli allarmi sanitari – dalla Mucca pazza all’influenza suina, da Ebola a Zika – e quale ruolo hanno avuto le ong e le loro sorelle maggiori (le quango, ovvero le ong quasi autonome, sconosciute ai più) in operazioni di destabilizzazione di paesi, che un tempo erano opera esclusiva dei servizi segreti. Insomma, Foa è un esperto in materia. E nell’audizione in Commissione di vigilanza, qualche ora prima del voto che ne ha sancito la nomina a presidente della Rai, dà prova di conoscere a fondo anche le regole deontologiche e le sfide della professione giornalistica: Quello che ho sempre cercato di fare, con molta, molta umiltà, è stato di onorare l’insegnamento dei maestri con cui ho avuto il privilegio di lavorare, [a partire] da Indro Montanelli. […] I miei valori sono quelli dell’indipendenza, servire il lettore con umiltà. Io credo molto nell’onestà intellettuale, nella capacità di riconoscere i propri errori e di correggerli non appena se ne è consapevoli. […] Con il mio libro, Gli stregoni della notizia, conduco da anni una battaglia intensa, motivata e irriducibile affinché la grande stampa riprenda un ruolo fondamentale in questo paese, affinché le false informazioni che troppo spesso ci hanno condizionato – da qualunque parte arrivino – perdino [sic] la loro attrattività grazie al fatto che la gente si riconosce senza se e senza ma nella grande informazione. […] Il mio saggio rappresenta tutto quello che io penso della professione ed è un inno d’amore nei confronti del giornalismo. Ma voglio che i giornalisti sappiano anche come l’informazione, purtroppo, viene gestita nell’ambito delle cosiddette guerre asimmetriche, o non convenzionali. Sono tematiche molto alte, ma sono fondamentali perché se un giornalista vuole riportare in maniera corretta quello che accade, sbagliando il meno possibile, deve essere consapevole di queste che sono delle insidie e invece purtroppo questa consapevolezza frequentemente non c’è. Onestà intellettuale, aspirazione a «sbagliare il meno possibile», disponibilità a riconoscere gli errori e soprattutto capacità di far fronte alle insidie dell’informazione manipolata sono le sue parole d’ordine professionali. Eppure è difficile trovare traccia di questi precetti negli articoli, nei post o negli interventi pubblici di Foa degli ultimi anni. Alla vigilia delle presidenziali che porteranno Donald Trump alla Casa bianca, per esempio, scrive il tweet: «#hillary ha un nuovo guaio: le cene sataniche». E invita i suoi fan a leggere il pezzo in cui l’ex inviato di «Avvenire» Maurizio Blondet riporta la notizia data da un sito americano privo di qualsiasi credibilità, Infowars, secondo cui la candidata democratica alla presidenza avrebbe partecipato a «cene sataniche». No comment. Non faccio commenti neppure su Maurizio Blondet. Mi limito a citare quello che dice di sé sul suo sito: Fin dagli anni Novanta ha cominciato a indagare sui poteri oligarchici, finanziari e sovrannazionali che, agendo dietro le quinte della democrazia, guidano la storia. […] L’11 settembre 2001, inviato da «Avvenire» a Manhattan a coprire il mega-attentato delle Twin Towers, non ha tardato a scoprire e denunciare gli indizi che smentivano la versione ufficiale. […] Non si trattava di un attentato «islamico», ma di un di colpo di Stato […] dove un nuovo centro di potere (i neoconservatori, estremisti filoisraeliani della lobby ebraica in Usa) avevano detronizzato l’oligarchia storica per lanciare la superpotenza americana nelle destabilizzazioni dei paesi del Medio Oriente troppo potenti per Israele. Ecco cosa dice dopo la strage di «Charlie Hebdo» in un video su YouTube «il discepolo di Montanelli» Marcello Foa: Oggi sappiamo che i due fratelli Kouachi sono gli autori della strage. Però qualcosa non torna. La cosa più strabiliante l’ho colta leggendo un reportage del «Nouvel Observateur» che è andato a ricostruire i sette giorni prima degli attentati […] e dal racconto è emerso un dettaglio sconcertante: uno dei due fratelli era quasi non vedente – aveva problemi di vista talmente seri che le autorità francesi gli avevano rifiutato la patente. Ed era una persona così imbranata che a casa non riusciva a piantare un chiodo nel muro. Usciva pochissimo, non faceva esercizio fisico. Allora, ricordate le immagini che abbiamo visto tutti, quelle filmate dai condomini in cui si vedono questi due atleticissimi terroristi con fisici pazzeschi? Allora, autorità francesi: che ci state raccontando? Siete sicuri che questo signore mezzo cieco poteva essere l’autore di una strage di quel tipo? Altra cosa anomalissima è che i due fratelli Kouachi siano stati uccisi benché non avessero ostaggi. Allora, la domanda che sorge spontanea – la domanda fondamentale – è: siamo sicuri che l’attentato di «Charlie Hebdo» sia stato commesso solo da questi due fratelli? Non è che ci sono ancora dei terroristi che sono in giro e che la cosa non viene detta? Altrettanto paranoico e infondato lo scenario che offre sulla strage di Bruxelles: La cosa che più mi colpisce è che questi attentati hanno tutti un tratto comune: l’11 settembre la Cia aveva ricevuto da diversi servizi segreti alleati […] avvertimenti sul fatto che un attentato di dimensioni spettacolari era in preparazione. E quegli avvertimenti sono stati ignorati, con le conseguenze che conosciamo. Lo stesso era avvenuto a Londra. A Londra si sapeva e anche a Londra c’è stata questa coincidenza strabiliante: un’esercitazione di simulazione di soccorsi […] era in corso nel momento in cui avvennero gli attentati. E anche in questo caso l’allerta sui possibili attentati è stata ignorata. […] E a Bruxelles idem: tra gli attentatori c’erano due persone già segnalate. Non soddisfatto continua: Noi sappiamo poco, prima degli attentati, […] e poi, una volta che il fatto avviene, veniamo a sapere tutto nell’arco di quarantott’ore. E questa è un’altra anomalia piuttosto strana. In termini di informazione, noi sappiamo che un’indagine condotta in modo serio e professionale richiede il segreto istruttorio – cioè dovremmo sapere che cosa è accaduto non ventiquattroquarantotto ore dopo, ma dopo due mesi, tre mesi, sei mesi, a conclusione di una seria inchiesta che permette di mettere in fila tutti gli elementi. Invece qui veniamo a sapere tutto e in fretta, con dettagli che sono francamente sconcertanti. […] Tutto questo dovrebbe indurre a una riflessione più ampia da parte della stampa. Non tanto per avvalorare o smentire tesi complottistiche, ma per dire: attenzione. Come ogni accorto venditore di teorie del complotto, Foa prende le distanze da qualsiasi teoria del complotto. Al punto da sottolineare persino il fatto di non sapersi spiegare cosa ci sia dietro alcuni degli improbabilissimi scenari da lui stesso proposti. Aiutare il pubblico a capire Dopo aver descritto un disegno di destabilizzazione del Medio Oriente portato avanti dagli Stati Uniti, dice che «alla fine fa comodo agli Stati Uniti perché evidentemente il disegno, per ragioni che non abbiamo ancora capito del tutto, è quello di promuovere il caos in questa regione del mondo anziché la stabilità». E insiste: «Per ragioni che ancora non capiamo». Dopo aver affermato che a sostenere l’Isis in Siria sono Usa e Arabia Saudita, dice che «dietro a questi giochi ci sono dei calcoli strategici che sfuggono alla ragione». Infine insiste nel negare l’evidenza: «Io non sono un complottista che dice “dietro a questo c’è…”. Ma un giornalismo onesto, che cerca di capire, non può fare a meno… senza arrivare a conclusioni… non può fare a meno di porsi legittimamente delle domande per aiutare il suo pubblico a capire». Aiutare il pubblico a capire? O confonderlo? L’improbabilità degli scenari da lui regolarmente proposti mi portano a propendere per la seconda possibilità. Possibile che si sia davanti al giornalista più paranoico del mondo? O peggio, a uno squilibrato convinto di avere il compito di allertare i lettori delle minacce che incombono e lui solo è in grado di intravedere? La sua carriera – inclusa la posizione che ha raggiunto alla Rai – mi porta a escludere questo scenario. Si tratta allora di un giornalista ingenuo portato fuori strada – o, come direbbe lui, fuori dal mainstream – dalle «cattive frequentazioni»? Il fatto che abbia partecipato a dibattiti sulla «crisi dell’informazione» organizzati in due città diverse da rappresentanti del movimento di Lyndon LaRouche potrebbe portarci a crederlo. Così come le sue riproposizioni di tweet di Maurizio Blondet o di Simone Di Stefano, il capetto di CasaPound. O la sua amicizia con Diego Fusaro, il filosofo oggi amato dai «fascisti del terzo millennio» (che lo hanno voluto come collaboratore della loro rivista ufficiale «Il Primato Nazionale») e ieri discepolo di Costanzo Preve, lo studioso di Marx che è stato il primo intellettuale di origine progressista a teorizzare il superamento della dicotomia destra-sinistra caldeggiando la nascita di un fronte comune «rossobruno» contro il capitalismo e che per questo ha finito col pubblicare i suoi libri per la casa editrice del saluzziano Claudio Mutti. A metà ottobre del 2018, Foa tesse le lodi di Fusaro con queste parole: Viviamo in una strana epoca […] e solo pochi pensatori liberi, di qualunque orientamento politico, sanno proporre chiavi di lettura davvero originali e controcorrente. Diego Fusaro esce ancora una volta dagli schemi per definire come si possa difendere l’interesse nazionale nell’era della globalizzazione. Meno di due settimane dopo, in occasione dell’insediamento di Foa alla presidenza della Rai, Fusaro ricambia la fiducia: Bisogna giubilare incondizionatamente per la nomina di Marcello Foa alla Rai. […] Oltre a essere un amico e una persona di indiscussa onestà, un grande professionista del giornalismo, […] la sua nomina non può che renderci felici giacché egli sarà indiscutibilmente il garante di un’informazione libera, plurale e non asservita al dogma del pensiero unico turbomondialista oggi ovunque egemonico. Giubilo deve averne provato anche Gianluca Savoini. Foa infatti è membro del Comitato scientifico e opinionista di «logos», la rivista «politico-culturale» online di matrice sovranista di cui Savoini è direttore responsabile. Ma a farmi pensare che l’attuale presidente della Rai possa essere considerato un «agente d’influenza» dei postnazisti secondo l’accezione del termine data dall’intelligence italiana – quindi sia una persona che «per convinzione personale» o perché «manipolato da altri e quindi senza rendersi conto» opera a favore di «interessi estranei ed esterni» – è un’analisi dei suoi lavori giornalistici a partire dal momento dell’elezione di Matteo Salvini a capo del Carroccio. Sul fronte del complotto per il meticciato, Foa prende posizione quasi immediatamente. E il 5 aprile 2014 nel suo blog scrive: L’Unione europea continua a incoraggiare – di fatto – l’immigrazione extraeuropea, promuovendo così il modello di una società multietnica, senza aver elaborato modelli di integrazione e, come sempre, senza aver chiesto ai popoli europei se queste dinamiche sono di loro gradimento. La politica di immigrazione europea è talmente contraddittoria, scriteriata e priva di buon senso che ci si può legittimamente chiedere se il vero scopo non sia quello di una destabilizzazione e di uno sradicamento identitario e culturale della civiltà europea. Foa non manca di puntare il dito contro il belzebù preferito di sovranisti e postnazisti, George Soros, che definisce «personaggio di grande cinismo». Anzi, «vero e proprio squalo». Ma l’intervento più esauriente è del 4 novembre 2017, quando sullo stesso blog scrive: Perché il Pd vuole suicidarsi con lo ius soli? Forse una ragione c’è, inconfessabile. Qualcosa non torna. I sondaggi sono inequivocabili: un numero crescente di elettori, ormai maggioritario, inclusi molti di sinistra, è contrario allo ius soli. E al Pd e a Renzi non mancano di certo gli esperti elettorali in grado di spiegare che intestardirsi su un tema impopolare significa urtare gli elettori moderati e dunque perdere le elezioni, domenica in Sicilia in marzo in Italia. Eppure Renzi, per una volta d’accordo con Gentiloni, va avanti. […] E allora bisogna chiedersi cosa spinga il Pd al suicidio politico. Ci deve essere una ragione suprema, per cui l’approvazione di un provvedimento straordinariamente impopolare diventa più urgente delle più ovvie considerazioni di strategia elettorale. […] Non ho risposte certe, solo ragionevoli dubbi. Ad esempio apprendendo che Open Society di Soros può contare su 226 europarlamentari «affidabili» per promuovere i propri progetti di diffusione dei migranti in tutta Europa. Di questi, 14 sono italiani, quasi tutti del Pd […]. Più Barbara Spinelli, della lista Tsipras, ex inviata speciale di «Repubblica». Attenzione: non si tratta di complottismo ma di un dettagliato documento interno della Open Society, pescato e divulgato da DcLeaks. […] Quel Soros che da anni tesse una meticolosa ed efficace rete di contatti negli ambienti progressisti italiani. Quel Soros che ha appena deciso di donare 18 miliardi del suo patrimonio a Open Society. È un uomo potente, influente, determinato, certo coerente con le sue convinzioni. E non è isolato. Fa parte di un mondo che persegue interessi che sono umanitari nelle motivazioni ufficiali ma dall’innegabile valenza politica pro immigrazione, contro la sovranità degli Stati, di aperta ostilità alle identità nazionali, ai valori e alle culture tradizionali. E allora viene da chiedersi: è a quel mondo che il Pd non può dire di no? In realtà basta leggere le prime righe del documento citato da Foa per capire che la sua è un’improbabile esagerazione. Ecco cosa riporta il documento: Questa mappatura fornisce all’Open European Policy Institute e alla Open Society informazioni sui membri dell’8° Parlamento europeo che potrebbero sostenere i valori della «società aperta» durante la legislatura 2014-2019. Lungi dall’essere l’equivalente dell’elenco dei membri della P2, è una semplice lista di europarlamentari ai quali sottoporre le idee della Open Society. Tant’è che il documento prosegue dicendo: La presenza di un deputato europeo in questo elenco indica che è probabile che sostenga il lavoro dell’Open Society […] seppure sia molto probabile che vorranno lavorare su tematiche alle quali sono già interessati. L’impronta cospirazionista Torniamo un attimo all’audizione di Foa in Commissione di vigilanza della Rai. In quell’occasione la senatrice di Liberi e Uguali Loredana De Petris gli chiede conto di alcuni suoi tweet o retweet di natura complottistica. E, più in particolare, della prefazione «piena di elogi» da lui fatta per il libro di Enrica Perucchietti, una giornalista sconosciuta ai più che la senatrice definisce «cospirazionista». Come un politico di lungo corso, Foa fa in modo di non rispondere sul suo conto e di minimizzare su tweet e retweet: Un giornalista esprime le sue opinioni attraverso i suoi articoli. I social hanno questa caratteristica: inducono alla scelta impulsiva – magari perché piace un titolo, o quello è lo stato d’animo – per cui il retweet di qualcuno, che magari non si sa neanche chi è, non è significativo di un’adozione, o un’adesione incondizionata a quello che c’è scritto. È che, semplicemente, in quel momento, può sembrare interessante come opinione da valutare. È molto importante che si capisca la differenza tra quello che uno scrive e quello che uno ritwitta nell’ambito dei social. Ma se c’è una definizione che non calza alla prefazione di un libro è quella di «scelta impulsiva». Occorre scriverla e consegnarla con mesi di anticipo dalla sua pubblicazione. Insomma non c’è un endorsement (per usare un termine nella lingua che ama Foa) più ragionato e programmato. A dimostrare che quella prefazione a Foa non sia «scappata» in un moto impulsivo sulla sua tastiera è anche un articolo pubblicato sul suo blog, in cui scrive: Alla manipolazione dell’informazione ho dedicato il mio ultimo saggio Gli stregoni della notizia. Atto secondo, ma questi episodi mi inducono a segnalare un altro ottimo lavoro di Enrica Perucchietti, Fake News. Dalla manipolazione dell’opinione pubblica alla post verità, che rappresenta un complemento ai miei studi e di cui ho avuto il piacere di scrivere l’introduzione. La realtà è che da anni Foa sceglie di associarsi a Enrica Perucchietti. E non ha smesso di farlo neppure dopo quell’audizione. A questo punto ritengo utile «inquadrare» il personaggio. Anche perché non è difficile. Un assaggio lo dà il suo libro L’altra faccia di Obama, in cui la giornalista rivela «ombre sulla sua biografia sconcertanti», che «nascondono verità scomode», e spiega come la vita del primo presidente afroamericano si intreccia con «i santuari mondiali della finanza», la massoneria e la Cia. Il grande interrogativo presentato ai lettori è: «Possibile che dietro Obama si nasconda l’ennesimo burattino comandato da un’élite ben al di sopra di lui. E di tutti noi?». Ancora più esplicito è il libro intitolato Governo Globale. La storia segreta del Nuovo Ordine Mondiale, in cui Perucchietti presenta «in modo chiaro e completo la storia segreta del Nuovo Ordine Mondiale», spiegando il disegno che «si nasconde dietro la diffusione della tossicodipendenza di massa, fenomeni inquietanti e criminali come il satanismo, […] e quale obiettivo nasconde il progetto di instaurazione di un Governo Globale che lungo il suo cammino assoggetta i Popoli, fa cadere nazioni e governi come pedine di un complesso domino». L’impronta ideologica postnazista è evidente nella spiegazione della tesi del libro che l’autrice fornisce in un’intervista al sito Letture.org: L’ideologia mondialista ha recepito e rielaborato nei secoli […] vari tipi di influssi: sull’originario substrato protestante-anglosassone, infatti, si innestano successivamente almeno altre due correnti politico-spirituali: l’ideologia universalistica […] di matrice massonica (a cui si innestano alcune derive occultistiche) e un certo neomessianismo di matrice sionista. […] Dalla rete inestricabile dei poteri occulti, delle logge e delle sette, dei potentati economici e dei gruppi di pressione impegnati da tempo a promuovere il progetto del Nuovo Ordine Mondiale, emergono con una frequenza non casuale, nomi, realtà e concreti gruppi di potere. Marcello Foa non si è limitato a contribuire a un libro di Enrica Perucchietti. È stato ripetutamente suo unico correlatore in dibattiti pubblici. Come quello intitolato La fabbrica della menzogna, organizzato a Bologna il 18 febbraio 2017 da un professore di liceo che si dichiara comunitarista (altra etichetta di matrice postnazista). In quell’occasione è la giornalista Perucchietti ad aprire il dibattito con alcune considerazioni su operazioni che lei definisce «autocreate» – le cosiddette false flags – al fine di manipolare l’opinione pubblica e spingerla ad approvare scelte governative altrimenti indigeste. Perucchietti mostra una foto che ritrae Zbigniew Brzezinski, l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter, assieme a un soldato afghano che lei spaccia per Osama bin Laden (senza alcuna prova). Dopodiché, con a fianco un Marcello Foa che la fissa con sguardo serio, si lancia in un’operazione ancora più azzardata lasciando intendere che, a detta dello stesso Brzezinski, Pearl Harbor sarebbe stata un’operazione orchestrata a tavolino per spingere alla guerra la popolazione Usa. A quel punto, Enrica Perucchietti passa la parola a Marcello Foa, il quale, dopo aver applaudito per l’intervento appena terminato dice: Mi fa piacere essere qui con voi e soprattutto mi fa piacere vedere una sala così piena, e non tanto per l’ego mio o quello di Enrica, quanto perché, se così tante persone di sabato pomeriggio di bel tempo trovano la voglia di venire a spendere un paio d’ore per affrontare un tema davvero fondamentale quale quello dell’informazione, e in fondo della libertà della nostra società, è un segnale a mio giudizio molto confortante. Perché testimonia una consapevolezza civica e un impegno in una fase molto delicata delle nostre democrazie. Alla fine del dibattito Foa incontra alcuni membri del Fronte sovranista italiano dell’Emilia-Romagna. A riportarlo è il sito del Fronte: In seguito alla conferenza, noi del gruppo Fsi Emilia-Romagna abbiamo avuto modo di presentarci ai due giornalisti e di illustrare brevemente il progetto del Fsi, scoprendo con piacere che entrambi ci conoscevano già. Abbiamo lasciato loro il nuovo volantino di Appello al Popolo e notato la simpatia e l’interesse per il nostro progetto. […] È segno che ci stiamo «facendo notare», e in modo a quanto pare positivo, da giornalisti che affrontano tematiche che come sovranisti ci stanno a cuore. Ma la conferma definitiva dell’allineamento ideologico che sente di avere con la postnazista Perucchietti, Foa la dà l’11 gennaio 2019, tre mesi dopo l’audizione al Senato, partecipando a un altro dibattito assieme a lei. A Torino. Titolo: Manipolazione dei media e fake news: la democrazia è in pericolo? Dice nell’introduzione: Io sono davvero molto lieto di essere qui questa sera. Questa è una serata che avevamo concordato con Enrica già tempo fa, prima che io diventassi presidente della Rai, però tengo particolarmente a onorare questo impegno per la stima e l’amicizia che mi unisce a Enrica da tanti anni. […] Perché la gente crede sempre meno alla grande stampa? Che cosa si è rotto? Be’, la risposta che io ho dato – a volte persino con eccessivo anticipo visto che la prima edizione de Gli stregoni della notizia è uscita nel 2006 – […] è anche la mia critica principale ai colleghi: non c’è stato questo processo di autocritica basata sull’onestà intellettuale che avrebbe permesso alla grande stampa di prevenire la crisi che oggi la colpisce. […] Il giornalismo dovrebbe essere innanzitutto – questo è il mio grande mantra – difesa del pluralismo, difesa di una capacità di proporre visioni articolate e differenziate della realtà, capacità di analizzare i problemi di un paese o di un contesto internazionale da diverse angolazioni. Di non accontentarsi di una sola impostazione. […] Purtroppo quello che io noto è che non c’è nemmeno la percezione dei meccanismi che nelle grandi crisi internazionali hanno portato ad atteggiamenti o visioni da parte della stampa monocolori e molto spesso non corrispondenti alla verità. […] Il mio libro tra l’altro è stato adottato da molte università, perché alla base è un’analisi accademica, non è un pamphlet giornalistico, è uno studio approfondito che dimostra come sia possibile tentare di o addirittura manipolare i media spesso all’insaputa degli stessi giornalisti. A illustrazione delle tecniche di manipolazione, Foa mostra la foto di Aylan, il bambino siriano trovato morto sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia. Queste tecniche sono usate a 360 gradi. Una foto come questa sappiamo tutti che effetto abbia avuto sulla politica migratoria in Europa. […] Una foto come questa ti toglie il fiato e disarma qualunque obiezione. Che il cadavere di Aylan sia stato usato da spin doctor per forzare la mano all’opinione pubblica europea spingendola ad accogliere centinaia di migliaia di siriani? Foa non lo dice apertamente, ma lo sottintende. Cosa che peraltro aveva fatto, in maggior dettaglio, nel suo blog, dove aveva scritto: Quella foto, e soprattutto l’interpretazione data, […] vengono ripresi nell’arco di minuti da tutti i grandi media. La Bbc, «Repubblica», «Corriere», Cnn, «Le Monde» pubblicano sui siti la «foto che sconvolge il mondo», assieme a editoriali che evidenziano l’egoismo dell’Occidente in cui, con grande, collettivo coraggio, attaccano i politici europei, facendo leva sul senso di colpa. Quella foto segna definitivamente un frame, spostando il giudizio dell’opinione pubblica: chi non vuole accettare gli immigrati è un uomo insensibile, crudele, incapace di capire quel dramma. Il piccolo Aylan diventa il simbolo di tutti gli immigrati. […] Per mesi i media e le organizzazioni umanitarie hanno «arato il terreno dell’opinione pubblica» per rimuovere le resistenze e indurla ad accettare i rifugiati. Quella foto è drammatica, sconvolgente, davvero casuale. E nella sua casualità straordinariamente propizia. State certi che le immagini dei piccoli uccisi in altre zone del mondo non produrranno lo stesso effetto. Perché non sostenute da uno spin collettivo, lo spin che prepara, lo spin che indirizza. Dove vogliono arrivare con quella foto gli spin doctor? Foa non lo dice, ma la risposta è ovvia: verso il meticciato. Poi interviene Enrica Perucchietti: Secondo me l’attuale battaglia contro le fake news è una forma di guerra, di moderna caccia alle streghe. Una caccia alle streghe 2.0 […] dove quelli che si vogliono perseguitare – le novelle streghe – sono i ricercatori alternativi, cioè coloro che cercano di far narrazione che vada oltre la narrazione mainstream che non rientri all’interno del pensiero unico. Cogliendo la palla al balzo, Foa s’intromette: Un’ottima difesa è leggere il mio libro, naturalmente. [Risatina] Ma l’autodifesa è nata spontaneamente sul web. La nascita di una certa informazione alternativa secondo me è positiva. Possibilmente un’informazione alternativa come quella fornita dalla sua amica Perucchietti. Magari un’informazione che spieghi come «l’ideologia mondialista» sia ispirata dall’«ideologia universalistica di matrice massonica e un certo neomessianismo di matrice sionista». Il complotto giudaico-massonico del terzo millennio è servito. Queste affermazioni confermano la mia conclusione: Marcello Foa si è, per scelta o di fatto, unito alla battaglia di Gianluca Savoini (e di chi balla sul suo spartito). Il suo sostegno alle teorie del complotto di matrice murelliana avviene infatti con una continuità e una perseveranza altrimenti inspiegabili. Il pluralismo al tempo di Foa La stessa ipocrisia che spinge i postnazisti a prendere le distanze dal nazismo e Salvini a definire antistorico qualsiasi ragionamento sul ritorno del fascismo, porta poi Foa a ricorrere spesso alla tecnica del ribaltamento delle carte in tavola, accusando gli altri di manipolazioni giornalistiche. L’apice lo raggiunge in un’intervista al «Corriere della Sera» del settembre 2018. Quando il collega gli chiede chi siano «gli stregoni della notizia», lui risponde: «Gli spin doctor che orientano la stampa». Poi aggiunge: Dopo averne smascherato le tecniche, ho provato sulla mia pelle la loro perfidia: l’inviato del tedesco «Die Zeit» è andato a rileggersi tutti i 1176 articoli che ho scritto in dieci anni sul blog del «Giornale» e ha scoperto che ne hanno scovati solo cinque per demonizzarmi. Lo 0,43 per cento dell’intera produzione. Al giornalista di «Die Zeit» che ha trovato tracce documentali delle teorie del complotto da lui proposte (o riproposte in caso di quelle altrui), Foa risponde non solo con numeri falsi (lavorando su questo libro ho trovato ben più di cinque pezzi complottistici), ma lo attacca personalmente come «perfido» manipolatore di notizie. A Foa non basta presentarsi come il giornalista che non cade nei tranelli degli spin doctor. Rivela i retroscena ignorati dai più, volendo addirittura far credere di aver ottenuto la poltrona di presidente della Rai senza alcuna sponsorizzazione politica. Come se fosse possibile. E soprattutto come se nessuno avesse notato i salti mortali fatti da Matteo Salvini per assegnarla proprio a lui. Eppure nella citata audizione ha precisato: «Io non ho mai militato in alcun partito politico, non ho mai preso la tessera di un partito politico, non ho mai cercato appoggi politici per far carriera». Sul passato non sono in grado di esprimermi. Ma sul più alto gradino della sua carriera penso nessuno possa negare che Salvini lo sostenga. Sicuramente lo sostiene dall’estate del 2016, quando il leghista Claudio Borghi scrive questa email a Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana a Armando Siri, suoi colleghi del comitato «Noi con Salvini» che stavano organizzando un dibattito: «Richiesta di Matteo di ieri notte: va aggiunto Marcello Foa (già sentito e confermato)». Matteo Salvini lo vorrà anche all’incontro di Milano, all’indomani della vittoria elettorale del 4 marzo 2018, con lo stratega di Donald Trump, il sovranista americano Steven Bannon. Nella sua presentazione in Commissione di vigilanza, Foa ha promesso che il suo sarà un ruolo di «garante del pluralismo». Nel pensiero di Foa abbiamo appreso che «pluralismo» è sinonimo di «voci fuori dal coro». E le voci fuori dal coro che gli piacciono sono senza dubbio quelle di Enrica Perucchietti, di Maurizio Blondet e di Diego Fusaro. La prima significativa novità della Rai dell’era salviniana viene annunciata il 3 gennaio 2019, quando Carlo Freccero, neodirettore di Rai2, presenta un nuovo programma, L’Ottavo Blog, definendolo «una rassegna dell’informazione che non deve essere divulgata». A chi gli chiede quale genere di informazione, Freccero risponde: «Lo sapete benissimo, ci sono dei giornali che ritengono queste notizie sempre complottiste, ed è sbagliata, questa cosa». Serve quindi un programma «sull’attualità secondo internet, internet che diventa mainstream». Per farsi capire meglio, Freccero cita alcuni blog e siti. Il primo dei quali è L’Intellettuale Dissidente. Ne è animatore e direttore Sebastiano Caputo, colui che assieme a Vincenzo Sofo, Fabrizio Fratus e Diego Fusaro ha prodotto il «contributo di idee» sovraniste alla Lega di Salvini. Basta fare una visita al sito di Caputo per essere inondati da citazioni di fan della Konservative Revolution tedesca o di Ernst Jünger, e scoprire che il giovane Sebastiano Caputo si è fatto le ossa professionali nella redazione del «Quotidiano Nazionale Rinascita», testata positivamente postnazista. Insomma, ecco il modello del pluralismo di Marcello Foa: un giovane di matrice postnazista. Che come Savoini, Salvini e Foa, sul fronte della politica estera, non è affatto pluralista. Si nutre infatti esclusivamente della propaganda del Cremlino. *** L’andamento del conflitto si stava facendo favorevole per gli Alleati, ma procedeva con una esasperante lentezza per noi che vivevamo nascosti e in pericolo, e per tutti che si logoravano nell’attesa della libertà. Venne il nipote di Tullio Della Volta, l’anziano cugino di mio suocero. Era stato catturato, ma fortunatamente come soldato, e per questo era riuscito a sopravvivere; vestiva un cappotto malridotto e in testa aveva un berretto. Ci disse che gli zii, presso i quali si era rifugiato dopo esser rientrato in Italia, fuggendo dal campo di lavoro in Germania in cui era stato internato, vivevano in casa di una loro ex donna di servizio. Sperava di poter, in qualche modo, proseguire il viaggio alla volta di Roma, sua città natale, dove aveva genitori e sorella. Ma attraversare il fronte della Linea gotica sarebbe stato pericoloso. I giorni passavano, il nervosismo cresceva, causato dalla staticità del fronte, dalla paura delle incursioni aeree, dai fascisti. Una delle figlie della Maria Canedi, che era venuta a stare da noi in via dell’Oro, ogni volta che rincasava alla sera diceva: «Danno 5000 lire a chi denuncia i partigiani e gli altri». A un certo punto, non sopportando più questa tensione, Guglielmo pensò addirittura di costituirsi. Per fortuna io sono sempre rimasta ottimista. Insieme ci immergevamo nella lettura dei libri che avevamo trovato in casa Vannini. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti Putin e la militarizzazione dell’informazione Una nuova Guerra fredda Prima di aprire il «fronte russo» dell’offensiva savoiniana occorre fare un passo indietro nel tempo e ricostruire, seppur brevissimamente, gli eventi internazionali più significativi verificatisi nei quattordici anni di interregno tra la prima e la seconda offensiva postnazista nel Carroccio. È un periodo in cui, anche a causa dell’11 settembre, nel mondo si riaccendono quelle tensioni che la caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’Unione Sovietica avevano date per superate. E Putin emerge come l’unico leader al mondo pronto a contrapporsi a un’America apparentemente sempre più dominante sia dal punto di vista militare sia da quello geostrategico. Alla vittoria militare su Saddam Hussein fanno seguito le tre «rivoluzioni colorate» che, tra il 2003 e il 2005, posizionano a Occidente la Georgia, l’Ucraina e il Kirghizistan, tre ex repubbliche sovietiche fino ad allora vicine a Mosca. Tra il 2010 e il 2012 arrivano poi le «primavere arabe». Nei paesi occidentali, governi e media celebrano sia le prime sia le seconde come rivolte popolari contro regimi corrotti e autoritari. Al Cremlino vengono invece viste come frutto di un complotto manovrato da Washington e New York. Come tutte le teorie del complotto che si rispettino, anche questa ruota attorno a elementi di verità: rivoluzioni colorate e primavere arabe sono state sicuramente alimentate da strumenti e soggetti occidentali; mi riferisco al ruolo dei social media e delle organizzazioni non governative americane o europee che per anni hanno sostenuto movimenti di protesta sia nei paesi dell’ex Urss sia in Medio Oriente e Nord Africa. Ma da lì a sostenere che i manifestanti di piazza Tahrir al Cairo o piazza Nezaležhnosti a Kiev fossero eterodiretti, ne corre. Me lo conferma Francesco Bascone, ex diplomatico italiano che tra il 2004 e il 2008 è stato dirigente dell’Osce – l’Organizzazione europea per la sicurezza e la cooperazione che, tra i vari compiti, ha quello del monitoraggio elettorale – e che in quella veste ha validato i risultati elettorali legati alle rivoluzioni colorate: «Sul piano dell’osservazione elettorale l’Osce è considerata un’autorità. Hanno sviluppato metodologie molto valide, fanno un’osservazione non superficiale […] e hanno criteri istituzionalizzati. […] Nell’insieme credo non si possa dubitare della professionalità e quindi dell’oggettività dei rapporti dell’Osce. […] Sono molto attendibili, anche secondo gran parte dell’opinione pubblica informata del mondo non russo. Se poi alla Russia questo dà fastidio…». «Ha il dubbio che le rivoluzioni colorate siano state il frutto di ingerenze esterne? O che siano stati addirittura dei colpi di Stato?» gli chiedo. «Se vuol sapere se da parte di ong è stato dato appoggio ai dissidenti, la risposta è: sì, certamente. […] In Ucraina per esempio c’è stata un’attività di incoraggiamento – forse anche di finanziamento – di questi giovani che stavano per le strade sotto le tende. Ma da lì a dire che sia stato un colpo di Stato… direi proprio di no. Da parte degli americani c’è stata sicuramente un’attività di incoraggiamento, ma non direi che sia stato un golpe pilotato dall’esterno.» Per un uomo come Putin, i cui schemi mentali sono stati forgiati prima dal Kgb, durante gli anni formativi, e poi da quelli al comando dell’Fsb, il servizio d’intelligence che gli è succeduto, non esistono tonalità di grigio. La realtà è bianca o nera. Altro che «incoraggiamento»! Per Putin quelle rivolte sono il prodotto del cosiddetto soft power del grande nemico americano, che, regione dopo regione, paese dopo paese, ha stretto un cappio attorno al collo russo minacciando la sopravvivenza del regime da lui faticosamente costruito. Le campagne di disinformazione del Cremlino Apro qui una brevissima parentesi per dare un’idea precisa della natura di quel regime, facendo un elenco sommario di critici o oppositori che si sospetta siano stati assassinati per ordine del Cremlino: il politico democratico Sergej Jušenkov, assassinato a Mosca il 17 aprile 2003; il direttore dell’edizione russa della rivista «Forbes» Paul Klebnikov, assassinato a Mosca il 9 luglio 2004; la giornalista d’inchiesta Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006; l’ex agente segreto Aleksandr Litvinenko, avvelenato con il polonio il 23 novembre 2006 a Londra; la giornalista Anastasija Baburova, uccisa il 19 gennaio 2009 a Mosca; l’avvocato difensore dei diritti umani Stanislav Markelov, ucciso lo stesso giorno anche lui a Mosca; l’attivista dei diritti umani Natalja Ėstemirova, rapita e uccisa il 15 luglio 2009 a Groznyj, in Cecenia; l’avvocato e paladino anticorruzione Sergej Magnitskij, morto il 16 novembre 2009, otto giorni prima della prevista scarcerazione dopo un anno passato in galera senza processo. Chiusa parentesi. Di fronte a quella che ritiene una versione aggiornata della famosa «teoria del domino» postulata negli Usa durante la Guerra fredda, secondo la quale il cedimento politico di un paese porta i vicini a cadere come pezzi di un domino, Putin si rende conto di avere poche scelte. E ancor meno tempo. Deve rispondere, con metodi convenzionali e non. Al soft power occidental-americano deve replicare con il soft power russo. Consapevole di non avere la forza per affermarsi economicamente e culturalmente su Stati Uniti e Unione europea, Putin e i suoi strateghi pensano a un piano di «militarizzazione dell’informazione» che non abbia come obiettivo il takeover politico dei bersagli, bensì la loro destabilizzazione e il loro indebolimento. Nel 2005, a complemento dell’agenzia giornalistica Sputnik, il Cremlino lancia il canale di news internazionali in inglese Russia Today, a cui poi viene cambiato il nome in Rt. È la risposta non solo alla storica Voice of America ma anche alla Cnn, alla Bbc e, nel giro di pochi anni, ai media in lingua tedesca, francese e spagnola. Ventiquattr’ore al giorno di notiziari e commenti che presentano il punto di vista russo in cinque lingue diverse. Ma offrire «la prospettiva russa» non basta. Un uomo dei servizi non smette mai di pensare come un uomo dei servizi. E la lunga esperienza in quel settore dà a Putin un vantaggio sugli altri politici: conosce l’efficacia delle cosiddette «misure attive», termine usato dal Kgb per indicare le operazioni di manipolazione informativa. Secondo una coppia di giovani ricercatori di base nel Regno Unito, Ilya Jablokov e Precious Chatterje-Doody, in questo contesto il Cremlino arriva addirittura a elevare la teoria del complotto a strumento geostrategico. Più precisamente la loro ipotesi di lavoro (già oggetto di una breve monografia di Jablokov intitolata Fortress Russia: Conspiracy Theories in the Post-Soviet World) è che, su mandato del Governo russo, Rt utilizzi la diffusione di insinuazioni e scenari di ogni genere – anche i più bizzarri – al fine di infondere sospetti, polarizzare le società dei paesi occidentali, isolare le loro classi dirigenti, mettere in discussione l’adeguatezza dei loro media, e poi, ma solo collateralmente, rafforzare il messaggio trasmesso dal Cremlino. Nessuno meglio di Putin, cresciuto a diretto contatto con il Dipartimento A, quello che all’interno del Primo direttorato centrale del Kgb era specializzato in «misure attive» e in particolare in dezinformatsiya, sa che l’opera di indebolimento del nemico è molto più efficace quando supportata da una parte dei suoi stessi opinion maker. È la grande leva della quinta colonna ideologica. E sul fronte europeo il Cremlino sa di potersi servire delle forze populiste che stanno emergendo un po’ ovunque nel continente e dei loro sponsor mediatici. Due grandi opportunità da non perdere. Al contrario, da usare e da alimentare. Bugie strategiche: Crimea e Ucraina Per identificare quelle che si possono definire le «priorità geostrategiche» per il Cremlino dal 2014 a oggi, mi sono rivolto a Ben Nimmo, senior fellow del Digital Forensic Research Lab dell’Atlantic Council, uno dei massimi esperti in operazioni di disinformazione e «d’influenza». «La prima a emergere in ordine cronologico è stata la questione della Crimea, poi mutata in una campagna a lungo termine sul conflitto ucraino in cui si inserisce anche l’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines. Il secondo teatro di guerra essenziale per i russi è quello siriano, con il discorso sull’uso delle armi chimiche. Poi c’è il tentato omicidio dell’ex agente russo Sergej Skripal a Salisbury, in Gran Bretagna, e infine le varie campagne di hacking negli Stati Uniti a supporto della campagna elettorale di Trump, ma anche in Europa» risponde Nimmo. A suo dire sono tutte questioni in cui la posizione del Cremlino non è solamente lontana dalla realtà, ma è documentalmente provata come errata. O falsa. «Il 28 marzo 2014 i cosiddetti “omini verdi” appaiono in Crimea, tutti con le stesse uniformi e le stesse armi. Mosca dice: non hanno niente a che vedere con noi, sono “forze di difesa locali”. Questo termine appare nelle dichiarazioni ufficiali del Cremlino e in tutti gli articoli di Rt e della sua agenzia sorella Sputnik. Ma un anno dopo, nel corso di una trasmissione televisiva sulla Crimea, Putin ammette di aver ordinato al proprio staff militare di “riprendere la Crimea”. E dice di averlo fatto inviando forze speciali prive di distintivi. Insomma, lui stesso ha ammesso quello che tutti sapevano: “gli omini verdi” non erano affatto volontari locali. Era una bugia clamorosa. Così come è stato provato che truppe corazzate russe sono entrate in Ucraina in un vero e proprio atto di guerra, perché abbiamo i selfie dei soldati. Chi dice che in Crimea c’è stata una sollevazione popolare pacifica seguita dalla legittima espressione della volontà popolare ignora tutte le prove che indicano il contrario» dice Nimmo. «Il referendum in Crimea a suo parere non ha valore?» gli chiedo. «Che valore può avere un referendum tenuto con le forze armate di una potenza straniera che fanno la guardia ai seggi? Per non parlare del fatto che è stato organizzato in meno di due settimane. Nessun referendum fatto in quelle condizioni può essere ritenuto espressione del libero volere di un popolo.» Per quel che riguarda l’abbattimento del volo MH17 delle linee aeree malesi in viaggio da Amsterdam a Kuala Lumpur, lascio parlare la lettera che il 25 maggio 2018, a seguito delle conclusioni della Commissione d’inchiesta internazionale, il ministro degli Affari esteri olandesi ha inviato al presidente della Camera del suo paese: Nella mia qualità di ministro degli Affari esteri e per conto del ministro della Giustizia, scrivo per informare l’Assemblea della decisione presa in merito alla responsabilità della Federazione russa nell’abbattimento del volo MH17. […] Sulla base delle conclusioni delle indagini, comprese quelle del team investigativo congiunto (Joint Investigative Team – Jit), la batteria missilistica Buk con cui è stato abbattuto il volo MH17 apparteneva all’esercito russo. L’Australia e i Paesi Bassi ritengono dunque la Russia corresponsabile dell’abbattimento del volo MH17. Il Jit ha concluso che il missile Buk è stato trasportato dalla Russia in una zona dell’Ucraina all’epoca controllata dai separatisti e che il missile è stato lanciato da questa zona. Più specificatamente, il Jit ha concluso che il missile Buk in questione faceva parte della 53a brigata missilistica antiaerea dell’esercito russo. Dibattito chiuso. Gli attacchi chimici in Siria Neppure sulla questione dell’uso di armi chimiche in Siria, secondo Nimmo, è legittimo avere dubbi. Perché le analisi dei periti internazionali portano a concludere che siano state effettivamente utilizzate e che a farne ricorso possano essere state solo le forze di Assad. Nel caso dell’attacco del 4 aprile 2017 nella regione di Khan Shaykhun, il rapporto degli ispettori dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, l’Opcw, ha stabilito che è stato usato l’agente nervino sarin. Il 26 giugno 2018 ha emesso un comunicato estremamente chiaro: Ci sono informazioni sufficienti per attribuire alle forze armate siriane la responsabilità di tre attacchi con armi chimiche avvenuti nel 2014 e 2015 e per dire che la Repubblica araba siriana è responsabile dell’utilizzo di sarin il 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun. L’Opcw osserva con preoccupazione che l’uso di tali armi chimiche da parte delle forze armate siriane dimostra che la Repubblica araba siriana non ha rispettato l’impegno a dichiarare e distruggere tutte le sue armi chimiche. Vista la risposta militare data dall’amministrazione Trump all’attacco con il sarin dell’aprile 2017, secondo Nimmo l’anno successivo i russi organizzano un piano di disinformazione inteso a confondere le acque in previsione di un nuovo ricorso ad armi chimiche da parte delle forze di Assad: «Nel febbraio del 2018 il ministero della Difesa russo organizza un briefing in cui sostiene che i ribelli hanno ottenuto da americani e inglesi delle bombole di cloro e si accingono a farle esplodere per denunciare poi un finto attacco aereo con armi chimiche. Così facendo, i russi preparano il terreno per una narrazione alternativa alla realtà, quella di una false flag, cioè di una messinscena pianificata dai ribelli in combutta con americani e inglesi. Il successivo 7 aprile, quando si verifica l’incidente di Douma in cui viene riportato l’uso di armi chimiche, il regime di Assad nega subito tutto. E il giorno dopo i russi dicono che è stata una messinscena dei ribelli». Nel loro primo (e finora unico) rapporto, gli ispettori dell’Opcw riportano di aver rinvenuto due cilindri metallici con tracce di cloro all’ultimo piano di un palazzo il cui tetto di cemento armato era stato sfondato, l’ovvio segno di un attacco dal cielo. In aggiunta, dicono di aver trovato anche residui di esplosivo. «Dopo la pubblicazione di questo rapporto, la linea di Sputnik è di sottolineare il fatto che il documento certifica l’assenza di tracce di “agenti nervini”. Ma l’attacco era stato condotto con il cloro – di cui sono state trovate tracce –, quindi urlare ai quattro venti che non c’è traccia di sarin non ha alcun senso» spiega Nimmo. Faccio una verifica con Dan Kaszeta, ex ufficiale dei Chemical Corps dell’esercito americano e consulente privato che ha quasi trent’anni di esperienza nel settore delle armi chimiche e biologiche. «L’attacco a Douma è stato condotto con il cloro, contenuto in due grossi cilindri metallici lanciati dal cielo» mi dice. «Come sempre in quelle situazioni, le prime segnalazioni furono confuse. I testimoni parlarono di un forte odore di cloro, che è un odore a tutti noto. Ma poiché ci fu un numero insolitamente alto di morti, alcune persone dissero che era stato forse usato anche il sarin. Cosa estremamente insolita, considerato che il cloro distrugge il sarin. L’Opcw ha investigato e non ha trovato tracce di sarin o di altri agenti nervini. Ma ha trovato abbondanti prove di uso di cloro. A differenza del sarin, il cloro in sé non è classificato come arma chimica, poiché ha molti usi legittimi, ma diventa tale quando viene deliberatamente usato contro le persone. Come nel caso di Douma. I “negazionisti” hanno poi estrapolato e manipolato la frase del rapporto che faceva riferimento all’assenza di agenti nervini. Il loro è stato un uso scorretto e incompleto dell’informazione perché omette di dire che, benché non ci fossero tracce di sarin, le armi chimiche sono state utilizzate anche quella volta. Invece il primo rapporto dell’Opcw non dà spazio ad ambiguità: i cilindri metallici rinvenuti all’ultimo piano di un palazzo col tetto sfondato contenevano cloro e sono stati usati come arma chimica a Douma» conclude Kaszeta. Torno a sentire Nimmo: «È vero che i governi mentono e che i media, soprattutto quelli legati all’establishment, spesso ripetono le loro menzogne. Io stesso posso elencare una serie di incidenti in cui è successo, a partire dal caso dell’allora segretario di Stato Colin Powell e delle false accuse sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. Ma una cosa è un sano scetticismo, un’altra farsi strumento di una campagna di disinformazione. Chi offre un megafono alla disinformazione russa non solo replica l’errore dell’Iraq, ma fa la scelta precisa di ignorare i fatti e diffondere propaganda». Nimmo sottolinea il fatto che quelle questioni – dalla Crimea al volo MH17, da Skripal all’hacking – hanno solo una cosa in comune: l’importanza geostrategica attribuita loro dal Cremlino. Gli chiedo se è in grado di identificare la linea di demarcazione tra scettico idiota e agente d’influenza. E Nimmo risponde: «Se su ognuna di queste priorità geostrategiche russe si continuano a ripetere le menzogne del Cremlino, anche dopo che sono state dimostrate false, se si ignorano tutte le evidenze, vuol dire che si è strumenti del Cremlino. Non è detto che si sia pagati per farlo, ma se si ripetono sempre ed esclusivamente versioni dei fatti dimostratesi false, si sta agendo per conto e a vantaggio del Cremlino». *** Era la notte tra il 20 e il 21 aprile. La temperatura era buona, perciò al buio tenevo la finestra aperta. Vidi nel cielo, verso est, un chiarore inconsueto. Mi appoggiai con i gomiti al davanzale, sentivo nell’aria qualcosa: giunse a un certo momento un rumore lontano che via via diventò più forte, poi assordante. D’un tratto, silenzio di tomba. Albeggiava e il chiarore rossiccio era scomparso. Udii poco distante, alla Porta Castiglione, un comando in tedesco e un motore partire rombando. Poi ancora silenzio. Erano le cinque, mi decisi ad andare a letto, Guglielmo dormiva e non lo destai. Alle sette udii bussare alla porta della stanza e la Maria dire: «Gli Alleati sono in piazza Aldrovandi!». Maria era sicuramente felice, ma noi esultanti. Fummo in piedi in un attimo. Uscimmo di corsa percorrendo via Castiglione diretti alle Due Torri. Giunti in via Rizzoli vedemmo i primi carri armati procedere verso la piazza, con i soldati sfiniti di stanchezza tra due ali di popolo urlante di gioia, mentre fiori cadevano dalle finestre e signore offrivano da bere a tutti. Vedemmo tra la folla il professor Spongano e la moglie, li raggiungemmo e ci abbracciammo commossi. Avevano pensato subito a noi. Erano stati in via dell’Oro a chiamarci, ma eravamo già usciti. Poi vedemmo avanzare una colonna di partigiani che fino a poco prima erano rimasti nascosti. La popolazione era in delirio. Una nostra vicina di casa ci abbracciò con le lacrime agli occhi. Dalle memorie di Eugenia Levi, mamma di Silvana Sacerdoti Putin, tutta la vita Savoini agente d’influenza del Cremlino L’Associazione Lombardia Russia non ha alcun legame formale con Matteo Salvini e il suo partito. Ma la sua sede legale, al civico 18 di via Colombi a Milano, è su un altro lato dello stesso palazzo in cui la Lega ha la sua sede storica, in via Bellerio. Appena venticinque metri separano un ingresso dall’altro. Oltre a essere stato scelto come portavoce di Salvini a seguito della sua elezione a segretario federale, il presidente e dominus dell’Associazione, Gianluca Savoini, è responsabile dei rapporti con la Russia. Insomma, al di là della forma, i legami sono forti. Ancora più forti sono quelli con la Russia di Putin. Il 13 febbraio 2014, presentando la sua associazione al pubblico nella Sala eventi del Consiglio regionale della Lombardia, Gianluca Savoini si assicura di metterli bene in evidenza, sottolineando anche il fatto che il presidente onorario è Alexey Komov, membro del World Congress of Families e responsabile internazionale della Commissione per la famiglia del Patriarcato ortodosso di Mosca. I soci fondatori sono invece Irina Shcherbinina (moglie di Gianluca Savoini), Luca Bertoni e Gianmatteo Ferrari. Il sito dell’associazione non lascia dubbi sul grado di contiguità con il Cremlino: Lombardia Russia è un’associazione culturale apartitica con idee molto precise che combaciano pienamente con la visione del mondo enunciata dal presidente della Federazione russa nel corso del meeting di Valdai 2013 e che si possono riassumere in tre parole: Identità, Sovranità, Tradizione. Il mondo attuale, perso in un delirio mondialista, è la negazione del mondo tradizionale come noi lo abbiamo conosciuto e la Russia pare oggi l’unico baluardo e l’unico faro verso cui guardare con speranza. L’esigenza di una nuova associazione nasce dal fatto che, malgrado milioni di europei guardino con simpatia alla Russia e al suo presidente, tutta la stampa sia schierata in maniera pregiudiziale contro Mosca e sia impossibile trovare una fonte obiettiva presso cui informarsi. Nel nostro piccolo cercheremo di far conoscere la Russia e la sua attualità per quel che sono, dando le notizie che gli altri censurano e smontando le menzogne, quando sarà il caso. Per farlo ci avvarremo naturalmente anche della collaborazione di media russi di provata serietà a partire da una fonte preziosa quale La Voce della Russia, ora Sputnik News. Appena scoppia la crisi della Crimea, Savoini è con la valigia in mano, pronto a rendersi utile. Lo spiegherà successivamente in un articolo su «logos», rivista da lui diretta: Mi sono recato in Crimea in occasione del referendum di autodeterminazione nel marzo 2014 e anche qualche mese dopo. Posso testimoniare che non è stato sparato un solo colpo, nemmeno a salve. Non si è vista la popolazione in strada in rivolta e i marinai russi se ne sono stati tranquilli nella base navale di Sebastopoli. Insomma, tutto democraticamente ineccepibile. Per questo, su input di Savoini, la Lega diventa il primo – e unico – partito italiano a riconoscere la legittimità del referendum. Altrettanto pronta è la risposta alla crisi creata dall’abbattimento del Boeing 777 del volo Malaysia Airlines MH17 nei cieli dell’Ucraina orientale. Nella sua pagina Facebook, l’Associazione Lombardia Russia posta, con tanto di sottotitoli in italiano, il video della conferenza stampa in cui, a quattro giorni dalla strage, il ministero della Difesa russo presenta immagini satellitari che a suo dire dimostrerebbero il coinvolgimento di una batteria missilistica appartenente all’esercito ucraino. Inutile dire che Savoini e la sua associazione si schierano sin dall’inizio contro le «inique sanzioni» imposte da Usa e Ue a seguito dell’abbattimento del Boeing malese. Ancora oggi, nonostante le conclusioni delle indagini del team d’inchiesta congiunto australiano-olandese, a me Savoini dice che occorre «verificare se è vero, se è veramente responsabilità russa o meno, se non ci sia qualcos’altro». Un ulteriore segno di fedeltà, Savoini lo dà mettendo in discussione la necessità della Nato in un’intervista concessa a un sito sovranista: Mi chiedo: la Nato a che serve? Se serve a provocare la Russia, meglio pensare ad altro, perché la Guerra fredda è morta e sepolta dal 1991, data della fine dell’Unione Sovietica, e solo un pazzo può averne nostalgia. A meno che, dietro questa ostilità contro la Russia, non si celino interessi finanziari e commerciali che verrebbero grandemente ostacolati dall’unione tra Mosca e le nazioni europee. Ovviamente la mia è una dichiarazione ironica: sappiamo benissimo che si tratta di questo e soltanto di questo. Non certo della difesa dei nostri «valori» minacciati da Putin e altre baggianate del genere. Ecco qui: le sanzioni alla Russia frutto del complotto della «finanza apolide» e dei massoni. La propaganda russa viene rilanciata incessantemente anche sulla Siria, con post, tweet e articoli. Tutti allineati con Mosca. Notizie false per sganciare altre bombe? Basta guerre, grazie! Già un mese fa avevo scritto delle preoccupazioni russe su una possibile provocazione con armi chimiche in Siria per incolpare Assad e l’alleato Putin. Siria: le fake news sulle armi chimiche per creare il casus belli? Lo scenario che si sta delineando in queste ore nel conflitto siriano ricorda da vicino la «pistola fumante» delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein con cui gli Usa giustificarono agli occhi del mondo l’invasione dell’Iraq nel 2003. Ci sono infatti molte ragioni per esprimere scetticismo di fronte alla denuncia dell’ennesimo attacco chimico contro i civili siriani attribuito al regime di Damasco nell’area di Douma, ultima roccaforte delle milizie jihadiste filosaudite di Jaysh alIslam nei sobborghi di Damasco. Già in passato attacchi simili sono stati attribuiti ai governativi senza che emergessero prove concrete, mentre notizie e immagini diffuse oggi dai «media center» di Douma, come ieri da quelli di Idlib, Aleppo e altre località in mano ai ribelli, sono evidentemente propagandistiche e palesemente costruite. Secondo le analisi dei periti internazionali, le armi chimiche in Siria sono state effettivamente utilizzate, e a farne ricorso possono essere state solo le forze di Assad, come riportato nel precedente capitolo. Ma queste informazioni, anche solo per completezza, non vengono minimamente citate da Gianluca Savoini. Che ha un solo obiettivo: fare da megafono della propaganda del Cremlino. Non manca di esprimersi sulla vicenda dell’ex agente russo Sergej Skripal, avvelenato a Salisbury assieme alla figlia Julija. Mentre il terrorismo islamico colpisce ancora nel cuore d’Europa, i governanti dell’Ue condannano senza prove la Russia per il «caso Skripal». Per fortuna l’Italia non seguirà questi matti. Sempre lesto a seminare dubbi, in un post della sua associazione, Savoini riporta una tesi fatta circolare dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov: Secondo scienziati svizzeri, per l’avvelenamento di Skripal è stata utilizzata la sostanza BZ, disponibile negli Usa e in Gran Bretagna, e non prodotta in Russia o dall’Urss. Perché nessuno lo dice? I mezzi di informazione occidentali sono scandalosi. Di fronte a queste dimostrazioni di lealtà politica, Mosca lo premia con un invito di cui, orgogliosamente, la sua associazione dà notizia il 6 settembre 2017: Il presidente di Lombardia Russia, Gianluca Savoini, è stato nominato osservatore internazionale per le elezioni regionali russe che si terranno domenica prossima 10 settembre. Nella lettera di invito, si leggono le motivazioni della scelta della nostra associazione: «Considerando la sua lunga esperienza nel campo dei diritti umani, delle libertà, dello sviluppo della democrazia e dello stato di diritto, facendo affidamento sulla sua professionalità, vorremmo invitarla a partecipare al monitoraggio delle elezioni il 10 settembre 2017 come esperto internazionale». Un postnazista scelto come esperto di diritti umani e democrazia. Solo il Cremlino poteva farlo. Assieme ai suoi associati Gianmatteo Ferrari e Claudio D’Amico, Savoini è invitato come «osservatore esperto» anche alle presidenziali russe del marzo 2018. In quell’occasione viene fatto loro il più grande degli omaggi. Possono assistere di persona e in diretta al momento di massima espressione della democrazia russa: il voto di Vladimir Putin. Una scena che Savoini e Ferrari non mancano di celebrare in rete con i loro fan, filmandosi a due passi dall’ex tenente colonnello del Kgb che, sorridente, infila la scheda nell’urna. Poco prima, al team leghista è concesso un privilegio operativamente più significativo, di cui informano il loro pubblico con un allegato fotografico e il post che dice: Il presidente di Lombardia Russia Gianluca Savoini, il vicepresidente Gianmatteo Ferrari e l’On. Claudio D’Amico hanno incontrato il portavoce del presidente Putin, Dmitri Peskov, poco prima del voto. Ricordando lo «schema interpretativo Nimmo», direi che questi episodi sono sufficienti per affermare senza timore di smentita alcuna – neppure da parte dello stesso giornalista – che Gianluca Savoini sia classificabile come agente d’influenza del Cremlino. Che poi il suo numero di cellulare su WhatsApp sia associato a una foto in cui lo si vede stringere la mano a Vladimir Putin, è forse solo un gesto di immodestia. Salvini e la causa putiniana Passiamo al suo capo, o Capitano. Il quale si cimenta subito con una serie di interventi online sulla questione spinosa (per gli altri, non per lui) del referendum in Crimea. 12 marzo 2014 Mi domando perché per Usa e Unione europea l’indipendenza di Bosnia e Kosovo andava bene e invece quella della Crimea no. 17 marzo 2014 Crimea, Veneto, Catalogna, Scozia. Quando i popoli decidono, è sempre una buona notizia. Il 10 ottobre 2014, nel suo primo anno da segretario federale della Lega, Salvini si reca per la prima volta a Mosca. Lo comunica ai fan con un video sulla sua pagina Facebook: Cari amici, primi due incontri importanti della Lega Nord a Mosca. Il primo con il presidente della commissione esteri [Aleksej] Pushkov. Totale sintonia per dire no alle sanzioni contro la Russia che costano a loro ma costano anche all’Italia. […] No all’immigrazione incontrollata, no al terrorismo islamico e totale collaborazione sia a Strasburgo che a Bruxelles tra la Lega e Russia Unita. Poi annuncia che su questo stesso fronte «ci saranno delle sorprese». Determinato a dare prova del proprio entusiasmo per i successi del regime putiniano posta anche un breve video con il Cremlino sullo sfondo: Piazza Rossa, Mosca. Città pulita. Non c‘è un mendicante, non c’è un lavavetri, non c’è un Rom, non c’è un clandestino, non c’è un rompiscatole. Di notte, alle due, le ragazze prendono la metropolitana e tornano a casa tranquillamente, senza il terrore. La polizia c’è, è discreta ma fa il suo lavoro. E se sbagli, paghi. Mi domando perché qua si può vivere con serenità mentre a casa nostra devi avere il terrore a uscire di casa. Quindi non dico che dobbiamo imparare da altri, però Mare Nostrum sicuramente qui non si sognerebbero mai di finanziarlo, di farsi invadere, di aiutare gli scafisti. I russi contraccambiano facendogli fare una comparsata alla Duma, prontamente ripresa e trasmessa dalla tv locale. Il servizio mostra Salvini che indossa una felpa bianca con la scritta «No sanzioni alla Russia» e al centro il simbolo della Lega Nord. Dietro di lui si notano D’Amico e Savoini, che mostra il pollice all’insù. Accanto ci sono Gianmatteo Ferrari ed Eliseo Bertolasi, un collaboratore di Sputnik e ricercatore dell’Istituto di Alti studi in Geopolitica e Scienze ausiliarie, o IsAG, un think tank fondato da Tiberio Graziani, personaggio storicamente legato al mondo postnazista saluzziano. Graziani è stato tra l’altro direttore responsabile della rivista «Eurasia» nel periodo in cui i suoi redattori erano solo tre: Aleksandr Dugin, Claudio Mutti e Carlo Terracciano. E l’unica collaboratrice era Alessandra Colla (la quale adesso dirige la rivista con la supervisione editoriale di Mutti). Oltre a Mosca, il leader leghista e il suo entourage si recano a rendere omaggio alla nuova Crimea russa. Ancora una volta lo apprendo dalla pagina Facebook di Salvini: Prima delegazione che va nella sede del ministero per la Crimea. Due milioni di persone che hanno deciso di scegliere al 95 per cento con un referendum di unirsi alla Russia. Le scelte dei popoli vanno rispettate sempre. […] Un’opportunità di sviluppo e collaborazione per tante imprese italiane soprattutto per il Nord e abbiamo già un appuntamento con il ministro per venire in Veneto, in Lombardia, in Piemonte per lavorare insieme. Per la gioia dei suoi fan. Salvini posta un video con alle spalle navi della flotta russa e un’appassionata dichiarazione di fede putiniana: Siamo nel porto di Sebastopoli, Repubblica della Crimea, che è parte della Federazione russa dopo regolare e libero referendum. E qua c’è una parte della flotta russa che difende i confini. E noi dedichiamo queste immagini a Renzi, ad Alfano, che invece usano le nostre navi per aiutare gli scafisti e agevolare l’invasione. Pochi giorni dopo a Milano, grazie al fido Savoini, il segretario della Lega vince il gran premio per i lusingatori putiniani: un colloquio privato con il presidente russo in occasione della sua visita a Milano per il vertice euroasiatico dell’Asia-Europe Meeting. Da allora le dichiarazioni di affetto e adesione politico-ideologica proseguono incessanti. Nel dicembre del 2014, in un’intervista al canale all-news russo Rt, Salvini dice: È molto più pericolosa, per il nostro futuro e il futuro dei nostri figli, Bruxelles che Mosca. Se dovessi scegliere tra Juncker e Putin, sceglierei Putin domani mattina. La Russia con i suoi problemi e i suoi difetti è una democrazia occidentale sviluppata con cui io voglio continuare a dialogare e costruire la pace. Il 18 gennaio 2015 insiste: L’Europa è una gabbia da cui liberarsi il prima possibile ridiscutendo tutti i trattati, tornando ad avere il controllo della moneta e, se serve, uscendone. Renzi è una pedina di quest’Europa. […] Tra Putin e Renzi chi scelgo? Preferisco Putin, tutta la vita. Due mesi dopo, nell’aula del Parlamento europeo di Strasburgo, va giù ancor più duro: Mi pagano lo stipendio per dare lavoro e futuro agli europei, non per andare a esportare la vostra sporca democrazia in giro per il mondo. E quando un collega gli chiede se crede che la Russia sia più democratica dell’Italia, risponde: Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica dell’Unione europea, così come oggi è impostata, che è una finta democrazia. Io farei a cambio e porterei Putin nella metà mal governata da presunti leader eletti che non sono eletti da nessuno, ma sono telecomandati da qualcun altro. Il 20 marzo 2015 Salvini sceglie di presenziare un convegno dal titolo Russia e Crimea, due grandi opportunità per le nostre imprese, organizzato dall’Associazione Lombardia Russia. Con lui sono Gianluca Savoini, Mario Borghezio e Roberto Jonghi Lavarini, oltre che il ministro dello Sviluppo economico della Repubblica di Crimea, Nikolaj Koryazhkin, e il viceministro della Federazione russa per lo sviluppo della Crimea, Elena Abramova. In quell’occasione, secondo una ricostruzione dell’agenzia di stampa Adnkronos, Salvini prende nuovamente posizione a favore del riconoscimento internazionale dell’annessione alla Russia della Repubblica di Crimea. Il giorno dopo, Lombardia Russia posta su Facebook il video di un’intervista concessa da Salvini alla televisione Russia24. L’intervistatrice gli chiede: «Sul palco vicino a lei si vedono costantemente bandiere russe, oltre a T-shirt sulle quali è scritto: “No alle sanzioni alla Russia!”. Come mai la Russia è improvvisamente diventata un tema fondamentale per la Lega Nord?». E Salvini risponde: Be’, è una questione innanzitutto di vicinanza culturale: la somiglianza di opinioni sulla famiglia, sul fronte dell’Europa. […] Io guardo con terrore alla prospettiva di truppe Nato al confine russo-ucraino. Mentre dall’Africa del Nord arrivano in Italia i barconi con decine di terroristi che si spacciano per rifugiati. Per me l’unione tra l’Italia e la Russia deve essere l’unione tra due paesi che identificano i problemi allo stesso modo e scelgono dei metodi simili per combatterli. Alla giornalista che gli chiede perché è andato in Crimea dice: Innanzitutto perché di mestiere faccio il giornalista, e mi piace controllare le cose che stanno sui giornali. [E poi] sono sempre stato un sostenitore dell’autodeterminazione dei popoli: la gente ha il diritto di scegliere come vivere. La collega russa insiste sul tema del giornalismo: «Ha detto che il giornalismo è la sua professione, come valuta l’informazione della stampa italiana sul conflitto ucraino?». E lui: Il 90 per cento dell’informazione italiana è controllata e pagata da coloro che sono contro la Russia. Altrettanto emblematica è l’intervista che darà successivamente, in veste di ministro dell’Interno, alla giornalista Lally Weymouth del «Washington Post»: Weymouth: «Lei ha detto che la Russia aveva il diritto di annettere la Crimea». Salvini: «C’è stato un referendum». Weymouth: «È stato un falso referendum». Salvini: «Lo dice lei. C’è stato un referendum, e il 90 per cento della gente ha votato a favore del ritorno della Crimea nella Federazione russa». Weymouth: «Che tipo di referendum può esser stato se c’erano soldati russi a presenziarlo?». Salvini: «Lo paragoni alla falsa rivoluzione in Ucraina, che è stata una pseudorivolta finanziata da potenze stranieri… proprio come le rivoluzioni della Primavera araba». La prova più convincente della dedizione alla causa putiniana, Salvini la offre in occasione di un’altra visita a Mosca, nel novembre del 2016, quando concede un’intervista ad Aleksandr Dugin, il pensatore russo preferito da Murelli e Savoini. L’intervista viene trasmessa in russo da Tsargrad Tv, la televisione di Konstantin Malofeev, l’oligarca tradizionalista vicino alla Chiesa ortodossa russa a cui è legato il presidente onorario di Lombardia Russia, Alexey Komov. Ma è poi riproposta in italiano da Katehon, sito di propaganda eurasiatica anch’esso finanziato da Malofeev: Dugin: «È possibile che l’Unione europea possa essere interamente smembrata?». Salvini: «L’Europa si sta già smontando, in quanto è una costruzione artificiale, è una gabbia, è l’antitesi della democrazia e del lavoro, e ha una moneta evidentemente sbagliata. Non è democraticamente rappresentativa, quindi i popoli si stanno riprendendo la loro sovranità». […] Dugin: «Il mio libro sulla quarta teoria politica è finalmente uscito in italiano. Penso che sia un invito a immaginare una visione che vada al di là delle vecchie idee di sinistra e destra, superate dalla modernità europea». Salvini: «Sì, sì. Anch’io ne sono assolutamente convinto». […] Dugin: «Populismo sarà un termine negativo per loro, ma è positivo per noi. Perché populismo significa stare con il popolo, essere amici del popolo». Salvini: «Io mi son fatto fare una T-shirt, che ogni tanto indosso, con la scritta “Io sono un populista”. Così almeno mi autodenuncio con orgoglio». Dugin: «È anche famosa la sua T-shirt con l’immagine di Putin». Salvini: «Sì, l’ho indossata nell’aula di Strasburgo del Parlamento europeo, fra mille polemiche. Ma con orgoglio». Dugin: «Grazie mille signor Salvini per questa intervista. Noi sappiamo che lei è grande amico del popolo russo, del nostro presidente, e questa amicizia è sicuramente reciproca». Salvini: «Nel mio piccolo è un avvicinamento che sto cercando di favorire da tre anni». Dugin: «Molte grazie anche per la sua lotta contro le sanzioni alla Russia». Salvini: «Speriamo che si sia arrivati alla fine. È una follia. Così come il mancato riconoscimento della Crimea, soggetto autodeterminatosi come parte della Federazione russa. È incredibile che gli organismi internazionali scelgano chi possa votare per l’autodeterminazione e chi non abbia questo diritto». Uno straordinario atto di genuflessione non solo al padrone del Cremlino, ma anche al filosofo dei postnazisti, amico stretto del suo fedelissimo Savoini. Contro l’Onu, la Nato e Bruxelles L’assoluta lealtà al verbo putiniano viene dimostrata anche sull’altro fronte prioritario per il Cremlino, quello siriano. Con Lilly Gruber a Otto e mezzo, arriva all’iperbole: Per quanto riguarda Putin, lo stimo e lo rispetto, perché se non fosse partito lui in Siria a combattere l’Isis forse stasera in redazione a La7 avremmo qualcuno con il burqa e qualcuno con il mitra in mano a decidere che cosa si può dire e cosa non si può dire. Il 7 aprile 2017, appena dopo l’attacco missilistico contro obiettivi siriani lanciato dall’amministrazione Trump in risposta all’uso di armi chimiche, Salvini commenta in una diretta su Facebook: Cinquantanove missili a colpire depositi siriani – di quell’Assad che a fianco di Putin ha quasi sconfitto il terrorismo islamico e i tagliagole dell’Isis. […] Non occorre uno scienziato della politica internazionale… io lo chiedo a voi: sono l’unico che ha avuto dei dubbi? Allora, Assad sta vincendo la guerra, […] e uno che sta vincendo la guerra secondo voi usa il gas per ammazzare i suoi bambini? Nel momento in cui sta vincendo la guerra? Non puzza lontano un miglio di bufala, di fake news, di montatura? Oltretutto la notizia sui gas chimici usati contro i bambini arriva da un esule siriano legato ai Fratelli musulmani. […] E si parte: Tg1, Tg2, «Repubblica», «Corriere», Radio 24: tutti dagli all’assassino, dagli al carnefice! Ma non c’è qualcosa che non torna? Come se uno che sta vincendo il derby 3 a 0 all’ottantanovesimo comincia a dare calci agli avversari, se la prende con l’arbitro e con i guardialinee. Non c’è qualcosa che non torna in questo racconto? […] A parte il fatto che bastano le immagini: se veramente ci fosse stato un attacco coi gas, possibile che i soccorritori fossero in maniche di camicia e a volto nudo o al massimo con una mascherina di plastica? Ecco, un attacco al gas non avrebbe fatto 50 ma 50.000 morti. Evidentemente, forse, i terroristi islamici l’hanno confezionata bene. E la cosa incredibile è che il 99 per cento dei giornalisti occidentali e il 100 per cento dei giornalisti italiani abbiano abboccato. Il video di Salvini è girato poche ore dopo l’attentato a Stoccolma, dove un camion guidato da un terrorista uzbeko ha travolto la folla causando la morte di cinque passanti. E il segretario del Carroccio denuncia un collegamento tra i due eventi: I missili non sono mai una buona idea. Le conseguenze dei missili degli americani le paghiamo noi, italiani ed europei. Lasciandosi andare alla foga retorica, si lancia poi in un attacco generalizzato contro tutto e tutti: L’Onu? Via dall’Onu! Smettere di finanziare l’Onu! Ente inutile! L’Onu e la Nato a cosa servono? Da chi ci difendono? Chi proteggono? Perché il contribuente italiano dovrebbe continuare a pagare queste istituzioni? Non è la prima volta che il leader del Carroccio esprime dubbi sulla Nato. In un’occasione precedente, a «il Giornale» spiega: Non sono antioccidentale, ma non credo nei blocchi. E credo che lo stesso ruolo della Nato sia da ridiscutere. In un’intervista concessa all’agenzia russa Sputnik, a Eliseo Bertolasi che gli chiede di esprimersi sull’alleanza atlantica, lui risponde: Noi non saremo più servi, perché un conto è far parte di un’alleanza tra pari, un conto è essere i servi e l’ultima ruota del carro di un’alleanza che ormai non ha senso, che evidentemente va rivista. Ma torniamo alla sfuriata sui missili americani e sull’attacco di Stoccolma. Dopo l’Onu e la Nato, Salvini se la prende anche con Bruxelles: Juncker, presidente della Commissione europea, esprime condoglianze alle vittime dell’attacco di Stoccolma??? Complice! Complice! Vigliacchi e complici! I politici che stanno governando questa Europa che sta piangendo i morti??? Vigliacchi e complici! Con il loro nulla, con il loro finanziare un’invasione fuori controllo, con la loro connivenza con le moschee che proliferano ovunque… Complici e vigliacchi… Vergognatevi! Pagati per fare gli interessi degli altri! Mi interessa dire quella che secondo me è la realtà che ci stanno nascondendo. Perché stasera vi invito a guardare i telegiornali della Rai, di Mediaset, di La7, di Sky, a sentire i giornali radio. E provate a vedere se non c’è una verità unica del potere. I cattivi tutti da una parte, i buoni dall’altra. E chi osa dissentire dal pensiero unico è populista, razzista, fascista, leghista, xenofobo, omofobo, islamofobo! Roba da matti! Roba da mattiiii! Passiamo all’altra priorità del Cremlino: il tentato omicidio dell’ex agente Sergej Skripal. Salvini comincia esprimendo il suo scetticismo in un video su Facebook: C’è qualcuno di voi che pensa veramente che le due cosiddette ex spie russe [una sarebbe la figlia di Skripal] siano state avvelenate dai russi a Londra? Suvvia, siamo seri! Nella conferenza stampa che terrà nella sede di Confindustria Russia a Mosca, il 15 ottobre 2018, aggiungerà ironico: Se commerci, lavori e importi o esporti con la Russia, sei uno dei peggiori delinquenti sulla faccia della terra… perché sicuramente il tuo contributo economico andrà ad acquistare boccette di un improbabile veleno usato da altre improbabili spie russe che vanno in giro per l’Europa ad avvelenare persone a caso, facendosi pure prendere!… Evidentemente in questa narrazione c’è qualcosa che non mi convince. Altrettanto scettico è infine sulle operazioni di hacking di cui la Russia è accusata. Sempre a Mosca, il 15 ottobre 2018 dice: Non ho mai creduto a ingerenze straniere nelle elezioni. […] Non credo a questo esercito di hacker russi in servizio continuativo h24 per influenzare i cervelli degli italiani, degli americani, dei tedeschi. Ognuno vota con la sua testa. Se c’è un voto per il cambiamento è perché chi ha governato per dieci, venti, trent’anni ha fallito. Penso che a Mosca abbiano ben altri problemi, più che preoccuparsi delle elezioni europee. Non c’è dubbio che Mosca abbia i suoi problemi. Ma ha anche un grande interesse per la politica interna degli altri paesi d’Europa. L’accordo con Mosca La miglior prova arriva il 6 marzo 2017 quando, dopo un colloquio con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, Salvini firma un accordo di collaborazione con il quale la Lega diventa il primo partito di un paese del mondo occidentale ad associarsi formalmente a quello di Putin, Russia Unita. Per il partito del nuovo zar, l’accordo è sottoscritto dal vicesegretario generale del Consiglio per le Relazioni internazionali Sergej Zhelezniak. L’articolo 1 prevede che le Parti si consulteranno e si scambieranno informazioni su temi di attualità della situazione nella Federazione russa e nella Repubblica italiana, sulle relazioni bilaterali e internazionali, sullo scambio di esperienze nella sfera della struttura del partito, del lavoro organizzato, delle politiche per i giovani, dello sviluppo economico, così come in altri campi di interesse reciproco. Quali campi di interesse non è specificato. È il primo, tangibile risultato del lavorio dei due fidi sherpa di Salvini in Russia: Gianluca Savoini e Claudio D’Amico. A rivelarlo è lo stesso Matteo Salvini, che in un’altra intervista al solito Eliseo Bertolasi sottolinea «il lavoro di collegamento fatto dal mio portavoce Gianluca Savoini e da Claudio D’Amico, già nostro parlamentare nell’Osce». Ma che il segretario del Carroccio abbia affidato a Savoini il compito di supervisionare tutta la politica estera del partito è dimostrato ancora più chiaramente da quello che succede nei primissimi giorni del 2018. Volendo definire i capisaldi di politica estera in vista delle elezioni del 4 marzo, il vicesegretario Giancarlo Giorgetti chiede aiuto a Germano Dottori, ricercatore presso il Centro militare di studi strategici e da decenni collaboratore della Lega. Il 7 gennaio 2018 lo studioso risponde con una email: «Ho riflettuto su come dovrebbe essere articolata una proposta leghista per la politica estera del nostro paese. I risultati li trovi allegati». Il contributo di Dottori viene immediatamente girato al leghista con maggior esperienza in campo di politica estera: l’onorevole Guglielmo Picchi (oggi sottosegretario agli Affari esteri) che, a sua volta, affida il compito di valutazione ed eventuale revisione del documento a un collaboratore, Daniele Scalea. Con grande prontezza, il giorno dopo, Scalea restituisce l’allegato da lui rivisto a Picchi, con un messaggio di spiegazione: Il documento di Dottori era strutturato più come linee guida a uso interno, e quindi ho dovuto tagliare alcune cose da non rendere pubbliche (tipo la critica velata a Savoini o la cosa che si può fare gli antiamericani solo se si è molto proisraeliani). Per capire meglio, ho chiesto spiegazioni allo stesso Dottori. «L’idea mia – peraltro condivisa anche da Giancarlo Giorgetti – era che una politica di grande amicizia con la Russia fosse sostenibile soltanto se inserita in una cornice in cui si ribadiva un rapporto con l’America di Trump […] e con Israele, perché se uno è allo stesso tempo prorusso e antisraeliano vuol dire che si schiera con gli antagonisti su scala globale». Favorevole a preservare invece la centralità dell’alleanza atlantica, Dottori mi spiega di aver suggerito di mantenere «un ancoraggio molto chiaro agli Stati Uniti e a Israele». Ovvio che l’«ancoraggio» al nemico storico dei postnazisti e al suo più stretto alleato mediorientale non possa piacere a Savoini. La cosa più significativa è che il vertice leghista si schieri compatto con l’ex giornalista de «la Padania», rimuovendo dal documento finale i passaggi non graditi. Ma c’è anche un altro dettaglio non insignificante: la persona scelta per spurgare le proposte di Dottori, Daniele Scalea, non solo è direttore generale dell’IsAG (Istituto di alti studi in geopolitica e scienze ausiliarie), il think tank a cui è legato Eliseo Bertolasi, ma ha un’origine cultural-ideologica postnazista. Ecco che cosa si legge in un dossier pubblicato nell’agosto del 2005 dal sito antifascista Salgalaluna: L’area di riferimento neofascista che intrattiene rapporti con gli antimperialisti di estrema sinistra è chiamata «comunitarista». Di quest’area fanno parte – fra gli altri – Carlo Terracciano, Claudio Mutti, Daniele Scalea […] e Tiberio Graziani. Le idee di fondo si rifanno a un «socialismo nazionale» o social-fascismo ispirato (come sempre) a Julius Evola. Ma centrale è l’antiamericanismo, peraltro associato all’«antisionismo» che sconfina facilmente nel razzismo antisemita e nel revisionismo negazionista. […] Il gruppo Aaargh è il più esplicitamente antisemita. Pubblica una rivista on line – «Il resto del Siclo» – che raccoglie le stesse tematiche di Progetto Eurasia, con le stesse firme (Claudio Mutti, Daniele Scalea, Maurizio Blondet ecc.), accompagnate da scritti negazionisti di Serge Thion, Carlo Mattogno ecc. Dalla homepage del sito dell’Aaargh è possibile scaricare in pdf tutta la paccottiglia negazionista sulle camere a gas e i campi di concentramento. Le tesi comunitariste non sono peraltro che un aggiornamento delle «teorie» pubblicate dagli stessi personaggi già a partire dagli anni Ottanta attraverso le riviste «Orion» e «L’uomo libero». Altro riconoscimento del ruolo di Savoini arriva alla fine della conferenza stampa che il ministro dell’Interno italiano tiene nella sede dell’agenzia Tass a Mosca nel luglio del 2018. In chiusura, la moderatrice russa, seduta accanto a Salvini, in un buon italiano dice: «Vorrei ringraziare lei: grazie mille per essere venuto, e l’aspettiamo di nuovo nell’agenzia di informazione Tass, l’aspettiamo sempre. E alla fine vorrei ringraziare Gianluca Savoini, che ha aiutato molto per questo incontro, per questa conferenza stampa». Salvini annuisce volgendo lo sguardo verso il suo silenzioso sherpa, che abbozza un sorriso. Seduto accanto a lui, si vede l’altro sherpa Claudio D’Amico. E visto che di Gianluca Savoini ho scritto molto, ritengo doveroso aggiungere un breve ritratto del secondo sherpa. Claudio D’Amico, gli Ufo e la Russia Prima sindaco di Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, poi deputato della Lega e membro della delegazione parlamentare italiana presso l’Organizzazione europea per la sicurezza e la cooperazione (Osce), quindi assessore alla Sicurezza del comune di Sesto San Giovanni e, dall’autunno 2018, «consigliere per la politica estera» del vicepremier Salvini, Claudio D’Amico è un personaggio poliedrico. Tra i suoi elettori è noto soprattutto per una cosa: la sua fissa per lo spazio. Più precisamente per gli Ufo. Sul tema c’è un articolo de «Il Giorno» con la cronaca di una sua conferenza: Tre anni fa, quando si candidò al Parlamento europeo, annunciò che avrebbe chiesto di aprire gli archivi top secret degli Stati comunitari. «Non possiamo sapere se ci sono alieni a casa nostra? Dobbiamo fare lobby! Non si può coprire la verità. Molti governi hanno informazioni che non dicono. Forse hanno paura del panico, ma ormai siamo abituati a vedere film di fantascienza e gente strana. Ogni giorno ne arrivano a migliaia di alieni coi barconi a casa nostra» dice in un video rispolverato da chi lo ha battezzato l’assessore ufologo. «Gli avvistamenti sono robe certe e serie. Anche Mario Borghezio in Europa portò questi argomenti quasi dieci anni fa. Io non ho timore a parlarne» si è difeso l’altra mattina in conferenza stampa. Quella degli Ufo non è la sua unica fissa. Ne ha anche un’altra ben più forte: quella per la Russia. A dirmelo sono stati alcuni parlamentari che erano con lui nell’Osce, organismo in cui D’Amico ha avuto modo di stringere un rapporto di amicizia con un parlamentare russo di un certo peso: Aleksej Pushkov, poi incontrato da Salvini, che all’epoca era deputato di Russia Unita e capo del comitato parlamentare per i rapporti con l’estero. Al di là dell’intesa personale, a colpire gli ex colleghi Osce è stata la sua assoluta fedeltà alla linea del Cremlino: su qualsiasi questione di interesse per la Russia, D’Amico ha sempre espresso il suo appoggio. Anche se nel più completo isolamento. «Tra i parlamentari occidentali era uno dei pochi che aveva sempre quel punto di vista» ricorda Matteo Mecacci, all’epoca deputato radicale, oggi presidente dell’International Campaign for Tibet, a Washington. «Dentro l’assemblea parlamentare dell’Osce D’Amico faceva l’ultrà filorusso.» Gli chiedo qualche esempio. «Quando fu invasa la Georgia, quando venne fuori la questione dell’Ucraina, lui si distinse tra i parlamentari occidentali. […] Quello che ricordo è che si schierava sempre e in modo costante a favore delle ragioni della Federazione russa e contro le ragioni della Nato e dell’Ue. Questo lo posso dire con certezza.» La figura di D’Amico spiccava perché, come mi spiega Mecacci, «i parlamentari occidentali filorussi erano pochi. Un gruppetto. E lui era molto scatenato… schierato a prescindere. Non è che avesse argomenti. E sinceramente mi sembrava una cosa politicamente e intellettualmente povera, oltre che sbagliata». Un quadro ancora più nitido della fedeltà di D’Amico al Cremlino viene da un altro parlamentare che è stato con lui nell’Osce, Emerenzio Barbieri, un reggiano doc, che è stato esponente della Dc, del Ccd e dell’Udc e infine del Popolo della Libertà. «Me lo ricordo bene. Una persona simpatica. Ero suo amico. Un filorusso… una cosa incredibile. Alle assemblee parlamentari interveniva sempre a favore dei russi. […] Lui era filorusso dovunque, sempre e in ogni caso.» – Non trova curioso che un leghista, quindi filoindipendentista, fosse sempre e comunque allineato a un regime ultracentralista? «Non c’è ombra di dubbio. E una volta o due, utilizzando proprio questi argomenti, gli ho chiesto: “Scusa Claudio, mi vuoi dire cosa ti spinge ad avere posizioni filorusse così marcate?”. Ma lui non mi ha mai risposto.» – E lei ha lasciato cadere la cosa? «Be’, ho chiesto una volta, due, tre. […] Ho fatto presto a far la somma: non voleva rispondermi… In Italia sostieni l’indipendenza della Padania, e poi sostieni il centralismo di Mosca? Coglievo anch’io una contraddizione tra le due cose. Però lui non mi ha risposto. Mai!» – Un’altra cosa che ha colpito un parlamentare Osce che mi ha chiesto l’anonimato è che spesso D’Amico non viaggiava con la delegazione. Lei ricorda questo? «Sono d’accordissimo. È verissimo. Neanche dormiva negli stessi alberghi nostri. […] Questa tendenza l’aveva. È vero che tendeva ad andare in alberghi diversi dal nostro.» – Per quale motivo? «È cosa che non gli ho mai chiesto. Però confermo che questa tendenza a essere sempre da solo ce l’aveva.» Con la fine della XVI Legislatura, nel marzo del 2013, D’Amico perde il posto alla Camera e conseguentemente all’assemblea parlamentare dell’Osce. Ma non la sua fede russa. Che nel marzo del 2014 gli assicura una chiamata a fare da osservatore elettorale in Crimea assieme a Savoini. Ecco come la spiega a un cronista de «Il Giorno»: Sono stato invitato dal Parlamento della Crimea come osservatore internazionale. Quando mi hanno chiamato non ho avuto dubbi: certe cose devono essere fatte, anche solo perché credi sia la cosa giusta. Troppo spesso, in queste situazioni, capita di sentire due voci in contrapposizione, invece è importante che qualcuno super partes possa davvero raccontare ciò che accade, vigilando sul fatto che il volere degli elettori sia rispettato. Occorre superare ogni preconcetto e basarsi solo sul volere del popolo, unico organo sovrano in una vera democrazia. Due giorni dopo, superando ogni preconcetto e con occhio vigile di osservatore super partes, pronuncia il suo verdetto via Twitter: Benvenuta Repubblica di Crimea! Il voto è stato corretto. Il 95 per cento dei crimeani ha detto sì alla secessione dall’Ucraina! Il 2014 è l’anno in cui Claudio D’Amico entra in contatto con il mondo dell’oligarca tradizionalista Konstantin Malofeev. Nell’ottobre del 2014 incontra Andrej Klimov, alto funzionario di Russia Unita. Ecco come il sito del partito putiniano ricostruisce l’evento: Il mercoledì 22 ottobre c’è stato un incontro di lavoro tra il vicepresidente del comitato del Consiglio della Federazione per gli affari internazionali di Russia Unita, Andrej Klimov, e il capo del dipartimento delle Relazioni internazionali della Lega Nord (Italia) Claudio D’Amico. […] A nome del suo partito, D’Amico ha espresso supporto alla posizione russa in merito alle sanzioni: «Fin dall’inizio la Lega del Nord ha assunto una ferma posizione contro le sanzioni e a favore di un miglioramento dei rapporti con la Russia» ha osservato. L’interlocutore italiano ha invitato Klimov a considerare la firma di un documento sulla cooperazione tra i partiti, tra la Lega del Nord e la Russia Unita. Il Parlamentare russo ha ringraziato l’omologo italiano per aver sostenuto la politica della Russia, e ha osservato che «il partito Russia Unita è sempre stato, e rimane, interessato a costruire partenariati con forze politiche europee che hanno posizioni costruttive». A tale riguardo è stato proposto di discutere il testo di un futuro documento [di collaborazione] e di organizzare un primo ciclo di consultazioni bilaterali. Ma Klimov non ha un ruolo di vertice solo in Russia Unita. È anche membro del Consiglio di vigilanza di Katehon, il think tank di elaborazioni strategiche di Malofeev, la cui anima intellettuale è Aleksandr Dugin. *** Miei carissimi, finalmente dopo tanti mesi di angoscia, mi sono giunte le vostre tanto desiderate notizie. Come vedete, anch’io sono viva. […] Il maresciallo, comandante della zona, mi ha sempre detto di restare tranquilla, che avrebbe pensato lui a me. E anche dopo aver lasciato la caserma è venuto la sera tardi a trovarmi e tranquillizzarmi. Ho avuto molta paura solo quando mi dissero che Ada [la figlia affetta da sclerosi multipla] sarebbe dovuta andare in campo di concentramento. Ho chiamato un dottore dicendo che Ada era impazzita e l’ho fatta ricoverare in manicomio da un’ora all’altra. Lettera di Bianca Levi, nonna di Silvana Sacerdoti, alla figlia Adriana Levi Foa e al marito Rino Foa Il Piano Premyak I cinque punti La natura di un’«operazione d’influenza» è quella di rimanere segreta. E comunque di non lasciare segni. A volte capita che se ne individui una qualche traccia. Ma è quasi impossibile trovare un documento che la descriva. Tutte le operazioni che i russi classificano come «misure attive» vengono infatti concepite in modo da poter essere negate fino all’ultimo. In questo caso però un documento c’è. Lo ha trovato il team investigativo del Dossier Center, organizzazione creata e finanziata da Michail Chodorkovskij, l’ex proprietario della società petrolifera Yukos divenuto dissidente, passato per le carceri e i campi di lavoro russi e poi andato in esilio a Londra. Il Dossier Center lo ha condiviso e ha collaborato alla sua autenticazione con un team giornalistico che oltre a me include Gabriel Gatehouse e Joe Plomin della Bbc e Alexander Sarovic del canale televisivo tedesco Zdf e del settimanale «Der Spiegel». Il documento in questione è un messaggio di posta elettronica inviato il 3 aprile 2017 da Pëtr Grigorevič Premyak, un ex funzionario governativo russo che, dopo aver rivestito importanti ruoli politici, d’intelligence e militari, è oggi assistente del deputato di Russia Unita, Viktor Shreyder. Il destinatario viene chiamato «Sergej Aleksandrovič», ed è identificabile con Sergej Aleksandrovič Sokolov, che nel sito del Cremlino viene indicato come responsabile del dipartimento di Politica estera della Presidenza della Federazione russa. A un team della Zdf, Premyak ha confermato di aver inviato la email, negando però di essere l’autore del documento allegato, un file word intitolato Attività del team di politica estera nel quale viene descritto un progetto «di promozione a medio e lungo termine degli interessi della Federazione russa nel campo della politica estera dei paesi dell’Unione europea». Il documento elenca cinque «attività»: 1. Organizzazione di conferenze o forme di protesta in paesi dell’Ue volte a screditare eventi o persone che si oppongono alla politica estera della Federazione russa. Organizzazione di manifestazioni a favore dell’abolizione delle sanzioni, a sostegno della Crimea e in generale della politica estera della Federazione russa (anche sul fronte siriano). 2. Organizzazione di visite di politici europei, personalità pubbliche e uomini d’affari nella Federazione russa. 3. Promozione, nei parlamenti nazionali e regionali dei paesi dell’Ue, di misure contrarie alle sanzioni antirusse, favorevoli al riconoscimento dell’annessione della Crimea alla Federazione russa. 4. Pubblicazione nei media dei paesi Ue, degli Stati Uniti e della Turchia di materiali che supportino gli interessi nazionali della Federazione russa. 5. Sviluppo e gestione di piattaforme di social media per la promozione dei messaggi necessari. Nella quinta pagina, il documento include una lista di partiti europei con i quali costruire una «rete informale». Per ogni singolo paese sono elencati uno o più partiti. Per la Francia c’è solo quello di Marine Le Pen. Per la Germania ce ne sono tre: l’Alternative für Deutschland (AfD), il Partito nazional democratico (Npd) e i Patrioti europei contro l’islamizzazione dell’Occidente (Pegida). Per l’Italia ce ne sono due: la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle. Il sospetto coltivato da molti – che dopo il ridimensionamento politico di Silvio Berlusconi il Cremlino abbia deciso di puntare sui due partiti che oggi costituiscono la coalizione governativa in Italia – trova dunque per la prima volta una conferma. Ufficiale. Il documento non chiarisce se i partiti elencati abbiano manifestato o meno la disponibilità a collaborare e quindi, nello specifico italiano, se Movimento 5 Stelle e Lega abbiano aderito alla «rete informale» prefigurata. Quando gliene chiedo conto, Savoini risponde: «Io di questo piano non so nulla. Ne apprendo in questo momento». I portavoce del Movimento 5 Stelle non si sono voluti neppure esprimere. È comunque interessante soffermarsi sui comportamenti e le azioni adottati dai due partiti relativamente alle questioni identificate dall’assistente parlamentare Premyak come prioritarie per la rete da formare. Per quel che riguarda il Movimento 5 Stelle, sappiamo che suoi esponenti si sono recati a Mosca, hanno chiesto la fine delle sanzioni alla Russia e la normalizzazione dei rapporti con il dittatore siriano Assad. In più è emerso che siti o blog del circuito grillino hanno diffuso fake news promosse da media russi quali Sputnik e Rt. Dall’Associazione Lombardia Russia all’accordo di collaborazione Sulla Lega di Salvini l’impegno è stato di gran lunga maggiore. E molto più strutturato. A partire dal febbraio del 2014 Savoini, allora portavoce del segretario del Carroccio e suo delegato ai rapporti con la Russia, ha concepito una creatura ad hoc alla quale far svolgere a tempo pieno attività di supporto agli interessi geostrategici e commerciali del Cremlino, l’Associazione Lombardia Russia. In seguito al lavoro di sherpa fatto dallo stesso Savoini assieme all’ex onorevole Claudio D’Amico, il 6 marzo 2017, quindi appena un mese prima che Premyak inviasse la sua email al Cremlino, Matteo Salvini ha firmato a Mosca un accordo di collaborazione politica di ampio respiro proprio con il partito di Premyak (e Putin). Faccio notare a Savoini che le priorità geostrategiche elencate dal documento inviato da Premyak sono le stesse su cui lui è da anni impegnato. «Non vuol dire che ci sia un accordo organico con loro» mi risponde. «Non so di che sta parlando.» – Sto parlando di un impegno a supporto degli interessi geostrategici russi. «Noi non lo abbiamo fatto.» – Come no? Lo fate regolarmente. Il Cremlino ha interesse che venga riconosciuta l’annessione della Crimea alla Russia, si supporti Assad in Siria, vengano abolite le sanzioni e che il maggior numero di parlamenti nazionali e consigli regionali si esprimano in quel senso. Tutte cose che fate da anni. «Non lo so… questo lo hanno fatto i consigli regionali di Veneto e di Lombardia… non è che l’abbia fatto io. O l’abbia fatto fare.» – Stiamo parlando della Lega. «Non lo so… ma non mi sembra che ci sia alcunché di male nel cercare di costruire ponti anziché abbatterli, se si cerca di evitare una nuova Guerra fredda… Io non sono mai stato al servizio di nessuno, tantomeno della Russia.» – Resta il fatto che gli interessi geostrategici elencati in quel piano sono quelli che voi sostenete da tempo. «Vabbe’… ma mica li sosteniamo solo noi. Siamo in buona compagnia in tutta Europa.» Comunque sia, sta di fatto che per quel che riguarda il Carroccio si può apporre il segno di spunta su ogni singolo punto dei cinque elencati nel documento allegato alla email di Premyak. Per la Russia i motivi per costruire quella «rete informale» sono lampanti: dal punto di vista economico-commerciale rompere l’isolamento delle sanzioni, da quello politico, costruire un polo euroasiatico in grado di controbilanciare l’influenza angloamericana. Solo patriottismo? Cosa spinga Salvini e la Lega è meno evidente. Certamente c’è la contiguità culturalideologica, risultato della contaminazione postnazista. A illustrarla in dettaglio è il principale «contaminatore», Gianluca Savoini, il 24 novembre 2018, quando viene invitato ad arringare trecento membri del partito d’estrema destra tedesco AdF ad Augustdorf, nella Renania del Nord. Parlando in italiano con un traduttore al suo fianco, il giornalista apre l’intervento portando «i saluti affettuosi del segretario del partito della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini». Dopodiché si avventura in una enarratio historiarum: La Prima guerra mondiale ha iniziato a cambiare la geopolitica continentale, a cambiare le nazioni, le società e le culture europee e i loro imperi secolari. Purtroppo fu l’inizio della fine della grande civiltà europea e del predominio europeo sullo scenario mondiale. L’impero germanico, quello russo zarista e quello ottomano si sono dissolti nel sangue e cominciò a emergere la talassocrazia americana, mentre l’impero britannico rinforzava il suo predominio su tutta l’Europa. Quel 1918 fu una vittoria anglosassone, decisiva per tutto il continente europeo, che portò a conseguenze rivoluzionarie eccezionali. Fino poi al disastro apocalittico del conflitto mondiale 1939-1945, dove […] uscì di scena l’Europa come superpotenza, sostituita da Stati Uniti e Unione Sovietica. È la lettura postnazista della storia moderna del nostro continente: alla Grande guerra hanno fatto seguito «conseguenze rivoluzionarie eccezionali», il fascismo e il nazismo, e a causa del «disastro apocalittico» del Secondo conflitto mondiale, l’Europa ha perso il suo ruolo di superpotenza. Da qui il grande rimpianto per i bei tempi antecedenti alla Grande guerra, quelli in cui gli europei e i loro colonizzatori governavano sull’84 per cento della massa terrestre e gli americani stavano ancora a casa loro. Bei tempi che Savoini non solo rimpiange, ma spera possano tornare. Continua: Oggi, dopo quasi trent’anni da quel fatidico novembre 1989, stiamo assistendo al crollo del Nuovo Ordine Mondiale post Guerra fredda. I cantori del mondialismo adesso sono terrorizzati, come sono terrorizzati anche i grandi banchieri globali, i finanzieri senza scrupoli che spostano miliardi dal mattino alla sera sulla pelle dei popoli. […] Il potere globale, il mainstream, si inventa il famigerato piano della Russia di Putin di condizionare le prossime elezioni nazionali ed europee, quando tutti ricordiamo bene chi spiava i telefonini dei primi ministri delle nazioni europee, inclusa la Merkel: non erano i russi, ma gli americani. […] Sappiamo tutti chi ha invaso l’Europa, non solo dal punto di vista militare e finanziario, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, per trasformarci in qualcosa di opposto alle nostre tradizioni e alla nostra storia, il cosiddetto American way of life. Non più tedeschi, italiani, austriaci, ungheresi, orgogliosi di essere tedeschi, italiani, austriaci e ungheresi, ma abitanti della Germania, abitanti dell’Italia, dell’Austria, dell’Ungheria e di tutti gli Stati d’Europa. Senza anima, senza tradizioni, senza radici. L’anima, le tradizioni e le radici di cui parla non sono certo quelle del sogno europeo di Altiero Spinelli. Quindi non si possono trovare nell’eurocrazia di Bruxelles, bensì nella Russia neozarista di Vladimir Putin: Basta entrare in una chiesa ortodossa russa per ritrovare il senso del sacro che per secoli è stato un patrimonio comune di tutti noi europei, prima delle rivoluzioni illuministe, individualiste, laiche e atee. Per questo possiamo dire, e lo abbiamo detto a ottobre con Salvini a Mosca, che ci sentiamo più a casa a Mosca che in certe capitali dell’Unione europea. Perché molte nostre città sono diventate cupe e minacciate da gruppi numerosissimi – e in alcuni casi maggioritari – di criminali di provenienza africana o araba che restano spesso impuniti a casa nostra. Noi sosteniamo questa posizione geopolitica non perché siamo filorussi, o perché prendiamo finanziamenti da Mosca, ma perché siamo patrioti europei. Quale movente più nobile del patriottismo. Addirittura europeo. Che l’impegno suo e della sua associazione con la Russia non abbia a che fare con il vil denaro, Savoini tiene a sottolinearlo anche a me: «Queste cose non le facciamo perché siamo pagati dai russi. Questo sia ben chiaro!». Ma ne Il libro nero della Lega, i colleghi Giovanni Tizian e Stefano Vergine scrivono di averlo sorpreso in una sala dell’hotel Metropol di Mosca mentre partecipava a un negoziato di compravendita di tre milioni di tonnellate di gasolio con interlocutori russi non meglio identificati. Secondo la loro ricostruzione, in quell’occasione si sarebbe discusso di uno sconto particolare che avrebbe permesso di generare fondi per finanziare attività elettorali della Lega. Savoini smentisce, seppur in modo confuso: «Non esiste questa roba legata alla Lega… non c’è niente. E io non ho ricevuto un rublo». Di fronte alla mia insistenza, fornisce maggiori dettagli: «La sera prima c’era stato un convegno di Confindustria-Russia aperto al pubblico… era pieno di persone… di uomini d’affari italiani e stranieri. Io conoscevo alcuni di loro – dormivano al Metropol, dove ero anch’io – e ci siamo visti la mattina dopo perché avevano interesse ad avere contatti con ambienti russi. Ma da qui a parlare di robe che hanno a che fare con la Lega…». «Avete parlato di prodotti petroliferi?» gli chiedo. «Non lo so, perché parlavano loro… io non parlavo di quelle cose.» «Non sa se si è parlato di prodotti petroliferi?» insisto. «Io non riesco a capire perché parliamo di questo. […] Di queste cose non voglio parlare più.» Ma a confermarmi la partecipazione di Savoini a svariate trattative, intese a generare commissioni o contributi per lui o per la sua associazione, è Bruno Giancotti, un italiano che vive in Russia da trentadue anni, su cui vale la pena soffermarsi. Se non altro per capire il profilo dei referenti italiani a Mosca del delegato ai rapporti con la Russia e dello stesso segretario della Lega Salvini. «Dopo esser stato comunista, Giancotti è diventato un convinto sostenitore della Lega e anche dell’Associazione Lombardia Russia» mi dice Giovanni Savino, ricercatore italiano che nel 2014-2015 ha ricostruito gli approcci tra Lega e ambienti russi. Il negoziatore Giancotti Dopo avermi annunciato di non aver «nulla da nascondere», Giancotti mi racconta di Savoini e dei loro affari comuni, spiegandomi di essere stato punto di riferimento in loco per Matteo Salvini e di averlo «sempre accompagnato quando veniva in Russia». Si occupava anche dei russi in trasferta a Milano. Come accadde in occasione della conferenza organizzata dall’Associazione Lombardia Russia, dopo che la Crimea era entrata a far parte della Federazione russa. Il riferimento è alla conferenza del 20 marzo 2015 in cui Matteo Salvini, Gianluca Savoini e Mario Borghezio hanno accolto il ministro dello Sviluppo economico della Repubblica di Crimea e il viceministro della Federazione russa per lo Sviluppo della Crimea. «Io mi occupavo dei problemi logistici, e ho fatto da interprete e da trait d’union» sottolinea orgogliosamente Giancotti, che del trio Salvini, Savoini, D’Amico dice: «Siamo nella stessa barca. Io sono amico della Russia, loro sono amici della Russia». Il mio interlocutore sottolinea che lo scenario dei finanziamenti russi alla Lega «è una grande fesseria» e che la «simpatia» che il Cremlino ha per la Lega è dovuta solo alla comunanza di valori, gli stessi valori condivisi da Giancotti. Quali? «La Russia è patriarcale e omofoba. La Russia ha valori che noi in Italia consideriamo retrogradi, sepolti da secoli addirittura. Ma a me stanno bene. Io sono contrario agli antivalori globalistici che stanno rovinando la nostra società.» Giancotti mi spiega di aver parlato spesso e a lungo con Matteo Salvini della Russia e di Putin, e ha compreso che ad affascinare il Capitano è il carisma del leader russo. «Salvini vede in Putin quello che vorrebbe essere lui. Un uomo deciso, un uomo autoritario.» «Salvini le ha esplicitato questo pensiero?» gli chiedo. «Nelle nostre chiacchierate […] Salvini ha sempre parlato di Putin come di una persona capace di svolgere il suo ruolo di statista sapendosi far amare dalla gente. […] Io addirittura gli ho esposto i problemi di questo paese. Anche per non dargli l’idea che qui vada tutto bene…» Giancotti sembra perdere il controllo del suo ragionamento (non sarà l’unica volta). «Tante cose non vanno bene in questo paese. E ho cercato di fargli capire che Putin è una grandissima persona, però con la Russia bisogna stare attenti a non sbilanciarsi con i giudizi. Perché ci sono tante cose che non sono completamente… elogiabili.» Giancotti mi dice di aver conosciuto Savoini poco dopo l’annessione della Crimea alla Russia: «È venuto a incontrare Dugin, e io conoscevo Dugin. C’era pure Claudio D’Amico. Da lì è nata una semplice conoscenza e poi abbiamo sviluppato rapporti più complessi, che hanno una valenza politica e finanziaria… ma non nel senso di finanziare la Lega!». Mi spiega prima la «valenza politica»: «Savoini fa il suo lavoro di giornalista. […] Molto spesso lo invitano in Russia, per esempio la tv satellitare Rt lo invita spesso. In Russia ci sono molte iniziative che richiedono la partecipazione di amici dall’Italia. Certe volte arriva lui, certe volte Claudio D’Amico». Secondo Giancotti, Savoini ha fatto in modo che la sua associazione godesse tra i russi di «un’ottima reputazione». E veniamo alla «valenza finanziaria». Giancotti me la spiega così: «Savoini e D’Amico hanno buoni rapporti con tutti: alla Camera, con i governatori di varie regioni – e qui i governatori sono molto potenti – […], avendo delle conoscenze che sono politiche e poi sono diventate economiche. Qua in Russia se si è amati dal potere, si hanno molte porte aperte. E avendo queste conoscenze molto probabilmente Gianluca ha pensato…». Giancotti non finisce il discorso, ma aggiunge un dettaglio: «Loro gestivano la parte italiana, quindi i rapporti con le ditte italiane. Io gestivo la parte russa». Il ritorno per Giancotti è ovviamente di natura finanziaria: mi parla di commissioni dal 5 per cento in su. Ma per Savoini o l’Associazione Lombardia Russia? Inizialmente mi dice che l’interesse è «di prestigio». Quando poi gli chiedo se – ottenuti i contratti in Russia – le aziende italiane dovessero dare un contributo all’associazione, mi dice: «Questo non lo so, ma penso di sì. Parliamo di contributi ufficiali. All’associazione, non alla Lega». Gli domando se è consapevole del fatto che Savoini e D’Amico abbiano costituito una società a Mosca, guarda caso con la stessa sede legale della ItalAgro, la società per cui lavora Giancotti con un altro italiano, Pasquale Vladimiro Natale. «Certo che sì… certo, certo. Addirittura l’ho aiutato io a costituire l’azienda» mi risponde. «Siccome io ho nel centro di Mosca un ufficio mio, gli ho “prestato” quello… Nella mia sede posso registrare fino a cinque aziende.» Ovviamente faccio una verifica anche con Savoini. Il quale afferma: «Con Claudio D’Amico abbiamo un amico in comune, che è un italiano che vive in Russia da una vita. Abbiamo voluto fare una società insieme a lui… lui già lavora nell’ambito della macellazione della carne». – A me veramente risulta che i proprietari siate solo lei e Claudio D’Amico. «Sì… ma dato che in Russia abbiamo questo nostro amico di ItalAgro…» – Parla di Bruno Giancotti? «Certo, Bruno Giancotti. Lui ci ha detto: “Fate una società qui, così se riuscite a portare qualche azienda per la macellazione di carni… se l’avete anche voi è meglio. Per questioni burocratiche”. Tutto qui.» – Questioni di burocrazia, o di commissioni da incassare? «No, no… Soltanto per avere una società russa che potesse fatturare tranquillamente. Così, nel caso ci fossero state delle collaborazioni avremmo potuto legittimamente… lavorarci.» – Quali sarebbero state le fonti di reddito della sua società? «Non lo so.» – Prima costituisce una società, poi si pone il problema di cosa farne? «Non costa niente aprire una società in Russia… sarebbe potuta essere una base.» – Di cosa? «Di una collaborazione con Giancotti.» – Giancotti fa affari in Russia, quindi lei voleva fare business? «Se possibile.» – Ma lei non fa il giornalista? «Uno può anche imparare.» – Quindi l’ha fatto per imparare? Sotto la guida di Giancotti? «Giancotti sta lì da una vita.» Inutile insistere. Ma una curiosità sulla società di Savoini è bene segnalarla. Sapete come si chiama? Orion! Il business del petrolio A questo punto chiedo a Giancotti della trattativa di compravendita di prodotti petroliferi che i colleghi Tizian e Vergine hanno intercettato nell’hotel Metropol a Mosca. Lui mi dice di non saperne nulla. Ma poi si lascia scappare che tramite l’Associazione Lombardia Italia Savoini aveva ottenuto una richiesta da un importatore di petrolio con sede a Montecarlo, il quale voleva comprare petrolio in Russia. – Un italiano? «Un italiano, che però vive a Montecarlo… aveva una società e voleva comprare del petrolio.» – Si ricorda il suo nome? «No… non è che non glielo voglio dire, non me lo ricordo.» – Questo incontro dov’è avvenuto? «A Milano.» – E chi c’era? «C’ero io e c’era Savoini, che sentiva quello che dicevo.» Chiedo lumi al giornalista. Che però smentisce tutto: «Non so di chi stia parlando Giancotti. Io non conosco nessuno a Montecarlo che voglia comprare… Non so di chi stia parlando». – Così dice Giancotti. «Se l’ha detto lui, lo chieda a lui. Io non c’ero.» – Mi ha detto che c’era anche lei. «No, io non c’ero… non so minimamente di chi sta parlando. Giancotti si confonde.» Giancotti invece mi fornisce altri dettagli: «Questa persona voleva fare un business che non era possibile… diceva: “Voi siete ben introdotti in Russia, conoscete tutti, perché non ci fate fare un prezzo di favore con uno sconto speciale?”. Io gli ho risposto: “Guardi, è vero che conosciamo, ma non è che si possono avere sconti speciali”… Se qualcuno facesse un prezzo politico, interverrebbero subito i servizi di sicurezza dello Stato [per capire] che cosa c’è dietro. Corruzione? Fuga di capitale? […] Gli ho detto che purtroppo sul petrolio noi non potevamo fare nulla». – E com’è finita? «Ho detto […] di rivolgersi altrove.» Secondo Giancotti, Savoini potrebbe non essersi arreso decidendo di rivolgersi a qualcun altro più «efficace» di lui. I colleghi Tizian e Vergine riportano che si sarebbe rivolto ad Avangard Oil & Gas, una piccola società petrolifera ai più sconosciuta ma che ha la stessa sede legale del Marshall Capital, il fondo di Konstantin Malofeev, l’oligarca collegato ad Aleksandr Dugin e ad Alexey Komov, presidente onorario dell’associazione savoiniana. Giancotti, che a Mosca sostiene di «conoscere tutti», mi dice di non aver mai sentito parlare di Avangard. Ma, sua sponte, aggiunge: «Come funziona qui il mercato del settore del petrolio e del gas? A parte il fatto che Putin ha iniziato una campagna di arresti di corruttori a livello di ministri, le posso dire che il settore più corrotto della Russia è proprio quello. E molte società statali utilizzano queste aziende affiliate per fare i loro giochi sporchi, per far transitare dei soldi, per permettere degli sconti eccessivi… cose normalissime. Questo lo sappiamo». Comunque sia andata con quella trattativa intercettata dai colleghi, Giancotti insiste nel sostenere che a beneficiare di questi eventuali affari in Russia non sarebbe stata la Lega perché, secondo lui, Salvini non avrebbe bisogno di finanziamenti russi. Ma, più avanti nella conversazione, sottolinea quanto bisognosa di fondi sia la Lega: «Io so solo una cosa: sono stato a via Bellerio, ricordo che era un inverno e stavano tutti in una stanza perché non avevano nemmeno i soldi per pagare il riscaldamento di tutto quello stabile». – Quindi i soldi servono. «Lo so, servono…» – Ma se un’azienda italiana riuscisse a chiudere un affare in Russia grazie a voi, e poi desse un contributo all’Associazione di Savoini – o alla Lega –, si sarebbe creato un circolo di finanziamento alla Lega, no? «Lo si sarebbe creato se la si ponesse come condizione. Se noi avessimo detto all’azienda russa: “Ti facciamo un contratto ma tu poi devi pagare una commissione alla Lega”. […] Ma non è una condizione prevista dai nostri accordi.» Gli spiego che lo scenario è un altro: sarebbe l’azienda italiana, dopo aver ottenuto un contratto con una controparte russa grazie a Lombardia Russia, a versare un contributo all’associazione o alla Lega. Disorientato, Giancotti risponde sostanzialmente confermando: «Se un’azienda prende un contratto milionario e guadagna… certo un po’ di riconoscenza è bene che ce l’abbia… Ma è tutto ufficiale. Non al nero. […] La legge lo consente… dov’è il problema? […] Se un’azienda italiana, nei limiti della legge, dice: “Lega, mi piaci, vedo che ser… ti voglio dare 100.000 euro”, lo può fare. Mica Salvini gli va a dire: “No, no, non ci dare soldi”. La legge consente fino a 100.000 euro». Ciò dopo aver sostenuto che gli affari da lui negoziati in Russia con Savoini e la sua associazione non avevano nulla a che vedere con finanziamenti alla Lega. E non ne parla per sentito dire: «Mi ricordo che, quando si andava alle aziende – all’epoca c’era ancora il Pd al governo – Savoini diceva: «Il Pd parla, noi invece cerchiamo di aiutare le aziende italiane». Savoini invece smentisce: «Io non ho partecipato a riunioni. Solo convegni. Le posso assicurare. […] Questa roba l’avrà portata avanti lui [Giancotti]. Io non avevo tempo». Gli affari dell’oligarca Malofeev Essendo Giancotti ben più loquace, approfitto per chiedergli se conosce Konstantin Malofeev. «Certo che lo conosco!» mi risponde con prontezza. «Siamo amici da quasi vent’anni.» – Ah, è stato lei a presentargli Savoini e D’Amico? «No. Loro sono stati presentati a Malofeev dal famoso Dugin, che lavora per la televisione di Malofeev. E che per parecchio tempo è stato il suo consulente, chiamiamolo così, “spirituale”.» Giancotti mi spiega di aver conosciuto Savoini e D’Amico dopo la creazione dell’Associazione Lombardia Russia, nel febbraio del 2014, e che i due erano già in contatto Malofeev. Gli chiedo la natura del suo rapporto con l’oligarca. «L’ho conosciuto tramite un mio amico, un altro oligarca russo che era al tempo presidente del fondo Marshall… Ho organizzato anche delle feste per loro in Toscana.» – Con Malofeev? «Sì, ho pure le fotografie… Lo conosco da moltissimi anni… ma è cambiato ultimamente.» Chiedo la natura del cambiamento. «Prima era più il tipico finanziere… di quelli un po’ cinici, interessato solo ai soldi. Poi ha avuto una specie di crisi mistica. All’inizio non ci credevo. Perché l’avevo sempre visto come uno che pensava solo ai soldi, a come guadagnare, tipico uomo d’affari. Ma ha cominciato ad avvicinarsi alla Chiesa, ed è diventato molto religioso. Addirittura ha aperto una scuola ortodossa. E fa molta beneficenza.» Sapendo che Malofeev si è arricchito grazie a operazioni finanziarie fatte attorno a una grande azienda di prodotti alimentari infantili, la Nutritek, a bruciapelo gli chiedo: «Lei risulta essere stato presidente del cda della Nutrinvest holding, la controllante di Nutritek…». Colto di sorpresa, Giancotti risponde con una certa titubanza: «No… quella è stata un’idea dell’altro mio amico oligarca… adesso lui è latitante… Era l’ex socio di Malofeev». – Come si chiama? «Georgij Sazhinov. Ha costituito Nutritek, che era la più grande azienda di latte in polvere… ed è diventato miliardario. […] Georgij si era rivolto a Malofeev per proporgli un affare, gli aveva detto: “Ho la mia azienda, sta andando bene, ti faccio vedere i bilanci, ho bisogno di iniezioni di capitale”. Ha così convinto Malofeev a investire attraverso un prestito di una grossa banca russa, la Vtb. Oltre 200 milioni di dollari. Poi è risultato che tutti i bilanci erano falsi, […] il credito l’aveva preso Marshall Capital per acquisire la società Nutritek sulla base di questi bilanci. Dopodiché i soldi sono spariti perché li ha presi il mio amico Sazhinov e si è trovato in difficoltà anche Malofeev, con un’azienda che non valeva nulla.» – Ma da documentazione trovata dal sito d’inchiesta francese Mediapart risulta che sia andata in tutt’altro modo: che Malofeev abbia convinto il colosso delle assicurazioni francese Axa a investire in Nutritek, e che sia stata Axa a rimanere con il cerino in mano. «Certo. Malofeev gestisce il fondo d’investimento. I soldi non sono suoi.» – Secondo Axa, Malofeev si sarebbe appropriato dei molti capitali investiti in Nutritek utilizzando poi quei fondi per comprare una quota della società telefonica Rostelecom. Non basta: la Vtb, la banca che ha erogato i circa 225 milioni di dollari, ha accusato Malofeev di aver ordito una truffa per ottenere quel prestito. «Chiaramente… io adesso… non è che io possa conoscere questi particolari» si giustifica Giancotti. Poi non resiste e aggiunge: «Ma questi sono tipici movimenti… purtroppo qua in Russia […] i capitali li hanno fatti tutti così». – Ma lei era presidente del cda di Nutrinvest holding! «Non c’entra Malofeev. […] Un giorno una mia amica, che era anche un’amante di Georgij, è stata assunta da Nutritek. Sa le solite assunzioni che si fanno per parcheggiare l’amante: ti metto lì, ti do uno stipendio per non fare niente. Lei si occupava dei regali di compleanno alle varie persone importanti – pensi un po’ che compito aveva! – e un giorno mi chiama e mi dice: “So che sei il mio capo. Ho letto che sei uno del consiglio della holding”. Io sono andato a guardare in internet ed era vero! Allora ho chiamato il mio amico Georgij e gli ho chiesto: “Scusa, ma che significa?”. E lui mi ha detto: “Ma no, non ti preoccupare. Tra un paio di mesi ti togliamo. Mi serviva”. […] Ho avuto anche un’indagine in Italia dalla Guardia di finanza: sospettavano che… siccome giravano parecchi soldi sul mio conto estero – io avevo un conto estero – secondo loro ero un residente estero fittizio. Ma su quel conto i soldi sono girati perché questo mio amico miliardario ha comprato quattro ville in Italia. E io gli ho fatto da cassiere.» – All’amico latitante? «All’amico latitante.» – In pratica mi sta dicendo che il suo amico Georgij l’ha fatto presidente del cda a sua insaputa? «Senza nemmeno… non c’è nemmeno una mia firma.» Tangenti a Mosca Mi pare giunto il momento di aprire un altro fronte e chiedo a Giancotti il suo ruolo in Burwell Consulting e Bracefield Builders, due società registrate nel Regno Unito. Mi risponde che anche quelle società erano «nel giro di questi giochi che facevano loro». – Loro chi? «La Nutritek, Georgij e i suoi soci.» – Lei lo sapeva di avere un ruolo in Burwell e Bracefield? «L’ho saputo dopo.» – Chi ha costituito quelle società? «Siccome c’era un amico di Georgij che si chiama Kirov… Era amico di [Pasquale Vladimiro] Natale, una sua conoscenza. Per cui hanno creato un gioco di scatole cinesi… che serviva a rubare soldi allo Stato, suppongo. Ma cosa abbiano fatto, sinceramente non lo so.» – In altre parole, quelle società sarebbero state intestate a lei come l’appartamento davanti al Colosseo di Claudio Scajola, a sua insaputa? «Assolutamente sì. Assolutamente sì. Così come Nutritek. Io non ho mai firmato nulla.» – Ma dalle carte risulta che, dopo esserne stato proprietario fino al 2005, Natale ha ceduto le quote proprio a lei. «Nooo, nooo.» – Lo dicono le carte. «Sinceramente io non so nulla di questo. Come abbiano fatto loro non so. […] Anche la Guardia di finanza mi ha fatto le stesse domande. Mi hanno detto: “Tu eri direttore lì, eri titolare là”. Io ho spiegato che assolutamente non ne sapevo nulla.» – Sta dicendo di aver scoperto di Burwell e Bracefiled dalla Guarda di finanza, e che prima non sapeva che esistessero? «Non lo sapevo.» – Dopo averle scoperte ha chiesto spiegazioni a Natale? «Sinceramente non gliele ho chieste.» Con le riserve di tolleranza alle favole ormai esaurite, decido di rivolgermi allo stesso Natale e chiedere a lui a cosa siano servite quelle società in Gran Bretagna. «Queste società sono fatte perché in Russia, per poter lavorare, bisogna pagare le commissioni» mi risponde. – Commissioni o tangenti? «Ma quali tangenti! Sono tutte commissioni… sono state fatte per aggirare il costo della dogana russa, […] per pagare meno Iva e meno dazi doganali in Russia. Questo era lo scopo di quelle società… Ma quali tangenti!» – Le società erano sue? «No, non erano mie. Erano società segnalate dai clienti.» – I clienti russi? «I clienti russi segnalavano queste società perché poi facevano delle sottofatture per non pagare i dazi doganali.» – Ma lei che c’entra con queste società? «Ah… niente! Io non c’entro niente.» – Ma nelle carte lei ne risulta proprietario! «Vabbe’… sono proprietario… certo… io ero uno dei fornitori, e quindi se volevo lavorare ero costretto a lavorare in quel modo.» – E Pavel Kirov cosa c’entrava? «Niente. Lui era un tecnico. Diceva cosa comprare e con chi lavorare. Non so che cosa le abbia riferito Giancotti, ma questa è la mia versione.» – Da carte del dipartimento di Giustizia americano di cui ho copia risulta che Bracefield e Burwell siano state usate per pagare tre milioni di dollari in tangenti a funzionari pubblici russi. «Ma non è vero niente. Dove sono i bonifici? Dove sono i riscontri?» – Risulta che quelle società avessero conti bancari in un paese baltico. «Sì, va bene… i paesi baltici non fanno parte della blacklist. E poi tutto ammesso… E dove c’è stato il passaggio di soldi? Lei dice che noi lo abbiamo usato per pagare funzionari russi?» – Non lo dico io, lo dicono le carte del dipartimento di Giustizia. Lo dice l’Fbi. E la società Hewlett Packard ha ammesso di aver pagato tangenti a funzionari russi per un contratto di fornitura di computer alla procura russa. «Sì va bene, va bene… infatti quando il signor Kirov è stato cinque anni fa negli Stati Uniti è stato chiamato dall’Fbi. Gli hanno detto che se avessero avuto bisogno sarebbero venuti a Mosca. Ma non è venuto nessuno. Da cinque anni stiamo aspettando.» – Resta il fatto che Hewlett Packard ha pagato 60 milioni di dollari di multa per aver corrotto funzionari russi. «Ma sì… non era la Russia… sta confondendosi con la Croazia.» – No, non sto confondendo nulla. Ci sono le carte. «Va bene, va bene… allora se Hewlett Packard ha pagato la multa vuol dire che ormai è in regola, giusto? Uno paga ed è in regola, giusto?» – Ma in questa indagine è emerso che le società usate da Hewlett Packard per pagare le tangenti sono le sue società. «Non è vero niente… ma di quali tangenti stiamo parlando? Sono soldi che abbiamo guadagnato. Io i soldi mica li davo ai politici. […] I soldi li abbiamo presi per me, per Kirov, per Giancotti… politici io non ne ho pagati.» – Ho notato che nel 2005 lei ha trasferito le sue azioni della Burwell a Giancotti, come mai? «Perché io ero stanco di lavorare. Ho guadagnato tanti di quei soldi e sono andato a divertirmi a Cuba, a Miami, a Santo Domingo. A spendere un po’ di soldi.» – Quindi Giancotti sapeva che cosa facevano quelle società? «Mah… io penso di no.» – Lei gli ha trasferito le sue azioni! «Sì… gli ho trasferito le azioni… e da quel momento a rispondere dell’operato è stato lui.» – Quindi il trasferimento di azioni è un’operazione di cui Giancotti è stato consapevole? «Ma certo. Mica le quote si trasferiscono così… c’è sempre un notaio. Almeno al mio paese in Calabria si usa così.» Dopo aver registrato la versione di Natale, torniamo a Giancotti. Quando gli dico che le due società britanniche risultano essere state usate per pagare tangenti, lui mi offre questa raffinata analisi di esperto di Russia quale dice di essere: «Guardi che fino a qualche anno fa – ma anche adesso, però adesso con più descrizione – non si faceva un contratto in Russia senza la mazzetta. Questo glielo dico con grande sicurezza… Una parte dei soldi torna ai russi che poi li spediscono in Costa Azzurra. È una pratica normale». Ma dopo aver minimizzato su quella pratica, Giancotti si sente in dovere di aggiungere: «Se c’è uno che manderebbe in galera queste persone sono proprio io. Io odio queste persone. […] Sono una massa di disperati, questi straricchi sono una massa di disperati». – Disperati ma anche amici suoi. Come Georgij Sazhinov e Malofeev. «Non confonda l’amicizia… io non ho mai avuto una lira da Georgij o da Malofeev. Eravamo amici di bottiglia, se vogliamo. […] L’unico vantaggio è stato che, per esempio, Georgij ogni tanto diceva: “Andiamo sette giorni a Parigi”. Andavo con lui e si mangiava ai migliori ristoranti. A Roma si andava all’Hotel de Russie, dove per una notte si spendevano 1600 euro.» Affari, soldi, voti «Anche Malofeev era così generoso con lei?» chiedo a Giancotti. «Prima di essere messo nella lista nera [delle sanzioni]. Adesso Malofeev non può andare fuori. […] Una volta mi ha chiamato e siamo andati a prendere una bottiglia di vino e due frittelle. Duemila dollari abbiamo… ha pagato. Questo è stato l’unico vantaggio. C’è stato un periodo in cui ho vissuto da straricco pur essendo una persona normale.» – Invece quali sono i vantaggi per Savoini e D’Amico? «Malofeev è vicino al potere. È uno di prima categoria. Ha un canale televisivo che si sta sviluppando sempre di più. Tramite Malofeev loro hanno conoscenze. Con la Chiesa ortodossa per esempio, e qui la Chiesa è potente. Come il Vaticano in Italia.» Certo è che da quando il Cremlino ha lanciato l’offensiva di militarizzazione dell’informazione, Malofeev è stato sempre in prima linea. A partire dalla crisi della Crimea. Nel luglio del 2014 il «Financial Times» ha scritto che si è recato nella penisola sul Mar Nero appena prima che sbarcassero gli «omini verdi». E che lì è stato impegnato nella campagna di promozione dell’annessione alla Russia. Il quotidiano inglese ha anche rivelato che il sedicente primo ministro della sedicente Repubblica popolare di Donetsk, paese che nessuno riconosce, è stato suo collaboratore, mentre il comandante delle forze separatiste dell’Ucraina orientale è un suo ex dipendente. E da allora Malofeev risulta aver allargato il suo raggio d’azione a tutto il continente, stabilendo una rete di contatti politici internazionali che a volte sono mediati da ong da lui sponsorizzate, quali il World Congress of Families (quella del convegno del marzo 2019 a Verona), a volte sono diretti, come quelli avuti con Jean-Marie Le Pen. Un ultimo dettaglio prima di chiudere il fronte del business moscovita della Lega. Ho chiesto a Pasquale Vladimiro Natale la natura dei suoi rapporti con Savoini e D’Amico e lui mi ha risposto: «Li conosco, certo. Sono bravissime persone. […] Io sono a favore della politica della Lega. Vivo in Russia, ho famiglia in Russia, quindi le sanzioni mi stanno danneggiando. Da che parte dovrei stare, se non dalla loro parte?». Quando gli chiedo dettagli, aggiunge: «Abbiamo fatto una fiera insieme in Crimea… E abbiamo lavorato insieme quando c’è stata la campagna elettorale italiana, per raccogliere voti qui in Russia». La triangolazione è completa: affari, soldi, voti. Ovviamente non posso non sottolineare che sul fronte dei finanziamenti russi all’associazione di Savoini o alla Lega ho trovato testimonianze soltanto di svariati tentativi fatti. Ma di nessuno riuscito. Qui il parallelo con ciò che è successo in America con il cosiddetto Russiagate è molto forte. Come per Trump, a mio giudizio, non occorre trovare evidenza di «collusione» per accertare l’interferenza politica. Pur senza la «collusione», il procuratore Robert Mueller ha stabilito che i servizi di intelligence russi hanno effettivamente condotto operazioni di «misure attive» per influenzare l’elettorato americano e far vincere Trump, il quale ha assunto una posizione molto più soft nei confronti della Russia sin da candidato alla presidenza. Le pagine di questo libro documentano che, sotto l’impulso di matrice postnazista, Salvini e il suo partito hanno sostenuto attivamente gli interessi geostrategici di un soggetto che ha interesse a indebolire o addirittura destabilizzare l’Unione europea. E lo hanno fatto in ognuna delle cinque «attività» elencate nel documento spedito da Pëtr Premyak: in conferenze e manifestazioni di protesta, in viaggi e missioni commerciali, in interventi parlamentari e prese di posizione sulle testate a disposizione, Sputnik e Rt da una parte e media filoleghisti dall’altra. Parliamo solo di affinità culturali o convergenze politiche? Oppure c’è stata anche collusione finanziaria? Dal punto di vista della sicurezza nazionale è secondario. Quello che conta è che Matteo Salvini e i suoi hanno operato come agenti d’influenza di una potenza straniera non alleata. *** A maggio ripresi la scuola iscrivendomi alla seconda media, classe alla quale avrei avuto diritto se avessi potuto frequentare regolarmente la scuola. Fui rimandata in latino e papà mi fece le ripetizioni. Mi buttai nello studio, ma avevo ancora paura, e a scuola, quando facevano l’appello e chiamavano «Sacerdoti», esitavo a rispondere «presente». Pian piano riprese la vita normale. Papà fu reintegrato nel posto di lavoro dopo un anno, i beni della mamma confiscati vennero restituiti. Zia Adriana rientrò dalla Svizzera con suo marito. Zia Ada, affetta da sclerosi multipla, rientrò a Cortemaggiore dal manicomio. Mia nonna, salvata dal brigadiere che l’avvisava quando c’era una retata, riprese a giocare a poker. Ma posso avere fiducia? So solo che ogni tanto affiora un rigurgito antisemita, una frase qua, una scritta lì, una parola sussurrata a mezza bocca. Dalle memorie di Silvana Sacerdoti Epilogo Sdoganare il pensiero postnazista «Bastaaaa! Oggi sentire alcune trasmissioni radio, tv, sentire e leggere alcuni siti internet… è una roba vomitevole! Abominevole! Mi riferisco all’episodio delle Marche, dove è stato ucciso quel ragazzo nigeriano.» In questa diretta Facebook, del 7 luglio 2016, Matteo Salvini fa riferimento a Emmanuel Chidi Nnamdi, giovane africano morto nella cittadina marchigiana di Fermo in seguito a una colluttazione con un ex pugile vicino ad ambienti di estrema destra. Al Capitano non va giù che quell’attacco sia stato collegato a lui: «È lo sciacallaggio di alcuni vermi di sinistra che dicono: “Di chi è la colpa di tutto questo? Della Lega! Anzi: di Salvini!”». E aggiunge: «Se qualcuno si permette di dire che io sono il mandante morale di quell’omicidio, questa la paga! E vediamo se c’è un giudice che ha voglia di fare il suo lavoro: QUERELATI! Perché un conto è la libertà di pensiero, un conto è la cazzata gratuita!». Ma quella che il futuro ministro dell’Interno chiama «cazzata gratuita» è l’ultima difesa di una società democratica, pacifica e civile. Perché se opinion maker o leader politici che seminano paura e odio non saranno percepiti come corresponsabili della violenza generata, si passerà con sempre maggior frequenza dalla colluttazione di Fermo alle sparatorie di Christchurch in Nuova Zelanda. Pochi hanno letto le 74 pagine del manifesto politico postato dal suprematista bianco Brenton Tarrant, autore della strage nelle due moschee neozelandesi. Io l’ho fatto. E dal titolo – Great Replacement, ovvero la Grande Sostituzione – in avanti, ho trovato ovunque richiami al pensiero postnazista dei protagonisti di questo libro. Le spiegazioni del suo gesto presentate nel manifesto – «creare un’atmosfera di paura che […] destabilizzi e polarizzi ulteriormente la società occidentale» – sembrano estratte da La disintegrazione del sistema, il manuale eversivo scritto da Franco Freda nel 1969. Dopo essersi definito «predominantemente etnonazionalista», il terrorista australiano sostiene di non essere antisemita, spiegando che «un ebreo che vive in Israele non è un mio nemico, purché non cerchi di sovvertire il mondo o far male alla mia gente». Dice anche di non essere un nazista, «perché i nazisti non esistono: da sessant’anni non sono più una forza politica o sociale in alcun paese del mondo». È evidente qual è la classificazione giusta: anche se non ne è consapevole, Tarrant è un postnazista. Più specificatamente appartiene alla sottospecie dei postnazisti stupidi, quelli che continuano a percorrere la «via del guerriero». Ben più pericolosi di lui sono i postnazisti intelligenti, quelli che hanno scelto la via del sacerdote e lavorano dietro le quinte per creare l’humus culturale desiderato. I Murelli, i Savoini e i Borghezio. Ma la categoria più pericolosa di tutti è una terza: quella dei cinici calcolatori che pensano di poter usare i postnazisti intelligenti senza attivare postnazisti idioti. È la categoria di Matteo Salvini. È poco importante che CasaPound sia stata prima sdoganata e poi messa in cantina. Quello che conta è che, con il contributo di Gianluca Savoini e Mario Borghezio, il Capitano ha reso presentabile il pensiero postnazista. Il seme ha attecchito Dopo essersene cinicamente servito per arrivare al potere, dopo averne incorporato e assimilato pensiero o seguaci, Salvini potrebbe anche decidere di liberarsene. Esattamente come ha fatto con CasaPound. E la decisione di non candidare Borghezio alle europee del 26 maggio 2019 potrebbe essere il primo segnale di questa possibile sterzata. Ma sarebbe anche un segnale della potenza di Salvini. E non avrebbe ripercussioni. Neppure da Borghezio, che in un’intervista data a «il Fatto Quotidiano», dopo aver avuto la notizia della mancata candidatura europea, ha dichiarato: «Io sono un soldato della Lega e rispondo: obbedisco!». Da bravo soldato, Borghezio rimane fedele al suo comandante che, parlando con me, definisce «un capo politico con la capacità di portare un cambiamento forte del paese. Forte!». Gli chiedo in che senso. «Nel senso di rispondere alle esigenze di un paese che ha bisogno di una guida forte. […] Di un uomo che dia sicurezza e protezione a un popolo che si sente abbandonato, che non ha fiducia nell’élite, che si vede sottomesso a interessi e poteri che non c’entrano nulla con l’interesse nazionale e popolare.» È la migliore illustrazione del progetto di contaminazione e infiltrazione postnazista: dopo aver delegittimato le istituzioni italiane ed europee, aver instillato ansia e istigato odio, si sta spingendo il popolo italiano verso il ripudio della democrazia liberale e il desiderio dell’uomo forte. Quanto deve esser forte quest’uomo ce lo dice ancora Borghezio: «C’è una situazione nella quale il paese ha bisogno di una guida, un capo, lo chiami come vuole… possibilmente non in tedesco». Neppure in latino. Perché dux odorerebbe troppo di ritorno al passato. E Thiriart ha insegnato che occorre riproporne l’essenza, ma con una nuova forma. Guardando avanti. L’ingegnere Alberto Sciandra non riesce quasi a credere ai suoi occhi: «Io sono ormai lontano anni luce da quelle idee, ma se guardo a Salvini dico: caspita, sta facendo ora quello a cui io e gli altri di Saluzzo aspiravamo trent’anni fa. E adesso lo trovo terribile!». Chi invece non lo trova affatto male è Maurizio Murelli che, anzi, non riesce a nascondere la propria soddisfazione per i risultati ottenuti in trent’anni di contaminazione culturale e ideologica. «Attraverso l’esperienza di “Orion” sono stati gettati tanti semi. Alcuni sono caduti sulle pietre e sono seccati lì. Altri hanno trovato terreno fertile e hanno germogliato» non esita a dirmi. E, usando un termine tragicamente rivelatorio, su Salvini aggiunge: «È stato contaminato dai valori di quelli che sono i movimenti identitari, e li ha fatti propri. Lui ha questa grossa capacità di interpretare il disagio sociale dell’italiano di oggi, che torna a cercare nel passato, o meglio nelle esperienze passate rielaborate, una sua identità che vede smarrita, dopo esser stato massacrato sul piano sociale. Le città sono devastate da questa immigrazione. Basta uscire di casa per fare i conti con la realtà di tutte le città d’Italia, una situazione devastante. Salvini è stato capace di cogliere tale elemento. Non è che sia una mente o abbia una preparazione [superiore] – non credo abbia letto Jünger, Nietszche o quant’altro – però interpreta perfettamente questo disagio. E il disagio porta a cercare di riaffermare l’identità. Sia nel piccolo che nel grande. Quindi adesso c’è anche questo orgoglio nazionale, che lui sa interpretare abbastanza bene. E più gli danno addosso per le sue posizioni di difesa dell’identità, più lui si rafforza». Non cercate il fascista in camicia nera! Su quest’ultimo punto Murelli ha sicuramente ragione. Salvini non ha solo contribuito allo sdoganamento del pensiero identitario postnazista, lo sta rendendo inattaccabile. A spiegarmi come, è la persona che, dopo aver partecipato al processo di estrapolazione di quel pensiero, ha dato il via al piano di contaminazione politica ideato da Murelli: l’ingegner Alberto Sciandra. Nel corso dell’attuazione di quel piano, lui ne ha prima compreso i rischi, poi la follia ideologica che lo sosteneva. E con uno sforzo interiore che si può definire erculeo, se non propriamente eroico, ha silenziosamente abbandonato la Lega e il contesto postnazista. Forse oggi non c’è nessuno che, come lui, può dirsi fuori dal pericolo di contaminazione, anche la più leggera. Perché è il solo a essere vaccinato. E dalla sua posizione privilegiata Sciandra lancia un avvertimento: attenzione a non fare l’errore di cercare segni di fascismo in Salvini. Perché il fascismo è cosa del passato, ed è facile per Salvini dimostrare che l’accusa è infondata. Ciò a cui occorre prestare attenzione è una realtà che ha lo stesso ceppo cultural-ideologico, ma una forma diversa. «Guardarsi da un fenomeno storico che si vuole evitare, senza capirne la capacità di mutazione, è come vaccinarsi contro l’influenza dell’anno precedente» avverte l’ingegnere. Così facendo, spiega, non solo non ci si protegge dal virus mutato, ma si acquisisce un falso senso di sicurezza. «Io penso che i sovranisti siano un pericolo per la pace. Lo Stato che hanno in mente, se mai lo creeranno, è uno Stato autoritario e antiliberale. Ma è sbagliato chiamarli fascisti, perché non metteranno mai la camicia nera. Se uno si fossilizza sul fascismo, e quindi si aspetta prima o poi di vedere un Achille Starace, sbaglia. Anzi, peggio ancora, non vede il pericolo che ha davanti.» *** «Ogni tempo ha il suo fascismo. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col terrore dell’intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l’informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l’ordine.» Citazione di Primo Levi con cui Silvana Sacerdoti chiude il libricino di memorie da lei scritto per i nipoti. E – aggiungo io – per tutti coloro che non vogliono dimenticare la Storia Ringraziamenti Questo libro non sarebbe mai potuto essere scritto senza il contributo di molte persone. Voglio quindi esprimere qui la mia gratitudine nei confronti di tutti quanti mi hanno concesso il loro tempo lasciandosi intervistare. Inclusi coloro che, leggendo questo libro, molto probabilmente si pentiranno di averlo fatto. In particolare, ringrazio l’ingegner Alberto Sciandra, che da giovane sognava di diventare un eroe di guerra e invece, raccontandomi senza timore la sua straordinaria avventura, a mio giudizio è stato un eroe di pace. E soprattutto di democrazia. Con lui mi sento in dovere di ringraziare vari colleghi giornalisti. In primis lo straordinario Leonardo Facco, ma anche Stefania Piazzo, Gigi Moncalvo, Gianluca Marchi, Matteo Mauri e Giovanni Polli, tutti ex colleghi de «la Padania». Un grazie anche al collega Saverio Ferrari e all’ex collega divenuto psicoterapeuta Alessandro Calderoni. Vengo poi alle ex professoresse del Liceo Manzoni. Un riconoscimento particolare va alla controprotagonista di questo libro, Silvana Sacerdoti, ma ringrazio anche Maria Adele Bertoli, Mariella Parravicini e don Luciano Spinelli. E con loro gli ex compagni di classe di Matteo Salvini: Maria Luisa Godino, Robert Ranieli, Enrico Roselli, Raffaele Rossetti e Francesca Tessore. Ringrazio inoltre gli ex compagni di liceo di Gianluca Savoini, il dottor Enrico Conserva e Massimo Zanelli. Tra i colleghi stranieri ringrazio Alexander Sarovic, del canale televisivo tedesco Zdf e di «Der Spiegel». Con lui anche il Dossier Center di Michail Chodorkovskij. Del mondo politico ringrazio invece il fondatore della Lega, architetto Giuseppe Leoni, l’ex leghista Flavio Tosi, il mai leghista Emanuele Fiano, gli ex consiglieri comunali milanesi Davide Atomo Tinelli e Roberto Predolin, l’ex sindaco di Milano Marco Formentini e gli ex parlamentari membri dell’Osce Emerenzio Barbieri e Matteo Mecacci. Del mondo della ricerca accademica ringrazio Giovanni Savino, autore dei primi saggi sui rapporti tra la destra radicale e la Russia, e il professor Michael Billig, che già quarant’anni fa aveva (pre)visto tutto. Sono grato inoltre agli ottimi (e sempre disponibili) bibliotecari della Biblioteca nazionale centrale di Roma. Ringrazio anche Caterina Malavenda per la sua come sempre preziosa consulenza. Un ringraziamento speciale infine a Maria Cristina Olati, che ancora una volta ha dato un contributo fondamentale nel dare forma alla mia inchiesta. www.illibraio.it Il sito di chi ama leggere Ti è piaciuto questo libro? Vuoi scoprire nuovi autori? Vieni a trovarci su IlLibraio.it, dove potrai: scoprire le novità editoriali e sfogliare le prime pagine in anteprima seguire i generi letterari che preferisci accedere a contenuti gratuiti: racconti, articoli, interviste e approfondimenti leggere la trama dei libri, conoscere i dietro le quinte dei casi editoriali, guardare i booktrailer iscriverti alla nostra newsletter settimanale unirti a migliaia di appassionati lettori sui nostri account facebook, twitter, google+ «La vita di un libro non finisce con l’ultima pagina.»