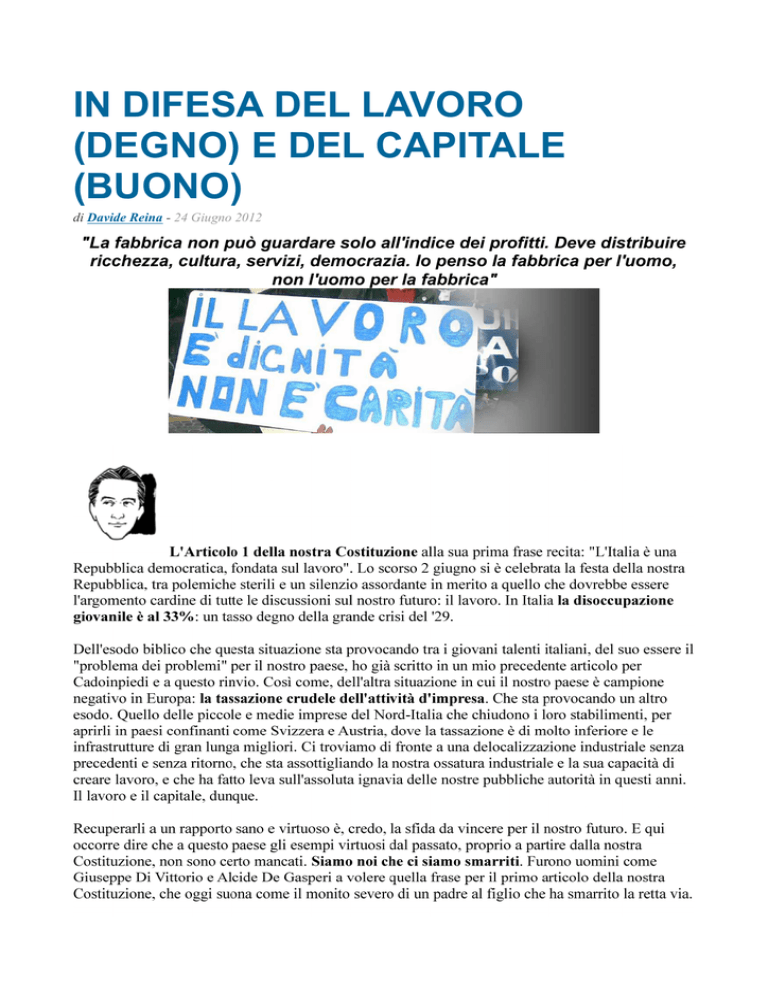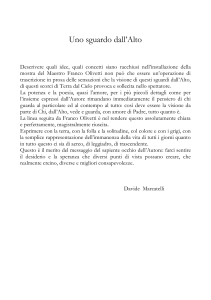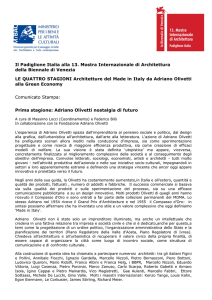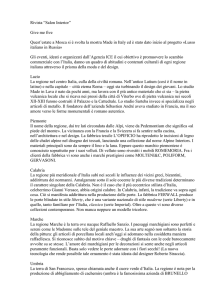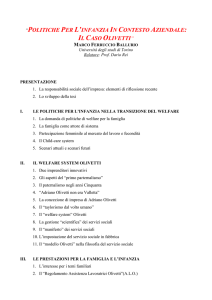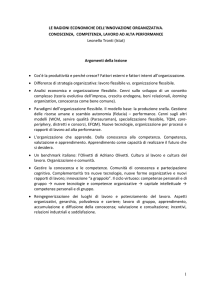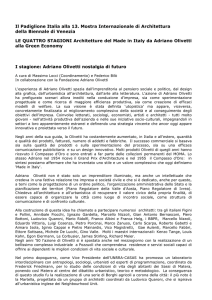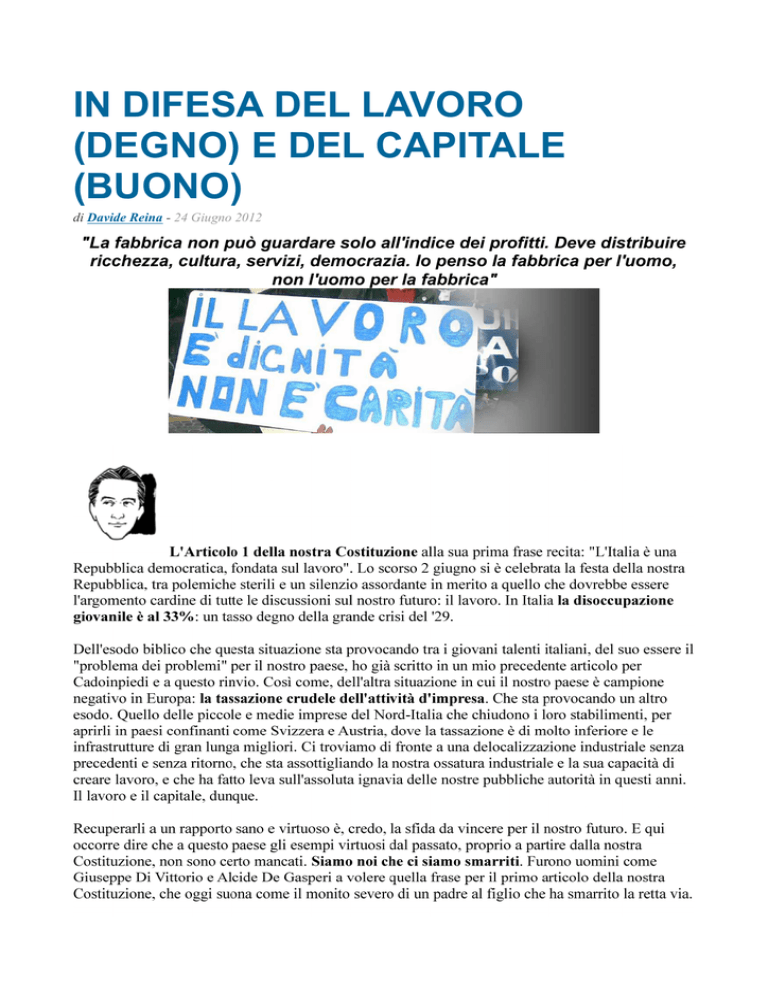
IN DIFESA DEL LAVORO
(DEGNO) E DEL CAPITALE
(BUONO)
di Davide Reina - 24 Giugno 2012
"La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire
ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo,
non l'uomo per la fabbrica"
E fu anche una parte della classe dirigente di quel tempo, politici, industriali e intellettuali, a esporsi
in prima persona per realizzare una convergenza tra lavoro e capitale che perseguisse il futuro
delle nuove generazioni invece che interessi di natura opportunistica. Nei primi anni '50, un grande
industriale come Adriano Olivetti affermava: "Nel lavoro intelligente e scrupoloso dei nostri
ottocento operai, nello studio metodico e incessante dei nostri quindici ingegneri, c'è la certezza di
progresso che ci anima. La lealtà dei nostri lavoratori è il nostro attivo più alto".
Che dire? Che è stata la grande tradizione industriale italiana, quella di Adriano Olivetti e prima
ancora del Senatore Marzotto, di Franco Tosi, di Ermenegildo Zegna o dei Crespi d'Adda, a
insegnare al mondo che costruire le case per i propri operai, istituire scuole per l'educazione dei loro
figli, non era padronale paternalismo ma lungimirante investimento sul futuro della comunità di cui
anche la propria industria faceva parte. Un investimento che diede, a quelle imprese e alle loro
comunità, stabilità, benessere, competitività sui mercati internazionali di quel tempo, grazie
all'opera di maestranze qualificate e fedeli.
E' ora che ammettiamo il fatto, in modo chiaro e netto, che se abbiamo smarrito quella visione è
perché abbiamo avuto la memoria corta e la coscienza sporca. E' ora che, in un mondo nuovo,
quella visione abbiamo il coraggio di recuperarla e rilanciarla. Citando ancora Adriano Olivetti:
"La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura,
servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica, giusto? Occorre
superare le divisioni fra capitale e lavoro, industria e agricoltura, produzione e cultura (...)". Quanto
al capitale, e alla necessità di discriminarne la tassazione in favore del profitto d'impresa e contro la
rendita, Angelo Costa (che fu grande industriale e presidente di Confindustria negli anni '50) così
affermava: "Un paese, che favorisca la rendita oltre il tempo di una generazione, è destinato al
declino". Con buona pace dei difensori a oltranza dei patrimoni e delle rendite finanziarie. Per non
parlare delle sue idee a proposito dell'importanza di una società che favorisse il merito: "(...)
Soltanto proporzionando i compensi ai meriti si può sperare in un aumento di ricchezza generale e
nell'ascesa dei più meritevoli". Oppure, a proposito di una società che non favorisse la ricchezza
ereditata: "(...) La proprietà, perché abbia un valore morale, è necessario che sia ottenuta attraverso
un sacrificio".
Un imprenditore "rosso"? No di certo. Invece, un industriale con una visione chiara delle condizioni
irrinunciabili da soddisfare per creare un'economia giusta e inclusiva: tasse che premino il
profitto d'impresa e sanzionino la rendita da patrimonio; una società che premi il merito dei più
capaci e volenterosi e punisca il demerito degli incapaci e dei lazzaroni, qualunque sia la loro
origine o estrazione sociale. Credo che oggi un Angelo Costa o un Adriano Olivetti si sarebbero
battuti per una Confindustria che proponesse al paese il sacrificio di una patrimoniale sui ricchi, per
poter chiedere in cambio una riduzione della tassazione sul reddito d'impresa e sul lavoro
dipendente.
Oggi, questo non sta avvenendo. Questa latitanza è uno dei sintomi dell'inadeguatezza della classe
dirigente italiana da un lato, il segno chiaro della mancanza di una politica industriale per il paese
dall'altro. Manca un progetto d'insieme che disegni, per il sistema industriale italiano, una traiettoria
chiara nel futuro che ci attende, nel quadro di un rapporto costruttivo e innovativo tra capitale e
lavoro. Come ogni uomo giunto alla prima maturità, anche noi come nazione dobbiamo chiederci
cosa vogliamo fare della nostra vita.
Dobbiamo decidere se vogliamo assomigliare a un paese di stampo Sud Americano con scarsa
mobilità sociale, difesa a oltranza dei patrimoni e delle rendite, mancato riconoscimento del merito
nel lavoro, oppure a un paese di stampo Nord-Europeo con elevata mobilità sociale, premio dei
redditi da innovazione e impresa, pieno riconoscimento del merito nel lavoro. Siamo a un bivio
della nostra storia e il tempo a nostra disposizione è scaduto. Si apre di fronte a noi un'epoca, io
credo, di grandi decisioni che sono prima che collettive individuali. Ciascuno di noi dovrebbe
domandarsi che italiano vuole essere. E darsi una risposta.
E' in gioco il nostro futuro, e non è una questione di denaro bensì di idee, valori e comportamenti
conseguenti. Come scrisse Ernst Junger: "Non forti mezzi, ma forti spiriti cambiano il mondo". Se
non ci chiariamo cosa vogliamo diventare come cittadini, non potremo determinare il nostro futuro
come paese. Per farlo, occorre che scegliamo di credere in un nuovo futuro. Un avvenire che nasce
prima di tutto dentro di noi. Oggi, forse di tutti gli ingredienti di cui avremmo bisogno, questo è
quello che più ci manca: il saper pensare a un futuro possibile e l'agire per realizzarlo. Anni di
abitudine al "d'altronde è così", anni di filosofia gattopardiana per cui "tutto si cambia perché nulla
cambi", ci hanno regalato un abito mentale da cinici e disincantati. Dimenticandoci che il cinismo e
il disincanto non servono a nulla.
E di certo non servono a costruire il nuovo. Siamo diventati, in questi anni, un paese che parla
usando troppi "se" e troppi condizionali. Anche la nostra lingua ha rispecchiato questo declino:
pochi ormai usano il futuro prossimo (io farò, noi faremo, ecc.). Probabilmente perché il futuro
prossimo è un tempo che porta con sé non soltanto la speranza di un domani, ma anche la promessa
e l'impegno di realizzarlo. E' ora che torniamo a usare il futuro prossimo. Ed è tempo che la
smettiamo di bollare come "utopia" quasi ogni cosa che si spinga al di là della nostra quotidianità.
Seppelliamo il cinismo e il disincanto ancora una volta con le magnifiche parole di Adriano
Olivetti: "Beh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la maniera più comoda per
liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a
quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande".
C'è un vecchio adagio che più o meno recita così: "quando non sai dove andare guarda da dove
vieni". Mi permetto di aggiungere: guarda da dove vieni, e guarda agli esempi migliori. Noi italiani
di ottimi esempi ne abbiamo avuti. In questi anni però abbiamo sviluppato una considerevole
abilità nel guardare ai cattivi esempi, finendo per prenderli come conferme che "non c'è niente da
fare". Che è l'alibi del colluso oppure, nella migliore delle ipotesi, la giustificazione del rassegnato.
Invece come cittadini dovremmo, almeno finché restiamo in questo paese, batterci perché i buoni
esempi diventino "maggioranza" nella nostra società, e recuperare quel sano disprezzo sociale di
una volta che accompagnava i farabutti e i disonesti, e che rappresentava il primo formidabile
deterrente per il delinquente, prima ancora del giudizio del tribunale.
Quanto alla Costituzione, il cui articolo 1 mi sono permesso di citare a testimonianza e difesa del
valore del lavoro, non posso mancare di rammentare come il 10 agosto 1946, alla conferenza della
pace di Parigi, fu l'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi a pronunciare un discorso
pieno di dignità e coraggio in difesa dell'Italia e delle sue possibilità di ricostruirsi come stato
libero. Quel discorso fu onorato dall'allora segretario di stato americano James Byrnes, il quale si
alzò per stringere la mano a De Gasperi al termine del suo intervento alla conferenza.
Fu in quel momento, che si determinarono le condizioni per cui la nostra Costituzione formale
potesse attecchire nella sostanza, fondandosi su di un paese indiviso e indipendente. Quel discorso,
così si concludeva: "(...) E' in questo quadro di una pace generale e stabile, Signori Delegati, che vi
chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica d'Italia: un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto
ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano". Il futuro, diceva
Abramo Lincoln, "arriva un giorno per volta". Ed è un passo alla volta, giorno dopo giorno, che
potremo risalire la china e costruire il nostro avvenire. A patto che la smettiamo di guardarci i piedi
e incominciamo a fissare la cima.