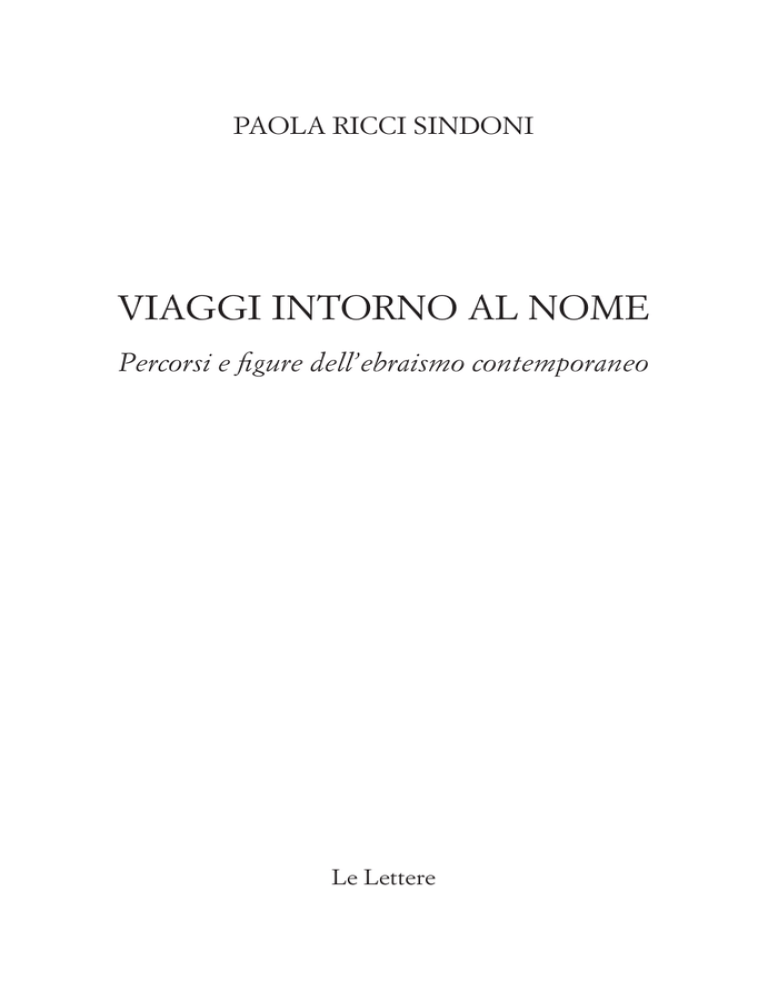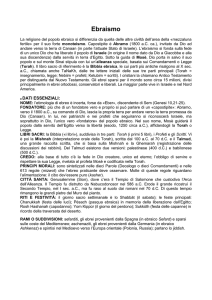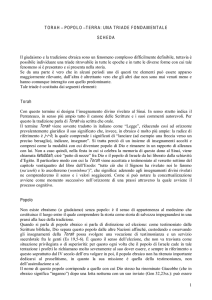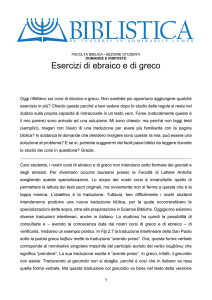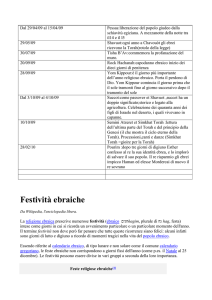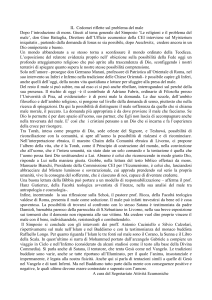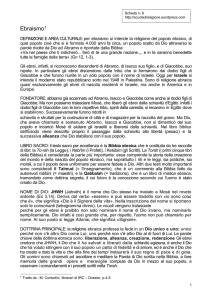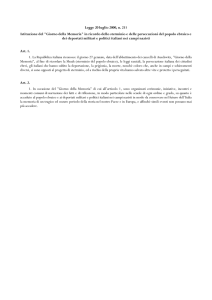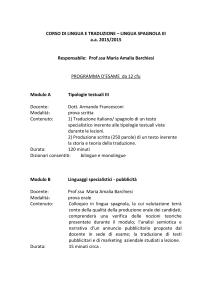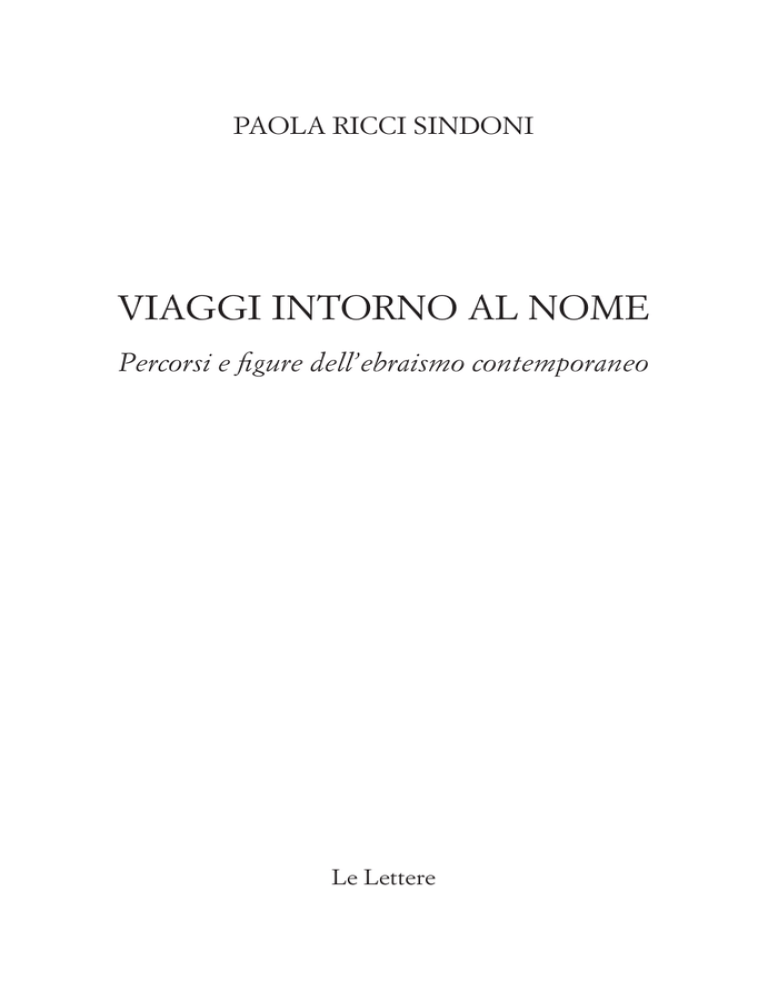
PAOLA RICCI SINDONI
Viaggi intorno al Nome
Percorsi e figure del­l’ebraismo contemporaneo
Le Lettere
Indice
Introduzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.
7
I. I percorsi
1. Torah, commento ed ermeneutica . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Per una epistemologia del pensiero ebraico. . . . . . . . .
3. Dialogo: struttura e fenomenologia . . . . . . . . . . . . . . .
4. Filosofia, ebraismo e cristianesimo. . . . . . . . . . . . . . . .
5. Due monoteismi a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Davos, Rosenzweig e Heidegger. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Il viaggio e il tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 17
» 37
» 60
» 89
»108
»118
»137
II. I protagonisti
8. Franz Rosenzweig e il ritrovamento della radice . . . .
9. Martin Buber. Per una filosofia di Sion . . . . . . . . . . . .
10. Abraham Joshua Heschel: simpatia e profezia. . . . . . .
11. Hannah Arendt. La fanciulla straniera. . . . . . . . . . . . .
12. Emil Fackenheim o “indossando due cappelli”. . . . . .
»155
»175
»204
»224
»238
2.
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO*
Alles Wort ist gesprochenes Wort
F. Rosenzweig
1. Frutto maturo dell’aspirazione del primo ellenismo all’incontro
fra le diverse culture, la traduzione in greco della Bibbia – i Septuaginta, iniziata ad Alessandria di Egitto intorno al 250 a.C. – segnò
emblematicamente l’inizio delle alterne vicende storiche e filosofiche, legate alla contrapposizione e all’incrocio di due differenti
universi creativi. Da un lato i Greci, osservatori straordinariamente
acuti delle culture altrui, ma convinti, per dirla con Platone, che
non occorre disperdere energie per imparare idiomi stranieri perché
«realmente noi elleni ci impadroniamo di quanto assimiliamo dai
barbari, e nel far ciò lo portiamo alla più compiuta perfezione»1.
Impiegando il termine hellenìzein per indicare il saper parlare, i greci erano infatti convinti di poter assimilare la saggezza straniera, per
ricondurla all’interno della propria architettura linguistica, in nome
della forte identità culturale, a lungo elaborata e custodita.
Dall’altro la tradizione storica e culturale del popolo giudaico,
le cui origini – risalenti all’incirca al 1200 a.C. – venivano a materializzarsi nella memoria di un Testo, composto e scritto tra il V e il
* Il saggio è comparso, in forma leggermente diversa, in C. Vigna, P. BettineMetafisica e violenza, Atti del convegno, Gallarate 21-23 settembre 2005, Vita
e Pensiero, Milano 2009, pp. 155-178, con il titolo Metafisica del suono e violenza
del logos.
1
Platone, Epinomide, 987E, in Opere, a cura di F. Adorno, vol. 2, Laterza,
Bari 1966.
schi,
38
paola ricci sindoni
IV secolo a.C., contraddistinto dal principio religioso della “elezione”, dalla distinzione cioè e dalla separazione da tutti gli altri popoli. Nonostante ciò, toccò a loro apprestarsi al lavoro monumentale
della traduzione della Torah, affidata ad un folto gruppo di eruditi
ebrei – settanta, secondo la leggenda – esponenti di spicco della
numerosa colonia dei giudei residenti in Egitto, attenti osservatori
delle diverse civiltà limitrofe e sensibili ai ritmi elaborati e sincopati
della lingua greca.
Spettò dunque al giudaismo ellenista presentare il millenario
tesoro della tradizione, rivestendolo di una lingua altra, offrendo
all’inquieto mondo mediorientale il frutto maturo della loro storia,
attraverso il lavoro faticoso e complicato della traduzione nella lingua dotta dei filosofi greci.
La forza d’urto scaturita dall’impatto di questi due differenti
ambiti linguistici – l’ebraico e il greco – è ancora in gran parte da
esplorare, visto che si trattò di riorganizzare concettualmente i fatti
storici e i vissuti dispersi in contesti narrativi differenti nel tempo,
integrandoli in schemi linguistici astratti, espressi nel lessico sintattico della lingua di arrivo. La lunga ed elaborata narrazione storica della Bibbia, gli eventi complessi della sua tradizione profetica
venivano in tal modo incanalati in una serie di enunciati formulati
entro una sintassi sostanziale e atemporale e, riguardando i vissuti
intercorsi nel tempo lungo dei secoli tra un innominabile Dio e il
suo popolo, bisognò strutturare lessicalmente degli enunciati nuovi,
capaci di riorganizzare il complesso mondo patico degli affetti e dei
vissuti in una fitta rete sintattica e concettuale, volta a ridirne in forma nuova l’antica essenza.
Come è già in parte stato notato2, lo scontro linguistico non era
che la spia di sostanziali differenze religiose e speculative difficilmente conciliabili: il determinismo intellettualistico greco in ambito
morale si trovava a doversi confrontare con il volontarismo giudaico, giocato sull’affermazione dell’origine divina della Legge. Da una
parte un’etica razionalistica e speculativa, dall’altra una morale volontaristica fondata sul timore di Dio. Eudemonismo greco e ete-
2
J. Sofros, Israel and Greece, in Ancient Jewish Philosophy, Akademy, Detroit
1964, pp. 142 e ss.
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
39
ronomia giudaica si trovavano così ad essere rappresentate da un
medesimo costrutto linguistico.
Il contrasto tra i due mondi non era meno grande in ambito
metafisico: quello greco fondamentalmente essenzialista, quello giudaico fondamentalmente realista; il primo legato all’ambito formale
dell’ontologia, il secondo riferito alla dimensione storica delle vicende divino-umane3. La differente visione del tempo, inoltre, produceva conseguentemente una diversa visione del mondo: essenzialmente statica quella dei greci, decisamente dinamica quella che troviamo
nel mondo giudaico. La stessa determinazione della divinità divideva i due universi religiosi: il secco monoteismo ebraico, caricato di
forti tonalità antropomorfiche trovò nel mondo spirituale greco un
punto inconciliabile di separazione.
La questione comunque riguardava, nel caso della traduzione
alessandrina come in quella analoga di Onkelos, un greco convertito4, non tanto le differenze sostanziali di entrambe le culture, quanto
la difficile operazione della lingua greca, chiamata a tradurre realtà
linguistiche e concettuali così differenti, tali da consentire un posto
d’onore all’“Uno”, accanto a quello dell’“Essere”5. Lavoro infaticabile, di continuo esposto alla profanazione, allo scontro violento
con la materialità dell’oggetto testuale, all’innaturale scissione tra
la forma linguistica e il contenuto dei vissuti, all’illogica spaccatura
tra significante e significato, alla costitutiva impotenza di ridire in
una lingua estranea il tono di un Testo, che andava in primo luogo
ascoltato e creduto.
2. Il riordinamento linguistico-concettuale della Torah, ad opera
della traduzione alessandrina, stava comunque a indicare che il nesso tra particolarismo ebraico e universalismo greco-occidentale, si
Cfr. E. Bertola, Ellenismo e Giudaismo. Contrasti e Rapporti, in Aa.Vv.,
Ebraismo, Ellenismo e Cristianesimo, vol. 1, CEDAM, Padova 1985, pp. 43-54.
4
La traduzione della Bibbia dall’aramaico, compiuta di Onkelos fu un esempio ulteriore di «una nuova esegesi capace di superare i numerosi antropomorfismi
biblici a proposito di Dio» (Ivi, p.47).
5
Cfr. A. Momigliano, Saggezza straniera. L’ellenismo e le altre culture, Einaudi, Torino 1980.
3
40
paola ricci sindoni
poggiava sul difficile snodo tra un logos per sua stessa natura fagocitante e assoluto, e una singolarità culturale e religiosa che rivendicava una propria specifica universalità.
La successiva storia del pensiero ebraico, dopo la nascita di Cristo, e che va da Filone a Derrida, appare intessuta di questa duplice
e irrisolta tensione a riproporre i paradigmi originali di una identità, segnata dal particolarismo che aspira all’universale, e, dall’altra
parte, a raccogliere dai mondi esterni, quello greco-occidentale, ma
anche quello arabo, alcune coordinate concettuali e linguistiche che
gli consentano di “tradurre” universalmente la propria visione del
mondo.
Questa prima traduzione della Sacra Scrittura non è che l’emblema di un’intensa questione teoretica, destinata a trascinarsi all’interno di ogni opera di traduzione, sempre più configurata come necessaria pratica filosofica, volta a ospitare6 la doppia compresenza di
due lingue e di due mondi umani, anche se custodisce in sé, per sua
stessa natura epistemica, la scomoda spinta profanatrice della lingua
di arrivo verso la lingua originaria, in uno scontro violento che fa
esplodere quella necessaria unità del significante con il significato7.
In questo senso la traduzione contiene in sé qualcosa di blasfemo, come anche i maestri del Talmud notavano8, perché a essere
profanati non sono solo i grandi Testi, come la Bibbia, ma anche
il logos filosofico, costretto a dipendere e a misurarsi, suo malgrado, con la materialità dell’oggetto testuale. Le alterne vicende storiche della traduzione indicavano però che lo scontro fra due mondi linguistici non era solo destinato a una lotta mortale conclusa
solo con la morte di un avversario, ma poteva compiersi nel gioco
più produttivo di una comunicazione interattiva. Nel secondo caso
6
Cfr. P. Ricoeur, La traduzione. Una sfida etica, trad. it. a cura di D. Jervolino,
Morcelliana, Brescia 2001.
7
J.R. Ladmiral, Per una filosofia della traduzione, in La traduzione: incontro
fra le culture, in «Studium», 1, 2005, pp. 69-87. Su questi temi resta ancora importante il classico: G. Steiner, After Babel, trad. it. Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Garzanti, Milano 2004.
8
Cfr. Megillath Ta’anith (Il Libro del digiuno) che si fa risalire al I sec. d.C. e
che registra la credenza dei tre giorni di tenebre totali che si abbatterono sul mondo, allorché la Torah venne tradotta in greco; cfr.: Talmud, Commentary by rabbi
A. Steinsaltz, 16 voll., Random House, New York 1991.
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
41
l’attenzione era maggiormente riposta sul significante della lingua
originale da tradurre, nel tentativo di preservarne la specifica connotazione semantica, mentre nel primo caso, ponendo l’accento sul
significato, si tentava poi di comprimerlo nella strettoia segnica della
lingua d’arrivo9.
Per tornare a Septuaginta, a quell’impresa intellettuale grandiosa
e complessa, può notarsi come il rischio dello scontro producesse
sorprendentemente anche il suo contrario, l’esigenza cioè di ridefinire ogni volta la propria fisionomia identitaria scaturita dall’incontro con altri mondi. Esplicito segnale di questa orgogliosa rivendicazione della propria particolarità è stata nei secoli l’opera ebraica del
“commento”, costituitosi nel tempo come Torah orale.
Va sottolineato al riguardo che è lo Yerusalmì o Talmud di Gerusalemme a fornire la prima formulazione dei vari significati della parola “Torah”, in riferimento non solo alla Scrittura Sacra, ma
anche all’ampia tradizione millenaria dei commenti biblici detta
Mishnah. Quando infatti vengono citati sia il versetto scritturale, sia
il commento a esso, seguito dall’espressione “parola di Torah”, si
precisa che la Mishnah gode dello status di Scrittura, pari alla Torah
scritta, quella rivelata, ossia della stessa Parola di Dio.
Come dire che questa medesima Parola rivelativa assume valore
fondativo solo in quanto alcuni uomini l’hanno udita e trasmessa
attraverso la catena delle generazioni e quella istituita attraverso il
contatto e lo studio fra maestro e discepolo. Quest’ultimi assumono,
alla luce dell’ampia espansione della parola Torah, un alto contenuto simbolico: «Chi vede morire il discepolo di un saggio è come se
avesse visto andar bruciato un rotolo della Torah» (Y. Mo’ed Qatan,
3,7). E ancora Ya’aqov bar Abbayye in nome di R. Acha: «Un anziano che abbia dimenticato il suo sapere a causa di qualche accidente
capitatogli, sia trattato con la santità dovuto a un’arca della Torah»
(Y. Mo’ed Qatan,3,1).
È questa relazione infatti che garantisce non solo la trasmissione
dell’eredità di un messaggio eterno, ma anche l’esigenza morale di
reinterpretarla sempre e di nuovo alla luce delle differenti condizio-
9
F. Marty, La traduzione alla prova dell’alterità, in La traduzione: incontro fra
le culture, cit., pp. 89-104.
42
paola ricci sindoni
ni storiche e spirituali del popolo scelto. Solo attraverso l’incessante
lavoro di rilettura e di commento del testo è possibile che il patrimonio della Scrittura sia preservata dall’usura del tempo, così da
riconsegnarlo alle generazioni future non tanto e non solo mediante
una parola scritta una volta per tutte, ma anche attraverso quel patrimonio della meditazione che lungo i secoli si è venuta a sedimentare prima oralmente e successivamente con una sua canonizzazione
scritta. La Torah è certamente “una”, ma si rivela attraverso due
forme, entrambe rivelate, quella scritta e quella orale. Né si pensi
che lo studio della Torah, così delineato, implicasse solo un lavoro
intellettuale e l’accumulo di nozioni, se è vero che il rimando alle
relazioni umane e alla durezza della storia venivano garantite dal
contatto quotidiano vitale tra maestro e discepolo.
Anche la Torah orale, in tale prospettiva, diventava fonte e garanzia di salvezza: da un lato contribuiva, insieme a quella scritta, a
formare il nucleo di una teoria della storia di Israele, e da un altro
si configurava come una vera e propria teleologia, una promessa di
benedizione e di salvezza per il tempo avvenire. Alla luce di questo
suo denso carattere simbolico e alla sua trasformazione, che da voce
diventava testo, occorre definirne ancora i caratteri e le inevitabili
implicazioni teoriche.
L’elemento significativo che va subito notato, è che il rifluire di
questa memoria orale nella scrittura non fu semplicemente legato
a una mera trascrizione del detto, ma, traducendosi nella forma
linguistica propria dello scritto, trascinò in sé quella mobilità e
quei caratteri dinamici e aperti propri dell’oralità, che finì per conservare ancora una intenzionalità specifica, capace di produrre un
vero e proprio orizzonte di comprensione, come in seguito vedremo. Torah scritta e Torah orale non sono, insomma, due differenti
versioni del Testo, ma due mondi autonomi, seppure dipendenti,
come se la rivelazione originaria, quella di Mosè, pur avendo incluso al proprio interno il commento, configurando la “tradizione”
come “traduzione” della rivelazione, si distendesse in un intreccio
di voci differenti, mai assimilabili l’una all’altra; due modi di dire
la rivelazione, una uscita dalla bocca di Dio, l’altra espressa dalla
voce di una ininterrotta catena, perché qui si costituisce, per dirla
con G. Scholem, «la traduzione nell’umano e nel comprensibile
dell’ineffabile parola di Dio, e come trasmissione della “voce”
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
43
che dal Sinai si fa ancora intendere con una ricchezza infinita di
suoni»10.
Il “suono” della Torah, la sua oralità, sembrava, in tal senso, custodire uno speciale paradigma interpretativo, indissolubilmente legato alla pratica del commento, là dove il nesso unitario di lettera e
significato le assegnava una sorta di “translitteralità”, quale modalità
originaria del darsi della parola stessa. La lettera, in altri termini, non
si configura mai come una realtà statica, un “sepolcro”11 del significato, ma, facendo tutt’uno con esso, si consegnava al lettore come forza
dinamica, pronta a sprigionare la sua plurivocità di segni.
È la Kabbalah a indicare, con l’immagine della noce, la forza
implosiva della lettera che già contiene in sé il suo segreto mistico: il
guscio della noce contiene il frutto, come la lettera contiene e custodisce il significato12. La lettera, in altri termini, raccoglie il senso che
già ha in sé e che non può essere altrimenti rinvenuto dall’esterno
con pratiche ermeneutiche, quali la logica razionale o l’allegoria. Il
suo denso frutto è in lei riposto, nascosto ma sempre disponibile,
secondo quanto richiedano il bisogno e il livello delle esigenze di chi
legge; come la tenda di Abramo che è sempre aperta lateralmente su
tutti i quattro punti cardinali, così che ciascuno possa entrarvi e trovare non un punto di passaggio, ma un luogo dove essere ospitato,
come recita un midrash13.
Se, dunque, la tradizione continuava nel tempo ad alimentare
con la Torah orale pratiche di riappropriazione originale del “pensiero-commento” del testo fondante, che comunque rimaneva sostanzialmente inclusivo, “siepe”, appunto, attorno alla Torah scritta, è dall’incontro con il pensiero greco che prese avvio la filosofia
ebraica, fortemente condizionata dalle categorie speculative grecooccidentali, e che ora vale la pena vedere in alcuni momenti della
sua evoluzione storico-concettuale.
G. Scholem, I concetti fondamentali dell’ebraismo, cit., p. 82.
Su questo tema si è a lungo soffermato S. Trigano, La demeure oublieè.
Genèse religieuse du politique, trad. it. Alle radici della modernità. Genesi religiosa
del politico, ECIG, Genova 1999, pp. 16-31.
12
G. Scholem, La Kabbalah e il suo simbolismo, cit., pp. 71-76.
13
L’immagine è di Bachya ben Asher. Cfr. Haggadah, a cura di M.H. Kook,
Shocken Book, New York 1970, p. 52.
10
11
44
paola ricci sindoni
3. La storia culturale e filosofica seguita alla traduzione di Alessandria sembrava infatti procedere per altre vie; il Testo, non più accreditato dalla sua riserva di verità, cercava una sorta di legittimazione
esterna, trovando nella struttura logico-razionale del pensiero greco
una forma capace di decretarne una nuova universalità. Resta da vedere se e fino a che punto l’accoglimento di un differente paradigma
avrebbe decretato un esito teorico completamente estraneo alla sua
natura, come, ad esempio, sostiene Trigano: «la tenda non accoglie
più; le sue porte si chiudono mentre sopra di lei si costruisce una
fortezza che la incastona come un fossile»14.
Sembra essere questo il guadagno di Filone d’Alessandria, volto
a ellenizzare il giudaismo, per rinvenire una sintesi convincente tra
filosofia greca e rivelazione biblica, nella certezza che solo il pensiero speculativo potesse offrire al mondo giudaico quelle categorie
teoriche capaci di dar ragione, e dunque una speciale universalità,
alla propria dottrina rivelativa. La traduzione dei Settanta costituiva, a suo avviso, la prova evidente che le leggi contenute nella Torah
potevano essere ordinate in modo sistematico, così da elaborare un
codice normativo universale15.
Mosè diventava il più grande filosofo dell’umanità, autentico e
unico trasmettitore della legge divina universale, su cui deve reggersi ogni società, al pari del logos stoico che regge in ugual modo la
vita dell’universo e quella delle vicende umane. Per Filone, la filosofia greca, quale scienza razionale delle cause ultime e come sapere integrale e autentico delle cose, non diventava un procedimento
propedeutico per accedere alle verità rivelate, ma la modalità specifica per penetrare la rivelazione biblica, una vera e propria «filosofia
dei nostri padri» (he patrios philosophia)16.
Non si trattava per lui – occorre ripeterlo – di sovrapporre una
comprensione filosofica sul Testo, quanto di smembrare il Testo stesso, ponendo in luce lo hiatus tra lettera e significato e la necessità
di una successiva opera di riunificazione tramite l’allegoria, quel tipo
speciale di spiegazione razionale che fosse universalmente compren S. Trigano, Alle radici della modernità, cit., p. 53
Filone, De congressu quaerendae eruditionis causa, n. 79, in Ouvres de Philon
d’Alexandrie, Cerf, Paris 1963.
16
Ivi, n. 139.
14
15
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
45
sibile. La teoria platonica delle idee diventava per Filone lo strumento
eccellente per illustrare lo “spirito” della lettera, quel senso nascosto
non più visibile e per questo destinato alla progressiva cancellazione.
Fedele al dualismo platonico, Filone ritenne essenziale distinguere tra uomo ideale e uomo reale, che vide indicato nei due racconti della Creazione presenti in Genesi. Commentando la seconda
narrazione (Gn 2,7), scriveva: «Mosè dice ancora: “Dio plasmò l’uomo prendendo dal fango la terra, e soffiò sul suo viso un soffio di
vita”. Ciò mostra nel modo più chiaro che c’è una differenza enorme
tra l’uomo così plasmato e quello precedentemente generato ad immagine di Dio (Gn 1,27). L’uomo così plasmato, infatti, è sensibile, partecipa delle qualità, è composto di anima e corpo, è uomo o
donna, è di natura mortale; l’altro al contrario, fatto a immagine di
Dio, è un’idea o un genere o un sigillo, intelligibile, incorporeo, né
maschio, né femmina, di natura incorruttibile»17.
Era comunque di fronte alla questione relativa alle immagini di
Dio che Filone utilizzava pienamente la sua ingegneria semantica, in
grado di neutralizzare le apparizioni antropomorfiche dell’Uno presenti in grande misura nella Torah. JHWH diventava, all’interno di
questo scenario teorico, il logos, l’Essere supremo, l’agente divino
della creazione, il punto di separazione e di legame tra Dio e la sua
creatura, essendo il primo «il luogo incorporale delle idee incorporali
[…] il non generato che ha niente in comune con gli esseri creati»18.
Veniva così a consumarsi rapidamente la concezione giudaica
di JHWH immanente e trascendente, dentro la storia tramite il suo
Testo, capace di custodirne la presenza; il logos filoniano, intermediario e testimone della separazione tra ideale e reale, diventava il
primo inequivocabile segnale dell’avvenuta scissione tra lettera e
spirito, tra significante e significato, svuotando in tal modo le parole
bibliche al fine di coprirle con la densità dell’allegoria razionale e
unificare, in un medesimo universo, religione di Israele, cultura greca e cittadinanza romana19.
Filone, De opificio mundi, nn. 134-135, in Ouvres, cit.
Filone, De specialibus legibus, n. 33, in Ouvres, cit. Cfr. anche H.A. Wolfson,
Philo, Cambridge, Mass 1968.
19
J. Reville, La doctrine du logos dans le quatrieme èvangile et dans le ouvres
de Philon, Cerf, Paris 1981, p. 75.
17
18
46
paola ricci sindoni
Su questa scia, altri passi verranno compiuti: basti pensare all’aristotelismo medievale di Maimonide, sottile sezionatore delle parole del Libro, al cui interno ritrovare una particolare razionalità, così
da determinare una dialettica tra spirituale e letterale. Convinto,
come Filone, che non esiste contraddizione tra riflessione razionale
e verità svelata dalla fede, Maimonide ricercava l’unità originaria dei
significati prodotti dalle due fonti della conoscenza umana, quella
profetica e rivelativa, da un lato, e quella logico-scientifica dall’altro.
Disposto a fornire un percorso di formazione ai saggi giudei – da qui la celeberrima Guida ai perplessi20 – il filosofo medievale accoglieva l’orizzonte cognitivo di Aristotele, insistendo sulle
virtù dianoetiche del pensiero: il suo insegnamento infatti intendeva
prendersi cura dello svolgimento corretto dei contenuti intellettuali
solo in quanto essi erano a un tempo la manifestazione della totalità
etica che avvolge la vita del saggio e della totalità religiosa che fonda
la saggezza e il primato dell’amore intellettuale per Dio21.
Ancora una volta il punto qualificante finiva per essere – come
per Filone ma attraverso un differente percorso – la modalità di
rapportarsi a Dio, una volta accettata l’impossibilità teorica dell’antropomorfismo e il conseguente rifiuto del “corpo” della lettera.
Occorreva, cioè, svuotare il Testo del suo significato, facendo irrompere un altro significato, capace di sanare la contraddizione tra paradigma teorico e realtà, tra norma e testo, tra concetto e parola. Da
qui la necessità di elaborare un vocabolario filosofico che permettesse di “tradurre” la Scrittura in un linguaggio corretto, indirizzandosi
verso colui «che è imbarazzato dal significato esteriore [letterale]
della Legge»22.
Anche le qualità sensibili applicate linguisticamente alla divinità
necessitavano di una depurazione semantica, che solo una elaborata teoria dell’allegoria era in grado di garantire, quasi ponendosi
M. Maimonide, Führer der Unschlüssigen, trad. it. La Guida dei perplessi,
Utet, Torino 2003.
21
Al riguardo cfr. H. Simon, M. Simon, Geschischte der jüdischen Philosophia,
C.H. Beck, München 1984, pp. 133-205.
22
J. Teicher, Observations critique sur l’interpretation traditionelle de la doctrine
des attributs chez Maimonide, in «Revue de l’études juives», XCIX, 1995, pp. 321328.
20
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
47
come un velo tra significante e significato. L’unità di lettera e spirito
veniva di nuovo infranta, in nome di una dialettica tra «l’interno
delle parole della Torah» (paragonato da Maimonide a una perla) e
il significato esteriore che non è nulla, se non strumento per cogliere
la ricchezza di ciò che sta dentro. Il corpo del Testo, identificato con
il senso letterale, veniva così screditato in nome della speculazione intellettuale, il cui compito finiva per essere, malgrado le buone
intenzioni di Maimonide, quella di operare uno sdoppiamento del
testo della Torah, uno spirituale, l’altro letterale; l’uno “interpretato” secondo lo schema filosofico, l’altro lasciato alla lettura semplice
degli ignoranti.
Svuotata del suo elemento profetico, la parola biblica, separata
dalla sua verità, veniva a fondarsi sull’autorità e sull’interpretazione;
la dimensione razionale del testo, incapace di dar conto di tutte le
esplicitazioni semantiche della lettera, affidava alla riflessione successiva quel notevole “scarto” presente nel Testo, che si rifiutava di
essere cancellato dentro l’universalità greca23.
Spetterà comunque a Mendelssohn inaugurare la stagione della
modernità, rafforzando il legame razionale tra l’universale grecooccidentale e il particolare ebraico, specie attraverso l’impresa emblematica della traduzione in tedesco dei Salmi e poi dell’intero Pentateuco. Concepita come un’opera pedagogica, rivolta al miglioramento degli ebrei-tedeschi in pieno clima dell’Illuminismo24, questa
traduzione mirava a “tedeschizzare” la lingua ebraica, utilizzando
tutta la gamma semantica del tedesco, dalla prosa alla poesia, dalle
sintassi più semplici a quelle più costruite. La traduzione, inoltre,
era sostenuta da una vasta opera di “commento”, così che il lavoro mendelsshoniano si definì: Commentario (Biur), in seguito scelto
come testo liturgico-sinagogale e intitolato significatamene Libro dei
cammini di pace25.
Pace, perché secondo le intenzioni di questa traduzione-commento, si dimostrava come non ci dovesse essere opposizione fra
S. Trigano, Alle radici della modernità, cit., pp. 117 e ss.
D. Sorkin, Moses Mendelssohn and the religious Enligthtenment, trad. it.
Moses Mendelssohn. Il Maestro dell’Illuminismo, ECIG, Genova 2000, pp. 121-125.
25
M. Mendelssohn, Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe, vol. 14, Frommann V., Stuttgart 1972, p. 267.
23
24
48
paola ricci sindoni
l’essere un pio ebreo e un brillante nuovo Platone tedesco (come
fu definito Mendelsshon)26, e il legame fra tradizione e modernità
si giocasse nella necessaria conciliazione tra particolare e universale. Veniva così riformulato il rapporto tra l’essere ebreo e l’essere
universale, secondo l’ormai consolidato postulato della validità del
paradigma «universale = greco e occidentale».
Entrava qui in gioco la questione della verità, visto che Mendelsshon, volendo difendere la speciale particolarità dell’ebraismo, si trovava a dover collocare la Torah all’interno della ragione universale.
Ricorse a tal fine all’idea della gerarchizzazione della verità, così da
accordare la Torah alle verità eterne e universali, da un lato, e dall’altro alla speciale singolarità di Israele. Tramite la distinzione tra verità
eterna e verità storica, l’ebraismo veniva a essere garantito come religione, solo se inserito dentro le trame della religione naturale.
È questo lo scenario teorico su cui Mendelssohn costruiva la sua
Gerusalemme ovvero sul potere religioso e il giudaismo27, dove la religione dei Padri, basata sulla legge rivelata e non su di una dottrina rivelata, veniva caratterizzata nella sua trama ritualistico-cerimoniale,
al fine di garantire la libertà di pensiero e la sua sostanziale parentela
con la religione naturale. Come dire che, spogliata della sua densità
rivelativa, la Torah era come consegnata a una verifica razionale che
le proveniva dall’esterno, perché «il tempio della ragione non ha
bisogno di porte chiuse. Non ha niente da conservare all’interno e
non deve vietare l’ingresso a chiunque provenga da fuori»28.
Basti come esempio la traduzione del termine ebraico “JHWH”
con quello tedesco “Der Ewige” (l’Eterno), su cui si concentrerà
due secoli dopo l’attenzione ermeneutica di Rosenzweig29, che non
mancò di sottolinearne l’ascendenza cristiano-europea30 e il tono
astratto, formale, squisitamente filosofico di questo termine, che
avrebbe avuto nei secoli conseguenze nefaste per tutto l’ebraismo.
M. Ruben Hayoun, Moses Mendelssohn, PUF, Paris 1997, pp. 23-54.
M. Mendelssohn, Jerusalem, trad. it. Jerusalem ovvero sul potere religioso e
il Giudaismo, a cura di A. Auletta, Guida, Napoli 1990.
28
Ivi, pp. 98-99
29
Cfr. F. Rosenzweig, Der “Ewige”, in Die Schrift: Aufsätze Übertragungen und
Briefe, trad. it. La Scrittura. Saggi dal 1914 al 1929, Città Nuova, Roma 1991, pp. 98114.
30
Ivi, p. 99.
26
27
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
49
Per Mendelsshon, esponente di spicco dell’Haskalah (l’Illuminismo
ebraico), il Dio invocato nella preghiera, autore assoluto delle verità
normativa, si trasformava in concetto filosofico, nell’“Essere eterno”, tramite uno svuotamento di senso di una innominabile Parola
piena di senso31.
Partendo da Filone – notava ancora Rosenzweig – che aveva desunto dai Septuaginta la traduzione di Jhwh come “L’Essente”,
fino al termine “l’Eterno” dell’Illuminismo tedesco, il nome proprio
di Dio rappresentava la cifra indicativa di un avvenuto scollamento
nel Testo tra lettera e spirito, tra quella connessione fra Nome e rivelazione del Nome, su cui si sono consumati nel tempo il tradimento
e l’abbandono del corpo pieno della lettera.
Se l’impianto del pensiero ebraico veniva a configurarsi in questa
progressiva riduzione delle sue categorie dentro il referente normativo del sapere greco, può capirsi come una parte della filosofia giudaica si veda anche oggi relegata nella sua struggente separatezza come
uno degli «ornamenti della civiltà occidentale»32, oggetto di pura
erudizione, figura letteraria, dimensione dello spirito, espressione
religiosa in grado di presentare un’esoterica intelligenza del mondo.
Su questa linea può collocarsi anche la lettura critica di Derrida nei confronti delle pagine di Totalità e Infinito, contestando
a Lévinas l’inutile presa di congedo da una filosofia totalizzante e
la successiva intenzione di “dire” altrimenti l’Essere, che rimane al
contrario ingabbiato nelle secche linguistiche della costruzione ontologica33.
Condannato ormai alla completa «reductio ad occidentalia», scosso da procedimenti di esclusione interni ed esterni, il pensiero ebraico sembra assistere impotente al declino del suo Testo fondante, di
quel Libro diventato Scrittura, incapace a garantire un differente
orizzonte cognitivo ispirato a una diversa intelligibilità del mondo e
della sua storia. Da qualsiasi prospettiva lo si voglia cogliere, esso si
offre allo studioso non ebreo in tutta la sua irritante estraneità, sia
quando si erige orgoglioso sopra le macerie del sapere occidentale,
Ivi, p. 103.
S. Trigano, Alle radici della modernità, cit., pp. 20 e ss.
33
J. Derrida, L’Écriture et la difference, trad. it. La scrittura e la differenza,
Einaudi, Torino 1971, pp. 99-198.
31
32
50
paola ricci sindoni
ormai roso dall’interno dalle sue stesse contraddizioni, sia quando
è pronto a servirsi dell’apologetica per rivendicare il tono differente
del suo esclusivo particolarismo.
La critica a questo atteggiamento diffuso è venuto proprio
dall’ebreo sui generis Derrida, il quale non manca di stigmatizzare
«la risorsa scaltra dell’esemplarismo», che pretende di identificare
«in quello che viene chiamato l’Ebreo, la figura esemplare di una
struttura del vivente umano, che consiste […] nell’essere stati scelti
come i guardiani di una verità, di una legge, di una essenza, di una
responsabilità universale»34.
Il pensiero filosofico – il pensiero tout-court, senza altra specificazione, quello che rintraccia il suo oggetto epistemologico, nutrendosi della linfa trascendentale che lo nutre dell’“originario” – questo pensiero si nutre e cresce con il sostegno di quanti, ebrei o greci,
hanno a cuore il percorso e l’esito del cammino umano nella storia, e
per questo fa appello alla memoria delle singole culture, depositarie
di differenti identità, che hanno concorso e concorrono ancora oggi
alla solida formazione della «philosophia perennis», per dirla con
Jaspers35.
È necessario, al riguardo, operare il possibile passaggio, come
suggerisce Trigano, dallo studio del pensiero ebraico, allo studio
ebraico del pensiero36, quello che trae ispirazione dal suo fondamento metafisico, dal Libro, Testo-evento di una cultura antichissima e vitale, cifra particolare e mobile di una vicenda universale.
Non si tratta, è ovvio, di riproporre hegelianamente singole porzioni
di pensiero veritativo, in grado di disegnare, in una sintesi dialettica
superiore, le linee di un’universale filosofia della storia, quanto di
recuperare alcune figure di verità, disseminate all’interno delle millenarie tradizioni religiose e culturali, che concorrono anche oggi a
produrre nuovi orientamenti del pensiero, legati ai rispettivi fondamenti originari.
È questo un altro modo per ridire l’esigenza di rintracciare me J. Derrida, Abraham, l’autre, trad. it Abramo, l’altro, Cronopio, Napoli
2005, pp. 50-51.
35
K. Jaspers, Die grossen Philosophen, trad. it. I grandi filosofi, a cura di F. Costa,
Longanesi, Milano 1973, pp. 131-144.
36
S. Trigano, Alle radici della modernità, cit., pp. 28-39.
34
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
51
tafisiche nascoste che, in questo caso, giacciono sepolte in quel ricco
deposito di senso, rappresentato dalla Torah orale, da quel lungo
lavorio di commento sul Testo, che continua a premere per uscire
dalle isolanti pareti del ghetto, così da riproporsi nella sua pregnanza epistemologica e nella sua inevitabile declinazione universale.
4. Torniamo pure ad Alessandria di Egitto, luogo strategico, punto di partenza necessario per osservare, oltre l’avventura culturale
dei Septuaginta, le tappe evolutive della lingua greca che in quell’epoca – siamo nel III secolo a.C. – ha ormai definitivamente compiuto il suo percorso, tramite il passaggio, maturato in più di tre secoli,
dall’oralità alla scrittura.
Gli studi importanti di Eric Havelock37 e di Milan Parry38 hanno
illuminato, negli anni ’60 del Novecento, le tappe complesse e affascinanti di questo percorso, che prende avvio con la cultura orale
rappresentata dal mondo di Omero, per concludersi con la civiltà
della scrittura di Platone. Cammino non semplice e per nulla lineare, se è vero che la lingua, deposito sempre in movimento di istanze
culturali, sociali e storiche assai diverse nel tempo e, dunque, produttrice di nuove modulazioni del pensare, si è dovuta di volta in
volta reinventarsi, per costituirsi infine nelle varie determinazioni
lessicali e sintattiche proprie del procedimento scritturale.
Né si pensi, come voleva Rousseau, che la scrittura sia necessariamente e inevitabilmente la traduzione della parola orale39; la
scrittura insomma come semplice riproduzione dell’oralità; indagare sulle dinamiche (linguistiche e insieme filosofiche) della scrittura
non significa tout court penetrare nei recessi dell’oralità, di cui certo
essa è connessa, ma non è in grado di esaurirla fino in fondo, pena la
perdita della comprensione della lingua e delle sue innegabili capacità di strutturare il pensiero.
37
E.A. Havelock, Preface to Plato, trad. it. Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone, a cura di B. Gentili, Laterza, Bari 2003.
38
M. Parry, The making of homeric verse: the collected Papers of M. Parry, a
cura di A. Parry, Clarendon Press, Oxford 1971.
39
È quanto riferisce, a ragione, J. Derrida, De la Grammatologie, trad. it. Della
Grammatologia, Jaca Book, Milano 1969, p. 14.
52
paola ricci sindoni
Vale la pena dar conto, sia pure in brevi cenni, del cammino greco verso l’uso generale della scrittura, se è vero che la tradizione poetica ed epica proprie del mondo di Omero continuò a essere affidata
alla pratica dell’oralità, anche dopo la sua trascrizione alfabetica, più
capace di conservarne gli espedienti del ritmo, del linguaggio dell’immagine, dell’evento e della situazione, in cui l’accadimento oggettivo
predomina sull’idea, e il simbolo concreto sul concetto astratto.
Grazie al lavoro di classificazione, attraverso cui l’esperienza veniva riordinata in categorie, Esiodo e i pensatori preplatonici si sforzarono di garantire con nomi nuovi il nesso tra due zone principali
dell’esperienza umana, l’ambiente fisico e quello morale, producendo il vocabolario di tutto il pensiero astratto. Termini come corpo
e spazio, natura e movimento, permanenza e mutamento, qualità e
quantità, combinazione e separazione modificarono il contesto sintattico delle parole, coniandole di nuove nell’impersonale singolare,
scoprendo in tal modo il pensiero concettuale come idea e come
metodo di scrittura40.
Toccherà a Socrate realizzare quella spinta concettuale non più
diretta soltanto verso l’ambiente esterno, ma indirizzata verso i modelli di comportamento umano, dunque verso l’etica e la politica
della città-stato. «La Grecia – nota al riguardo Havelock – era ormai
entrata in un gioco pericoloso e affascinante, in cui gli scontri degli
eroi omerici si trovavano tradotti in battaglie tra concetti, categorie
e principi»41, destinate ad acquisire il suo slancio definitivo nelle
pagine di Platone.
Fu lui a garantire forma classica al linguaggio scritto con le sue
regole logiche e le sue sintassi, segnando il passaggio definitivo, la
via del non ritorno dalla lingua dell’oralità al linguaggio della scrittura, divenuta nel tempo rappresentazione della coscienza, disciplina dell’astratto, fonte di un sapere essenziale, analitico, ipotattico42.
Non sfugga il differente scenario mentale che in questa rivoluzione linguistica veniva a imporsi: la struttura paratattica, aggregativa, ridondante, soggettiva della lingua parlata veniva a modificarsi
E.A. Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura, cit., pp. 248-249.
Ivi, p. 251.
42
W.J. Ong, Orality and Litetacy. The technologizing of the Word, trad. it.
Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, il Mulino, Bologna 1986, pp. 65-70.
40
41
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
53
nello scritto, più oggettivo, analitico, astrattivo, capace di generare
pensiero deduttivo, formale, introspettivo, al cui interno il lavoro
concettuale e filosofico sembrava trovare il suo habitat privilegiato
per uno sviluppo che dalla Grecia si impose in tutto il sapere occidentale. Indiscusso regno del logos, non solo affidando a questo
termine l’accezione di “ragione”, ma anche quello di “linguaggio”,
come Heidegger propone, leggendo Aristotele43, il linguaggio risponde alle pretese del pensiero facendosi scrittura, architettura segnica, che nel tentativo di fissare nei segni il movimento mobile del
pensiero, ne garantisce la stabilità contro la corruzione del tempo,
e ne articola l’esercizio del potere, dal momento che fissa una verità
che altri non possono lì modificare.
In quest’ottica può essere letta l’obiezione alla parola scritta,
mossa dal Socrate di Platone nel Fedro: «quei strani segni di fuori»
privano l’uomo della memoria, che è quell’energia interiore che alimenta il pensiero, diventando un temibile velo tra il soggetto e la verità, oltre che strumento per costruire le rappresentazioni dell’altro
esplicitandone, anche senza il suo consenso, il flusso arbitrario delle
sue parole44. La parola parlata, al contrario, e l’evento sonoro che
produce, è agonistica ed enfatica, frutto di una situazione concreta,
dell’interagire immediato tra esseri umani. È la parola-azione che
muta il mondo contro la parola-ricordo, – annota ancora Platone – è
l’evento contro la situazione, il mutamento contro la stasi, la memoria contro la dimenticanza45.
Paradossalmente il filosofo greco, anche se elogia l’oralità, si fa
paladino della scrittura, e non solo in quanto non “dice”, ma “scrive”
il suo pensiero, servendosi proprio di quel medium, che a parole svilisce, ma anche perché la sua speculazione dipende interamente dalla
scrittura. Il pensiero analitico è, infatti, comunicabile solo all’interno
di una civiltà della scrittura, della Grecia appunto, culla privilegiata
dello sviluppo del linguaggio scritto e del progressivo distacco dalla
trama fonetica dell’oralità. Con buona pace di Derrida, che come
È quanto ha notato, al riguardo, H.-G. Gadamer, Gesammelte Scriften,
vol. 8, trad. it. Linguaggio, a cura di D. Di Cesare, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 6061; 155.
44
Platone, Fedro, 275a, trad. a cura di L. Robin, Mondadori, Milano 1998.
45
Ivi, 274c.
43
54
paola ricci sindoni
è noto sviluppa le sue riflessioni sul nesso oralità-scrittura in modo
assai differente, anzi rovesciandolo dialetticamente, nella polemica
contro la metafisica occidentale, accusata di “logofonocentrismo”,
frutto – a suo vedere – del legame mai rotto di logos e phonè46.
Decostruendo la questione platonica della scrittura come pharmakon, nella sua ambigua e paradossale accezione di medicina-veleno, Derrida procede, come è noto, a scalzare i presupposti metafisici dell’Occidente nella sua pericolosa deriva, quella che identifica
l’Essere come presenza e la voce come coscienza47. Seguendo intenzionalità differenti, anche se spesso incrociate, oralità e scrittura accompagnano la storia del pensiero, che nell’universo dell’ebraismo
sembrano andare – a differenza della Grecia e dell’interpretazione
che ne dà Derrida – in modo assolutamente opposto.
5. Il Libro, testo-evento fondante l’orizzonte conoscitivo e storico
della comunità di Israele nel tempo, rende evidente nel linguaggio
orale l’origine nascosta in grado di guadagnare una nuova intelligibilità del mondo. L’oralità, con i suoi modelli di pensiero fissi e formulaici affidati alla memoria e al ritmo lessicale e sintattico del suo dire,
caratterizza sistematicamente l’impianto narrativo della Bibbia che,
sebbene scritta – Sacra Scrittura appunto – conserva al suo interno
l’intenzionalità originaria della struttura del linguaggio orale.
A differenza della Grecia di Platone, dove la scrittura finiva con
l’attrarre a sé la densità semantica dell’oralità, che pure doveva pure
conservare la sua ineliminabile funzione di tecnica della comunicazione, nell’orizzonte ebraico la Bibbia indicava che «In principio c’è
la voce», espressa nel “grido” della creazione, con cui fu fatto il mondo48, e data all’uomo non tanto o non solo come strumento di relazione dialogica, ma come orizzonte di pensiero, principio unificatore
dell’esperienza nel mondo, centro di attrazione della scrittura.
Cfr. J. Derrida, Della Grammatologia, cit., p. 14.
Cfr. anche J. Derrida, La voix et le phénoméne. Introduction au probleme du
signe dans la phenomenologie de Husserl, trad. it. La voce e il fenomeno, a cura di
G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 1968, p. 147.
48
F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, (1921), trad. it. La Stella della redenzione, a cura di G. Bonola, Marietti, Casale Monferrato 1985, pp. 31-36.
46
47
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
55
È quanto non riuscirono a capire i “settanta” saggi di Alessandria, convinti che una buona traduzione esigesse l’incontro di due
universi linguistici scritti, ugualmente esposti – pur attraverso l’uso
di architettoniche lessicali differenti – alle medesime regole. L’oralità “scritta” del Libro, a differenza della scrittura “orale” dei greci,
porta in sé segnali permanenti che rimangono densificati, per così
dire, dentro la parola scritta rappresentandone l’impensato, l’originario, quell’ulteriorità del dire, nell’accezione che ne dà Lévinas49, e
che oggi chiede di essere rivalorizzata nella sua implicita metafisica.
Anteriore a ogni differenziazione, la voce è il luogo di un’assenza
che in essa si trasforma in presenza, nella parola vocalizzata attraverso il linguaggio che la penetra senza lasciare traccia. In tale “disessere” essa comunque si impone come “cosa”: di essa possiamo infatti
descriverne le qualità materiali come il tono, il timbro, l’ampiezza,
il registro, possedendo al suo interno l’indicibile soffio che la anima
e la fa essere. È lo spirito, in ebraico ruah, midollo vivo dell’intero
universo, presenza innominabile dell’Essere che la fa essere, energia
che si dice nel momento stesso in cui dice: pura esigenza in sé, il cui
uso produce godimento e volontà di emanazione che la voce aspira
a riattualizzare incessantemente nel flusso linguistico che essa manifesta e a cui promette di vivere parassitariamente50.
È la forza, l’energia del grido – il grido della nascita, il grido di
guerra, il grido di dolore – voce piena, negazione di ogni rassicurazione del linguaggio codificato, esplosione dell’Essere in direzione
dell’origine, nostalgia del tempo della voce senza parola. La voce è
dunque parola senza il peso del linguaggio, visto il modo etereo con
cui scompare, parola leggera, purificata, filo vocale che fragilmente
ci collega all’Unico, non a caso innominabile nel pensiero religioso
del giudaismo, proprio perché non genera discorso, né contenuto
determinato, né flusso linguistico che si apra necessariamente ad alcuna rappresentazione.
Pura presenza, la voce, senza determinazione; attraverso il cor Cfr. E. Lévinas, Autrement qu’être au au-delà de l’essence, trad. it. Altrimenti
che essere o aldilà dell’essenza, a cura di S. Petrosino, Jaca Book, Milano 1983, pp. 2976.
50
P. Zimthor, Introduction à la poésie orale, trad. it. La presenza della voce.
Introduzione alla poesia orale, il Mulino, Bologna 1984, pp. 9-10.
49
56
paola ricci sindoni
po tramite la bocca (os-oris) vagheggia l’origine, l’oriente, fonte e
inizio, luogo simbolico pregnante che indica tanto l’entrata che l’uscita, scambio fonetico che esibisce l’uscita da sé e ritorno dell’altro,
in quell’intreccio di dentro/fuori, di interiorità/esteriorità, entro cui
si consuma la sete di relazione con l’altro51.
Grazie alla voce, l’altro si presenta, e l’enunciazione della parola acquista qui il suo valore: è esibizione e dono, aggressione e
conquista, interiorità manifestata, liberata dalla necessità di vedere
e di afferrare l’oggetto del desiderio, speranza di incontro dell’altro
tramite l’interconnessione di due voci. «Non definibile se non in
termini di rapporti, di scarto, di articolazione tra soggetti, tra l’uno e
l’altro, la voce resta inoggettivabile, enigmatica, arbitraria (De Saussure), non speculare»52, rivolgendosi all’interlocutore, lo costituisce
come tale, e vi imprime la cifra dell’alterità, fondatrice di un nuovo ordine, quello della relazione che è determinata dalla voce, fatta
attenzione e tempo, presenza senza possesso, antidoto contro ogni
forma di logocentrismo, traccia di una “archi-voce” originaria, per
dirla in termini capovolti con una espressione di Derrida53.
L’oralità infatti – come Buber e Rosenzweig più volte precisano
nei saggi dedicati alla traduzione, posti come introduzione alla loro
traduzione in tedesco della sacra Scrittura – è ciò che vertebra il
Libro, la cui energia resiste al potere della scrittura, che è sistema
logico di segni che con la sua forza oggettivante e atemporale mortifica il flusso relazionale della voce, vero grembo del senso, densificazione della parola di Dio all’uomo, della parola dell’uomo a Dio e
della parola degli uomini di fronte a Dio54.
Trasformata in scrittura la parola-voce si allontana e si stacca
dall’uomo; condannata a non avere più tempo, né patria, essa si
51
Ivi, pp. 14-49. Su questi temi insospettate analogie, che andrebbero sviluppate, con M. Bachtin, Slovo v zinzi, slovo v poezii, trad. it. La parola nella vita e
nella poesia, in Linguaggio e scrittura, Molteni, Roma 2003, pp. 34-64.
52
Ivi, p. 14. Cfr. anche lo studio ormai classico di F. De Saussure, Cours de
linguistique generale, trad. it. Corso di linguistica generale, a cura di T. De Mauro,
Laterza, Bari 1993.
53
Su questo dibattito, innescato da J. Derrida, cfr. W.J. Ong, Oralità e scrittura, cit., pp. 111-122.
54
M. Buber, F. Rosenzweig, Die Scrift una ihre Verdeutschung, Lambert, Berlin 1936, pp. 76-87.
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
57
chiude al commento, diventando letteratura, mutismo irrigidito di
parole fissate una volta per tutte, forma linguistica che, come un
involucro vuoto, ha perduto la sua verità, depotenziando l’ascolto e,
dunque, smarrendo l’“evento” del Libro55. Nasce da qui l’esigenza
filosofica di guarire le parole, restituendo a esse, con la nuova traduzione, vitalità e sonorità, quei tratti del suono non trasferibili nei
segni della scrittura, ma ancora nascosti nell’alveo inamovibile del
linguaggio originario.
Vale la pena ricordare la presenza, nella tradizione giudaica, della Torah orale, accanto a quella scritta, come si è prima notato, là
dove risulta capovolta l’usuale scansione cronologica che vedrebbe
prima quella orale e successivamente quella scritta. Le due Torah,
pur essendo “una”, sono invece distinte da differenti intenzionalità,
guadagnate da una sincronia della parola ottenuta attraverso il suo
capovolgimento diacronico.
La catena del “commento”, in altri termini, non costituisce soltanto il corpo di una tradizione, la consegna storica a una letteratura successiva, ma il segno della trasmissione della voce, custodia di
una memoria, registrazione dei suoni dell’oralità che indicano la vita
della parola contro la sua possibile morte nella scrittura. Duplice
paradosso del linguaggio scritto, che si consegna alla morte, una volta fissato dentro la rigida fissità dei segni, ma capace di riprendere
vita quando è affidato al numero potenzialmente infinito dei suoi
lettori. E ancora paradosso, quando la vita della parola è consegnata
al carattere effimero della voce, inafferrabile come il respiro del­
l’universo che l’accoglie, ma anch’essa esposta alla morte nel momento in cui prende forma e svanisce56.
La Torah nella sua versione orale, movimentata dalla tentazione
di sfuggire alla fedeltà della lettera, infine cedette alla seduzione della scrittura, fortemente voluta dai rabbini perché acquistasse valore
normativo. Forte segnale che la pagina scritta – durante il dolorosissimo periodo della diaspora dopo la seconda caduta del Tempio
(70 d.C.) – fu capace di invadere lo spazio e di capitalizzare il tempo,
Ivi, pp. 55-75
Cfr. M. Blanchot, L’espace lettéraire, trad. it. Lo spazio letterario, a cura
di G. Neri, Einaudi, Torino 1975; Cfr. anche M. Blanchot, L’arrêt de mort, Gallimard, Paris 1948.
55
56
58
paola ricci sindoni
a fronte di una parola liquida che non va lontano, che non conserva,
che non è esportabile e il cui «significante non è distaccabile dal
corpo individuale e collettivo»57.
Proprio il Libro, assoluto orizzonte di comprensione per il pensiero ebraico, non può che ospitare, al proprio interno, questa lotta
imperitura tra la forza espansiva del segno che riempie e si fissa sullo spazio, e l’energia sfuggente della voce che trasporta la presenza
dell’origine, che sfuma nell’attimo fuggente, ma che evidenzia un
“essere qui” del Principio, libero e indenne dalle trasformazioni di
generazioni millenarie.
Logos e Torah dimostrano in questo scenario la differente direzione dei loro principi creativi: da un lato il greco che giunge all’estrema maturità linguistica e filosofica, trascrivendo l’oralità, dando
a essa forma e sostanza duratura. Dall’altro lato, l’ebreo, ancorato
alla fonte prima del Testo-evento, si spinge ancora per ritrovare le
insospettate valenze metafisiche del pensiero moralizzando la scrittura, mantenendola cioè aperta all’esteriorità della presenza dell’altro che ascolta, alla relazione mai appagata con ogni altro.
La storia dell’Occidente, che, per dirla con Derrida, è storia del
greco e dell’ebreo, non ha ancora visto lo sviluppo pieno di questo
incredibile incontro, distesosi prevalentemente sui percorsi ellenici
della scrittura-traduzione, trascinando sulla sua onda l’incerto cammino della lettera ebraica scossa da contrapposti movimenti di tradimento e di fedeltà alla sua naturale materialità.
Consegnata sinora agli etnologi, agli antropologi e ai linguisti, lo
studio dell’oralità, nata all’interno del giudaismo come commento e
come rielaborazione millenaria del Talmud, attende nuove indagini
teoriche, capaci di riorientare il pensiero ebraico verso le sue originarie strutture epistemologiche.
Se oggi si è di fronte – come si dice – a una nuova oralità di ritorno, segnata nell’era elettronica dalle trasformazioni dei meccanismi
linguistici e cognitivi della comunicazione e sull’utilizzo di formule
memorizzabili58, significa che lo studio sull’oralità, principalmente
57
M. De Certeau, Ethno-graphie, L’oralité, ou l’espace de l’autre: Léry, trad. it.
La scrittura dell’altro, a cura di S. Borutti, Raffaello Cortina, Milano 2005, pp. 40-49.
58
Su questo tema si è particolarmente soffermato W.J. Ong, Oralità e scrittura, cit., pp. 190-193.
PER UNA EPISTEMOLOGIA DEL PENSIERO EBRAICO
59
affidato alla ricerca di ulteriori principi teorici del pensiero ebraico, è un campo ancora tutto aperto per la filosofia, ancora lontano
dall’essere conosciuto e affidato a quegli esploratori del pensiero,
che non smettono di tracciarne con fatica i sentieri.