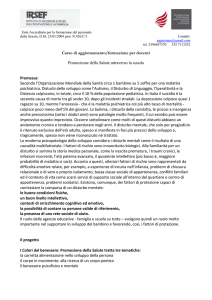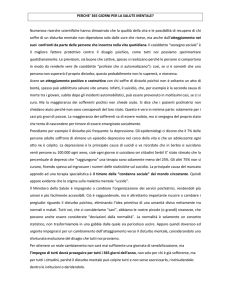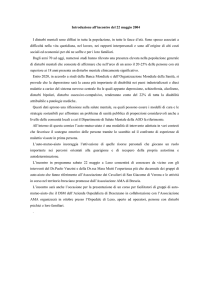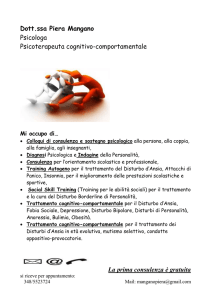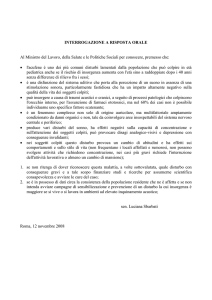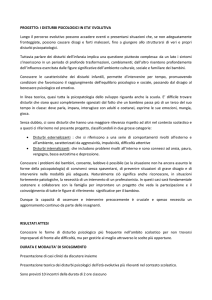REALTÀ E VALORI NEL CONCETTO DI DISTURBO MENTALE:
IL DISTURBO COME DISFUNZIONE DANNOSA*
Jerome C. Wakefield**
Il concetto di disturbo mentale è alla base delle professioni della salute
mentale ed è al centro delle dispute accademiche e pubbliche riguardanti le
condizioni che dovrebbero essere classificate come psicopatologia. Finora,
nonostante la grande quantità di letteratura dedicata al concetto di disturbo
mentale che attraversa la filosofia, la psicologia, la psichiatria, la medicina, la
sociologia e altre discipline accademiche, e nonostante i molti dibattiti comparsi sulla stampa divulgativa, non esiste un’analisi generalmente concorde
che spieghi adeguatamente le opinioni condivise riguardo ai disturbi mentali.
Tale analisi è necessaria come alternativa alle prospettive, piuttosto sterili,
oggi disponibili. Da una parte, un’improbabile amalgama di antipsichiatri,
comportamentisti, postmodernisti e sociocostruzionisti affermano che non esiste nulla di simile ad un disturbo mentale inteso nel senso letterale di “disturbo”, e cioè nel modo in cui il concetto viene utilizzato in medicina. Essi affermano piuttosto che le diagnosi di disturbo mentale sono semplicemente
giudizi di valore relativi a categorie socialmente costruite di un comportamento disapprovato, giudizi che consentono di esercitare il potere medico, con
scopi di controllo sociale, su condizioni che in realtà non consistono in disturbi. Dall’altra parte, l’establishment della psichiatria, rappresentata dal DSMIV dell’American Psychiatric Association (1994) tende a considerare come
“disturbo” ciò che è definibile da qualsivoglia sindrome comportamentale negativa che possa essere appropriatamente operazionalizzata. C’è disperatamente bisogno di una ragionevole posizione intermedia che riconosca la realtà
secondo la quale alcune condizioni mentali sono davvero genuini disturbi
mentali, e che ne spieghi il perché, e che al contempo distingua tali condizioni
dal vasto insieme di “problemi della vita” che risultano devianti e socialmente
indesiderati sebbene non classificabili come disturbi. Solo una simile posizione intermedia potrà fornire una base per la critica ed il miglioramento dei correnti criteri diagnostici.
*
Traduzione di Catia Ghinelli.
New York University, 1 Washington Square North, New York, NY 10003, USA, Fax
212-2229524, E-Mail <[email protected]>.
**
Psicoterapia e Scienze Umane, 2004, XXXVIII, 4: 439-464.
439
Presenterò qui la sintesi di un’analisi intermedia di questo genere, l’analisi
del concetto di disturbo mentale nei termini di “disfunzione dannosa”, analisi
che è già stata sviluppata e sostenuta altrove (Wakefield, 1992a, 1992b, 1993,
1999a, 1999b). Illustrerò anche le implicazioni di tale analisi per la critica ai
criteri diagnostici del disturbo mentale contenuti nel DSM-III e nel DSM-IV.
Nello studio dei “disturbi mentali” una suddivisione fondamentale è quella
tra approcci valoriali e approcci scientifici. Kendell (1986) imposta così la
questione: «Il tema fondamentale, e anche il più controverso, è se la malattia
ed il vissuto di malattia siano concetti normativi basati su giudizi di valore, o
se essi siano piuttosto termini scientifici liberi da valori; in altre parole, se essi
siano termini biomedici o sociopolitici» (p. 25). Io propongo un modello ibrido secondo il quale un disturbo è una disfunzione dannosa. In questo modello
“dannosa” consiste in un termine valoriale che si riferisce a condizioni giudicate negativamente secondo gli standard socioculturali, e “disfunzione” in un
termine scientifico fattuale basato sulla biologia evoluzionistica che si riferisce al fallimento di un meccanismo interno nell’esecuzione di una delle sue
funzioni naturali.
Poiché questa analisi, in definitiva, riguarda il concetto generale di disturbo così come esso viene applicato sia alle condizioni mentali che a quelle fisiche, per testare l’analisi saranno utilizzati esempi riguardanti sia l’ambito
mentale che quello fisico. Userò l’espressione “meccanismo interno” come
termine generale per riferirmi alle strutture fisiche e agli organi così come alle
strutture mentali e alle disposizioni, quali ad esempio i meccanismi motivazionali come ad esempio ai meccanismi motivazionali, cognitivi, affettivi, e
percettivi. Alcuni autori distinguono tra “disturbo” (disorder), “malattia” (disease), e “vissuto di malattia” (illness); io mi focalizzerò sul termine “disturbo” ovvero sul termine più ampio entro il quale rientrano sia le ferite traumatiche che la malattia, e che, di conseguenza, è vicino al concetto medico globale di patologia.
I presupposti di questa disamina includono i seguenti punti:
(1) Il punto principale consiste nello spiegare i criteri classificatori maggiormente condivisi su ciò che è considerato come esempio chiaro di disturbo
o di non-disturbo. I casi controversi invece saranno inizialmente accantonati
Essi potrebbero in effetti rappresentare dei limiti alla conoscenza attuale o al
concetto stesso di disturbo, oppure una particolare sfida all’applicazione del
concetto di “disturbo” all’ambito del mentale.
(2) I membri di una medesima cultura generalmente condividono le rappresentazioni mentali che costituiscono i concetti, ovvero i significati di termini linguistici condivisi. Quindi così come fa il linguista che tenta di formulare una teoria della grammatica del linguaggio considerando i criteri condivisi dai soggetti su quali frasi sono o non sono grammaticalmente corrette, così
l’analista concettuale tenta di formulare una teoria delle rappresentazioni concettuali condivise considerando i criteri classificatori condivisi dai membri
della comunità circa ciò che rientra e ciò che non rientra entro un dato concetto. Si noti che non assumiamo che i criteri classificatori maggiormente condi440
visi siano per ciò stesso corretti; avere un concetto e giudicare se una certa cosa rientri nell’ambito di quel concetto sono due operazioni differenti: il nostro
scopo è spiegare tali giudizi, sia che essi siano o non siano corretti.
(3) Non si ipotizza che vi sia un confine preciso o netto tra disturbo e nondisturbo. Come per la maggioranza dei concetti, ipotizziamo che il “disturbo
mentale” abbia aree di indeterminatezza, ambiguità, e vaghezza, e che una
buona analisi debba riflettere e spiegare questi aspetti dei nostri giudizi.
(4) Il significato di “disturbo” che viene applicato ai disturbi mentali è lo
stesso significato che viene applicato ai disturbi fisici. Questo è essenziale
qualora l’analisi sia rivolta alle affermazioni dell’antipsichiatria secondo le
quali i disturbi mentali non sarebbero disturbi medici. Si noti che il fatto che i
disturbi mentali siano disturbi medici in senso concettuale non significa che i
disturbi mentali debbano essere disturbi fisiologici del cervello; le funzioni
mentali possono fallire a causa di problemi che si verifichino a livello del
“software” rappresentazionale piuttosto che dell’“hardware” fisiologico.
(5) Mi focalizzerò sulla questione di che cosa sia a rendere una condizione
mentale un disturbo mentale. Non cercherò di distinguere i disturbi mentali da
quelli fisici. Lascerò da parte anche la complessa questione di che cosa sia a
rendere una certa condizione una condizione mentale piuttosto che fisica. Per i
nostri scopi i processi mentali sono semplicemente i sentimenti, i pensieri, le
percezioni, le motivazioni, il linguaggio, le azioni intenzionali ed altri processi analoghi. Non vi sono deliberate implicazioni cartesiane riguardanti alcuno
speciale status ontologico del mentale, si tratta solo di un riconosciuto insieme di funzioni e processi. Il principio in base al quale le funzioni vengono
classificate come mentali non sarà approfondito in questa sede, ma probabilmente questo principio ha a che vedere con ciò che i filosofi e gli scienziati
cognitivi chiamano intenzionalità o rappresentazionalità.
(6) Ipotizzo che il concetto di disturbo sia condiviso da profani e da professionisti e prenderò in considerazione alcuni esempi tenendo presente
quest’ipotesi. Questo assunto va contro argomentazioni recenti secondo le
quali quello di “disturbo mentale” sarebbe un concetto puramente tecnico, definito solo attraverso un arcano discorso professionale (vedi ad esempio Kirmayer & Young, 1999).
(7) Al contrario di quanto sostenuto da alcune visioni olistiche dei concetti,
i concetti non sono sempre gli stessi per tutti, così come d’altra parte le credenze o le teorie sulle cose che rientrano in un dato concetto (Wakefield,
1994a). Ad esempio, due persone possono condividere esattamente lo stesso
concetto di “scapolo” ma uscire da un incontro con idee completamente differenti circa quali uomini sono scapoli a causa delle teorie diverse che esse hanno circa le prove del celibato (ad esempio una persona potrebbe credere che la
mancanza della fede nuziale sia un buon segno di celibato mentre un’altra potrebbe non pensarla così).
Questo per ciò che riguarda gli assunti di fondo. Passo ora all’analisi del
concetto di “disturbo”.
441
La componente valoriale del “disturbo”
Come suggeriscono i valori tradizionali, una determinata condizione è un
disturbo mentale solo se, secondo i valori sociali, essa è dannosa e quindi merita, almeno potenzialmente, l’attenzione dei medici. Il “danno” qui è inteso in
modo ampio fino ad includere tutte le condizioni negative.
I comportamenti classificatori sia dei profani che dei professionisti dimostrano che il concetto di disturbo mentale contiene una componente valoriale.
Ad esempio, l’incapacità ad imparare a leggere a causa di una disfunzione del
corpo calloso (se si assume che questa teoria riguardante alcune forme di dislessia sia corretta) è dannosa nelle società letterate, ma non lo è nelle società
preletterate nelle quali leggere non è una capacità che venga insegnata o valorizzata, e quindi, in quelle società, essa non è un disturbo. Ancora, la maggioranza delle persone ha quelle che i medici chiamano “anomalie benigne”, ovvero malformazioni minori che sono il risultato di errori genetici o dello sviluppo, che tuttavia non determinano problemi significativi e che quindi non
vengono considerate come disturbi. Ad esempio una certa parte dello sperma
maschile è malformato e disfunzionale, tuttavia queste disfunzioni interne non
sono considerate disturbi fino a quando esse non siano causa di un danno in
termini di ridotta funzione riproduttiva. Allo stesso modo gli angiomi benigni
sono piccoli vasi sanguigni la cui crescita è stata difettosa tanto da arrivare a
connettersi alla pelle, ma poiché essi non sono dannosi non vengono considerati come disturbi. Il requisito che vi sia un danno spiega perché il semplice
albinismo, l’inversione della posizione del cuore, le dita fuse insieme non
vengano generalmente considerati come disturbi sebbene ognuno di essi sia
l’esito di un anormale funzionamento di certi meccanismi, programmati invece per funzionare diversamente.
Altrove, nel discutere della componente valoriale del “disturbo”, ho argomentato contro l’“errore essenzialista” scientistico che intende il “disturbo
mentale” come un concetto puramente scientifico o fattuale (Wakefield,
1997b). I miei recensori appartenenti all’orientamento “valoriale” hanno talvolta dichiarato che io ho contributo ad accantonare la visione puramente fattuale del concetto di “disturbo” (Sadler, 1999). Rimane vivo il dibattito sul
concetto di “disturbo mentale”, ovvero se esso sia un concetto puramente valoriale o se esso contenga piuttosto una significativa componente fattuale che
consenta di discriminare un insieme di condizioni negative che possono essere
considerate disturbi, da quelle che invece vengono considerate non-disturbi.
Perché deve esistere una componente fattuale del “disturbo”?
Alcune analisi del concetto di “disturbo” si fermano a questo punto, asserendo che un disturbo mentale è semplicemente una condizione mentale disapprovata socialmente (ad esempio Houts, 2001; Sedgwick, 1982). Ma vi sono buone ragioni per insistere sull’idea che il “disturbo mentale” non può es442
sere un concetto solamente valoriale (Wakefield, 1995, 2003). E’ necessaria
una componente fattuale aggiuntiva per distinguere i disturbi dalle molte altre
condizioni mentali negative che non vengono considerate come disturbi, quali
l’ignoranza, la mancanza di abilità, la mancanza di talento, la poca intelligenza, l’analfabetismo, la criminalità, la maleducazione, la stupidità e la debolezza morale. Quello del “disturbo mentale” è solo uno tra i molti eventi negativi
che possono accadere ad una persona.
In effetti, sia i professionisti che i profani distinguono, tra condizioni abbastanza simili, i disturbi dai non-disturbi. Ad esempio, l’analfabetismo non è di
per sé considerato un disturbo sebbene nella nostra società esso sia valutato
negativamente e considerato nocivo, tuttavia una condizione simile all’analfabetismo che si ritiene causata invece dalla mancanza di abilità ad imparare a
leggere a causa di alcune disfunzioni interne, neurologiche o psicologiche, è
considerata, viceversa, un disturbo. L’aggressività maschile e la più forte inclinazione maschile all’infedeltà sessuale sono considerate negative, ma generalmente non come disturbi poiché esse sono viste come risultato del funzionamento, naturalmente selezionato, del genere maschile. Condizioni simili ma
sostenute da spinte compulsive sono invece considerate disturbi. Il dolore del
lutto è considerato normale, ma se un sentimento di tristezza altrettanto intenso non viene provocato da una perdita reale allora esso è visto come disturbo.
Un’accezione puramente valoriale del concetto di “disturbo” non spiegherebbe distinzioni di questo genere tra condizioni negative simili.
Per di più noi spesso adeguiamo le nostre visioni del disturbo sulla base di
evidenze transculturali che possono andare contro i nostri valori. Ad esempio,
la nostra cultura non approva la poligamia, tuttavia riteniamo che essa non sia
il fallimento di un modo naturale di funzionare, e che pertanto non consista in
un comportamento disturbato, e ciò in parte sulla base di dati transculturali.
Per questo tipo di ragioni la ricerca di un’analisi puramente valoriale dei
“disturbi” non ha condotto ad un’adeguata definizione esplicativa, capace di
distinguere i disturbi da altre condizioni negative. L’insufficienza di alcune
descrizioni così “indipendenti dai fatti” ci sfida ad identificare una componente fattuale che sia in grado di spiegare i giudizi sui disturbi. L’analisi della
“disfunzione dannosa” afferma che la componente fattuale è un significato del
termine disfunzione, quello che Donald Klein (1978) etichetta come “disfunzione parziale”. Io sostengo che questa componente della disfunzione consiste
in un giudizio puramente non-valoriale, fattuale, fallibile, che evidenzia un
errore del naturale funzionamento umano. La principale obiezione a questo
approccio è l’affermazione secondo la quale il concetto di “disfunzione” è esso stesso un concetto valoriale. La sfida consiste pertanto, ora, nel chiarire
meglio il senso fattuale della “disfunzione”.
La discussione riguardante questi temi spesso ignora la distinzione tra le
seguenti due affermazioni: (1) le valutazioni delle disfunzioni spesso sono influenzate da, associate a, o determinate da giudizi di valore; (2) il concetto di
disturbo (che include la disfunzione) è insitamente (semanticamente) un puro
concetto valoriale. Quando sostengo che la “disfunzione” (in senso specifico)
443
è un concetto fattuale, io contesto solo la seconda affermazione, ovvero che il
significato di “disfunzione” sia (almeno in parte) valoriale. Sono invece
d’accordo con la prima tesi. È evidente, dalla documentazione storica ed antropologica, che i valori, le norme e le ideologie influenzano pesantemente ciò
che le persone ritengono essere funzioni naturali, specialmente quando vi è
un’insufficiente comprensione scientifica della “funzione” e della “disfunzione” (come avviene attualmente nel caso di molte caratteristiche mentali). Ma
nulla di tutto ciò implica che il contenuto semantico del concetto di “funzione
naturale” sia valoriale. Allo stesso modo, se i valori religiosi di una persona la
conducono a rifiutare l’idea che la Terra ruoti attorno al Sole e ad affermare
che la Terra ha meno di 7.000 anni, ciò non significa che i concetti “ruota attorno al Sole” o “meno di 7.000 anni” siano concetti carichi di valori. Essi sono concetti puramente fattuali, descrittivi, veri o falsi che siano, riguardanti la
Terra, indipendentemente dai valori di ciascuno, anche se le credenze di ognuno circa la loro applicabilità alla Terra sono ampiamente influenzate, o
addirittura interamente determinate, da valori.
Le funzioni come effetti che spiegano le proprie cause
La prospettiva secondo la quale il concetto di disturbo include in qualche
modo i concetti di funzione e di disfunzione emerge con notevole coerenza
dalle osservazioni di molti autori che per il resto sostengono posizioni diverse
(ad esempio Ausubel, 1971; Boorse, 1975, 1976a, 1977; Caplan, 1981; Kendell, 1975; 1986; D.F. Klein, 1978; Macklin, 1981; Moore, 1978; Ruse,
1973). Spitzer & Endicott (1978) sottolineano l’universalità e l’apparente necessità di usare il concetto di “disfunzione” per rendere il senso di “disturbo”:
«Il nostro approccio rende esplicito un assunto di fondo che è presente in tutte
le discussioni riguardanti la malattia (disease) o il disturbo, ad esempio il concetto di disfunzione organica» (p. 37). Ciò che occorre è un’analisi adeguata
dei concetti di “funzione” e “disfunzione”.
Che cos’è, allora, una disfunzione? Un punto ovvio dal quale iniziare è la
supposizione che una disfunzione implichi il non adempimento di una funzione, ovvero il fallimento del meccanismo con cui l’organismo esegue una propria funzione. In ogni caso, non tutti gli usi dei concetti di “funzione” e “disfunzione” sono specifici. Il significato di “disfunzione” specifico in senso
medico chiaramente non coincide con il significato colloquiale secondo il
quale il termine si riferisce all’insuccesso di un individuo ad avere buone performance in un certo ruolo sociale o in un dato ambiente, come avviene nel
caso di frasi del tipo “sono in una relazione disfunzionale” o “provare disagio
nelle strutture di potere gerarchico è disfunzionale nell’ambiente corporativo
moderno”. Problemi di questo tipo possono non essere disturbi individuali.
Inoltre i tipi di funzioni specifiche non sono quelle che risultano dalle decisioni personali o sociali di utilizzare una parte della mente o del corpo in un certo
modo. Ad esempio il naso è utile per reggere gli occhiali e il rumore del cuore
444
svolge una funzione utile nella diagnosi medica. Ma una persona il cui naso
avesse una forma tale da non consentirle di portare gli occhiali essa non avrebbe per questo un disturbo nasale, e una persona il cui cuore non producesse il rumore consueto non soffrirebbe per questo di un disturbo cardiaco. Un
disturbo è differente dal non riuscire a funzionare in una maniera preferita socialmente o personalmente, precisamente perché una disfunzione esiste solo
quando un organo non può funzionare come si suppone che debba funzionare
naturalmente (ad esempio indipendentemente dalle intenzioni umane). Presumibilmente, allora, le funzioni rilevanti sono le “funzioni naturali”, concetto a
proposito del quale esiste un’ampia letteratura che sarà analizzata dopo. Tali
funzioni sono frequentemente attribuite a meccanismi mentali inferiti: ad esempio una funzione naturale dell’apparato percettivo è trasmettere semplicemente informazioni accurate circa l’ambiente circostante, pertanto gravi allucinazioni indicano disfunzione; e alcuni meccanismi cognitivi hanno la funzione di fornire alla persona la capacità e la razionalità che vengono espresse
nel ragionamento deduttivo, induttivo e in quello orientato a uno scopo, pertanto si considera disfunzione il crollo della capacità di eseguire un simile genere di ragionamento come accade negli stati psicotici gravi. Hempel (1965)
ha opportunamente posto il problema della “funzione naturale” nel modo seguente: ogni organo ha molteplici effetti, la maggior parte dei quali non sono
sue funzioni naturali. Ad esempio, il cuore ha l’effetto di pompare il sangue o
di produrre un suono nel torace, ma solo pompare il sangue è una funzione naturale del cuore. Un’analisi della “funzione naturale” deve quindi specificare
cosa distingua le funzioni naturali di un organo da suoi altri effetti.
Il concetto di funzione si applica anche ai manufatti, come le automobili,
le sedie e le penne. Sembra possibile estendere per analogia il concetto di
“funzione” dai manufatti agli organi (Wright, 1973, 1976). Pertanto l’uso del
concetto di “funzione”, nel caso dei meccanismi che avvengono naturalmente,
deve essere un modo di riferirsi alle proprietà che tali meccanismi hanno in
comune con i manufatti. Ora, la funzione di un manufatto consiste proprio
nello scopo per cui il manufatto è stato concepito; ad esempio le funzioni delle automobili, delle sedie e delle penne sono rispettivamente quelle di metterci
in grado di essere trasportati, di sedere e di scrivere, poiché quegli oggetti sono stati creati per fornire proprio questi benefici. Ma gli organismi e i loro organi funzionano naturalmente e non sono stati “ideati” realmente da qualcuno
che aveva consapevolmente uno scopo, pertanto progetto e scopo non possono
essere proprietà condivise dai manufatti e dagli organi. Naturalmente i biologi
evoluzionisti parlano frequentemente in termini di scopo e di progetto quando
parlano delle funzioni naturali, ma questo porta il rompicapo un passo indietro; cosa giustifica un simile discorso metaforico nel caso dei meccanismi che
avvengono naturalmente? L’estensione del concetto di “funzione” dai manufatti ai meccanismi naturali deve essere giustificata da qualche altra proprietà
condivisa che sottenda all’idea di “progetto” e di “scopo” e fornisca significato al discorso.
La funzione di un manufatto è importante in larga misura per via delle sue
445
connessioni al progetto e allo scopo, essa ha un enorme valore esplicativo. La
funzione spiega perché il manufatto è stato realizzato, perché è stato strutturato in quel modo, perché le parti interagiscono come fanno e perché si possono
realizzare determinate cose con quell’oggetto. Ad esempio possiamo spiegare
parzialmente perché le automobili esistono, perché i motori delle auto sono
strutturati in quel modo, e perché con un apprendimento adatto si può andare
da un luogo ad un altro per mezzo di un’automobile, tutto semplicemente facendo riferimento alla funzione dell’automobile di trasportare.
Le spiegazioni funzionali dei manufatti hanno la strana peculiarità che un
effetto (ad esempio il trasporto) è chiamato in qualche modo a spiegare il manufatto (ad esempio l’automobile) che produce l’effetto. Di conseguenza talvolta è stato detto che le spiegazioni funzionali violano il principio basilare
secondo il quale una causa deve precedere il suo effetto. Eppure una descrizione della funzione potrebbe legittimamente essere inclusa nella spiegazione
del manufatto se esistesse qualche ulteriore teoria in grado di mostrare che
l’effetto riferito gioca un ruolo negli eventi che precedono la creazione del
manufatto. Per quanto riguarda i manufatti questa teoria è ben conosciuta: il
beneficio “precede” il manufatto nel senso che è rappresentato prima nella
mente della persona che concepisce il manufatto. Quindi una spiegazione funzionale (ad esempio “la funzione delle automobili è fornire trasporto” o, in
modo equivalente, “le automobili esistono per fornire trasporto”) è l’abbozzo
di una più approfondita spiegazione causale: il manufatto (ad esempio
un’automobile) esiste perché qualcuno ha desiderato un certo effetto (ad esempio il trasporto) ed ha ritenuto che creare quell’oggetto sarebbe stato un
modo per ottenere l’effetto, e la credenza e il desiderio, che hanno preceduto
il manufatto, hanno indotto la persona a creare il manufatto stesso.
Ho mostrato che la funzione di un manufatto è importante per via del suo
potere esplicativo, e che le spiegazioni “delle funzioni” dei manufatti hanno
una forma distintiva: l’esistenza e la struttura del manufatto sono spiegate facendo riferimento agli effetti del manufatto stesso. Ci sono anche altri ambiti
nei quali questa forma peculiare di spiegazione rende conto degli attributi della funzione. Ad esempio quando i comportamentisti parlano di “analisi funzionale” e di funzione di un comportamento, essi non si riferiscono semplicemente agli effetti negativi del comportamento. Piuttosto essi intendono quegli
effetti del comportamento che rinforzano il comportamento stesso e quindi ne
spiegano l’esistenza, il mantenimento e la struttura. Ancora una volta è la
struttura della “spiegazione dell’effetto” che conduce a parlare di funzioni.
É questa forma di spiegazione che le affermazioni circa i manufatti e le
funzioni naturali hanno in comune, ed è essa che giustifica l’estensione del
discorso sulla “funzione” dai manufatti ai meccanismi naturali. Ad esempio
l’effetto del cuore di pompare il sangue fa anche parte della spiegazione del
cuore, per cui si può legittimamente rispondere ad una domanda quale “Perché abbiamo il cuore?” o “Perché il cuore esiste?” con la risposta “Perché il
cuore pompa il sangue”. L’effetto di pompare il sangue entra anche nelle
spiegazioni dettagliate della struttura e dell’attività del cuore. Pertanto pompa446
re il sangue è una funzione naturale del cuore. La ricerca anatomica e fisiologica è ampiamente dedicata a definire le funzioni naturali degli organi e a
spiegare le forme degli organi nei termini del loro contributo alle funzioni naturali dell’organo stesso. Parlare di “progetto” e di “scopo” nel caso dei meccanismi che avvengono naturalmente è solo un modo metaforico di riferirsi a
questa peculiare proprietà esplicativa secondo la quale gli effetti di un meccanismo spiegano il meccanismo stesso. Così la “funzione naturale” può essere
definita come segue: la funzione naturale di un organo o di altri meccanismi è
un effetto dell’organo o dei meccanismi che partecipa alla spiegazione
dell’esistenza, della struttura o dell’attività dell’organo o del meccanismo.
Una “disfunzione” esiste quando un meccanismo interno non è in grado di espletare la sua funzione naturale (in verità questa è una prima approssimazione: vi sono altre questioni nell’analisi della “funzione” che non possono essere trattate qui e che richiedono ulteriori analisi, come quella ad esempio fornita in Wakefield, 1999b, 2000).
Questa analisi si applica altrettanto bene alle funzioni naturali dei meccanismi mentali quanto alle funzioni degli organi fisici, pertanto essa costituisce
la base comune per l’individuazione sia dei disturbi fisici che di quelli mentali. Proprio come i manufatti e gli organi, i meccanismi mentali, quali ad esempio i meccanismi cognitivi, linguistici, percettivi, affettivi e motivazionali,
hanno vantaggi così evidenti e dipendono da interazioni così complesse ed
armoniose che i loro effetti non possono essere interamente casuali. Le spiegazioni funzionali dei meccanismi mentali sono talvolta giustificate da quello
che sappiamo circa il modo che le persone hanno di destreggiarsi per sopravvivere e per riprodursi. Ad esempio una funzione dei meccanismi linguistici è
quella di fornire la capacità di comunicare, una funzione della risposta di paura è evitare il pericolo, ed una funzione della stanchezza è indurre riposo e
sonno. Queste spiegazioni funzionali rendono conto delle disfunzioni quando
i rispettivi meccanismi falliscono nell’adempiere alle loro funzioni, come nel
caso dell’afasia, della fobia e dell’insonnia.
Una caratteristica importante delle spiegazioni funzionali è che esse devono essere plausibili e utili anche quando si conosca ancora poco della reale natura di un meccanismo. Nel caso dei meccanismi naturali, così come nel caso
dei manufatti, gli effetti che essi producono sono così rilevanti e dipendono da
interazioni così complesse ed armoniose che, in assenza di ipotesi alternative,
è spesso ragionevole ipotizzare che l’effetto non sia accidentale, nel senso che
il manufatto esiste poiché ha proprio questi effetti. Ad esempio non può essere
solamente un fortunato incidente che gli occhi ci permettano di vedere, che le
gambe ci rendano capaci di camminare o che il cuore pompi il sangue, non
più del fatto che un’automobile fornisca trasporto. Gli occhi, quindi, devono
esistere in parte perché ci rendono capaci di vedere; questo significa che il fatto che gli occhi forniscano la vista deve entrare in qualche modo nella spiegazione del perché abbiamo gli occhi. Questo rende il vedere una funzione degli
occhi. Ovviamente avanzando un tentativo di spiegazione di questo genere ci
potremmo sbagliare; ciò che sembra essere non accidentale potrebbe invece
447
rivelarsi accidentale. Tuttavia potremmo anche essere nel giusto: le ipotesi esplicative funzionali trasmettono una conoscenza complessa che non potrebbe
essere così facilmente ed efficientemente comunicata in alcun altro modo.
Quindi, anche se oggi non conosciamo i dettagli dei meccanismi mentali e le
loro funzioni e disfunzioni, tuttavia noi spesso possiamo plausibilmente riconoscere dalle prove circostanziali quando si sta verificando una disfunzione.
La nozione di “disegno” discende da questa spiegazione: che certi effetti siano
responsabili dell’esistenza e della struttura dei meccanismi che producono
quegli effetti.
Disfunzione e teoria evoluzionistica
Così come nel caso dei manufatti, anche le spiegazioni delle funzioni naturali sembrano apparentemente violare il principio secondo il quale una causa
viene prima del suo effetto. Ad esempio, “il desiderio sessuale esiste perché
esso fa sì che le persone si accoppino e che si riproducano” sembra spiegare il
desiderio sessuale nei termini di un qualcosa che di norma viene dopo. Per
comprendere esattamente come e in quale senso tali effetti possano giocare un
ruolo nel determinare i loro rispettivi meccanismi è necessaria un’ulteriore teoria.
Nel caso dei manufatti è una precedente rappresentazione mentale dell’effetto a spiegare l’esistenza del manufatto. Suggerire questo tipo di spiegazione
causale nel caso delle funzioni naturali pone invece un antico enigma: fino a
tempi recenti l’enigma poteva essere trattato soltanto assumendo che esista un
Dio benevolmente intenzionato che di proposito ha creato i nostri meccanismi
interni, riducendo così le funzioni naturali ad uno speciale caso di funzioni dei
manufatti.
Oggi la teoria evoluzionistica fornisce una spiegazione migliore di come
gli effetti di un meccanismo possano spiegare l’esistenza di quel meccanismo
e la sua struttura. In breve, quei meccanismi che avevano effetti sull’organismo tali da contribuire al suo successo riproduttivo per un numero sufficiente
di generazioni, aumentavano in questo modo in frequenza ed erano quindi
“selezionati naturalmente”, e sono quei meccanismi che permangono negli organismi di oggi. Quindi la spiegazione di un meccanismo in termini della sua
funzione naturale può essere considerata un modo tortuoso di riferirsi ad una
spiegazione causale in termini di selezione naturale. Finché la selezione naturale è l’unico mezzo a tutt’oggi conosciuto attraverso cui un effetto può spiegare un meccanismo che avviene naturalmente e che lo determina, le spiegazioni evoluzionistiche saranno presumibilmente alla base di tutte le corrette
spiegazioni delle funzioni naturali. Di conseguenza un approccio evoluzionistico al funzionamento mentale (Buss, 1984, 1991; Wakefield, 1989a) è centrale per la comprensione della psicopatologia.
“Disfunzione” è quindi un concetto scientifico puramente fattuale. Comunque scoprire cosa, di fatto, è naturale o disfunzionale (quindi cosa è di448
sturbato) può essere difficile ed essere soggetto a controversia scientifica,
specialmente in riferimento ai meccanismi mentali sui quali sappiamo ancora
molto poco. Questa poca conoscenza è in parte il motivo dell’alto grado di
confusione e di controversia circa le condizioni che si possono considerare realmente disturbi mentali. Ma, paradossalmente, questa scarsa conoscenza sulla natura dettagliata e sulle storie causali dei meccanismi mentali rende ancor
più necessario fare affidamento su spiegazioni funzionali basate sulle inferenze circa ciò per cui i meccanismi mentali sono probabilmente stati concepiti.
A questo riguardo siamo ora ad uno stadio di comprensione che è paragonabile in qualche modo alla posizione degli antichi medici che dovevano affidarsi
ad inferenze simili nel giudicare i disturbi fisici. Ad esempio, sebbene non si
conoscesse nulla circa i meccanismi coinvolti nella vista o della storia naturale dell’occhio, quei medici compresero già, sulla base di inferenze funzionali,
che la cecità ed altre condizioni fisiche sono disturbi. Appena apprenderemo
di più sulle funzioni, selezionate naturalmente, dei meccanismi mentali i nostri giudizi sulle disfunzioni diventeranno più affidabili.
Dal punto di vista della teoria dei concetti si dovrebbe tecnicamente distinguere l’analisi concettuale del disturbo come disfunzione dannosa dalla teoria
evoluzionistica della disfunzione. Il disturbo non può essere analizzato direttamente in termini evoluzionistici perché l’analisi mira a cogliere un concetto
intuitivo ampiamente condiviso, medico e profano, che esisteva molto prima
che la teoria evoluzionistica venisse formulata e che è condivisa da molti che
non conoscono o che rifiutano la teoria evoluzionistica, come ad esempio i
cristiani fondamentalisti i quali credono che Dio abbia dato forma ai meccanismi umani. Credenti e atei sono concordi su quali condizioni sono disfunzioni
e disturbi poiché condividono la nozione sottostante di funzione come “modello esplicativo” ed utilizzano prove circostanziali per applicare quel concetto più o meno nello stesso modo, nonostante le loro teorie radicalmente divergenti su come quei meccanismi “progettati” si realizzano. Pertanto non si deve
comprendere o accettare l’evoluzione per possedere il concetto di disturbo. E’
una scoperta scientifica molto importante, non una questione di definizione,
che la selezione naturale sia il processo essenziale in grado di spiegare le funzioni e le disfunzioni. Disfunzione dannosa è il significato di disturbo, e
l’evoluzione è la teoria più incisiva sulla natura delle funzioni e delle disfunzioni.
Quindi un disturbo esiste solo quando un meccanismo interno è disfunzionale, specificamente nel senso che esso non è in grado di eseguire una delle
sue funzioni naturali (a questo punto dell’analisi la funzione naturale è impiegata in un senso intuitivo esistito per millenni, non in senso tecnico evoluzionistico). La nozione apparentemente antropomorfica della funzione di un
meccanismo biologico è analizzata in chiari termini scientifici, causali, per
indicare che certi effetti dei meccanismi biologici sono così complessi, benefici e strutturati in modo tanto elaborato che non possono essere effetti collaterali accidentali di processi causali fortuiti ma, come le funzioni dei manufatti,
ideate intenzionalmente, devono in qualche modo essere parte della spiega449
zione del perché i meccanismi sottostanti esistono e sono strutturati in quel
determinato modo. Come per i manufatti, anche di tali funzioni spesso si dice
che esse sono quello per cui sono state “designate”. Le affermazioni secondo
le quali certi effetti di un meccanismo sono utili non offrono alcuna spiegazione del meccanismo: l’utilità potrebbe essere dovuta al caso. Per contro, le
attribuzioni delle funzioni sostengono implicitamente un’affermazione esplicativa, vale a dire che l’utilità in parte spiega il meccanismo.
Più precisamente, l’analisi esplicativa della funzione naturale completa
l’analisi concettuale di disturbo. In ogni caso questa analisi non spiega come
un effetto (ad esempio pompare o vedere) possa spiegare la propria causa (il
cuore o gli occhi), né l’analisi fornisce un criterio attraverso cui si possano distinguere scientificamente le funzioni naturali da altri effetti in un modo più
preciso di quello offerto dalle intuizioni del senso comune. L’analisi porta inevitabilmente alla domanda: “Che tipo di processo sottostante potrebbe essere responsabile di questo apparente disegno nei sistemi naturali senza che vi
sia alcun ‘progettista’?” Per rispondere a questa domanda bisogna che vi sia
una teoria scientifica riguardante il come questi effetti esplicativi possano verificarsi. Il tentativo di rispondere a questa domanda porta al passo successivo
della discussione: la teoria evoluzionistica fornisce l’unico riscontro scientifico plausibile oggi esistente sul modo con cui le funzioni naturali di un meccanismo possano spiegare l’esistenza e la struttura del meccanismo stesso (le
prime spiegazioni dello stesso fenomeno includono le “cause finali” di Aristotele e le “intenzioni di Dio” di Tommaso D’Aquino). Secondo la teoria evoluzionistica, alcuni degli effetti di un certo meccanismo risultarono benèfici per
gli organismi del passato e quindi determinarono la selezione naturale del
meccanismo stesso. Di conseguenza, quegli effetti fanno parte della spiegazione dell’esistenza e della struttura dei meccanismi degli organismi di oggi.
Tali effetti, selezionati naturalmente, sono le funzioni naturali dei rispettivi
meccanismi. Questo argomento teorico porta alla conclusione che i disturbi
consistono in fallimenti dei meccanismi nell’adempiere alle funzioni per le
quali essi erano stati selezionati naturalmente.
Si potrebbe obiettare che ciò che non funziona, nei disturbi, sia talvolta
una funzione sociale che nulla ha a che fare con categorie naturali e universali. Ad esempio i disturbi della lettura sembrano essere insuccessi di una funzione sociale poiché non vi è nulla di naturale o di generato nella lettura. Sebbene l’analfabetismo coinvolga un tipo di danno molto simile al disturbo della
lettura, tuttavia esso non è considerato un disturbo. L’incapacità a leggere è
considerata indicativa di disturbo solo quando le circostanze suggeriscono che
la ragione dell’incapacità consiste nel fallimento di qualche meccanismo cerebrale ad eseguire la sua naturale funzione. Vi sono molti fallimenti ad adempiere funzioni sociali, e tuttavia essi non vengono considerati disturbi, a
meno che non siano attribuiti ad una funzione naturale fallita.
Se si scorre l’elenco dei disturbi nel DSM-IV è evidente che nel complesso
essa è una lista dei vari modi in cui qualcosa può non funzionare nelle caratteristiche, apparentemente progettate, della mente. Semplificando molto, i di450
sturbi psicotici implicano il fallimento dei processi di pensiero, che non funzionano pertanto come dovuto; i disturbi d’ansia implicano il fallimento dei
meccanismi generatori di ansia – e paura – che non funzionano per lo scopo
progettato; i disturbi depressivi implicano il fallimento dei meccanismi che
regolano la risposta di tristezza e perdita; i disturbi da comportamento dirompente dei bambini implicano il fallimento dei processi di socializzazione e dei
processi sottostanti la coscienza e la cooperazione sociale; i disturbi del sonno
implicano il fallimento dei processi del sonno a funzionare propriamente; le
disfunzioni sessuali implicano il fallimento di vari meccanismi coinvolti nella
motivazione e nella risposta sessuale; i disturbi alimentari implicano il fallimento dei meccanismi dell’appetito, e così via. C’è anche una certa quantità
di nonsense nel DSM-IV. Tuttavia, si può sostenere che nella stragrande maggioranza delle categorie sono individuabili esempi ispirati a condizioni che
anche un profano riconoscerebbe correttamente come fallimento di un meccanismo designato.
Quando distinguiamo il normale dolore dalla depressione patologica, o il
normale comportamento delinquenziale dal disturbo della condotta, o la normale criminalità dal disturbo antisociale di personalità, o la normale infelicità
dal disturbo di adattamento, o l’analfabetismo dal disturbo della lettura, o la
normale mancanza di empatia per i nemici del gruppo di appartenenza dalla
mancanza di empatia per chiunque che è tipica della personalità antisociale, o
la normale vivacità infantile dal Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività,
noi stiamo implicitamente usando il criterio del “fallimento della funzione designata”. Tutte queste condizioni – normali e anormali – sono condizioni spiacevoli e dannose. Gli effetti delle condizioni normali e patologiche possono
essere piuttosto simili dal punto di vista del comportamento, tuttavia alcune
sono considerate patologiche e altre no. Il criterio “funzione naturale” spiega
queste distinzioni.
E’ da sottolineare il fatto che anche le condizioni biologiche che oggi sono
dannose non vengono considerate disordini qualora siano considerate caratteristiche che un tempo avevano una funzione. Ad esempio la preferenza per il
gusto dei grassi non è considerata un disturbo, sebbene nel mondo ricco di cibo di oggi i grassi possano ucciderci, poiché essa è considerata una caratteristica che ci aiutava ad ottenere le calorie necessarie in un mondo, ormai lontano nel tempo, in cui il cibo era scarso. L’aggressività maschile mediamente
più alta non è considerata un disturbo di massa degli uomini, sebbene nella
società odierna essa sia ragionevolmente nociva, poiché è considerata il modo
in cui gli uomini sono stati “progettati”. Le femministe talvolta dichiarano che
gli uomini soffrono di un disturbo di massa da intossicazione da testosterone,
ma questa è generalmente intesa come una battuta e non piuttosto come un serio giudizio classificatorio (naturalmente esistono disturbi dell’aggressività; in
questo caso, come negli altri, gli individui potrebbero avere risposte disturbate
di tratti che erano “progettati”).
In breve, un disturbo mentale è una disfunzione mentale dannosa. Se
l’analisi della disfunzione dannosa è corretta allora le categorie del disturbo
451
mentale in una società offrono due informazioni. Primo, esse indicano il giudizio di valore secondo il quale la società considera quella condizione negativa o dannosa. Secondo, esse dichiarano di fatto che il danno è dovuto al fallimento della mente a funzionare come ideato; questa affermazione può essere
corretta o scorretta, ma in ogni caso rivela cosa la società pensi circa il naturale o designato modo di funzionare della mente umana.
Che dire di Foucault?
Una debolezza dei punti di vista normativo o scettico sul disturbo mentale,
punti di vista che ignorano l’oggettività della “disfunzione”, è che essi non offrono una base dalla quale costruire una critica dei criteri diagnostici della
psichiatria. Se tutti i criteri sono ugualmente non validi allora non c’è speranza di migliorare i criteri per renderli validi, ed ogni insieme di criteri non sarà
valido, così come tutti gli altri. Questo non corrisponde a come la maggior
parte di noi vede la situazione. Ad esempio noi pensiamo che un medico vittoriano conservatore fosse pienamente in errore nel classificare la masturbazione e l’orgasmo clitorideo come disturbi, che i medici sudisti anteguerra fossero ampiamente in errore nel classificare gli schiavi fuggiaschi come affetti da
“disturbo di fuga degli schiavi” (drapetomania), e che Freud fosse pienamente
in errore nel classificare le donne che non raggiungevano l’orgasmo vaginale
come disturbate. Ma se i normativisti hanno ragione, allora si deve dire che in
relazione ai valori dei loro tempi, tra cui fare diagnosi, questi erano veri disturbi e le diagnosi perfettamente corrette. Oppure, se gli scettici dell’antipsichiatria hanno ragione, allora si deve dire che queste diagnosi non sono più
sbagliate di quanto lo siano le nostre diagnosi di schizofrenia o di disturbo di
panico o bipolare. In entrambi i casi le necessarie distinzioni si perderebbero.
L’oggettività della “disfunzione” autorizza ad effettuare tali discriminazioni e a spiegare perché varie pratiche diagnostiche sono scorrette – e precisamente perché esse falliscono nel cogliere le condizioni causate da disfunzioni.
L’oggettività della disfunzione limita anche la relatività culturale del “disturbo”. Le disfunzioni definiscono possibili disturbi, e i valori culturali determinano quali disfunzioni vengono considerate disturbi. I disturbi non possono
essere prodotti interamente al di fuori dei valori.
Solo una spiegazione della natura umana può costituire la base adeguata
per una persuasiva critica sociale, per cui è solo in relazione ai bisogni dettati
dalla natura umana che si può fare l’ipotesi suggestiva che le strutture sociali
non abbiano funzionato a dovere. Avendo violato questo principio le conseguenti difficoltà di Foucault (1965, 1976) dovute al suo relativismo sono ben
conosciute e spesso sintetizzate nella frase “Dove può situarsi Foucault?”. Ciò
significa che se tutto è costruito coerentemente con la dinamica del potere –
incluso, ad esempio, il senso di giustizia e anche la preferenza del corpo per il
piacere piuttosto che per il dolore – allora qual è la base indipendente per dimostrare che un particolare ordinamento sociale è meglio di un altro?
452
Nell’ambito dei disturbi mentali sembrerebbe che analizzare il concetto di disturbo mentale riconoscendo che ci sono realmente disfunzioni mentali, nel
senso letterale di fallimenti di funzioni naturalmente designate, fornisca un
ambito in cui posizionarsi e ci consenta di fare le necessarie distinzioni.
Questo significa forse che l’approccio di Foucault in termini di analisi del
potere inscritto nei discorsi deve essere completamente rifiutato? Niente affatto. Piuttosto, una critica foucaultiana nei termini delle origini del potere e delle implicazioni di questo concetto deve essere integrata da una precedente analisi concettuale in modo che essa rispetti e sia costruita sulla natura del concetto (Wakefield, 2002b). Bisogna prima comprendere un concetto per poi poter comprendere come esso venga usato per scopi di potere.
Una volta completata l’analisi concettuale, due analisi foucaultiane tra loro
collegate della struttura concettuale possono essere intraprese e adattate
all’analisi concettuale. Primo, la domanda: “Perché questo concetto è saliente
in questo momento e in questa cultura?”. Quest’analisi situa il concetto in un
più ampio contesto storico-sociale, fornendo una genealogia foucaultiana che
spiega come un concetto, piuttosto che un altro, sia emerso e abbia organizzato il pensiero e l’azione. Ad esempio ci si dovrebbe chiedere perché il concetto di disturbo mentale, piuttosto che concetti collegati, è così importante nella
nostra cultura, e perché il disturbo mentale, più di ogni altra fonte di sofferenza, venga privilegiato rispetto alle risorse sociali disponibili per l’aiuto. Posizionando l’analisi concettuale in un contesto sociale più ampio, si ha la strategica domanda foucaultiana: “Perché questo concetto?”.
Dall’altro lato la struttura concettuale stessa è il contesto assunto per una
domanda tattica foucaultiana più dettagliata: com’è sviluppato questo concetto
nei giudizi classificatori manipolati per scopi di potere? Ogni concetto è caratterizzato da indeterminatezza, ambiguità e confini vaghi – e ciò consente ampie possibilità che i giudizi classificatori vengano manipolati in modo da avvantaggiarsi dallo sviluppo di un concetto in un modo o in un altro. Controversie sull’applicazione di concetti quali quello di disturbo mentale sono possibili perché specialmente i concetti essenzialisti sono molto astratti e molti
sono i passaggi che intervengono tra il concetto ed i concreti giudizi classificatori, tanto da offrire ampi spazi di disaccordo. Comprendere la logica del
concetto astratto sottostante è cruciale nell’analisi di simili dispute poiché è la
logica del concetto che spiega perché certe (forse fallaci) inferenze possono
sembrare sensate e altre no. Vale a dire che il concetto aiuta a spiegare la natura e le possibilità delle dispute sull’impiego dei concetti. Quindi, ad esempio, potremmo chiederci come le nuove categorie di comportamento vengono
ad essere costruite come disturbi o piuttosto ri-costruite come non-disturbi (ad
esempio introdotti o rimossi dal Manuale) nel DSM, ed il grado in cui la logica del concetto di disturbo e le prove della disfunzione versus altri processi
sociali determinano tali cambiamenti. Potremmo anche analizzare le tecniche
che vengono usate per estendere il concetto di “disturbo mentale” ad ambiti
sempre più ampi di condizioni quando sono in gioco gli interessi economici di
aziende farmaceutiche e di terapeuti – come la spinta attuale ad identificare la
453
depressione, nella pratica medica generale, come disturbo, senza riguardo alla
comprensione contestuale del fatto che la condizione sia dovuta ad una perdita
reale, e quindi possa non essere affatto un disturbo.
Il successo delle mosse tattiche fatte nel tentativo di impiegare un concetto
dipenderà dal convincere gli altri che l’impiego è giustificato. La natura ed il
successo di queste mosse dipenderà sensibilmente dalla logica del concetto e
da come le sue figure logiche possono essere sfruttate. E’ dunque solo integrando tutti e tre i suddetti livelli analitici – ovvero ponendo l’analisi concettuale o dell’evidenza tra i due livelli dell’analisi foucaultiana – che può essere
ottenuta una spiegazione sociale completa di un concetto e del suo impiego.
Cosa ne è di Szasz?
Gli scettici avanzano molte questioni pratiche, etiche ed epistemologiche
riguardanti il concetto di disturbo mentale e la sua applicazione alla psicodiagnostica. Essi sottolineano, ad esempio, che le persone etichettate come mentalmente disturbate vengono spesso stigmatizzate, che la psicodiagnosi è spesso utilizzata per scopi di controllo sociale, e che è spesso difficile dire se
qualcuno è mentalmente disturbato. Però queste questioni, legittime e importanti, devono essere separate dalle domande riguardanti la coerenza e la logica
del “disturbo” (Gorenstein, 1984; Horowitz, 1982, p. 5). Il bisogno di tenere
così separate le questioni può essere chiarito con un esempio fisico: le persone
etichettate come HIV positive sono spesso socialmente stigmatizzate, tale etichetta è spesso usata con obiettivi di controllo sociale e a causa delle imperfezioni dei test disponibili talvolta risulta difficile stabilire se qualcuno è HIV
positivo. Nonostante questi problemi “HIV positivo” è un concetto perfettamente coerente e lo status di persona HIV positiva sfortunatamente esiste. I
problemi pratici, etici ed epistemologici semplicemente non dimostrano che ci
sia qualcosa di sbagliato nel concetto di disturbo mentale.
Un altro tipo di argomento del punto di vista scettico è più puntuale, poiché esso sottolinea direttamente la natura del disturbo. Questa argomentazione
è stata avanzata più esplicitamente da Szasz (1961; vedi anche Sarbin, 1967,
1969), ma è implicita anche in molte altre posizioni scettiche. Szasz parte
dall’assunto che il “disturbo fisico” è un concetto legittimo basato su un chiaro fondamento, precisamente che un disturbo consiste in una lesione fisica,
dove il termine lesione si riferisce ad una deviazione riconoscibile della struttura anatomica. Il ragionamento continua con l’osservazione che “disturbo
mentale” è un’estensione del concetto di “disturbo fisico” all’ambito del mentale. Pertanto i disturbi mentali esistono letteralmente solo se il concetto molto
simile di disturbo che si applica alle condizioni fisiche si applica anche alle
condizioni mentali etichettate come “disturbo”. D’altra parte l’estensione di
“disturbo” alle condizioni mentali è puramente metaforica. Szasz sostiene, ancora, che “disturbo mentale” è utilizzato per etichettare il comportamento che
devia dalle norme sociali, e che il funzionamento psicologico che viene eti454
chettato come “disturbo mentale” non è accompagnato, tipicamente, da alcuna
lesione identificabile del cervello o di ogni altra parte del corpo (Szasz assume
implicitamente, qui, che nemmeno in futuro saranno trovate lesioni per spiegare queste condizioni). Pertanto il concetto di “disturbo” come “lesione” applicabile alle condizioni fisiche non è applicabile invece alle condizioni mentali ed i “disturbi mentali” non sono letteralmente dei disturbi. Szasz (1961, p.
1) conclude «non esiste un qualche cosa che corrisponda al concetto di “malattia mentale”».
La debolezza dell’argomentazione di Szasz risiede nell’inadeguatezza del
concetto di “lesione” come spiegazione del disturbo fisico. La spiegazione si
fonda su due tesi: che una lesione (o una struttura del corpo non normale) sia
una deviazione statistica dalla struttura anatomica tipica, e che un disturbo fisico sia una lesione. In ogni caso l’idea che una lesione possa essere riconosciuta direttamente dalla sua struttura anatomica deviante è scorretta. Le strutture del corpo normalmente variano da persona a persona, e molte variazioni
normali sono insolite quanto le lesioni. Inoltre alcune lesioni non sono statisticamente devianti in una determinata cultura, così come l’aterosclerosi, la
bronchite e la ritrazione delle gengive nella nostra o le devastazioni dei vermi
uncinati e la malaria in alcune altre. Quindi per riconoscere una lesione non si
tratta semplicemente di osservare deviazioni anatomiche. In secondo luogo, e
ciò è più importante, non è l’esistenza di una lesione a definire un “disturbo”.
Infine ci sono disturbi fisici per i quali non sono riconosciute lesioni anatomiche, così come la nevralgia del trigemino ed il prurito senile (Kendell, 1975).
Inoltre una lesione può essere un’anormalità non dannosa, che non è un disturbo, come quando il cuore è situato nel lato destro del corpo ma mantiene
l’integrità funzionale. Così la “lesione” spiega gli errori dei “disturbi fisici” e
ciò è coerente con la posizione degli scettici secondo la quale il concetto di
“disturbo” non può applicarsi letteralmente alle condizioni mentali.
Ma allora come riconosciamo le deviazioni che sono lesioni e le lesioni
che sono disturbi? Riconosciamo una variazione nella struttura anatomica
come lesione, rispetto ad una variazione normale, quando la variazione compromette l’abilità di quella particolare struttura a realizzare le funzioni per eseguire le quali essa era stata designata. Un simile deterioramento di uno specifico meccanismo potrebbe essere considerato come una “disfunzione parziale” (Lewis, 1967; D.F. Klein, 1978). Inoltre, riconosciamo la disfunzione/lesione parziale come disturbo solo se la deviazione nel funzionamento
della parte colpisce il benessere dell’organismo in un modo dannoso. Ad esempio, la ragione per cui le dita fuse insieme, l’albinismo e l’inversione della
posizione del cuore non sono considerati disturbi, anche se sono variazioni
anatomiche anormali, è che essi non danneggiano significativamente le persone che ne sono affette. Quindi un approccio in termini di “disfunzione dannosa” sembrerebbe spiegare i due aspetti che la spiegazione della “lesione”, così
come è posta dal punto di vista degli scettici, non può spiegare, e cioè quali
deviazioni anatomiche sono lesioni e quali lesioni sono disturbi.
Se la “lesione” è essenzialmente un concetto funzionale, allora le condi455
zioni mentali e le condizioni fisiche per la stessa ragione possono essere letteralmente disturbi, vale a dire per le loro implicazioni funzionali (Borse,
1976a, pp. 62-63). I processi mentali giocano importanti ruoli specie-specifici
nella sopravvivenza e nella riproduzione umane, pertanto non c’è motivo di
dubitare che i processi mentali siano stati selezionati naturalmente ed abbiano
funzioni naturali, come Darwin spesso sottolineava (Borse, 1976a, p. 64).
Grazie al nostro patrimonio evolutivo possediamo meccanismi fisici come il
fegato e il cuore, e per via dello stesso patrimonio abbiamo meccanismi mentali come varie disposizioni e strutture cognitive, motivazionali, affettive, personologiche, edoniche, linguistiche e comportamentali. Alcune condizioni
mentali interferiscono con la capacità di questi meccanismi ad eseguire le
funzioni per le quali essi sono stati designati. In questi casi c’è una “disfunzione parziale” del particolare meccanismo mentale. Il concetto di disturbo, se
applicato ai disturbi epatici, ai disturbi cardiaci o ai disturbi mentali, si riferisce a disfunzioni parziali che danneggiano la persona che ne è affetta. In disaccordo con le affermazioni di Szasz e di Sarbin, la nozione di disturbo mentale non è un mito basato su una cattiva metafora, ma l’applicazione letterale
all’ambito del mentale dello stesso concetto di disturbo quale “disfunzione
dannosa” applicata all’ambito fisico.
Critica ai criteri diagnostici del DSM-III e del DSM-IV
Passerò ora ad utilizzare l’analisi della disfunzione dannosa per criticare i
criteri diagnostici del DSM-IV (le stesse considerazioni possono essere fatte
in generale anche per il DSM-III). Come gli antipsichiatri, mi focalizzerò
sull’eccessiva patologizzazione di condizioni che in realtà non sono disturbi.
Per ulteriori discussioni si vedano anche Wakefield & First (2003) e Wakefield (1996, 1997a, 1998, 1999c, 2002a).
I sintomi sono certamente nocivi. L’analisi della disfunzione dannosa suggerisce che la principale causa di errori diagnostici, in particolare di falsi positivi, nel DSM-IV (ad esempio condizioni che non sono veri disturbi ma che
vengono erroneamente classificate dai criteri del DSM-IV come disturbi mentali) è probabilmente il fatto che le condizioni che rientrano nei criteri diagnostici talvolta non riescono a soddisfare i requisiti della “disfunzione”. Frequentemente si può riconoscere una disfunzione soltanto situando il comportamento nel suo contesto e vedendo se si tratta di una risposta normale, adeguata alle condizioni ambientali, o se essa risulti piuttosto da meccanismi interni andati storti. Il DSM-IV generalmente elimina il contesto dalle considerazioni sulle diagnosi e si focalizza sui sintomi e sui comportamenti, minando
così la capacità di distinguere le condizioni disturbate da quelle non disturbate
che tuttavia hanno manifestazioni superficiali simili. Fornirò ora degli esempi
di mancata validità dei criteri del DSM-IV dovuta al fatto che non soddisfano
i requisiti della “disfunzione”:
(1) I criteri per il Disturbo Depressivo Maggiore prevedono un’eccezione
456
per il lutto non patologico (fino a due mesi dopo la perdita di una persona amata i sintomi sono consentiti come normali) ma nessuna eccezione è prevista
invece nel caso di reazioni, ugualmente normali, ad altre perdite importanti
come una diagnosi medica di terminalità che riguardi direttamente la persona
od una persona da questi amata, la separazione dal coniuge, la fine di
un’intensa storia d’amore, o la perdita del lavoro ed il pensionamento. Le reazioni a questo tipo di perdite possono soddisfare i criteri diagnostici del DSMIV ma non sono necessariamente disturbi. Se la reazione di una persona ad
una simile perdita include, ad esempio, due settimane di umore depresso, la
diminuzione del piacere nello svolgere le solite attività, insonnia, stanchezza e
diminuita capacità di concentrarsi sui compiti lavorativi, allora tale reazione
soddisfa i criteri diagnostici del DSM-IV per il Disturbo Depressivo Maggiore, sebbene una simile reazione non implichi patologia più di quanto non accada nel lutto. Chiaramente, il requisito essenziale che indica la presenza di
una disfunzione in un disturbo depressivo – forse un requisito secondo il quale i meccanismi di risposta alla perdita non rispondono in modo adeguato alla
perdita come dovrebbero – non è colto adeguatamente dai criteri del DSM.
(2) Il Disturbo dell’Adattamento è definito nei termini della reazione ad
uno stressor identificabile che: 1) causa un distress marcato che è in eccesso
rispetto a quello che ci si aspetterebbe dall’esposizione a quello stressor o che
2) deteriora significativamente il funzionamento scolastico, lavorativo, o sociale. La prima proposizione “più grande di quanto atteso” fa sì che almeno un
terzo della distribuzione normale della reattività allo stress possa essere diagnosticata come disturbo e quindi non tiene adeguatamente conto delle variazioni normali. Essa non tiene conto neanche dei fattori contestuali che possono fornire buone ragioni perché una persona reagisca più intensamente di
un’altra. Il secondo criterio, quello del “deterioramento del ruolo”, porta a
classificare come disturbata anche la normale reazione alle avversità che temporaneamente compromettono il funzionamento (ad esempio una persona che
non voglia socializzare o che non si senta di andare al lavoro). Ma il ritiro
temporaneo dal normale funzionamento di ruolo spesso è esattamente il modo
in cui funzionano le normali risposte di coping o di adattamento. Anche in
questo caso i criteri contengono un’eccezione per il lutto ma non per altre reazioni, ugualmente normali, ad avversità che non siano la morte di una persona
amata. Chiaramente l’essenza di un disturbo di adattamento è che qualcosa
non ha funzionato con i normali meccanismi di coping che sono presumibilmente designati a far tornare la persona all’omeostasi, gradualmente e dopo
un periodo di ritiro, dopo gli stress o i cambiamenti nelle circostanze della vita. Questo elemento essenziale di disfunzione dei meccanismi di coping non
viene contemplato nell’insieme dei criteri del DSM-IV.
(3) La categoria del Disturbo Acuto da Stress sembra patologizzare il repertorio normale di risposte allo stress. Se un evento terribile, come una minaccia di morte, un ferimento o un rapimento, causa paura, senso di impotenza o orrore (così come tipicamente dovrebbe) e una persona mostra sintomi di
risposta allo stress (ad esempio si sente stordita e “fuori”, pensa all’evento,
457
reagisce ai ricordi dell’evento in un modo che causa distress o deterioramento) per più di due giorni, allora viene considerata disturbata. Inoltre per come
sono presentati i criteri è sufficiente che i sintomi dissociativi più estremi siano presenti mentre si sta vivendo veramente l’evento, mentre non c’è bisogno
che essi continuino dopo l’evento stesso. Dopo si dovrebbe essere stressati dai
ricordi dell’evento o continuare ad avere pensieri sull’evento, cercare di evitare quei ricordi, rimanere ansiosi e incontrare difficoltà nel modo di funzionare
soltanto per due giorni. Sembrerebbe che molte reazioni normali ad un evento
di tal genere includano questi effetti. Non c’è dubbio che alcune risposte acute
allo stress siano gravi e dannose come se fossero disturbi, tuttavia i criteri del
DSM-IV non distinguono adeguatamente queste risposte dalle normali reazioni allo stress.
(4) I criteri diagnostici per i Disturbi della Condotta autorizzano la diagnosi di disturbo per gli adolescenti che rispondono con comportamenti antisociali alla pressione dei pari, ad un ambiente minaccioso o ad abusi domestici
(Wakefield, Pottick & Kirk, 2002). Ad esempio, se una ragazza, nel tentativo
di evitare i sempre più frequenti abusi sessuali del patrigno, mente ai genitori
su dove va e rimane spesso fuori fino a tardi la notte nonostante i divieti, e
quindi, stanca, di giorno spesso non va a scuola e il suo funzionamento scolastico viene di conseguenza compromesso, ella può essere diagnosticata come
affetta da un disturbo della condotta (criteri 11, 13 e 15). I ragazzi ribelli o
quelli che finiscono nelle compagnie sbagliate, che marinano la scuola e che
ripetutamente si dedicano al taccheggio e al vandalismo hanno anch’essi i requisiti per la diagnosi. Poiché questi problemi sono conosciuti, è stato incluso
un paragrafo nella sezione “Caratteristiche collegate a cultura, età e genere”
nel testo del DSM-IV sul Disturbo della Condotta che afferma che «conformemente alla definizione di disturbo mentale del DSM-IV, la diagnosi di Disturbo della Condotta dovrebbe essere applicata solo quando il comportamento in questione è sintomatico di un sottostante malfunzionamento all’interno
del soggetto, e non è semplicemente una reazione al contesto sociale
immediato»; in esso si sottolinea inoltre che «può essere utile al clinico
considerare il contesto economico e sociale in cui i comportamenti indesiderabili si sono manifestati» (American Psychiatric Association, 2000, p. 96 ed.
or.). Poiché queste idee sono state incorporate nei criteri diagnostici, allora
molti falsi positivi potrebbero essere stati eliminati. Sfortunatamente nella
ricerca epidemiologica queste sfumature testuali probabilmente sono ignorate.
(5) Il Disturbo d’Ansia da Separazione viene diagnosticato nei bambini
sulla base di sintomi che indicano un’ansia eccessiva, non appropriata all’età,
relativa alla separazione da coloro ai quali il bambino è legato, che duri almeno quattro settimane. I sintomi (ad esempio un eccessivo distress quando avviene la separazione, la preoccupazione che un evento porti alla separazione,
la preoccupazione che le figure di attaccamento vengano danneggiate, il rifiuto di andare a scuola a causa della paura della separazione, la riluttanza a rimanere soli o senza la principale figura di attaccamento) sono proprio il tipo
di cose che i bambini sperimentano quando hanno una normale, intensa rispo458
sta di ansia da separazione. I criteri pertanto non forniscono all’utilizzatore
nessuna guida su come distinguere adeguatamente tra un vero disturbo, nel
quale le risposte di separazione sono scatenate inappropriatamente, e le risposte normali a minacce insolite che il bambino percepisce al suo legame primario, minacce dovute ad un caregiver inaffidabile o ad altri gravi sconvolgimenti. Ad esempio, in uno studio condotto sui figli del personale di tre basi
militari (Bikman et al., 1995) in servizio al tempo di Desert Storm, quando
molti genitori dovevano effettivamente partire per il Medio Oriente dove i
bambini sapevano che i genitori avrebbero potuto essere uccisi o feriti, il livello di ansia da separazione di molti dei bambini era abbastanza alto da far sì
che essi avessero i requisiti per essere diagnosticati come affetti da Disturbo
d’Ansia da Separazione secondo i criteri del DSM-IV (confrontate con le risposte alle separazioni tipiche dell’età, le loro reazioni risultarono “eccessive”), ma in realtà essi stavano rispondendo con risposte adeguate ad un ambiente altamente insolito nel quale essi avevano la preoccupazione realistica
che il genitore non sarebbe tornato (A.M. Brannan, comunicazione personale).
I bambini normali i cui attaccamenti sono minacciati nella realtà potrebbero
pertanto essere trattati come se avessero risposte di attaccamento disturbate,
piuttosto che avere riconosciuti i loro reali bisogni di attaccamento.
(6) Una diagnosi di Abuso di Sostanze secondo il DSM-IV, diagnosi che
riguarda le conseguenze negative dell’uso di sostanze, richiede la presenza di
uno qualsiasi di questi quattro criteri: scarsa performance di ruolo al lavoro o
a casa come conseguenza dell’uso di sostanze; uso di sostanze in circostanze
pericolose, quali guidare sotto l’influenza dell’alcol; problemi legali ricorrenti
legati all’uso di sostanze; o l’uso continuativo nonostante persistenti problemi
sociali o interpersonali dovuti all’uso di sostanze, come liti con i famigliari
sulle conseguenze dell’intossicazione. Questi criteri non solo non hanno validità apparente come indicatori di disturbo, essi sono anche incoerenti con la
definizione del DSM-IV di disturbo mentale, secondo la quale i “sintomi” non
devono essere dovuti a conflitti con la società. Gli arresti per attività illegali e
l’uso di droghe nonostante la disapprovazione dei membri della famiglia sono
esattamente il tipo di conflitti sociali che risultano insufficienti per avanzare la
diagnosi di disturbo secondo la definizione del DSM-IV. Poiché, secondo il
DSM, continuare ad usare sostanze nonostante le liti con il coniuge sull’uso di
alcol o droghe è di per sé sufficiente per fare diagnosi di Abuso di Sostanze,
qualora voi beviate o fumiate marijuana il vostro coniuge potrebbe tacciarvi di
avere un disturbo mentale semplicemente discutendo con voi di tale comportamento ed inoltre egli potrebbe curarvi diventando più tollerante circa il vostro essere intossicati! Anche essere arrestati più di una volta per “condotta
molesta” è un criterio sufficiente per la diagnosi, pertanto avere una diagnosi
del DSM-IV potrebbe dipendere anche dalla diligenza della polizia locale.
Quanto al criterio dell’uso in “situazioni fisicamente rischiose” un numero
molto grande di persone guida sotto l’influenza dell’alcol per molte futili ragioni, e non c’è bisogno di avere un disturbo mentale per farlo.
459
Limiti del “criterio della significatività clinica”
nell’eliminare i falsi positivi
Lo sforzo più importante del DSM-IV per migliorare in generale il problema dei falsi positivi è, in tutto il Manuale, il requisito secondo il quale i
sintomi devono causare “un distress clinicamente significativo o una compromissione nel funzionamento sociale, scolastico o lavorativo” – quello che
chiamerò “criterio della significatività clinica” – un requisito che è stato introdotto per circa la metà dei criteri. Il criterio della significatività clinica mira
a fissare una soglia di deterioramento e di distress tale da consentire di eliminare i falsi positivi, nei quali il danno per l’individuo è minimo, e in alcuni casi questo intervento aumenta la validità della diagnosi. Eppure richiedere che
vi sia un distress “clinicamente significativo” o una compromissione del ruolo
come criterio per distinguere il disturbo dal non-disturbo è tautologico poiché,
in questo contesto, “clinicamente significativo” può voler dire soltanto che la
compromissione è abbastanza significativa da comportare l’esistenza di un disturbo. Quest’affermazione pertanto non offre una guida reale per decidere se
il livello di compromissione è o non è sufficiente a comportare un disturbo.
Inoltre essa non funziona con un ampio numero di potenziali falsi positivi,
specificamente quelli in cui vi potrebbe essere danno ma non disfunzione
(Spitzer & Wakefield, 1999). Ad esempio, il bambino normale che si trovi in
un ambiente minaccioso e il cui comportamento aggressivo incontri i criteri
per il disturbo della condotta, o la ragazza normale che venga minacciata da
un teppista a scuola, e il cui apparente “mutismo” incontri il criterio del Mutismo Selettivo, sperimentano distress e compromissione significativa del funzionamento come loro normali reazioni e tuttavia essi non vengono esclusi
dalla diagnosi mediante l’uso del criterio della significatività clinica. Mentre
qui si annida ovviamente la spinosa questione che riguarda il limite oltre il
quale le motivazioni divengono così intense e rigide da essere patologiche,
sembra chiaro che in alcuni casi tali motivazioni (ad esempio non parlare allo
scopo di evitare di essere picchiati da un teppista) possono essere
perfettamente normali anche se compromettono le prestazioni e causano
distress.
Forse l’aspetto più problematico del criterio della significatività clinica è
che esso riflette un fraintendimento del problema principale sottostante i falsi
positivi. Il criterio della significatività clinica è basato sull’assunto che il modo per essere certi che una condizione è patologica è assicurarsi che essa sia
causa di un disagio significativo o della compromissione del ruolo, un assunto
che è in disaccordo con la pratica diagnostica più diffusa in medicina. I falsi
positivi del DSM-IV più frequentemente sono dovuti non al fatto che i sintomi non riescano a raggiungere la soglia della nocività ma all’incapacità dei
criteri diagnostici di indicare una disfunzione sottostante. Quindi aumentare il
livello del danno, quale il distress o la compromissione, non è sufficiente per
distinguere il disturbo dal non-disturbo. Ci sono due buoni indicatori di questo
insuccesso nello stesso DSM-IV. Primo, il potenziale falso positivo più ovvio
presente nel Manuale, il lutto “normale”, distinto dal Disturbo Depressivo
460
Maggiore, che deve essere trattato con un’affermazione aggiuntiva speciale di
esclusione ma che non viene eliminato dal criterio della significatività clinica,
che è aggiunto all’insieme dei criteri, perché il lutto normale può causare proprio tanto distress e compromissione del ruolo quanto la depressione patologica. Secondo, sebbene il criterio della significatività clinica sia stato aggiunto
ai criteri per il Disturbo della Condotta, il DSM-IV già sottolinea, attraverso
una nota nel testo, che i bambini possono soddisfare i criteri e tuttavia non essere disturbati poiché il loro comportamento antisociale potrebbe non essere
dovuto ad una disfunzione ma piuttosto alla normale reazione ad un ambiente
problematico. Chiaramente, il criterio della significatività clinica non evidenzia il problema disfunzionale.
Come speriamo che la discussione presentata abbia illustrato, il potere esplicativo dell’analisi della disfunzione dannosa è probabilmente maggiore di
quello della spiegazione rivale di “disturbo”. Essa può fornire anche una base
operativa per una critica sostanziale delle pratiche diagnostiche della psichiatria, critica che mantiene ciò che risulta sensato e respinge ciò che è eccessivo
nell’applicazione del concetto di “disturbo” alle condizioni mentali e comportamentali. Speriamo inoltre che l’analisi condotta aiuti a chiarire i fondamenti
concettuali della psichiatria in un modo che le critiche di Foucault e di Szasz
non hanno saputo fare.
Riassunto. Il concetto di disturbo mentale come “disfunzione dannosa” prevede che un disturbo
sia: (1) dannoso secondo i valori sociali; e (2) causato da una disfunzione di un meccanismo
psicologico nell’assolvere la propria funzione. La disfunzione e il danno vanno intesi in termini
evoluzionistici, e quindi sono concetti scientifici fattuali. Il disturbo è un valore ibrido e un
concetto fattuale. Il concetto di “disfunzione dannosa” quindi è a metà strada tra le posizioni
antipsichiatriche di autori come Szasz e Foucault, che liquidano le diagnosi psichiatriche come
giudizi di valore per cui non offrono alcuna critica costruttiva, e la cultura del DSM-III e del
DSM-IV. Il concetto di “disfunzione dannosa” difende la psichiatria dagli antipsichiatri dimostrando che i disturbi mentali esistono, e permette una critica dall’interno degli assunti impliciti
della psichiatria criticando i criteri diagnostici del DSM perché spesso patologizzano condizioni
normali. [Parole chiave: DSM-IV, disturbo mentale, disfunzione dannosa, psicologia evoluzionistica, filosofia della psichiatria]
Abstract. «Fact and Value in the Concept of Mental Disorder: Disorder as Harmful Dysfunction». The Harmful Dysfunction (HD) analysis of the concept of mental disorder asserts that a
disorder must be: (1) harmful, i.e., negative as judged by social values; and (2) caused by a dysfunction, i.e., by failure of a psychological mechanism to perform its function. Dysfunction and
function are to be understood in evolutionary terms, and thus are factual scientific concepts.
Thus, disorder is a hybrid value and a factual concept. The HD analysis offers a middle ground
between antipsychiatrists like Szasz and Foucault, who dismiss psychiatric diagnoses as value
judgments and hence offer no constructive critique, and institutionalized psychiatry as expressed in the DSM-III and DSM-IV. The HD analysis vindicates psychiatry from the antipsychiatrists by explaining how genuine mental disorders can exist, and offers grounds from within
psychiatry’s own implicit assumptions for critiquing DSM diagnostic criteria as often pathologizing normal conditions. [Key words: DSM-IV, mental disorder, harmful dysfunction, evolutionary psychology, philosophy of psychiatry]
461
Bibliografia
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV). Washington, DC: APA (trad. it. basata
sulla “Versione internazionale con i codici dell'ICD-10” del 1995: DSM-IV.
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 4a edizione. Milano: Masson, 1995). DSM-IV-TR (Text Revision): 2000 (trad. it.: 2001).
Ausubel D.P. (1971). Personality disorder is disease. American Psychologist, 16: 5974.
Boorse C. (1975). On the distinction between disease and illness. Philosophy and Public Affairs, 5: 49-68.
Boorse C. (1976a). What a theory of mental health should be. Journal for the Theory
of Social Behavior, 6: 61-84.
Boorse C. (1976b). Wright on functions. Philosophical Review, 85: 70-86.
Boorse C. (1977). Health as a theoretical concept. Philosophy of Science, 44.
Caplan A.L. (1981). The “unnaturalness” of aging – a sickness unto death? In: Caplan
A.L., Engelhardt H.T. Jr. & McCartney J.J., editors, Concepts of Health and Disease: Interdisciplinary Perspectives. Reading, MA.: Addison-Wesley, pp. 725-738.
Cummins R. (1975). Functional analysis. The Journal of Philosophy, 72: 741-765.
Elster J. (1983). Explaining Technical Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Foucault M. (1965). Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of
Reason (Trans. by R. Howard). New York: Pantheon.
Foucault M. (1976). Histoire de la sexualité, Tome 1. Paris: Gallimard (trad. ingl.:
History of Sexuality. Vol. 1. An Introduction. New York: Pantheon, 1978; trad. it.:
Storia della sessualità, 1: La volontà di sapere. Milano: Feltrinelli, 1978).
Gorenstein E.E. (1984). Debating mental illness: Implications for science, medicine,
and social policy. American Psychologist, 39: 50-56.
Hempel C.G. (1965). The logic of functional analysis. In: Hempel C.G., Aspects of
Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. New York:
The Free Press, 1965, pp. 297-330 (trad. it.: Aspetti della spiegazione scientifica.
Milano: Il Saggiatore, 1986).
Horwitz A.V. (1982). The Social Control of Mental Illness. Orlando, FL: Academic
Press.
Houts A.C. (2001). Harmful dysfunction and the search for value neutrality in the definition of mental disorder: response to Wakefield. Part 2. Behavior Research and
Therapy, 39: 1099-1132.
Kendell R.E. (1975). The concept of disease and its implications for psychiatry. British Journal of Psychiatry, 127: 305-315.
Kendell R.E. (1986). What are mental disorders? In: Freedman A.M., Brotman R.,
Silverman I. & Hutson D., editors, Issues in Psychiatric Classification: Science,
Practice and Social Policy. New York: Human Sciences Press, 1986, pp. 23-45.
Kirmayer J.L. & Young, A. (1999). Culture and context in the evolutionary concept
of mental disorder. Journal of Abnormal Psychology, 108: 446-452.
Klein D.F. (1978). A proposed definition of mental illness. In: Spitzer & Klein, 1978,
pp. 41-71.
462
Macklin R. (1981). Mental health and mental illness: Some problems of definition
and concept formation. In: Caplan A.L., Engelhardt H.T. Jr. & McCartney J.J.,
editors, Concepts of health and disease: Interdisciplinary perspectives. Reading,
MA.: Addison-Wesley, 1981, pp. 391-418.
Moore M.S. (1978). Discussion of the Spitzer-Endicott and Klein proposed definitions of mental disorder (illness). In: Spitzer & Klein, 1978, pp. 85-104.
Nagel E. (1979). Teleology Revisited and Other Essays in the Philosophy and History
of Science. New York: Columbia University Press.
Ruse M. (1973). The Philosophy of Biology. London: London University Press.
Sadler J.Z. (1999). Horsefeathers: a commentary on “evolutionary versus prototype
analyses of the concept of disorder”. Journal of Abnormal Psychology, 108, 3:
433-437.
Sarbin T. (1967). On the futility of the proposition that some people be labeled “mentally ill”. Journal of Consulting Psychology, 31: 447-53.
Sarbin T. (1969). The scientific status of the mental illness metaphor. In: Pong S.C. &
Edgerton R.B., editors, Changing Perspectives in Mental Illness. New York: Holt,
Rinehart, & Winston, 1969.
Sedgwick P. (1982). Psychopolitics. New York: Harper & Row.
Spitzer R.L. & Endicott J. (1978). Medical and mental disorder: Proposed definition
and criteria. In: Spitzer & Klein, 1978, pp. 15-39.
Spitzer R.L. & Klein D.F., editors (1978). Critical Issues in Psychiatric Diagnosis.
New York: Raven Press.
Spitzer R.L. & Wakefield J.C. (1999). DSM-IV diagnostic criterion for clinical significance: Does it help solve the false positives problem? American Journal of
Psychiatry, 156: 1856-1864.
Szasz T.S. (1961). The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal
Conduct. New York: Harper & Row, 1974 (Revised edition) (trad. it.: Il mito della
malattia mentale: fondamenti per una teoria del comportamento individuale. Milano: Il Saggiatore, 1966).
Wakefield J.C. (1992a). The concept of mental disorder: On the boundary between
biological facts and social values. American Psychologist, 47: 373-388.
Wakefield J.C. (1992b). Disorder as harmful dysfunction: A conceptual critique of
DSM-III-R's definition of mental disorder. Psychological Review, 99: 232-247.
Wakefield J.C. (1992c). Freud and cognitive psychology: the conceptual interface. In:
Baron J.W., Eagle M.N. & Wolitzky D.L., editors, Interface of Psychoanalysis
and Psychology. Washington, D.C.: American Psychological Association, 1992
(trad. it.: Freud e la psicologia cognitiva: la interfaccia concettuale. Psicoterapia e
scienze umane, 1994, XXVIII, 2: 33-65).
Wakefield J.C. (1993). Limits of operationalization: A critique of Spitzer and Endicott's (1978) proposed operational criteria for mental disorder. Journal of Abnormal Psychology, 102: 160-172.
Wakefield J.C. (1995). Dysfunction as a value-free concept: Reply to Sadler and Agich. Philosophy, Psychiatry, and Psychology, 2: 233-246.
Wakefield J.C. (1996). DSM-IV: Are we making diagnostic progress? Contemporary
Psychology, 41: 646-652.
463
Wakefield J.C. (1997a). Diagnosing DSM, Part 1: DSM and the concept of mental
disorder. Behavior Research and Therapy, 35: 633-650.
Wakefield J.C. (1997b). Diagnosing DSM, Part 2: Eysenck (1986) and the essentialist
fallacy. Behavior Research and Therapy, 35: 651-666.
Wakefield J.C. (1998). Meaning and melancholia: Why the DSM cannot (entirely)
ignore the patient's intentional system. In: Barron J.W., editor, Making Diagnosis
Meaningful: Enhancing Evaluation and Treatment of Psychological Disorders.
Washington, D. C.: American Psychological Association, 1998, pp. 29-72.
Wakefield J.C. (1999a). Evolutionary versus prototype analyses of the concept of disorder. Journal of Abnormal Psychology, 108: 374-399.
Wakefield J.C. (1999b). Disorder as a black box essentialist concept. Journal of Abnormal Psychology, 108: 465-472.
Wakefield J.C. (1999c). The measurement of mental disorder. In: Horwitz A.V. &
Scheid T.L., editors, A Handbook for the Study of Mental Health. New York:
Cambridge University Press, 1999, pp. 29-57.
Wakefield J.C. (2000a). Aristotle as sociobiologist: The “function of a human being”
argument, black box essentialism, and the concept of mental disorder. Philosophy,
Psychiatry, and Psychology, 7: 17-44.
Wakefield J.C. (2000b). Spandrels, Vestigial Organs, and Such: Reply to Murphy and
Woolfolk’s “The Harmful Dysfunction Analysis of Mental Disorder”. Philosophy,
Psychiatry, and Psychology, 7: 253-270.
Wakefield J.C. (2002a). Values and the validity of diagnostic criteria: Disvalued versus disordered conditions of childhood and adolescence. In: Sadler J.Z., editor,
Descriptions & Prescriptions: Values, Mental Disorders, and the DSMs. Baltimore: John Hopkins University Press, 2002, pp. 148-164.
Wakefield J.C. (2002b). Fixing a Foucault sandwich: Cognitive universals and cultural particulars in the concept of mental disorder. In corso di stampa in: Cerulo
K.A., editor, Culture in mind: Toward a sociology of culture and cognition. New
York: Routledge, 2002, pp. 245-266.
Wakefield J.C. (2003). Dysfunction as a factual component of disorder: Reply to
Houts, Part 2. Behavior Research and Therapy, 41: 969-990.
Wakefield J.C. & First M. (2003). Clarifying the distinction between disorder and
non-disorder: Confronting the overdiagnosis (“false positives”) problem in DSMV. In: Phillips K.A., First M.B. & Pincus H.A., editors, Advancing DSM: Dilemmas in Psychiatric Diagnosis. Washington, D.C.: American Psychiatric Press,
2003.
Wakefield J.C., Pottick K.J. & Kirk S.A. (2002). Should the DSM-IV diagnostic criteria for conduct disorder consider social context? American Journal of Psychiatry,
159: 380-386.
Woodfield A. (1976). Teleology. Cambridge: Cambridge University Press.
Wright L. (1973). Functions. Philosophical Review, 82: 139-168.
Wright L. (1976). Teleological Explanations. Berkeley, CA: University of California
Press.
464