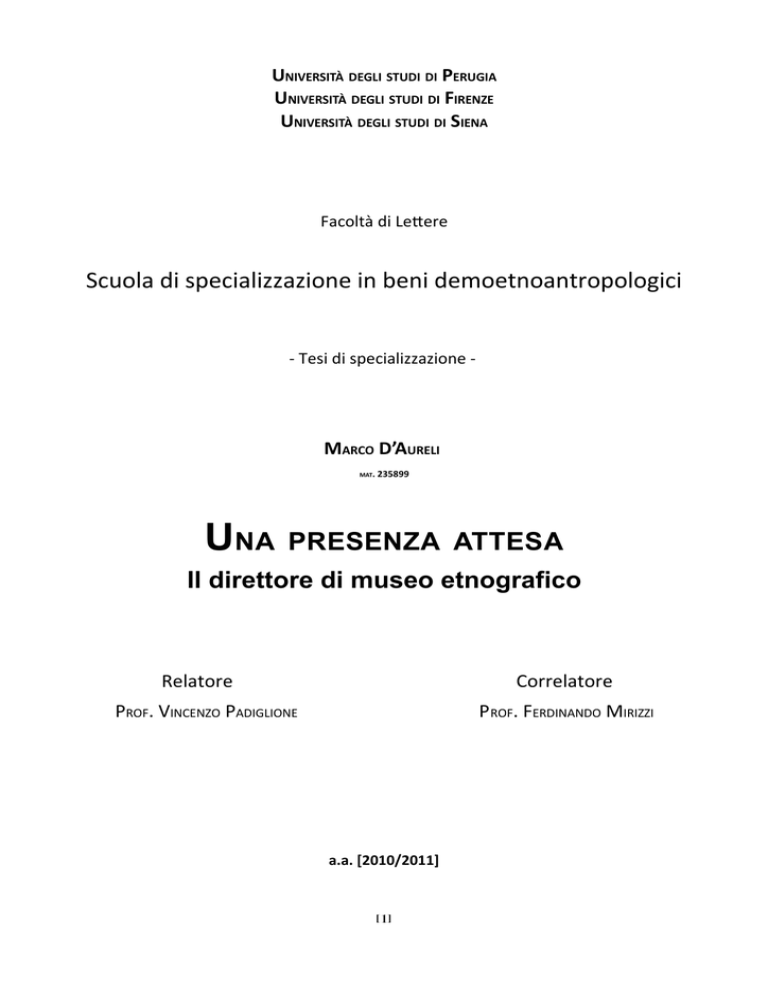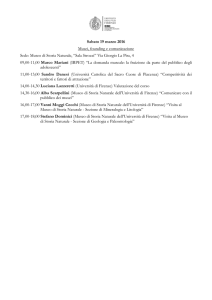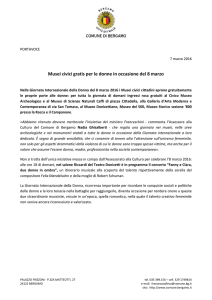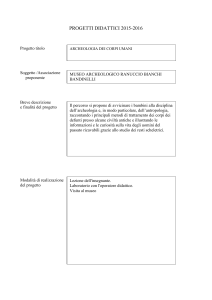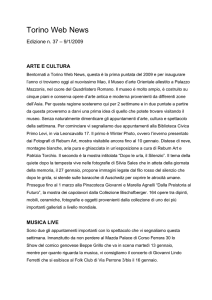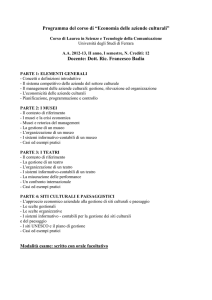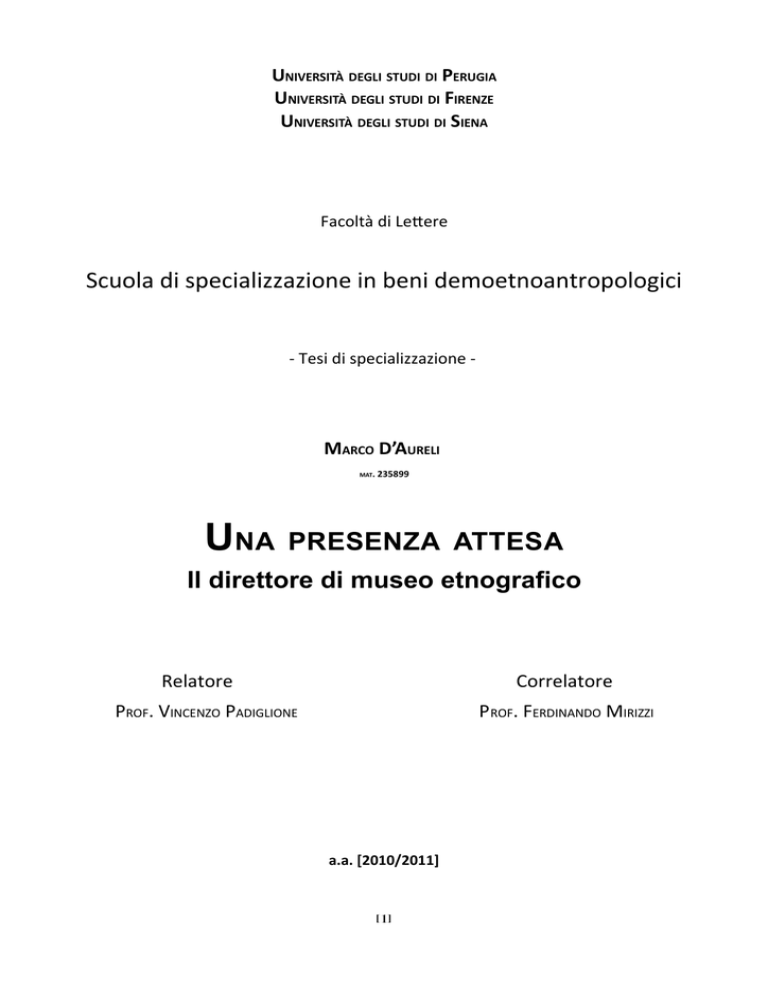
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Facoltà di Lettere
Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici
- Tesi di specializzazione -
MARCO D’AURELI
MAT.
UNA
235899
PRESENZA ATTESA
Il direttore di museo etnografico
Relatore
Correlatore
PROF. VINCENZO PADIGLIONE
P ROF. FERDINANDO MIRIZZI
a.a. [2010/2011]
[1]
UNA PRESENZA ATTESA
Il direttore di museo etnografico
- INDICE -
0.
PROBLEMA E PROSPETTIVA, p. 4
1.
I MUSEI ETNOGRAFICI: FRATTURE E CONNESSIONI. STORIE IN TENSIONE
1.1 POSIZIONI
1.2 MUSEI
A CONFRONTO,
DELLA CIVILTÀ CONTADINA E MUSEI ETNOGRAFICI,
1.3 ORDINAMENTO
1.4 MUSEOLOGIA
1.5 TAGLIO
1.6 MUSEI
2.
PER CICLI E MONUMENTI,
p. 16
p. 29
RAZIONALISTICA E MUSEOLOGIA ESTETICA,
p. 35
ANTIQUARIO E PROSPETTIVA CONTEMPORANEISTA,
E PATRIMONIO,
p. 42
p. 46
LA DIREZIONE DEI MUSEI: LEGISLAZIONI, MUSEOLOGIE E PRATICHE
2.1 MA
UN DIRETTORE È NECESSARIO?,
2.2 MUSEI
2.3 LA
p. 54
INESISTENTI E DIRETTORI INVISIBILI,
VIA LAZIALE AI MUSEI CIVICI,
2.4 SPECIALISTA E /O
2.5 PROFESSIONE
2.6 TERRENI
3.
p. 10
p. 64
MANAGER?,
p. 66
ANTROPOLOGO ,
p. 76
PRECARI,
p. 58
p. 83
VOCI DAL CAMPO
3.1 INTERVISTARE
3.2 APPUNTI
ANTROPOLOGI DIRETTORI,
DI ANTROPOLOGIA DELLE PROFESSIONI,
4. CHI LO FA, COME LO FA.
4.1
p. 86
p. 91
PERCORSI, ESPERIENZE, PROSPETTIVE
FORMAZIONE E APPRENDISTATO, p. 95
4.2 COMPETENZE
4.3 QUALE
SPECIALISTICHE E COMPETENZE GESTIONALI,
FUTURO?,
p. 110
[2]
p. 107
5.
TESI IN DISCUSSIONE
5.1
ETNOGRAFIA: IL SUO POSTO NEI MUSEI, p. 117
5.2 A SCUOLA
DALL'ENTOGRAFO,
p. 120
5.3 VERSO
UN'ETICA DELLA RESPONSABILITÀ,
p. 123
5.4 BUONE
PRATICHE E MODESTE PROPOSTE,
p. 125
BIBLIOGRAFIA, p. 129
APPENDICE, p. 135
1 INTERVISTA
CON
VINCENZO PADIGLIONE, p. I
2 INTERVISTA
CON
GIANFRANCO MOLTENI, p. XII
3 INTERVISTA
CON
MARIO TURCI, p. XXXIV
4 INTERVISTA
CON
ANTONIO RICCIO, p. LI
5 INTERVISTA
CON
PIETRO TAMBURINI, p. LXXIV
6 INTERVISTA
CON
GIOVANNI KEZICH, p. CV
[3]
0. PROBLEMA E PROSPETTIVA
«Dalla scelta e dalla gestone del personale dipende gran parte del futuro del museo» 1.
Vale la pena di sofermarsi a rifettere su questa frase. L’afermazione, in modo perentorio,
lega il futuro del museo, di ogni museo, futuro – sembra di capire – da intendere tanto in
chiave flogenetca quanto ontogenetca (il destno dell'isttuzione Museo in generale e quello
di ogni esemplare della specie), alla scelta ed alle modalità di impiego delle diverse fgure
professionali all'interno dei singoli isttut. Ma quanto questo rapporto di dipendenza diretta
ha valore di necessità? Perché, ed eventualmente in quale misura, la proposizione citata è
vera? In base a quali criteri è possibile stabilire, sia sul piano quanttatvo sia su quello
qualitatvo, la adeguatezza del numero e del proflo delle unità di personale che lavorano in un
museo alle esigenze dell’isttuto? La sflza degli interrogatvi appena elencat è al centro di una
più che avviata discussione che ha visto, e vede tutt’ora, coinvolt diversi attori e che ha
prodotto molta letteratura2, un ricco corpus comprensivo di raccomandazioni, dichiarazioni e
manuali a disposizione degli addet ai lavori e dei decisori politci. Degli strument per
orientarsi in questo settore, dunque, esistono; anche di essi si parla nel presente dossier. Si
tratta di document che, per forza di cose, tendono ad avere una portata molto ampia,
generale. In questo senso non sarà sfuggito al lettore che nella riga di testo tratta dalla
Introduzione al Manuale Europeo delle Professioni Museali, curato dal Presidente ICTOP
Angelika Ruge, e citata in apertura, il sostantvo “museo” compare privo di qualsiasi
aggetvazione. Il che lascia trasparire la volontà dell’Autrice di intendere che quella del
personale è questone basilare per il futuro di qualsiasi tpologia di museo indipendentemente
da qualsivoglia specializzazione tematca o disciplinare.
Nonostante il livello avanzato della rifessione che ha per oggetto il mondo dei musei, la
loro funzione, la lor missione, la loro organizzazione, persistono – almeno nel nostro Paese –
delle aree di opacità. Aree di opacità che investono in partcolare, ed è questo il campo che mi
interessa esplorare, i musei etnografci e che hanno a che fare, ad esempio, con il ruolo e con il
1 Angelika RUGE, Introduzione, in id. (a cura di), Manuale Europeo delle Professioni Museali, 2008, p. 11. Il documento è
consultabile online sul sito web del comitato nazionale italiano di ICOM (www.icom-italia.org), sezione EDITORIA
E DOCUMENTI – Archivio.
2 Cfr. Emilio CABASINO, I mestieri del patrimonio. Professioni e mercato del lavoro nei beni culturali in Italia , Milano, Franco
Angeli, 2005; Alessandra MOTTOLA MOLFINO e Cristiana MORIGI GOVI, Lavorare nei musei. Il più bel mestiere
del mondo, Torino, Umberto Allemandi & C., 2004.
[4]
proflo professionale dei direttori, con la formazione scientfca di quest ultmi, nonché con le
modalità di reclutamento e di conferimento degli incarichi professionali.
La questone delle professioni museali, che è l’argomento all’interno del quale si
inscrive questo lavoro, intendo afrontarla in modo mirato dedicando specifca attenzione al
ruolo del direttore. Scrive Alberto Garlandini, nella Introduzione alla Carta Nazionale delle
Professioni Museali, che quella del direttore è «la fgura centrale e inderogabile del museo. Il
direttore è il garante dell’atvità del museo nei confront dell’amministrazione responsabile,
della comunità scientfca e dei cittadini. A lui aferisce la piena responsabilità dell’attuazione
della missione e delle politche del museo, della sua gestone, della conservazione,
valorizzazione, promozione e godimento pubblico delle collezioni, nonché della ricerca
scientfca svolta dal museo. Ė il responsabile diretto e indiretto delle risorse umane e
fnanziarie, dell’attuazione delle funzioni del museo e dell’insieme delle sue relazioni interne
ed esterne»3.
Nelle pagine che seguono mi pongo l'obietvo di indagare l'oggetto di studio prescelto
in un contesto ristretto ma tutt'altro che normalizzato e statco, quello rappresentato dai
musei etnografci, e in partcolare da quelli locali: un ricco e artcolato panorama composto di
realtà con alle spalle storie diverse e legate a situazioni ed esperienze spesso molto diferent
tra di loro4. Il proposito che intendo perseguire, dunque, è quello di rifettere, non in astratto
ma nel concreto di un determinato ambito disciplinare, sulle prerogatve del direttore di
museo etnografco locale, sul ruolo che questa fgura svolge e sulle critcità connesse ad un
simile ufficio.
L’idea di afrontare questo argomento prende le mosse da motvazioni in parte
contngent e in parte connesse ad un orizzonte di più ampio respiro. Nel 2009 ho assunto la
direzione di due musei etnografci, due musei civici che si trovano in provincia di Viterbo: il
Museo della terra di Latera5 e il Museo del brigantaggio di Cellere 6. Di quest'ultmo ho avuto
modo di seguire una buona parte del processo di progettazione-realizzazione essendo stato
3 Alberto GARLANDINI, Introduzione, in id. (a cura di), Carta Nazionale delle Professioni Museali, 2008, p. 7. Il documento
è consultabile online sul sito web del comitato nazionale italiano di ICOM (www.icom-italia.org), sezione
EDITORIA E DOCUMENTI – Archivio.
4 Cfr. Pietro CLEMENTE, I Dea-musei, «AM-Antropologia Museale», anno 4, numero 12, inverno 2005, pp. 33-37.
5 Cfr. Fulvia CARUSO (a cura di), Il Museo della terra di Latera. Oggetti, riti, storie di una realtà contadina, Bolsena, Quaderni
del Sistema museale del Lago di Bolsena, 2007.
6 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE e Fulvia CARUSO, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi. Catalogo del Museo del
brigantaggio di Cellere, a cura di Marco D’AURELI, Effigi, Arcidosso, 2011.
[5]
coinvolto nello svolgimento delle ricerche necessarie al suo allestmento. La mia nomina a
direttore delle due strutture è avvenuta in virtù del lavoro svolto negli anni precedent
all'interno degli stessi isttut con il ruolo di conservatore accanto all'allora direttrice di
entrambi Fulvia Caruso. Privo di una pregressa formazione specifca in campo museologico, nel
corso di quest anni ho avuto modo di sperimentare direttamente le difficoltà e i problemi
connessi alla professione. Problemi come quello relatvo all'apprendimento del mestere, che
per forza di cose ho dovuto mutuare dall’esperienza diretta, osservando ed arrangiando il
sapere ed il saper fare degli altri (spesso, a loro volta, autoformatsi). Esiste dunque, ed il mio
caso ne è testmonianza, una questone legata al fatto che la formazione del personale che
opera nei musei etnografci avviene tutt'ora in maniera poco strutturata e sistematca, per non
dire episodica. La Scuola di Specializzazione in Beni DemoEtnoAntropologici è un primo passo
verso il superamento di questa situazione, ma molto sembra essere il lavoro ancora da fare su
questa strada.
Dal 2002, anno del conseguimento della Laurea in Lettere grazie alla discussione di una
tesi di argomento museale 7, ho partecipato – in maniera più o meno atva a seconda dei
periodi – alla vita ed alle atvità di SIMBDEA 8. In questo modo ho avuto la possibilità di
osservare da vicino il mondo dei musei DEA, di stare accanto a chi al loro interno lavora e a chi
queste isttuzioni le studia in quanto espressione del nostro mondo occidentale. Quello mio,
dunque, rispetto alla materia in esame, è lo sguardo di chi al tempo stesso è dentro ciò che
osserva, investto in prima persona delle problematche aferent l'oggetto di studio, ma anche
di chi cerca di osservare – con la distanza connaturata allo sguardo etnografco – un mondo,
un “campo” tradizionalmente inteso.
Ma c’è anche dell’altro. Da anni è aperta una vertenza con il Ministero per i Beni e le
Atvità Culturali sul tema del riconoscimento del proflo scientfco e del ruolo
dell'antropologo all'interno dei suoi organismi e delle sue artcolazioni. La comunità
antropologica, in questo senso, si è battuta apertamente riportando a volte vittorie e a volte
sconftte. Sta di fatto che al momento la guida della più importante isttuzione statale del
patrimonio demoetnoantropologico, e cioè L'Isttuto Centrale per la DemoEtnoAntropologia
7 Titolo della tesi: I giovani imparano, i vecchi ricordano. Il museo Agostinelli di Acilia, Relatore: Prof. Pietro CLEMENTE,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 2001/2002.
8 La Società Italiana per la Museografia e Beni DemoEtnoAntropologici è stata fondata nel 2001 presso il Museo degli
Usi e Costumi della Gente di Romagna di Santarcangelo di Romagna. Per conoscere l'associazione può essere utile
visitare il sito web ufficiale www.simbdea.it.
[6]
(che ha inglobato il Museo Nazionale delle Art e Tradizioni Popolari) è affidata a non
antropologi, così come d'altra parte la Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico
Etnografco "L. Pigorini". Questo sul piano delle isttuzioni centrali. A livello locale – per lo più i
musei etnografci italiani sono di pertnenza comunale, e dunque sono sogget a normatve e
linee guida di natura regionale – la questone dell'affidamento della direzione è aperta. La
Regione Lazio, ad esempio, ha adottato una legislazione che esorta i comuni a dotare i musei
civici di un direttore in possesso di ttolo di studio conforme alla specifcità disciplinare del
singolo isttuto, anche se poi non ha previsto alcuna forma di sostegno economico per fare in
modo che ogni realtà locale possa efetvamente dotarsi di un direttore e garantre al
medesimo condizioni adeguate di lavoro. Molto, dunque, anche su questo fronte resta da
migliorare.
Infne merita di essere segnalato un altro punto. Nei decenni scorsi, a partre in
partcolare dagli anni Settanta, c'è stato grande fermento sul piano delle realizzazioni museali,
su quello della produzione teorica inerente i fenomeni del collezionismo popolare nonché
della museografa antropologica e dell'antropologia museale. Tuttavia, guardando a quella
stagione non sembra possibile riscontrare tracce signifcatve di dibatto avente per oggetto la
questone del personale – specie di quello investto di incarichi diretvi – da utlizzare
all'interno dei tant musei inaugurat. Volendo porre a confronto la traiettoria e la velocità con
le quali hanno viaggiato la rifessione sui e la realizzazione dei musei etnografci, da una parte,
con quanto nello stesso periodo è stato detto e fatto a proposito delle professioni museali 9,
dall'altra, si ha la sensazione netta che su questa seconda questone si sia prodotto un certo
attardamento. Sembra cioè che siano state spese energie intellettuali – e non solo – più nello
studiare e nel realizzare musei, valorizzare collezioni, organizzare convegni sul tema della
migliore resttuzione al pubblico dei document conservat, che non in merito alla questone di
come – ad inaugurazione avvenuta – garantre la sopravvivenza e la qualità dell'operato degli
isttut, qualità di cui il direttore di un museo è – e lo vedremo meglio più avant – responsabile
e garante.
Appare chiaro, in conclusione, quanto il tema della direzione dei musei etnografci sia
9 La questione venne affrontata, per esempio, dalla Commissione Franceschini, anche se le proposte avanzate dalla
medesima non arrivarono ad essere concretizzate, cfr. Anna Maria VISSER TRAVAGLI, La prospettiva museologica, in
Fabio DONATO e Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi. Dialogo fra museologia e management, Milano,
Electa Mondadori, 2010, p. 24.
[7]
pressante per la nostra comunità scientfca, per i musei che ad essa aferiscono e per il ruolo
sociale e culturale che la prima e i secondi rivestono. Quanto sia importante dare consistenza
apprezzabile ad un ruolo tanto atteso dalla comunità degli antropologi e al tempo stesso, in
molt scenari, tanto poco defnito se non addirittura fumoso. Tramite la presente ricerca, che
nasce come elaborato conclusivo nell’ambito del percorso didatco che ho seguito presso la
prima la Scuola di specializzazione nel settore del patrimonio demoetnoantropologico ad
essere stata isttuita, mi pongo il proposito di focalizzare – fornendo dat, sintesi e
interpretazioni maturate tramite analisi di tpo indiziario – alcuni nodi problematci connessi al
ruolo, alla funzione ed al proflo del direttore di museo etnografco. Inoltre, di contribuire a
sviscerare questoni a mio avviso centrali rispetto a questa sfera di atvità che vede (o
dovrebbe vedere) protagonist i demoetnoantropologi. Ne faccio una questone di dignità
professionale e scientfca, di buona gestone di isttuzioni pubbliche e non di bieco
corporatvismo.
La prospetva entro la quale mi sono mosso per indagare il tema prescelto è stata di
carattere non esclusivamente teorico. Parte della ricerca è consistta nella realizzazione di
interviste a direttori di musei demoetnoantropologici locali fnalizzate a capire quali sono le
competenze necessarie a dirigere simili isttut culturali, quali i percorsi formatvi possibili,
quali le buone pratche, quali le esperienze utli da raccontare e mettere in valore, quali i
problemi che i direttori incontrano nel loro lavoro.
Il primo capitolo del dossier lo dedico a tratteggiare, procedendo per categorie
oppositve, in modo dialetco dunque, lo stato dell'arte circa il mondo dei musei etnografci in
Italia. L'obietvo che perseguo in questa sezione è quello di individuare le principali tendenze
che hanno animato il nostro campo negli ultmi decenni, di metterne in risalto le prerogatve,
le potenzialità ed i limit procedendo per accostament e per comparazioni. Senza alcuna
pretesa di esaustvità e completezza, afronto questo tpo di analisi con un taglio prospetco
teso a far emergere quegli element di rifessione che mi sono utli per indagare la fgura del
direttore di museo etnografco locale e che sono ad esso riconducibili in maniera diretta. Sul
piano diacronico quello che cerco di fare è ricostruire le tappe fondamentali dell'evoluzione
della rifessione maturata in campo antropologico sull'isttuzione museo nel nostro Paese, il
tutto senza tralasciare di dar conto delle principali questoni teoriche e metodologiche
dibattute a livello internazionale. L'arco temporale lungo il quale mi muovo è quello che va
[8]
dalla fne degli anni Sessanta del Novecento fno al primo decennio del 2000. Oltre a ciò dò
conto – per casi esemplari – di quanto a livello di realizzazioni concrete ha preso forma nello
stesso periodo. Sul piano sincronico, invece, lavoro alla individuazione delle principali tpologie
di museo etnografco che attualmente si afacciano sulla scena italiana e mi fermo a rifettere
su alcune questoni di portata generale che riguardano natura e funzioni delle isttuzioni di
questo tpo.
Il secondo capitolo propone una ricognizione che ha per oggetto questoni normatve e
museologiche connesse con il tema delle professioni museali. Inoltre afronta questoni di
portata più ampia che hanno a che fare con il proflo professionale dell'antropologo e con la
pratca della direzione dei musei.
Mentre nei primi due capitoli cerco di problematzzare le categorie, i poli dialetci
(musei e professioni museali) che delimitano il mio campo di interesse, col terzo passo dalla
dimensione storiografca e compilatva a quella della ricerca sul campo. Presento e
problematzzo in questo spazio la campagna di interviste condotte con i responsabili di alcuni
musei diversi tra loro per origine, statuto e dimensioni (fermo restando la scelta di isttuzioni
riconducibili ad amministrazioni locali ed escludendo quelle dipendent dallo Stato). Oltre a
rendere conto del modo in cui le interviste sono state realizzate ed a sollevare rifessioni di
tpo metodologico, suggerisco possibili chiavi di lettura e prospetve di indagine entro le quali
studiare la questone delle professioni museali, sempre con partcolare riferimento alla fgura
del direttore.
Il capitolo successivo è quello dove afronto una lettura etnografca delle interviste
realizzate. Confronto le posizioni dei direttori ascoltat, cerco di ricondurre le loro afermazioni
a scenari disciplinari e professionali più ampi, di proporre contestualizzazioni.
Il quinto capitolo, infne, è quello all'interno del quale concludo l'itnerario di rifessione
iniziato nel capitolo primo cercando di mettere a sistema quanto emerso nel corso della
trattazione, di fornire sintesi e di suggerire ulteriori spunt di approfondimento sul tema.
Dovendo sinterizzare la prospetva entro la quale si colloca questo dossier, dico che si
tratta di un contributo di museologia – dato per il tramite di una ricerca e di una scrittura
etnografca – che ha per oggetto la fgura del direttore di museo etnografco locale.
[9]
1. I MUSEI ETNOGRAFICI: FRATTURE E CONNESSIONI. STORIE IN TENSIONE
1.1
POSIZIONI A CONFRONTO
Un certo tocco di parzialità – ma diciamo meglio: un taglio prospetco – in ogni lavoro
di sintesi10 che voglia render conto di determinat fenomeni, di come quest si siano evolut nel
corso del tempo, di come determinate conformazioni di idee e pratche siano mutate, è
inevitabile. Quanto detto vale non solo in relazione alla lettura e alla interpretazione delle
vicende di cui intendo occuparmi, ma anche rispetto al problema di dove far iniziare e dove
terminare l'analisi. Questo appare vero specie nel nostro campo, dove più che vere e proprie
fratture tra epoche – che pure potrebbero essere scandite dalla pubblicazione della tale
monografa o dalla inaugurazione del talaltro museo – quello che di solito registriamo è un
progressivo slittamento di pratche discorsive, di paradigmi. Chiaramente le esigenze della
scrittura impongono attacchi bruschi e tagli discutbili: da un inizio – o da un oggetto – occorre
partre, a un traguardo – o una qualche forma di sintesi, per quanto non totalizzante – occorre
giungere. Quello che intendo fare in questa sede è ragionare su alcuni aspet e momentchiave della museografa antropologica11 e dell'antropologia museale italiana partendo dal
10 Questo excursus non pretende di avere portata esaustiva rispetto all'argomento che affronta. Fonti per una più
puntuale storiografia e lettura critica della museografia antropologica, della museologia antropologica nonché
dell'antropologia museale dagli anni Settanta ad oggi nel nostro Paese si trovano in alcuni testi tra i quali segnalo:
Alberto Mario CIRESE, Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, Torino, Einaudi, 1977; Giovanni Battista
BRONZINI, Homo laborans. Cultura del territorio e musei demologici, Galatina, Congedo Editore, 1985; Giovanni
KEZICH e Mario TURCI (a cura di), Antropologia museale. Caratteri, rappresentazioni e progetti dei musei antropologici,
demologici ed etnografci, Atti del 1° Seminario nazionale di antropologia museale, Roma-San Michele all'Adige, giugnosettembre 1993, «SM – Annali di S. Michele», n. 7, 1994; Pietro CLEMENTE, Graffti di museografa antropologica
italiana, Siena, Protagon. 1996; Pietro CLEMENTE e Emanuela ROSSI, Il terzo principio della museografa. Antropologia,
contadini, musei, Roma, Carocci, 1999; Pietro CLEMENTE, La vita come uso. Scenari epocali della museografa antropologica
italiana, in Franca DI VALERIO (a cura di), Contesto e identità. Gli oggetti fuori e dentro i musei, Bologna, CLUEB, 1999,
pp. 73-90; Mario TURCI (a cura di), Antropologia museale, numero monografico della rivista «La ricerca folklorica»,
numero 39, aprile 1999; Vincenzo PADIGLIONE, Presentazione, in Sezione di Antropologia museale dell'A.I.S.E.A.
(a cura di), L'invenzione dell'identità e la didattica delle differenze, Atti della sessione “Antropologia Museale” al II Congresso
Nazionale A.I.S.E.A. Identità differenze confitti, Roma, 28-30 settembre 1995, Milano, Edizioni ET, 1999, pp. 13-26;
Vincenzo PADIGLIONE, Poetiche dal museo etnografco. Spezie morali e kit di sopravvivenza, Imola, La Mandragora Editrice,
2008; Jean CUISENIER e Janne VIBAEK (a cura di), Museo e cultura, Palermo, Sellerio, 2002; Il patrimonio museale
antropologico. Itinerari nelle regioni italiane. Rifessioni e prospettive, Roma, Cangemi Editore, 2008.
11 Utilizzo il termine museografa nell'accezione proposta da Clemente alle pp. 29-30 della Introduzione a id. Graffti di
museografa antropologica italiana, op. cit.. Museografia, dunque, intesa come «scrive[re] con oggetti, spazi, sequenze
significative, e de-scrive[re] forme antropologiche della vita. [...] museo come sforzo di dire, di raccontare, di far
capire attraverso codici specifici». L'aggettivazione, l'utilizzo della parola “antropologica”, rimanda ovviamente allo
specifico quadro disciplinare entro cui tanto il saggio di Clemente quanto il presente dossier si inseriscono. Per
antropologia museale, sempre sulla scorta dello stesso Autore, intendo la «rifessione antropologica sul museo come
spazio, banca, monumento, rito, forma della nostra cultura»; cfr. anche Vincenzo PADIGLIONE, Presentazione, op.
cit., pp. 17-22; Giovanni KEZICH, Il museo selvaggio. Note per uno studio di antropologia museale, in Giovanni KEZICH e
Mario TURCI (a cura di), Antropologia museale, op. cit., p. 51. Su museografa e museologia cfr. anche Pietro C. MARANI
[10]
descrivere genesi e caratteristche dei musei di cui attualmente sono responsabile e che
conosco meglio. Attraverso la presentazione del Museo della terra di Latera, del Museo del
brigantaggio di Cellere e la loro comparazione solleverò questoni di portata generale che
andrò successivamente ad analizzare con maggiore puntualità.
Il Museo della terra di Latera (Vt) è stato inaugurato nel maggio del 1999 12. La prima
parte ad essere stata allestta è quella collocata al piano terra della grancia di San Pietro e
dedicata all'esposizione di una parte della collezione 13 di ogget raccolt a partre dagli anni
Settanta del Novecento da Luigi Poscia, bracciate agricolo del paese altolaziale. Nel 2003 poi, è
stato inaugurato uno spazio – collocato fsicamente al piano superiore del fabbricato storico –
dedicato ai beni immateriali ed in partcolare alla resttuzione, tramite multvisioni e apparat
di difusione acustca, di document audiovisivi e fotografci relatvi a feste, narratva di
tradizione orale, giochi14. Ci si può leggere, in questo partcolare ampliamento del percorso
museale, la progressiva afermazione e riconoscimento, in ambito internazionale e poi anche
italiano, della specifcità dei beni immateriali 15. Inoltre, i document audiovisivi fruibili lungo
all'interno della Galleria delle processioni attestano il lavoro di documentazione che, seppur
con fatca, il Museo compie durante il corso dell'anno rispetto al suo territorio di riferimento.
Tutto all'interno del Museo ruota intorno alla terra, intesa non solo come elemento alla
base della produzione agricola, dell'economia e delle relazioni sociali del posto, ma come
elemento simbolico forte, metafora di sentment di appartenenza. In ossequio alla Missione
che orienta l'azione dell'isttuto, il Museo di Latera mette in campo costantemente iniziatve
che lo rendono non solo luogo di raccolta, conservazione e valorizzazione, ma sopratutto
strumento di conoscenza del territorio e di confronto critco con le esigenze, le funzioni e gli
12
13
14
15
e Rosanna PAVONI, Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo, Venezia, Marsilio, 2009, cap.
1, e Alessandra MOTTOLA MOLFINO, Il libro dei musei, Torino, Umberto Allemandi & C., 1998, cap. 6.
Fulvia CARUSO (a cura di), Il Museo della terra di Latera, op. cit.. Il progetto generale, edilizio e di allestimento è stato
opera dell'architetto Lorenzo GREPPI, la consulenza scientifica è stata fornita da Luciana MARIOTTI, all'epoca
antropologa del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma.
Sulla collezione Poscia cfr. Fulvia CARUSO (a cura di), Chi lavora sotto un tetto è benedetto. Artigianato a Latera nel Ventesimo
secolo, Latera, 2004.
In relazione a questa specifica categoria di beni, e più in generale sul tema dei beni culturali nel campo degli studi
demoetnoantropologici cfr. Gian Luigi BRAVO e Roberta TUCCI, I beni culturali demoetnoantropologici, Roma, Carocci,
2006. Il progetto di allestimento di questa sezione è stato curato da Fulvia Caruso e Giulia Monaci, che hanno anche
realizzato le ricerche.
Nello stesso anno, il 2003, a Parigi La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, scienza e la cultura (UNESCO) ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale. Sulla individuazione e corretta denominazione di questa tipologia di beni cfr. Alberto Mario CIRESE,
Beni immateriali o beni inoggettuali?, in «AM-Antropologia museale», anno 1, numero 1, maggio 2002, pp. 66-69 ed
anche id. Beni volatili, stili, musei. Diciotto altri scritti su oggetti e segni, Prato, Gli Ori, 2007.
[11]
interessi locali.
Attualmente, e in conformità con quanto previsto dall'impianto conferito al percorso
allesttvo, il Museo della terra è artcolato in tre grandi nuclei: la collezione Poscia, lo spazio
dedicato ai beni immateriali, l'orto-frutteto esterno. Il piano terra è consegnato alla cultura
materiale. Al suo interno gli ogget sono raccolt attorno a tre poli concettuali che
corrispondono al fuori (atvità del bosco e della campagna, luogo della produzione delle
materie prime), al dentro (casa e bottega, luogo della trasformazione delle materie prime in
prodot semilavorat o fnit) e infne allo scambio. Diciotto bacheche aperte, ognuna delle
quali avente carattere monografco, illustrano, tramite ogget esemplari e senza la pretesa di
esaurire un intero ciclo di produzione, mesteri artgiani, lavori agricoli o aspet della vita
domestca. Ogni teca è abbinata ad una gigantografa tratta da foto d'epoca (in parte
provenient da archivi locali, in parte tratte da Il lavoro dei contadini16), una immagine di forte
impatto evocatvo alla quale è affidato il compito di fornire una sintesi visiva del contesto
all'interno del quale i repert espost erano originariamente inserit. Completano gli apparat di
contestualizzazione le trascrizioni di part di intervista e test prodot dai progetst e dai
ricercatori nel corso delle indagini condotte preliminarmente all'apertura del Museo.
Lo spazio di fuori è dedicato a documentare i modi partcolari in cui a Latera ha preso
forma il rapporto uomo-ambiente ed è stato modellato il paesaggio. Inoltre, dato che la
grancia faceva parte di un complesso conventuale, sempre nel giardino i progetst 17 hanno
ritenuto legitmo collocare un piccolo di giardino dei semplici con esemplari di piante
aromatche e medicinali.
Infne, altre sezioni sono costtuite dalla Mostra permanete delle chiavi e serrature
artigianali, una esposizione inaugurata nel 2007 a seguito del lavoro di riordino dell'inventario
del Museo, e della Parete del collezionista, fatta allestre a Luigi Poscia secondo il proprio gusto
estetco e secondo i propri criteri di accostamento degli ogget. Una sala attrezzata per le
proiezioni consente la fruizione di documentari, flm e rappresenta lo spazio entro il quale il
Museo ospita le atvità che il medesimo, adempiendo al suo ruolo di isttuto culturale,
16 Paul SCHEUERMEIER, Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Svizzera italiana e
retoromanza, a cura di Michele DEAN e Giorgio PEDROCCO, Milano, Longanesi, 1981, 2 voll.
17 A livello botanico la progettazione è stata curata da Gianluca Forti, direttore del Museo del fiore di Torre Alfina,
fraz. di Acquapendente (Vt).
[12]
organizza periodicamente (conferenze, performance di improvvisazione poetca).
Il Museo della terra, in defnitva, nasce per mettere in valore, secondo criteri maturat
all'interno del mondo della museografa antropologica, una collezione di ogget che
rimontano alla prima metà del Novecento e hanno a che fare con la vita domestca e coi lavori
agricoli pratcat dagli uomini e dalle donne a Latera. Una raccolta nata per opera di un
“proliferatore locale”, uno di quei «benemerit di possibili risorse documentarie e
immaginatve per le generazioni future»18 che la storia recente del nostro Paese ha conosciuto
e grazie al cui lavoro sono nat moltssimi dei piccoli musei che raccontano le condizioni di vita
di un passato – di fatto – prossimo, ma quanto mai lontano nella percezione.
Il Museo vive in quest anni difficoltà legate in parte al contesto sociale all'interno del
quale è inserito e in parte e motvi congiunturali – la crisi 19 – più ampi. Latera è un paese
soggetto a forte spopolamento 20, l'età media dei resident è alta e per il futuro sono previst
tagli nell'erogazione dei servizi essenziali 21. A tutto ciò va aggiunto che la struttura
architettonica che ospita l'allestmento, seppur ristrutturata a metà anni Novanta, risale
all'anno Mille e necessita di contnui intervent di manutenzione. Nonostante queste difficoltà,
tuttavia, il Museo nel corso degli ultmi tre anni è riuscito a produrre ricerche 22 e a promuovere
atvità culturali23 ad ampio raggio e di qualità elevata.
Mentre il Museo della terra di Latera nasce per valorizzare una collezione, e veicolare
tramite la sua messa in forma una lettura partcolare della storia recente della comunità
18 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, in Pietro CLEMENTE e Emanuela ROSSI, Il terzo principio della
museografa, op. cit., p. 31.
19 A proposito della nozione di crisi, nozione obiettivamente infazionata in questi mesi, conviene tenere bene a mente
quanto scrive Fabio Dei a proposito della nozione di Grande Trasformazione, spesso chiamata in causa dagli antropologi
a proposito dello studio della cultura popolare ed anche dei musei (cfr. il paragrafo 1.1 del presente dossier). La
sensazione è che, al pari della prima, la nozione di crisi «non importa quanto storicamente fondata, [abbia] natura
indicale, come dicono gli etnometodologi: [sia] cioè una categoria che noi assumiamo come attori e non (o oltre che)
come studiosi. In questo senso è pregiudiziale, e dovremmo esercitare su di essa un certo dubbio invece di portarcela
dietro come metanarrativa o master trope che sottende le nostre rappresentazioni» del mondo che stiamo vivendo, cfr.
Fabio DEI, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi Editore, 2007, p. 13.
20 Cfr. dati ISTAT 1991 (1150 residenti) – 2001 (1023 residenti) – 2010 (951 residenti) .
21 In paese non ci sono più scuole dal 2010 e in questi ultimi mesi si è iniziato a parlare della chiusura della locale
Stazione dei Carabinieri nonché dell'ufficio postale. Gran parte delle risorse del Comune sono impegnate nei servizi
di assistenza agli anziani.
22 Cfr. Fulvia CARUSO e Marco MARCOTULLI, Lanterne di fede. Riti e canti della settimana santa a Latera, DVD, Inf.o.l.
2010; Marco D'AURELI e Marco MARCOTULLI, Il pranzo del Purgatorio di Gradoli, DVD, Inf.o.l. 2011; Fulvia
CARUSO, Suoni, canti, rumori. Il paesaggio sonoro del territorio di Latera, Bolsena, Quaderni del Sistema museale del Lago
di Bolsena, 2011.
23 Nel 2011 il Museo ha ospitato un ciclo di conferenze di Etnoarcheologia organizzato dalla Associazione Italiana di
Etnoarcheologia di Roma;
Nostalgia - Processo a un clandestino, di Mohamme' Ba & Massimiliano Andreo, uno
spettacolo realizzato nell'ambito del progetto Anima&Terra curato da Andrea Bargna; un incontro interregionale di
poesia a braccio; la proiezione del film di Paolo Bianchini Il giorno, la notte. Poi l'alba e altre piccole iniziative distribuite
lungo il corso dell'anno.
[13]
laterese, il Museo del brigantaggio di Cellere nasce senza una collezione precosttuita 24 e
attorno ad un problema storico-sociale, il brigantaggio per l'appunto 25. Inaugurato a settembre
del 2007, il Museo è collocato all'interno di un ex mattatoio comunale. L'isttuto ofre una
comprensione del brigantaggio maremmano attraverso la lettura della vicenda di Domenico
Tiburzi, capobanda cellerese, in un frangente preciso, il 1893, anno del maxiprocesso di
Viterbo ai manutengoli del brigante Tiburzi e del suo sodale Luciano Fioravant. Il tessuto
narratvo che connette le diverse sezioni dell'allestmento è fornito dal reportage Nel regno di
Tiburzi26 scritto dal giornalista Adolfo Rossi. Lungo il percorso espositvo sono disseminate
citazioni tratte dal medesimo volume ma trattate, anche dal punto di vista grafco, in modo
tale da rendere evidente al visitatore il lavoro di interpretazione fatto sul testo, quel lavoro di
decostruzione teso a far emergere le strategie retoriche, le poetche e le politche 27 implicite
nella scrittura, per arrivare a cogliere e comprendere tramite quali lent Adolfo Rossi
osservava, interpretava e “costruiva” negli artcoli che scriveva ad uso dei suoi lettori, il
fenomeno brigantaggio.
Un allestmento, quello del Museo del brigantaggio, di fortssimo impatto scenografco
giocato sulla presenza di un simulacro di treno (espressione della Modernità incipiente alla
fne del XIX secolo e tradita sul nascere) e del bosco (la Tradizione). Un percorso artcolato
come un ipertesto che aspetta di essere atvato dai visitatori, uno spazio esperienziale
all'interno del quale aprire casset, scovare connessioni, atvare ascolt audio, toccare ogget.
Un luogo denso che coniuga il rigore nell'analisi delle font coeve al brigantaggio con la
leggerezza, la potenza evocatva e – in qualche caso – l'ironia delle installazioni etnografche 28.
24 Lungo il percorso espositivo sono messi in mostra un numero piuttosto limitato di reperti storici, documenti, libri e
giornali, armi; si tratta di oggetti che sono stati acquistati sulla base di un preciso disegno, che svolgono spesso una
funzione evocativa e che risalgono all'anno a cui fa riferimento l'intero allestimento. Sul ruolo degli oggetti all'interno
dei musei cfr. Antonio AIMI I frutti puri impazziscono ma gli ibridi sono sterili, «AM-Antropologia Museale», anno 1,
numero 1, 2002, pp 25-29. Quella di Aimi è una posizione molto distante da quella degli allestitori del Museo del
brigantaggio. Sostiene l'Autore, infatti, che «un dato che in ogni caso non dovrebbe essere messo in discussione è la
centralità dell'oggetto, perché i musei, pur definiti in migliaia di modi bizzarri e creativi, soprattutto in questi ultimi
tempi, sono spazi che contengono oggetti. Un museo senza oggetti è semplicemente un non museo, è il surrogato,
più o meno interessante, di un libro illustrato, di una pagina di internet, di una Disneyland edificante, di un
happening», p. 26. La questione è estremamente complessa ed articolata, ed è al centro di un dibattito che in questa
sede può essere soltanto segnalato.
25 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE e Fulvia CARUSO, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi, op. cit.. Il progetto, il
coordinamento scientifico museografico e la co-realizzazione delle installazioni espositive sono opera di Vincenzo
PADIGLIONE e di Fulvia CARUSO, mentre il progetto museografico integrato e le scenografie espositive è stato
realizzato dall'architetto Lorenzo GREPPI.
26 Adolfo ROSSI, Nel regno di Tiburzi, Roma, Perino, 1893.
27 Cfr. James CLIFFORD e George E. MARCUS, Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell'etnografa, Roma, Meltemi, 2005.
28 Su questi tema cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Installazione etnografca: un genere di comunicazione visivo, in «AM-
[14]
Se il piano terra del Museo è incentrato sulle font scritte, il piano superiore dà conto di un
altro aspetto dei brigant, il loro essere stat non solo personaggi storicamente esistt ma
anche fgure che hanno vissuto (e vivono tutt'ora) nell'immaginario delle persone che abitano
le maremme29. Tre stanze allestte come piccoli set teatrali fanno da scenografa alla
narrazione di storie che resttuiscono i tre volt del brigante Tiburzi, il suo essere “livellatore” 30,
vendicatore ma anche uomo a cui la memoria dei testmoni attribuisce notevole senso
dell'umorismo. Al piano terra, infne, è collocata La locanda dei briganti, uno spazio allestto in
modo tale da citare l'arredamento di un agriturismo, uno dei tant che a cavallo tra la provincia
di Viterbo e quella di Grosseto recano nel nome il brigante o comunque ne evocano
l'immagine31. Un ambiente dedicato a documentare il processo di patrimonializzazione della
fgura del brigante, processo di cui il Museo è al tempo stesso spettatore distaccato,
osservatore, ma anche attore tra gli altri atvi sulla scena.
Le diferenze tra i due musei, alcune autoevident ed esplicite, altre meno immediate da
cogliere, sono molte. Sono diferenze che riguardano l'impostazione generale (museo locale
generalista vs museo con taglio decisamente tematco, museo di ogget vs museo narratvo32),
le scelte estetche, il livello di rifessività 33 che ha caratterizzato le ricerche preliminari
all'allestmento e che quest'ultmo lascia percepire. Il fatto è che tra la progettazione e la
realizzazione del primo e la progettazione e realizzazione del secondo è passato un lasso
signifcatvo di tempo. È vero che il semplice calcolo matematco ci resttuisce una diferenza
cronologica di appena un lustro, ma indiscutbilmente la distanza generazionale che passa tra i
Antropologia museale», anno 8, n. 23/24, autunno-inverno 2009, pp. 99-101.
29 Sull'utilizzo della desinenza in e (maremme) in sostituzione di quella più comune in a (maremma) cfr. Antonello
RICCI, Maremme in leggìo, Manziana, Vecchiarelli editore, 2000.
30 Nel 2006, a ridosso quindi dell'inaugurazione del museo, il «Corriere della Sera» pubblica a p. 7 un articolo di
Simona De Santis dal titolo Domenichino, un Robin Hood della Maremma, cosa che che dà ben risalto a come
l'immaginario contemporaneo riconosca a Tiburzi anche la fama di benefattore dei poveri.
31 Nel tentativo di promuovere il l'istituto è stato avviato un progetto tendente a stabilire un sistema di agevolazioni
economiche tra Museo ed attività commerciali e ricettive a marchio brigante, o comunque ad esercizi pubblici sparsi
sul territorio di riferimento del Museo. L'operazione che è stata avviata prevede la messa a punto di un sistema di
fidelizzazione basato su sconti di cui possono beneficiare coloro i quali entrano al museo con una ricevuta dei locali
convenzionati o viceversa. Senza parlare dell'attenzione che verso il Museo hanno manifestato associazioni,
collezionisti e soggetti interessati, a vario titolo, ad allestire spettacoli o performance di altro tipo sul tema.
32 Cfr. Pietro C. MARANI e Rosanna PAVONI, Musei, op. cit., pp. 59-64
33 «Favorire un atteggiamento rifessivo significa per il museo porsi come centro di ricerca e documentazione offrendo
percorsi interni ed esterni di approfondimento invitando in libertà il visitatore a entrare in contatto con fonti,
problemi, e strumenti interpretativi», Vincenzo PADIGLIONE, Storie contese e ragioni culturali. Catalogo del Museo
demoetnoantropologico del brigantaggio di Itri, Itri, Odisseo, 2006, p. 75. Sul tema della rifessività cfr. id.,
Interpretazione e differenze. La pertinenza del contesto, Roma, Edizioni Kappa, 1996, cap. 1 Usi della rifessività in antropologia, e
Vincenzo PADIGLIONE e Sabina GIORGI (a cura di), Etnograf in famiglia. Relazioni, luoghi e rifessività, Roma,
Edizioni Kappa, 2010.
[15]
due è rilevantssima.
Il Museo della terra è un museo il cui progetto e la cui realizzazione coincidono con la
fase matura della museografa antropologica di stampo tradizionale, razionalistco, anche se il
suo completamento è avvenuto in un periodo in cui si iniziavano a scorgere i primi segnali di
un cambiamento di paradigma che si sarebbe compiuto nel giro di pochi anni.
Indiscutbilmente il processo che ha portato alla formazione della collezione che ne sta alla
base ricalca sostanzialmente, e coincide cronologicamente 34, con un fenomeno che la
letteratura antropologica conosce bene e ha descritto con grande puntualità. Luigi Poscia
racconta di aver iniziato a raccogliere strument del lavoro contadino nel momento in cui il
suocero smise di allevare di vacche e decise di chiudere la stalla. A quel punto, quando si trattò
di vuotare il fenile, Luigi decise di conservare per sé alcuni degli strument in esso contenut e
fnì con esporli all'interno di una cantna dando così inizio alla sua atvità di collezionista,
atvità destnata a protrarsi e ad allargarsi nel corso tempo. La storia della passione
collezionistca di Luigi Poscia va letta non in chiave individuale, come la più o meno originale
“mania” di una eccentrica persona, ma come un capitolo di una dinamica sociale e culturale di
ben più ampio respiro – la cosiddetta musueografa spontanea dal basso – che ha portato alla
nascita di moltssimi musei della civiltà contadina; musei che oggi sono presi in carico, a diversi
livelli – dalla progettazione alla direzione alla lettura critca –, dalle discipline
demoetnoantropologiche.
1.2 MUSEI DELLA CIVILTÀ CONTADINA E MUSEI ETNOGRAFICI
«In Italia i censiment regionali dei musei negli anni Settanta registravano un contnuo
aumento di nuove piccole realtà sopratutto locali e soprattutto devote alla cultura popolare» 35
scrive Alessandra Mottola Molfno. In quegli anni vengono costtuite molte collezioni di ogget
34 Sandra Puccini fa notare che, rispetto alle regioni dell'Italia del nord, il Lazio si è affacciato sul mondo del
collezionismo etnografico un po' in ritardo, a partire dagli anni Ottanta e in maniera più massiccia negli anni
Novanta, cfr. Sandra PUCCINI, Il Lazio e i suoi musei etnografci. Tra ritardi e recuperi, persistenze e trasformazioni, in Sandra
PUCCINI, Pier Luigi CATALDI e Maria Teresa BRANDIZZI, I musei etnografci del Lazio. Collezioni, raccolte e musei
della cultura contadina, Viterbo, Agnesotti, 2002, in particolare pp. 11-14.
35 Alessandra MOTTOLA MOLFINO, Il libro dei musei, op. cit., p. 47. Sono anni, quelli, caratterizzati da forti tensioni
che attraversano il panorama museale italiano. Con la fine del secondo confitto mondiale il museo, «“documento
globale” della storia della società» (ibid., p. 9) diviene oggetto di attenzione e di progetti di rinnovamento tesi a
recidere un senso di continuità con un passato percepito come superato e da superare. Cfr. Anche Lanfranco BINNI
e Giovanni PINNA, Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal '500 a oggi, Milano, Garzanti, 1989 e Adalgisa
LUGLI, Museologia, Milano, Jaca Book, 1996.
[16]
di cultura materiale popolare con lo scopo di conservare testmonianza, traccia tangibile, di
quella che era stata la realtà socio-economica e culturale dell’Italia del periodo antecedente il
boom economico. Raccolte che prendono forma grazie al lavoro di «ex contadini e non più
nobili o intellettuali amant delle identtà locali o nostalgici del buon tempo antco»36, come era
avvenuto all'inizio del Novecento 37. Una proliferare di collezioni e di musei che si avvia e si
propaga non a seguito di proget concordat o di campagne pianifcate a tavolino, bensì
spontaneamente, tanto che per descrivere il fenomeno si è cominciato a parlare, a partre
dagli stessi anni in cui esso prendeva forma, di «museografa spontanea degli ogget di cultura
materiale»38, o anche di museografa spontanea di matrice contadina o dal basso39. Il processo
avviatosi in quel frangente, e che è poi proseguito ben oltre, ha assunto nel tempo caratteri
veramente considerevoli, almeno sul piano quanttatvo. Gli estensori della Guida ai musei
etnografci italiani40, nel 1997, registrano la presenza di cinquecento musei etnografci sul
territorio nazionale, mentre da un precedente conteggio realizzato nel 1985 ne risultavano
circa centocinquanta. Tale è stata la portata di questo incremento – crescita che si è protratta
per un lungo periodo di tempo – che gli autori si sono sentt legitmat ad esprimersi nei
seguent termini: «sicuramente il sorgere spontaneo, in un certo senso plebiscitario, in solo
qualche decennio di centnaia e centnaia di musei e collezioni di questo tpo, la collocazione,
36 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, op. cit., p. 29.
37 La storia del collezionismo di oggetti espressione di culture subalterne interne all'Italia rimanda a precorritori quali
Giuseppe Pitrè, Lamberto Loria e la folta schiera di raccoglitori sparsi sul territorio nazionale che aiutarono
quest'ultimo nella costituzione della collezione alla base del Museo di etnografia italiana di Borgo San Jacopo a
Firenze, istituito nel 1906, e poi della Esposizione Universale di Roma del 1911. Su queste vicende cfr. Sandra
PUCCINI, L'itala gente dalle molte vite. Lamberto Loria e la Mostra di Etnografa italiana del 1911, Roma, Meltemi Editore,
2005, e poi Giuseppe COCCHIARA, Storia del folklore in Italia, Palermo, Sellerio, 1981, in particolare pp. 234-248.
Notizie su uno dei referenti locali collaboratori di Loria, Giuseppe Bellucci, si trovano in Giancarlo BARONTI, Tra
bambini e acque sporche. Immersione nella collezione di amuleti di Giuseppe Bellucci, Perugia, Morlacchi, 2009.
38 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, op. cit., p. 29.
39 Alcuni studiosi invitano ad un utilizzo cauto e maggiormente rifessivo di questa categoria; per una sua lettura critica
cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Piccoli etnografci musei, in id. Poetiche dal museo etnografco, op. cit., in particolare le pagg.
146-148. Sulla opportunità di sostituire l'espressione “dal basso” con “dall'interno”, vedi Sandra PUCCINI, Il Lazio
e i suoi musei etnografci, op. cit., p. 19. Una ulteriore proposta, particolarmente pertinente, è quella di parlare, in
relazione al contesto che stiamo analizzando, non di «vera e propria museografia antropologica semmai – volendo
dare una definizione – di “museografia rurale spontanea”», vedi Pietro CLEMENTE, Museografa estetica,
comunicazione, in id. Graffti di museografa antropologica italiana, op. cit., p. 148, dove si puntualizza sul fatto che «lo
sviluppo di questa museografia è esso stesso un fenomeno antropologico di notevole rilievo». Sulla questione – non
banale – delle denominazioni tornerò più avanti.
40 Roberto TOGNI, Gaetano FORNI, Francesca PISANI, Guida ai musei etnografci italiani. Agricoltura, pesca, alimentazione
e artigianato, Firenze, Leo S. Olschki, 1997. I risultati di un ulteriore censimento dei musei etnografici aggiornato a
epoca più recente sono stati pubblicati all'interno del volume Il patrimonio museale antropologico, op. cit.. A p. 7 della
stessa opera Valeria Cottini Petrucci sottolinea come il processo di incremento dei musei etnografici non abbia
mostrato battute d'arresto neanche nell'intervallo di tempo intercorso tra l'edizione 2004 e l'edizione 2008
dell'opera.
[17]
perfno in salot e negozi, di ogget rurali, costtuisce il più straordinario processo museale di
tut i tempi»41. È a questa defagrazione, avvenuta tanto sul piano numerico quanto su quello
della difusione geografca, che si riferisce Giovanni Kezich quando, nel tentatvo di elaborare
una sorta fenomenologia del collezionismo popolare e della conseguente museografa
spontanea42, parla di museografa selvaggia43. Una museografa, spiega Kezich, legata a
personaggi – i collezionist, «l'“anima” del museo stesso» – dotat di profondo carisma; una
museografa di impostazione prevalentemente ergologica e georgologica, caratterizzata da
allestment non troppo elaborat e attraversata da confit con le autorità locali (spesso
accusate di scarsa attenzione nei confront dei proget in corso di realizzazione). Quello che
risulta accomunare le raccolte che sono state costtuite in quegli anni è il fatto che esse
documentano «ogget del lavoro e della vita quotdiana (tecnologia del riscaldamento, della
trasformazione alimentare, del trasporto, dell’allevamento dei bambini ecc.) dotat di un
rapporto con la terra, il tempo, lo spazio delle società non urbanizzate, non ancora basate sulle
macchine o comunque non su macchine capaci di fare a meno dell’uomo. Più che vere e
proprie forme di vita, culture, sono state documentate condizioni tecnologiche e rapport tra
sapere dell’uomo e natura sulla quale esercitarli» 44. Quello che sembra emergere, sul piano
delle motvazioni che hanno spinto molt sogget a farsi collezionist di ogget di vita
quotdiana, è «la consapevolezza comune dell’essere entrat in una società più ricca, dal
benessere difuso»45, ma anche la volontà di ribadire accanto al «valore positvo (anche di dura
conquista sociale) di questo evento [...] da quali difficili radici di sacrifcio e di soferenza
venissero gli uomini egualizzat della società democratca» 46. La percezione di aver smarrito
«un universo di rapport più diret con la natura, di più larghi saperi fabrili, di parsimonia e
resistenza»47 è stata la molla che , secondo una parte signifcatva della critca, ha favorito
41 Ibid., p. 11.
42 Continuo, nonostante quanto segnalato alla nota n. 39, ad utilizzare questa espressione per pura comodità di
esposizione.
43 Giovanni KEZICH, Il museo selvaggio. Note per uno studio di antropologia museale, in Giovanni KEZICH e Mario TURCI
(a cura di), Antropologia museale, op. cit., pp. 51-55. L'aggettivo “selvaggio” non va inteso, spiega l'Autore nella nota 3
del suo testo, come un dispregiativo, ma come termine che sta ad indicare un qualcosa, un processo, di non
domestico e «non dòmito». Come ogni lettura di tipo fenomenologico, e quindi tendente ad astrarre i fenomeni dal
loro contesto specifico, quella proposta presenta qualche limite anche se può essere utile per inquadrare
sinteticamente il fenomeno.
44 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, op. cit., p. 33.
45 Pietro CLEMENTE, La museografa locale: un'identità diffcile, in id., Graffti di museografa antropologica italiana, op. cit., p.
166.
46 Loc. cit..
47 Ibid., p. 167.
[18]
la costtuzione di rassicurant simulacri del mondo perduto (i musei etnografci per
l'appunto) tramite il recupero degli ogget precedentemente rimossi non soltanto dalle
case ma anche dall'immaginario dei consumi.
Una ulteriore chiave di lettura utle ad interpretare la museografa spontanea dal basso
è quella che, nel costtuirsi delle raccolte che ne stanno alla base, vede l'esito di un processo di
democratzzazione di una pratca tradizionalmente aristocratca quale quella del
collezionismo48. E proprio al collezionismo, da intendersi come pratca culturale storicamente
determinata e connessa ad una partcolare sfera sociale, quella popolare, invitano a guardare
con attenzione molt autori nell'otca di una efetva antropologia museale, di uno studio
antropologico delle pratche connesse – in maniera più o meno evidente – alla realizzazione
dei musei. Un collezionismo, nel caso che ci riguarda, legato «al sentmento di un passaggio
epocale ‘del mondo delle cose’, e in questo animato da un sentmento di nostalgia
contraddittorio: rifuto e insieme amore per il mondo dell’autoconsumo, del lavoro da sole a
sole, della subordinazione al padrone e della donna all’uomo, del tempo senza ferie e della
casa senza servizi igienici, dell’impossibile mobilità sociale e territoriale»49.
Quanto detto fn qui porta alla luce un partcolare di non poco conto. I musei la cui
genesi è ascrivibile al processo appena descritto sono prevalentemente musei di ogget, di
cose, espressione di una impostazione «fondamentalmente oggettuale, basat[a] su
semplici classifcazioni o ricostruzioni di ambient, e nonostante l'intenzione di valorizzare
identtà locali l'oggetstca è assai ripettva su scala nazionale»50. Musei di cultura
materiale per lo più, e non propriamente demoetnoantropologici , perché «l’ antropologia
rientra in gioco quando gli ogget riprendono a parlare con la voce degli uomini, e intorno ad
essi si ricostruiscono – oltre alle somiglianze tecnologiche – le diferenze dei valori, degli stli,
48 Sull'argomento vedi anche Sandra PUCCINI, Raccogliere oggetti demologici, storia e signifcati, disponibile online
all'indirizzo http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/130/1/puccini_oggetti_demologici.pdf ed anche Le sentinelle
della
memoria.
Per
una
tipologia
del
collezionismo
antropologico,
http://dspace.unitus.it/bitstream/
2067/127/1/puccini_sentinelle_memoria.pdf . Il tema del collezionismo in generale, e di quello connesso ai musei
di cui mi occupo in questa sede, ha generato una bibliografia ricchissima; valgano come parzialissime segnalazioni le
seguenti: James CLIFFORD, I frutti puri impazziscono. Etnografa, letterature e arte nel XX secolo, Torino, Bollati
Boringhieri, 1999; George W. STOCKING jr. (a cura di), Gli oggetti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura materiale,
Roma, EI Editori, 2000. Infine John ELSNER and Roger CARDINAL (edited by), The Cultures of Collectig, London,
Reaktion Book, 1994 offre una ampia panoramica sull'argomento.
49 Pietro CLEMENTE, La museografa locale: un'identità diffcile, op. cit., p. 166.
50 Pietro CLEMENTE, La museologia antropologica sull'Italia: qualche problema, in Pietro CLEMENTE, Graffti di museografa
antropologica italiana, op. cit., p. 184.
[19]
dei cibi, dei sentment, delle pratche della vita di tut i giorni »51. Musei nat dal gesto
complementare allo scartare, e cioè il raccogliere 52, quanto le famiglie che abbandonavano le
campagne per trasferirsi in città si lasciavano dietro. Musei «le [cui] esposizioni sono ripettve e
non hanno carattere antropologico, oscillano semmai tra un valore di tecnologia rurale e una
sorta di antropologia ideologica che oppone strument e consumi poveri del passato a quelli
della tecnologia industriale»53, espressione di una «museografa nata da passioni
collezionistche locali e sovente approdata a fnanziament dei Comuni, delle Provincie o delle
Regioni». Quello che non è sfuggito a chi, già sul fnire degli anni Ottanta, ha osservato il
fenomeno in questone è il fatto che i musei nat dalle collezioni costtuite da ex mezzadri, da
ex contadini, non hanno benefciato di attenzione e di risorse pubbliche, e che il ruolo avuto
dalla ricerca DEA nella loro vicenda è stato scarso e il più delle volte legato ad intervent di
natura riparatoria piuttosto che di tpo propriamente progettuale 54. Musei “ruspant”55 dunque,
frequentemente carent sul piano prettamente museografco (in termini di dotazione di
apparat comunicatvi, di accessibilità e fruibilità), non in grado di «“rappresentare forme di
vita” nella loro partcolarità e diferenzialità»56 come avrebbero dovuto fare musei
compiutamente antropologici, ma ai quali è stato riconosciuto comunque, e da molto tempo,
un grande valore culturale e di testmonianza57.
Nella relazione Il mondo contadino: documentazione e storia tenuta nel 1975 al
Convegno nazionale di museografa agricola sul tema Il lavoro contadino58, organizzato
51 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, op. cit., p. 35.
52 Sul rapporto tra scartare cose e raccogliere cose, che molto ha alimentato la rifessione sul collezionismo 'povero', cfr.
Italo CALVINO, La poubelle agréée, in id., La strada di San Giovanni, Milano, Mondadori, 1995, pp. 71-94.
53 Pietro CLEMENTE, Museografa, estetica, comunicazione, op. cit., p. 148.
54 Loc. cit..
55 Loc. cit.
56 Ibid., pp. 149-150.
57 Cfr. il saggio di Pietro CLEMENTE, La museografa locale, un'identità diffcile, op. cit., e id., La civiltà contadina come epoca,
op. cit., dove l'autore scrive: «pur talora idoleggiati o gestiti un po' miticamente, questi nuclei documentari hanno
continuato l'immagine dell'Italia postbellica dotata di una feconda e non fascistizzata società civile, attiva,
zavattiniana, un po' kitsch o populista per i gusti dell'intellettualità ufficiale, ma terribilmente viva», p. 33; vedi anche
p. 112 del saggio Il museo, la comunicazione, il pubblico dove si legge: «benché ripetitiva e localistica, la museografia
spontanea ha portato i musei all'attenzione della gente comune, ha avvicinato le scuole alla cultura contadina, ha
sorretto una pubblicistica locale di grande interesse, per mantenere ferma la comprensione di una “forma di vita”
così vicina a noi nel tempo ma divenuta lontana dall'esperienza dei giovani come fosse trascorsa un'era geologica», p.
109. Oltre al valore del recupero vengono individuati anche altri significati e meriti rispetto a questa pratica: «alle
origini la museografia spontanea […] aveva un valore di opposizione della piccola storia contro la grande; poteva
pertanto vantare l'esposizione di oggetti poveri della vita quotidiana come atto polemico e di rinnovamento
culturale».
58 Il saggio si trova nel volume di Alberto Mario CIRESE, Oggetti, segni, musei, op. cit., con il titolo Condizione contadina
tradizionale, nostalgia, partecipazione, pp. 4-34.
[20]
dall’Isttuto nazionale per la storia dell’agricoltura e da ent locali della Regione EmiliaRomagna, tenutosi tra San Marino di Bentvoglio (sede dell’allora nascente Museo della civiltà
contadina59) e Bologna, Alberto M. Cirese fornisce una chiave di lettura alla comprensione
della museografa contadina difusa. L'intervento, pubblicato successivamente sotto forma di
saggio nella raccolta Ogget segni, musei, è un testo di «politca della cultura»60 che muove
nella prospetva di un «marxismo critco, non innamorato della spontaneità e dei mit del
momento, severo nel lavoro scientfco» 61; uno scritto che si colloca «in una linea di
museografa critca che si distngueva dalla museografa di base e di ricostruzione di contest» 62
che già allora aveva preso piede.
Il quadro che Cirese delinea è il seguente. Gli anni che seguono la fne della seconda
guerra mondiale vedono un massiccio esodo della popolazione rurale verso le grandi città, le
quali sono in grado di ofrire maggiori opportunità occupazionali rispetto alle campagne. Ma la
città, in generale, impone nuovi modelli e ritmi di vita a persone che per adattarsi al
cambiamento non possono far altro che rompere i rapport con il proprio mondo di origine. In
città, gli ex contadini ormai operai e impiegat, a fronte di un minimo miglioramento delle
proprie condizioni materiali di vita, subiscono un netto peggioramento delle condizioni sociali
dell’esistenza. Perché se è vero che i neocittadini per un verso accedono a «una sfera di
disponibilità economiche superiori»63, va anche detto che il prezzo pagato per compiere
questo passaggio è alto. Un prezzo quantfcabile nella perdita «più in generale di quel
rapporto diretto e proprio con gli ogget e le condizioni del sia pur misero e fatcoso lavoro, e
l'annullamento totale di quegli spazi per l'espressione di sé che restavano in certa misura
garantt dalla integrazione tra vita domestca, vita associata e vita lavoratva» 64. Ed è proprio
dalla percezione di quanto perso, di quanto guadagnato e a quale costo, che l'Autore lega «il
recupero che nelle zone più avanzate gli stessi contadini vengono facendo proprio di quegli
59 Si tratta di uno dei musei intorno ai quali, negli anni Sessanta-Settanta si è discusso con maggiore profondità, ed è
anche un po' un esempio prototipico dei musei di impronta fortemente razionalista. Notizie più dettagliate sono
reperibili nel volume di Massimo TOZZI FONTANA, I musei della cultura materiale, Roma, La Nuova Italia
Scientifica, 1984 ma anche di Pietro CLEMENTE, I confni del Museo, il Museo dei confni: un viaggio nell'opera di una vita
di Ettore Guatelli, in Pietro CLEMENTE e Emanuela ROSSI, Il terzo principio della museografa, op. cit., pp. 78-85.
60 Pietro CLEMENTE, Vent'anni dopo. Alberto M. Cirese scrittore di musei, in Mario TURCI (a cura di), Antropologia museale,
op. cit., p. 11.
61 Loc. cit..
62 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, op. cit., p. 32.
63 Alberto Mario CIRESE, Condizione contadina tradizionale, nostalgia, partecipazione, op. cit., p. 24.
64 Ibid., p. 25.
[21]
ogget tradizionali che magari fno a poco tempo fa rifutavano (o abbandonavano alla rapina
dell'antquariato speculatvo) come simboli della faccia negatva della loro vecchia
condizione»65. È la nostalgia a guidare questa operazione di recupero e conservazione,
sentmento da intendersi come il «volgersi con desiderio e rimpianto […] a condizioni e modi di
vita ormai irrimediabilmente perdute e infrante quali sono appunto quelle del mondo
contadino tradizionale»66. Questa la sintesi della lettura ciresiana del processo che ha portato
alla costtuzione – nel periodo in analisi – delle mille collezioni e dalle centnaia di musei sparsi
un po' in tutta Italia.
Una questone importante che Cirese solleva – importante specie se considerata in
relazione al clima politco-culturale del periodo – è quella relatva ai problemi connessi
all'utlizzo, nella denominazione dei musei, della locuzione civiltà contadina. Quello verso cui
l'Autore mette in guardia è la «carica mitca che essa storicamente contene», l'idea – che
trova spazio nelle opere di Carlo Levi – secondo la quale il mondo contadino è un qualcosa di
chiuso in sé, al d fuori della storia e delle sue dinamiche, escluso dalla dialetca con le classi
dominant. Scartata anche la possibilità di parlare di musei del lavoro contadino, espressione
quest'ultma ritenuta troppo ridutva e suscetbile di porre in secondo piano molt altri aspet
dell'esistenza rispetto a quello chiamato in causa direttamente, la soluzione che Cirese
propone è quella di far ricorso alla nozione di condizione contadina, una nozione mutuata dalla
lettura di Marx ed in grado di legare le «condizioni di realizzazione del lavoro»67 agli altri
moment della vita domestca, al susseguirsi delle stagioni ed alla socialità.
Sembra questo lo spazio più adeguato per sollevare una questone che sarebbe errato
considerare marginale, quella della denominazione dei musei 68. La tendenza invalsa è a
rubricare i vari musei della civiltà contadina, contadini, delle tradizioni popolari, delle art
popolari69 alla voce “museo etnografco”. Accade anche agli addet ai lavori di generalizzare in
65
66
67
68
69
Loc. cit..
Ibid., p. 23.
Ibid., p. 22.
Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Etnografco nome di museo, in id., Poetiche dal museo etnografco, op. cit., pp. 127-139.
«I nomi dei musei sono anche essi artefatti, parlano spesso più della cultura osservante, dei saperi e delle ideologie
dei conservatori, che della cultura in mostra», p. 128. Cfr. anche Massimo PIROVANO, Le parole del museo DEA.
Civiltà contadina, tradizioni popolari ed etnografa: campi e discipline per un museo etnoantropologico, in Massimo PIROVANO e
Carlo SIMONI (a cura di), Cose e memorie in scena. Strumenti ed esperienze per i musei della cultura materiale, Brescia, Centro
Servizi Museali della Provincia di Brescia, 2006, pp. 28. cfr. anche Vincenzo PADIGLIONE, Etnografco nome di museo,
in id. Poetiche dal museo etnografco, op. cit., p. 129: «i nomi dei musei sono dichiarazioni sintetiche ed esplicite di
missione che, nel tempo, possono diventare oscure, perdere il carattere ostensorio di seduzione concettuale,, o di
esplicita autoevidenza, apprezzato sovente agli esordi. […] I tanti e diversi nomi del museo DEA possono denunciare
[22]
questo modo, il più delle volte per esigenze di immediatezza comunicatva. Chiarito che in
questa sede non si vogliono assolutamente alimentare processi di normalizzazione 70, è però il
caso di interrogarsi sulla reale etnografcità di molt dei musei riconducibili più o meno
direttamente alla stagione della museografa contadina dal basso.
Forme di ironia fn troppo facili e a buon mercato che circolano a proposito dei musei
della galassia DEA sono quelle che defniscono gli stessi come i musei delle zappe. Accantonata
ogni forma di risentmento verso questo motteggiare, risentmento che comunque sarebbe più
che giustfcabile dato che – quand'anche i nostri fossero veramente solo musei di zappe –
quest meriterebbero rispetto se non altro per il fatto che quelle zappe state raccolte e
conservate grazie all'impegno, al lavoro e spesso al sacrifcio di qualcuno, resta una domanda. I
musei delle zappe sono etnografci? Lo sono sempre? E in che misura? Lasciamo da parte gli
strument del lavoro agricolo e allarghiamo l'orizzonte di rifessione agli ogget più in generale.
Quale è il loro ruolo in un museo? Che diferenza c'è, se c'è, tra un museo di civiltà contadina e
un museo etnografco? Dove si colloca l'etnografa in un museo? Rispondere a domande simili
consente non solo un esercizio di antropologia museale, ma in prospetva è utle anche in
relazione alla questone che sta al centro di questo elaborato, quella delle professioni museali
e in partcolare della direzione degli isttut.
Nel linguaggio comune museo etnografco è sinonimo di una raccolta di ogget che
hanno a che fare con il mondo dei lavori agricoli e artgianali, della cura della casa, della
cucina. Bastano dei gioghi, una zuppiera ed il gioco è fatto. Quasi come fosse l'oggetto, una
certa tpologia di ogget – poveri, umili, banali, legat alla sfera del lavoro – a dare l'impronta
ad un museo. Eppure, e la mostra Art/artifact lo dimostra71, un oggetto, un reperto d'arte
ad un tempo incuria accademica, limiti dell'egemonia scientifica, vischioso provincialismo, effervescenza e ricchezza
locale». I primi esiti di un lavoro di carattere lessicografico teso a fare un po' di chiarezza tra le tante e varie
denominazioni delle tante e varie tipologie di museo che rientrano nella sfera DEA sono stati pubblicati sulla rivista
«AM-Antropologia Museale», anno 4, numero 12, inverno 2005-2006, pp. 33-46. Vincenzo PADIGLIONE, nella
sede appena citata, si è occupato dei musei etnografici (Etnografco nome di museo, pp. 41-46); Vito LATTANZI ha
affrontato il tema della specificità dei musei etnologici e del rapporto tra etnografia ed etnologia (con particolare
riferimento alla storia di queste discipline e alla loro vicenda museale, cfr. Scenari e defnizione del museo etnologico, pp. 3741); Pietro CLEMENTE ha proposto un confronto tra due generazioni di museografi italiani di area DEA, quelli che
hanno operato nel primo Novecento e quelli che invece hanno lavorato nella seconda metà (cfr. I Dea-Musei, pp. 3337).
70 In questo senso aderisco a quanto scrive Vincenzo PADIGLIONE nel saggio Etnografco nome di museo, op. cit., p. 127:
«a noi antropologi museali stanno a cuore le varietà interne al nostro settore. Ne siamo orgogliosi, in quanto le
consideriamo un elemento caratterizzante e rappresentativo di un patrimonio che nella mediazione rivela le tracce
ad un tempo della cultura osservata e di quella osservante».
71 Cfr. Susan VOGEL, Sempre fedeli all'oggetto, a modo nostro, in Ivan KARP e Steven D. LAVINE (a cura di), Culture in
[23]
africana – ma l'universo di riferimento può essere ampliato notevolmente – può essere
“museografato”, cioè messo in mostra, interpretato, mediato 72, in modi molto diversi tra di
loro. Nel caso della mostra citata quello che è stato fatto, tramite la ricostruzione di diversi
setng museografci (quello di tpo naturalistco di fne 1800, quello della museografa dell'arte
contemporanea, quello della museografa antropologica di stampo evoluzionista) è stato far
vedere come – in diversi periodi della storia occidentale – è cambiato lo sguardo tramite il
quale sono stat vist e dunque interpretat e resttuit al pubblico tramite esposizioni gli ogget
d'arte africana. Il resoconto di questa esperienza mi sembra evidenziare in maniera esemplare
quanto di culturalmente determinato, relatvo, ci sia nel concepire allestment museali. Scrive
a questo proposito Vogel: «che i musei ricontestualizzino e interpretno è un dato di fatto, che
non richiede giustfcazioni. I musei dovrebbero, tuttavia, essere consapevoli dei loro limit e
riconoscere apertamente il grado di soggetvità che è loro proprio, anch'esso un dato di
fatto»73. Prendiamo il caso di manufat coi quali abbiamo una certa familiarità, come un
falcetto. Un simile arnese potremmo trovarlo in un museo di storia dell'agricoltura, ad
illustrare determinat cicli lavoratvi; in un museo d'arte contemporanea, valorizzato per la sua
forma, per la materia con cui è realizzato, posto accanto ad un altro oggetto in un gioco di
rimandi tra forme, linee, ritmi di pieni e vuot; in un museo di ergologia, ad illustrare le
tecniche costrutve attraverso le quali lo strumento è stato prodotto. L'oggetto non cambia,
tale è e tale rimane in tutte le possibili forme di allestmento. Quello che cambia è lo sguardo
col quale esso viene indagato, esposto e fruito. E questa è una acquisizione che rimanda non
soltanto allo stretto ambito dell'antropologia museale, ma all'etnografa contemporanea più in
mostra. Poetiche e politiche dell'allestimento museale, Bologna, CLUEB, 1994, pp. 119-135. Il saggio è raccolto all'interno di
un volume (ed. or. Exhibiting cultures. The poetics and politics of museum display, Washington and London, Smithsonian
Institution Press, 1991; l'edizione italiana contiene soltanto una selezione dei saggi presenti in quella originale) che
raccoglie i contributi portati da diversi studiosi ad un Convegno svoltosi nel 1988 a Washington presso la
Smithsonian Institution dal titolo The Poetics and Politics of Representation dedicato al tema della rappresentazione degli
altri, delle culture altre, all'interno dei musei. I saggi contenuti nel volume toccano una serie di questioni cruciali per
il mondo dei musei e in particolare per quelli che mettono in scena culture altre; questioni legate al così detto “effetto
museo”, alla “risonanza” o alla “meraviglia” quali modalità di fruizione dei reperti, concetti come quello di
“autenticità”. Dal saggio di Susan Vogel emerge in maniera chiara – grazie anche alla citazione di esempi molto
efficaci – la questione del lavoro museale come forma di mediazione, la questione della ricontestualizzazione degli
oggetti lungo i percorsi espositivi secondo i criteri di valutazione dei curatori, ed infine quella riguardante i limiti
culturali dell'estetica (da cui la difficoltà di parlare di arte – nozione interna al nostro mondo – a proposito di oggetti
prodotti in Africa).
72 Sul lavoro museografico come forma di mediazione cfr. Andre PERIN, Cose da museo. Avvertenze per il visitatore curioso:
Milano, Eleuthera, 2007: «svincolati opere e oggetti dai vecchi committenti e dai contesti di appartenenza che fino
ad allora avevano dato loro una funzione, è il museo a definire il loro significato, a essere il filtro per poterli osservare
e comprendere», p. 51.
73 Ibid., p. 135.
[24]
generale. Le discipline demoetnoantropologiche ormai riconoscono apertamente che non
esiste l'oggetto (da intendere in senso ampio) etnografco 74 ontologicamente tale, esiste
semmai l'oggetto di un interesse, di uno sguardo etnografco, che è uno sguardo – al tempo
stesso – contestualizzante e defamiliarizzante, interpretatvo, strabico per defnizione, che
caratterizza il modo in cui viene concepita l'etnografa oggi. Non esiste l'oggetto etnografco in
sé, e l'allesttore, al pari dell'etnografo, è un autore; un autore che guarda al proprio oggetto
74 Cfr. Barbara KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Destination culture. Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley, University of
California Press, 1998, Part 1 Objects of Ethnography, pp. 17-78. Secondo Hélène Balfet «niente ha, più o meno
spontaneamente e di per sé stesso, un valore etnologico, […] ogni oggetto (in senso ampio), può diventare un
documento etnologico nel momento in cui viene sottoposto ad analisi da parte di un etnologo», cfr. Hélène BALFET,
L'analisi etnologica degli oggetti tecnici, in Pier Giorgio SOLINAS (a cura di), Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura
materiale in antropologia, Montepulciano, Edizioni del Grifo, 1989, p. 17. Tra i tanti “oggetti” suscettibili di uno sguardo
etnografico c'è lo stesso museo. Un ruolo importante nel processo che ha gettato le premesse per fare anche del
museo un oggetto di indagine dell'etnografia lo ha avuto la New Museology. ll volume collettaneo The New Museology
[Peter VERGO (edited by), The New Museology, London, Reaktion Book, 1997] rappresenta il manifesto della nuova
museologia di matrice anglosassone e costituisce una delle pietre miliare del cambiamento del paradigma
museologico tradizionale. Accanto a questo merita di essere citato un altro volume, citato dallo stesso Vergo quale
opera in grado di indirizzare verso il nuovo corso della museologia, quello curato da Robert LUMLEY e intitolato
L'industria del museo. Nuovi contenuti, gestione, consumo di massa, Genova, Costa & Nolan, 1989. Peter Vergo, nella sua
Introduction alla raccoltapubblicata nel 1997, in poche battute contrappone la nuova museologia a quella vecchia
utilizzando queste parole: «Beyond the captions, the information panel, the accompanying catalogue, the press
handout, there is a subtext comprising innumerable diverse, often contradictory strands, woven from wishes and
ambitions, the intellectual or political or social or educational aspirations and preconceptiones of the museum
director, the curator, the scholar, the designer, the sponsor – to say nothing of the society, the political or social or
educational system which nurtured allt hese people and in so doing left is stamp upon them. Such considerations,
rather, than, say, the administration of museums, their methods and techniques of conservation, their financial wellbeing, their success or neglect in the eyes of the public, are the subject matter of the new museology» (p. 3). Secondo
Vergo la old museology è stata troppo concentrata a rifettere sui metodi (come far funzionare i musei, come esporre gli
oggetti) per porsi domande, come quelle tipiche che propone la new museology, sugli obiettivi della museologia e sulla
funzione sociale del museo. Scorrendo l'indice del volume citato si ha un elenco pressoché completo degli argomenti
di rifessione che la nuova museologia pone all'attenzione della comunità museale a livello internazionale. Si va da
questioni che riguardano il ruolo educativo dei musei a considerazioni sulla qualità dell'esperienza dei visitatori
passando per i problemi legali connessi con le acquisizioni per arrivare alla esplicitazione della funzione autoriale di
chi lavora nel museo, funzione che si concretizza nello scegliere cosa esporre, come, comunicando al pubblico quale
tipo di informazione. Accanto alla new museology anglosassone, e riconoscendo alla seconda un primato temporale, si
colloca la Nuovelle Muséologie francese. I testi di riferimento di questa tradizione sono due volumi antologici pubblicati
negli anni Novanta (Cfr. Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie, vol. I, Textes choises et presentés par André
Desvallées, Savigny-le-temple, Editiones W-MNES, 1992 ed anche Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie vol. 2 ,
textes choisis par Marie-Odile de Bary, André Desvallées et Francoise Wasserman, Savigny-le-temple, Editiones WMNES, 1994. Vedi anche François Mairesse, La belle histoire. Aux origines de la nouvelle muséologie, «Publics et Musées»,
N°17-18, 2000. pp. 33-56). La distanza tra i due approcci rimanda soprattutto all'idea, espressa dalla scuola francese,
secondo la quale «l'esigenza primaria è quella di aprirlo [il museo] verso l'esterno, di farlo uscire dalle sue mura
abolendo la distanza tra pubblico e collezioni», Cecilia RIBALDI, Introduzione, in id. (a cura di), Il nuovo museo.Origini e
percorsi. Vol. 1, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 31.
Un inquadramento critico efficace utile a leggere la vicenda della new museology lo offre Vincenzo Padiglione
all'interno di Presentazione, op. cit.. Vedi pure Cecilia RIBALDI, Introduzione in id. (a cura di), Il nuovo museo, op. cit., pp.
31-33. Cfr. anche di Vincenzo PADIGLIONE, Introduzione, in id., Poetiche dal museo etnografco, op. cit., pp. 7-22.
All'accusa di scarsa rifessività che sembra muovere Vergo alla tradizione di studi precedente, Padiglione
contrappone la visione secondo la quale «rifettere negli anni '60 sulle potenzialità educative del museo e sui modi
grazie ai quali accrescere il numero dei visitatori […] significava porsi il problema etico, politico e culturale di una
possibile trasformazione democratica e, a suo modo multiculturale di una istituzione che, seppure pubblica,
manteneva intatto il suo carattere elitario» (p. 13) e ricorda il fatto che già nel corso degli anni Settanta – e dunque
prima della pubblicazione di The New Museology – specie con Duncan Cameron e, sul versante francese, con Riviere,
molte questioni circa ruolo e funzione del museo erano già state sollevate. Quello che salva The new museology dalle
[25]
partendo da un partcolare posizionamento scientfco-disciplinare, storico e culturale e in
questo modo lo costruisce come etnografco. È per questo, secondo Vogel, che i responsabili
di una mostra hanno «il dovere di informare il pubblico mostrandogli che ciò che vede non è
un materiale che parl[a] da solo, bensì un materiale fltrato attraverso i gust, gli interessi, le
posizioni politche il grado di conoscenza propri di specifci presentatori in uno specifco
momento»75. Mettere in mostra ogget – insomma – non è un atto innocente, è anzi un gesto
carico di implicazioni culturali ed etche. Tenuto presente quanto appena detto possiamo
passare a chiederci in quant dei musei sedicent etnografci, o defnit in questo modo per
approssimazione, lo sguardo tramite il quale le collezioni sono indagate giustfchi una sifatta
denominazione.
Un esempio di cosa si debba intendere per museo etnografco autentcamente e
profondamente tale è rappresentato dell'Etnomuseo Mont Lepini76, la cui progettazione e
realizzazione ha segnato una svolta nella museografa italiana, antropologica e non solo. La
portata e la direzione intrapresa dal nuovo corso inaugurato dall'Etnomuseo trova risonanza
nel nome stesso dato al museo 77. Quell'etno che precede e qualifca la denominazione
dell'isttuto sta ad indicare il ruolo fondamentale avuto dall'etnografa nella sua progettazione
e nel suo allestmento. Un museo la cui ragion d'essere non consiste nel dover valorizzare una
collezione precosttuita, che ha il suo baricentro, il suo centro di gravità, non negli ogget ma
nel «discorso scientifco, quale ricostruzione dell'ordine delle relazioni signifcative a cui quest
ogget partecipavano quando erano in uso»78. La nascita dell'Etnomuseo può essere presa
come esempio paradigmatco di cosa signifchi assumere l'etnografa quale prospetva
pervasiva che innerva il museo. Il suo autore, Vincenzo Padiglione, lo ha descritto come un
75
76
77
78
feroci critiche mossegli dai detrattori, soprattutto di scuola francese, viene individuato nell'apertura che dalle sue
pagine si coglie in direzione della sensibilità postmoderna. Un merito particolare che viene riconosciuto alla new
museology è quello di aver «rimodellato il suo [del museo, ndr] ambito d'analisi […] così da costituirlo come oggetto
etnografico: sorprendentemente simbolico, irriducibile ad uno sguardo disciplinare e normalizzante» (p. 17) e quindi
ad aver aperto la strada ad un modo di guardare e studiare una simile istituzione.
Susan VOGEL, Sempre fedeli all'oggetto, a modo nostro, op. cit., p. 135.
Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Ma chi mai aveva visto niente. Il Novecento, una comunità, molti racconti . Catalogo EtnoMuseo
Monti Lepini, Roccagorga, Roma, KAPPA, 2001. Le ricerche per l'allestimento del museo prendono avvio nel 1991,
l'inaugurazione risale al 1999, cfr. la Presentazione al volume sopra citato. Cfr. anche Antonio RICCIO, Identità e
territorio. Un etnografo nei Monti Lepini, Roma, KAPPA, 2007, raccolta di saggi che in gran parte nascono dall'esperienza
della ricerca preliminare alla costituzione del museo.
Oltre al citato catalogo dell'Etnomuseo si veda anche Vincenzo PADIGLIONE, L'EtnoMuseo dei Monti Lepini, ovvero
scegliere l'etnografa come prospettiva museale, in Sandra PUCCINI (a cura di), Beni culturali e musei demoetno-antropologici, Atti
della Giornata di Studi Viterbo e Canepina, 9 maggio 1997, Roma, CISU, 2001, pp. 84-97.
Ibid., p. 86.
[26]
museo che «si avvale della ricerca sul campo per rappresentare il punto di vista locale non
irrelato rispetto il contesto di sua manifestazione, […] per mostrare in quali modi la memoria
colletva è selezionata e perpetuata, la tradizione costruita, l'interpretazione locale alimentata
e resa manifesta in forma ed espressioni partcolari»79. Un museo dunque che «individua,
osserva e mette in valore un patrimonio locale con spirito critco e coscienza del rapporto tra
mondo locale e la comunità più ampia»80. Ci si leggono, in questo passaggio, gli esit della
svolta rifessiva dell'antropologia, la de-essenzializzazione del concetto di tradizione, la
crescente attenzione verso i processi di patrimonializzazione, la messa in evidenza – e non più
la occultazione – dei processi tramite i quali il documento viene costruito, della natura
negoziale dei signifcat culturali e del lavoro dell'etnografo quale interprete 81. Un museo
molto più vicino all'immagine del forum 82, luogo di discussione polifonica e di
sperimentazione, piuttosto che del tempio, spazio sacro delle muse.
Torno per un momento ai due esemplari di museo con cui ho aperto questo percorso di
rifessione. Il Museo della terra di Latera è un museo all'interno del quale si insiste molto su
questoni che stanno a cuore all'antropologia: vita sociale, familiare, organizzazione del lavoro.
Molto spazio del suo allestmento è dedicato alla documentazione e resttuzione ai beni
immateriali, beni che più di altri segnano lo specifco antropologico. Se è vero per un verso che
il Museo «riesce a porre al centro della sua comunicazione i trat marcant una ‘forma di vita’,
la socialità, la famiglia, le espressioni estetche, i rituali, il suo universo simbolico» 83, e dunque
pone al centro dell'attenzione del visitatore questoni che sono alimento dell'antropologia, va
79 Loc cit..
80 Ibid., p. 87.
81 Il riferimento è ad autori come James Clifford (ed alle sue opere già citate) e Clifford Geertz e ai suoi lavori più
importanti: Interpretazione di culture, Bologna, il Mulino, 1998, Antropologia interpretativa, Bologna, Il Mulino, 2001 Opere e
vite. L'antropologo come autore, Bologna, Il Mulino, 1990.
82 Nel 1971 Duncan Cameron pubblica un saggio destinato a divenire celebre e a segnare una prima frattura nel modo
classico di considerare i musei: The Museum: a Temple or the Forum (comparso originariamente su «Curator. The
Museum Journal», volume 14, Issue 1, pp. 11-24, March 1971 e disponibile anche nell'antologia curata da Cecilia
RIBALDI, Il nuovo museo, op. cit., alle pp. 54-63) Cameron, che fa partire la sua argomentazione della denuncia
dell'assenza di capacità da parte dei musei di individuare quale sia la loro funzione, il loro ruolo sociale, coglie nella
funzione di «sacralizzare le testimonianze del controllo sociale esercitato dai borghesi e aristocratici» il ruolo
tradizionalmente affidato al museo (da cui l'immagine celebre del “museo-tempio”). Il punto di arrivo della sua
rifessione lo porta ad auspicare non l'introduzione del forum all'interno del tempio, le attività inedite e sperimentali
connesse al forum rischierebbero di «svalutare quelle che pertengono specificatamente al museo», e neanche la
sostituzione del primo col secondo, ma un loro affiancamento nel rispetto dell'autonomia di entrambe le istituzioni.
Forum a cui Cameron affida il compito di «accoglie[re] e incorpora[re] le manifestazioni del cambiamento in atto»,
di «assicurare il più vasto ascolto possibile alle nuove, stimolanti percezioni della realtà, ai nuovi valori e alle forme in
cui oggi essi si esprimono», perché «là dove manca il forum, il museo-tempio diventa un ostacolo al cambiamento»
(p. 63 della traduzione italiana).
83 Pietro CLEMENTE, La museografa locale: un'identità diffcile, op. cit., p. 170.
[27]
anche detto che lungo il percorso espositvo non sono rintracciabili tracce signifcatve di quel
lavoro di “interpretazione di interpretazioni”, per dirla in termini geertziani 84, che caratterizza
l'etnografa contemporanea. Insomma, quello che si percepisce, accanto alla trattazione di
questoni che hanno a che fare con gli ogget di studio delle discipline DEA, è una forte
mancanza di rifessività. A diferenza di questo, il Museo del brigantaggio di Cellere – con la
sua attenzione ai processi di patrimonializzazione, con il suo decostruire il testo di Adolfo Rossi
per metterne in evidenza le strategie retoriche, le modalità della costruzione dell'immagine del
brigante, le poetche e le politche della scrittura giornalistca – si impone a tut gli efet
come etnografco.
Giunto a questo punto della discussione mi sembra opportuno sofermarmi ad
indagare, o quanto meno segnalare, i motvi che hanno portato così frequentemente, anche in
maniera non del tutto giustfcata e condivisibile, ad utlizzare l'aggetvo “etnografco” per
indicare i musei descrit sopra. L'impressione che ho è che esso sia stato spesso impiegato in
riferimento ad una accezione classica di etnografa intesa come pratca di osservazione e di
raccolta di document sul campo. Come a dire che laddove sono custodit ogget raccolt
nell'ambito di una qualche campagna di documentazione di qualsiasi atvità legata al mondo
contadino – o comunque a qualcosa di riconducibile ad una dimensione temporale o culturale
percepita come “altra” –, lì si ha un museo etnografco.
Un'altra questone di fondo, non trascurabile, che in questa sede però posso soltanto
sforare, anche se meriterebbe di essere tematzzata con maggiore attenzione, è quella
riassumibile nei seguent termini: come mai i musei che comunemente vengono defnit di
civiltà contadina, musei contenent per lo più attrezzi da lavoro e suppelletli domestche nat
da forme di collezionismo popolare, sono stat considerat fn da subito musei aferent la sfera
DEA? Come mai sono stat presi in carico, diciamo così, dalla grande famiglia delle discipline
antropologiche? Un conto è assumere oggi all'interno di questo novero musei pensat per
essere espressione di uno sguardo etnografco, ma per quanto riguarda quelli nat negli anni
Settanta come ci si è regolat? Perché, ad esempio, quest musei non sono stat fn da subito
condot nell'alveo della storiografa (storia dell'agricoltura, storia economica e sociale in
generale) con la stessa forza con la quale sono stat invece condot, spint o comunque
assorbit dall'etnografa? La risposta probabilmente va cercata nel fatto che le collezioni di cui
84 Cfr. Clifford GEERTZ, Antropologia interpretativa, op. cit..
[28]
stamo parlando sono espressione (tanto per il tpo di ogget che le compongono, tanto per
l'appartenenza sociale delle persone che quelle collezioni hanno costtuito) di modi di vita di
classi subalterne, e in quanto tali rientrant a pieno ttolo nella sfera di interesse della
demologia ciresianamente intesa come studio dei dislivelli interni di cultura 85. Certamente le
discipline storiografche non hanno tralasciato del tutto lo studio il fenomeno, come dimostra
il lavoro svolto da storici dell'agricoltura su questo tema, come attestato dalla pubblicazione
nel 1976 del volume della rivista «Quaderni Storici» dedicato alla Cultura materiale86, dagli
intervent di Massimo Tozzi Fontana, di Gaetano Forni e molt altri. Tuttavia, innegabilmente,
questo genere di museografa e le ragioni che la sostengono, nel corso degli anni si sono
sedimentate, per così dire, nel settore DEA e sono diventate suo solido feudo.
La conclusione provvisoria alla quale consente di arrivare questo primo paragrafo è di
importanza cruciale per l'economia generale del dossier. Sostenere e dimostrare che un
museo etnografco è tale non sulla base della tpologia dei repert che espone, ma perché è
etnografca la prospetva con la quale gli ogget (in senso ampio, come ricorda Balfet) sono
valorizzat, mediat e comunicat mette in risalto il ruolo di chi nel museo lavora, di chi lo ha
progettato e soprattutto di chi ne cura la direzione. L'ipotesi che inizia a prende forma – e che
sarà più avant sottoposta ad ulteriori prove – è quella che per progettare un museo (dargli
l'imprintng di base) e per dirigerlo (guidare la struttura attraverso le opportunità e le difficoltà
che le si presentano) sia necessario far riferimento alla fgura di uno specialista di discipline
DEA.
1.3 ORDINAMENTO PER CICLI E MONUMENTI
Il problema di come allestre le collezioni, e prima ancora di trovare un principio
ordinatore in base al quale organizzare i musei, attraversa tutta la museologia. Quella di
matrice DEA non fa eccezione. Già nel corso del I Congresso di Etnografa Italiana si discusse
molto su quale ordinamento87 adottare per l'allestmento delle collezioni del nascente Museo
85 Cfr. Alberto Mario CIRESE, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna di studi sul mondo popolare tradizionale, Palermo,
Palumbo, 1973.
86 A. XI, fasc.I, gen-dic. 1976.
87 In campo museologico ordinamento scientifico e progetto espositivo sono due fasi diverse della costituzione di un
museo, per quanto inestricabilmente interrelate. Al primo è affidato il compito di proporre «lo sviluppo narrativo che
dà senso alle raccolte»; il responsabile di questo aspetto del progetto «conosce e detta le condizioni di conservazione
[29]
di Etnografa Italiana. Due furono allora le posizioni in anttesi: quella di Francesco
Baldasseroni, che proponeva un ordinamento per materia, e quella di Luigi Pigorini, fautore di
un ordinamento per area geografca 88. Nessuna delle due si impose, e la linea che uscì dal
Congresso fu quella di un compromesso che prevedeva di seguire il criterio geografco per poi,
all'interno di aree omogenee, raggruppare gli ogget per materia 89. Quello per area geografca
e quello per tema sono rimast per molto tempo i criteri di riferimento per l'ordinamento
museale demoetnoantropologico. Il primo è quello che caratterizza tutt'ora tanto il Museo
Etnografco Preistorico “Luigi Pigorini” di Roma quanto il Museo Nazionale di Antropologia e
Etnologia di Firenze; il secondo è quello in base al quale è stato organizzato il Museo Pitré di
Palermo90, tanto per rimanere a isttuzioni di rilevanza nazionale. L'ordinamento per area
geografca non ha avuto in grande difusione presso i musei etnografci locali, che per lo più
oscillano tra tre diverse “interpretazioni” del modello tematco, e cioè la ricostruzione
d'ambiente, il monotematsmo e la rappresentazione di canali chiusi (opzioni alle quali vanno
aggiunt vari possibili ibridi generat dalla fusione di quest paradigmi). La ricostruzione di
ambiente si adatta a collezioni ampie e generaliste, quelle che più direttamente sono
riconducibili al modello della collezione di civiltà contadina. Tanto per fare due esempi
concret, è il caso del Museo della civiltà contadina di Gaville (FI) oppure del Museo delle
tradizioni popolari di Canepina (VT). A metà strada tra la ricostruzione d'ambiente e il canale
e gestione» delle collezioni. Cfr. Maria Laura TOMEA GAVAZZOLI, Manuale di museologia, Milano, ETAS, 2003, p.
94. L'Autrice insiste sulla «centralità e sull'impegno dell'ordinatore museologo quale detentore dei significati per
rivelare i quali si muove tutta la macchina del cantiere museale» (loc. cit.). L'ordinamento può essere considerato
come un modello organizzativo di determinate collezioni, e dunque un qualcosa di connotato nello spazio e nel
tempo in maniera molto forte (cfr. Janne VIBAEK, Pratiche museografche etnoantropologiche, in Jean CUISENEIR e Janne
VIBAEK (a cura di), Museo e cultura, op. cit., p. 145). Sul tema dell'ordinamento dei musei etnografici cfr. anche la
voce Musei etnografci, redatta da Ilaria PULINI, dell'Enciclopedia tematica aperta, Milano, Jaca Book, 1993, pp. 342-346.
88 Vedi in proposito Carlo NOBILI, Per una storia degli studi di antropologia museale. Il Museo “Luigi Pigorini” di Roma, Lares,
LVI, n. 3, Luglio-Settembre 1990, in particolare nota 35. Sul Congresso di Etnografia Italiana del 1911 e sulle
posizioni in merito ai principi in base ai quali organizzare il nascente Museo di Etnografia Italiana vedi Sandra
PUCCINI, L'Itala gente dalle molte vite. Lamberto Loria e la Mostra di etnografa italiana del 1911, Roma, Meltemi, 2005, e
id., Evoluzionismo e positivismo nell'antropologia italiana (1869-1911), in AA.VV., L'antropologia italiana. Un secolo di storia,
Roma-Bari, Laterza, 1985, inoltre Giuseppe COCCHIARA, Storia del folklore in Italia, Palermo, Sellerio, 1981 in
particolare la seconda appendice.
89 Cirese, che torna sull'argomento in Oggetti, segni musei, concorda con Baldasseroni circa la «inconsistenza di fondo
dell'ordinamento per regioni (ordinamento “burocratico” e non storico né scientifico […])», cfr. p. 47. Nello stesso
volume, e poi anche nel saggio I beni demologici inItalia e la loro museografa, in Pietro CLEMENTE, Graffti di museografa
antropologica italiana, op. cit., l'autore ipotizza la realizzazione di due tipi diversi di musei, quelli sintagmatici (musei
locali), e quelli paradigmatici (centrali, regionali). Secondo CIRESE ai primi dovrebbe spettare il compito «di dare
documenti tutti immersi nel proprio spazio tempo e nei propri vissuti di ieri e di oggi», ai secondi «quello di porre a
raffronto i diversi discorsi locali per ricavarne uniformità e differenze» (pp. 259-260).
90 Sul Museo Pitrè cfr. Gabirella D'AGOSTINO, Antropologia e museografa in Sicilia. Uno sguardo da lontano, in Jean
CUISENEIR e Janne VIBAEK (a cura di), Museo e cultura, op. cit.. L'ordinamento per temi trova una esplicitazione
in quel repertorio etnografico-linguistico redatto da Paul SCHEUERMEIER che è Il lavoro dei contadini, op. cit..
[30]
chiuso si collocano soluzioni come quella adottata dal Museo della terra di Latera, con ogget
raccolt su base tematca (la bottega del falegname, il calzolaio, la cucina, la preparazione o la
conservazione degli aliment) pur senza alcuna pretesa di esaustvità nel documentare dicli
produtvi. Poi il caso dei musei monotematci, come il Museo della canapa, o il Museo del
Lino, dove tutto verte attorno all'oggetto prescelto documentandone varie dimensioni (nel
caso delle fbre vegetali: coltvazione lavorazione, tessitura, impieghi altri). Infne il canale
chiuso, che in maniera rigorosa è stato interpretato soltanto dal suo ideatore Giuseppe
Šebesta.
Più in generale, la museografa di area DEA che ha preso vita nell'arco temporale in
analisi è stata attraversata da alcune tendenze dominant. Da una parte abbiamo i musei nat
dal lavoro di raccoglitori che, in maniera sostanzialmente autonoma, contando sull'aiuto di
gruppi locali e di associazioni, hanno trasformato le proprie collezioni da semplici cumuli di
ogget in allestment, per quanto estemporanei, accessibili al pubblico. Accanto a queste
realizzazioni si collocano i musei e le mostre nate da una precisa progettualità e
dall'applicazione di principi museografci riconosciut e ampiamente condivisi. É il caso,
quest'ultmo, dei musei di impostazione razionalistca riconducibili al modello ciresiano (cfr.
par. 1.4). Eppure si corre il rischio di appiatre troppo e di schematzzare forzatamente la
realtà riducendo il campo della museografa di interesse antropologico di quegli anni
all'alternatva tra musei basat su semplici ricostruzioni d'ambiente frutto di sensibilità locali, e
musei di impronta razionalistca di matrice ciresiana. In efet questa dialetca così stretta non
esaurisce la complessità di un mondo che a partre proprio da quel periodo ha iniziato a
partorire iniziatve museali estremamente diverse e plurali. Realizzazioni che meritano di
essere ricordate anche perché alcune di esse hanno fornito spunt che hanno fnito con
alimentare il dibatto teorico e col contribuire non poco a determinare mutament di
paradigma nell'ambito della museografa antropologica dei decenni successivi. Tra le
esperienze eccentriche rispetto alle tendenze principali della museografa anni Settanta e
rispetto ai modelli appena vist meritano una partcolare attenzione quelle di Giuseppe
Šebesta91, già chiamato in causa, e di Ettore Guatelli. Due fgure distant che hanno
91 Sulla figura di Šebesta e sul suo ruolo di realizzatore di musei ma anche – seppur parzialmente – di scrittore di musei
cfr. Pietro CLEMENTE, Vent'anni dopo. Alberto M. Cirese scrittore di musei, op. cit., pp. 8-9, dove si tratteggia anche la
figura di Giovanni Battista Bronzini, altro scrittore e progettista di musei, per il quale oltre al citato Homo Laborans
(cfr. nota 1) si veda anche Ferdinando MIRIZZI, Giovanni Battista Bronzini scrittore e progettista di musei, in Ferdinando
MIRIZZI, Storie di oggetti Scritture di musei. Rifessioni ed esperienze tra Puglia e Basilicata, Bari, Edizioni di Pagina, 2008. Gli
[31]
immaginato e realizzato, grosso modo nello stesso periodo, anche se forse il primo con un po'
di antcipo, proget molto diversi tra di loro.
Giuseppe Šebesta (1919-2005) è stato «chimico, cineasta, cartoonist, scrittore, pittore
etnografo, nonché fondatore, proprio da raccoglitore esausta, vorace e pigliatutto»92 sia del
Museo degli Usi e Costui della Gente Trentna 93 di San Michele all'Adige, sia del Museo degli
Usi e Costumi della Gente di Romagna di Santarcangelo di Romagna 94. Intellettuale ecletco95,
Šebesta non è stato soltanto raccoglitore, ma anche cercatore e studioso di font, come
dimostra la sua ricca e artcolata bibliografa. Quello suo è stato un interesse proiettato
fondamentalmente verso il mondo dell'ergologia ed in partcolare dello studio dei processi
lavoratvi. L'impianto che Šebesta ha conferito al MUCGT, quello che è rimasto maggiormente
fedele sul piano degli allestment al progetto originario, è quello di «un museo etnografco di
evidente derivazione natural-scientfca»96, incentrato sui canali chiusi, attento ai passaggi
elementari delle lavorazioni artgianali della tradizione locale, «i cosiddet intermedi della
lavorazione degli ogget in legno, in rame, in ferro dai quali si [può] evincere con chiarezza
lampante il debito profondo della tecnologia rurale ad alcuni principi strutturali fondamentali,
annidat nelle pieghe più remote della manualità, della fabrilità stessa dell'uomo» 97. Quello
pensato da Šebesta è stato, come puntualizza il suo attuale direttore Giovanni Kezich, un
museo distante dai modelli e dagli interessi della museografa anni Settanta, all'interno del
quale alcuni temi – come ad esempio quelli legat alla dimensione festva e rituale – non hanno
trovato partcolare spazio. Un museo basato su un ordinamento incentrato sul concetto
ergologico di “canale chiuso”, dove antropologia ed archeologia si compenetrano98.
92
93
94
95
96
97
98
scritti museografici di Šebesta sono stati pubblicati nella raccolta Giuseppe ŠEBESTA, Scritti etnografci, San Michele
All'Adige, MUCGT, 1991, Parte II. Infine vedi anche Giovanni Battista BRONZINI, L'avventura etnomuseografca di G.
Šebesta, «Lares», n. 58, pp. 499-513.
Giovanni KEZICH, Il museo selvaggio. Note per uno studio di antropologia museale, op. cit., p. 52.
Giovanni KEZICH, Eriberto EULISSE e Antonella MOTT, Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina. Nuova guida
illustrata, San Michele All'Adige, MUCGT, 2009 ed anche Giovanni KEZICH, Il Museo degli Usi e Costumi della Gente
trentina e l'opera di Giuseppe Šebesta, in Giovanni KEZICH e Mario TURCI (a cura di), Antropologia museale, op. cit., pp.
71-80.
Sulla storia del Museo cfr. Mario TURCI (a cura di), Storia di un museo. Il Museo degli Usi e Costumi della Gente di
Romanga. 1971-2005, Imola, Editrice La Mandragora, 2005. Vedi anche Mario TURCI e Federica FOSCHI, MET.
Museo degli Usi e Costui della Gente di Romagna. Guida catalogo, Rimini, Provincia di Rimini, 2007.
Testimonianze autobiografiche legate anche alla formazione del museo di San Michele all'Adige sono contenute nel
volume scritto da Giuseppe ŠEBESTA e intitolato In forma di museo. Il flm dei primi anni nei ricordi del fondatore, San
Michele all'Adige, MUCGT, 1998.
Giovanni KEZICH, Il Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina e l'opera di Giuseppe Šebesta, op. cit., p. 73.
Ibid., p. 74.
Massimo TOZZI FONTANA, I Musei della cultura materiale, op. cit., p. 68: «esemplificando, una falciola o il
correggiato per il grano sono attrezzi che rientrano nel canale “molinologia”, intesa come punto di convergenza e di
sintesi di tutte le attività cerealicole». Una tanto sintetica quanto efficace descrizione dei principi base
[32]
Altra fgura del tutto originale che emerge dal panorama preso in analisi è quella di
Ettore Guatelli (1921-2000) . Il Museo Guatelli 99 non può essere accomunato totalmente coi
musei spontanei che, negli anni in cui esso nasceva, venivano allestt un po' in tutta l'Italia
centro-settentrionale. Il Museo, opera della vita di Ettore, «è tutt’altro che ingenua ed è
tutt’altro che artfciosa. Non è riconducibile a quella che i museograf professionist e
accademici chiamano ‘museografa spontanea’, e che costtuisce la parte principale del
patrimonio nazionale di museografa locale della vita e del lavoro contadino e artgiano in
Italia»100. Guatelli, profondo conoscitore della realtà all'interno della quale si è trovato
immerso fn dalla nascita (il mondo contadino e mezzadrile), maestro elementare iscritto alla
Bocconi e membro del ‘cenacolo Bertolucci’, profondo scrittore di musei, poeta e
museografo101, ha collezionato ogget riguardant classi sociali, epoche e mesteri diversi. Ma
non si è limitato a raccogliere cose. Un aspetto assolutamente non secondario dell'operato di
Guatelli risiede nella raccolta di testmonianze, informazioni e storie che poi sono fnite
archiviate nel suo grande schedario 102. Quello di Ozzano Taro, come suggerisce Pietro
Clemente, può essere considerato un museo «che vive nell’intersezione di un grande
collezionismo povero, un’ area di acquisizione degli ogget (l’Emilia appenninica e padana), un
campo di informatori (la valle del Taro), e delle sortte molteplici in aree diverse legate sia ai da
transit reali nell’area del parmense (tagliatori, sediai...), sia di informatori occasionali e
conosciut in contest extraemiliani (il sanatorio di Iesolo), sia infne di prodot industriali privi
di reali signifcat localizzatvi, e di cose le più varie reperibili nel contesto del piccolo
dell'allestimento del Museo di San Michele la offre il suo direttore in un articolo pubblicato su
http://www.questotrentino.it/qt/?aid=9327: «una serie di "canali chiusi" (molinologia, alpeggio, filatura/tessitura,
metallurgia, ecc.) che corrispondono ad altrettante filiere tecnologiche del mondo tradizionale, ovvero ai vari aspetti
del sistema agrosilvopastorale tradizionale della montagna trentina e alla minuta tecnologia artigiana che lo
supportava: legno, pietra, tessuti, ceramica, rame, ferro… All’interno di ciascun settore, gli oggetti/testimoni sono
disposti nell’ordine in cui compaiono all’interno della filiera di riferimento, secondo una sequenza precisa, del genere
falce, rastrello, gerla, ovvero filatoio, aspo, arcolaio, orditoio, telaio… I settori stessi, a loro volta, sono ordinati
secondo uno schema che colloca alla base – ovvero ai piani bassi – l’agricoltura e i processi della trasformazione
agrosilvopastorale, al livello intermedio le attività artigiane di supporto, e a quello sommitale la socialità e il
simbolico: costumi, folklore, musica, riti, devozione…».
99 Catia MAGNI e Mario TURCI, Il Museo è qui. Il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, Ginevra-Milano, Skira, 2005;
CLEMENTE, I confni del Museo, il Museo dei confni, op. cit., pp. 69-105.
100 Ibid., p. 69.
101 Nel senso di colui che «scrive con oggetti, spazi, sequenze significative, e de-scrive forme antropologiche della vita»,
cfr. Pietro CLEMENTE, Introduzione. Graffiti: il libro raccontato, in id., Graffti di museografa antropologica italiana, op. cit.,
p. 29. Di Ettore GUATELLI, a proposito del suo mondo e del suo museo, si veda anche La coda della gatta. Scritti di
Ettore Guatelli: il suo museo i suoi racconti (1948-2004). Nuova edizione aggiornata e ampliata, a cura di Vittorio
FERORELLI e Flavio NICCOLI, Bologna, IBC, 2005.
102 Cfr. Ettore GUATELLI, Il Taro e altre storie, Reggio Emilia, Diabasis, 2005.
[33]
antquariato, da rigateri e rottami, nelle discariche»103.
Cifra caratterizzante il Museo Guatelli è il modo in cui Ettore, prima all’interno del
fenile e poi anche della casa di famiglia, ha disposto gli ogget seguendo una complessa
strategia comunicatva e creando dei graffiti. Quello della corretta sistemazione, del disporre
“bene” quanto raccolto, è stata incessantemente per Guatelli una esigenza primaria. Questa
tensione non deve essere interpretata come il tentatvo di Ettore di dare valore artstco alla
propria opera e a quanto la costtuisce: mettere “bene” gli ogget ha sempre signifcato per
Guatelli creare grafsmi tali da far sì che la ripulsa dei visitatori nei confront degli ogget
poveri coi quali i grandi disegni erano stat compost fosse superata grazie alla curiosità e alla
meraviglia che gli stessi erano in grado di suscitare. Un modo, questo, per avvicinare il
pubblico a quelle testmonianze materiali e al loro mondo di provenienza 104. L’ideale
allestmento di un museo, secondo Guatelli, deve essere un «compromesso tra la scientfcità,
la seriosità inevitabile e naturalmente mista a una certa tristezza un poco cimiteriale, e l’ironia,
la leggerezza e il fascino delle storie che si riesce a far raccontare agli ogget» 105, e ciò perché i
musei devono atrare un pubblico che non è tanto quello degli specialist, quanto quello
composto da persone che «forse cerca[no] più piacere, in genere, che cose serie»106.
Nel 1987 l'Amministrazione provinciale di Parma chiese ad una equipe di universitari,
in prevalenza antropologi, una “perizia” 107 sul Museo Guatelli. Secondo il ricordo di Clemente
fu Cirese a trovare una chiave di lettura della cosa guatelliana, vista fno ad allora più che altro
come espressione di una sorta di insanabile «patologia da collezionista locale»108; una
interpretazione in grado di farla uscire dalla condizione di marginalità nella quale nel corso del
tempo era progressivamente sprofondata 109. Secondo Cirese, gli ogget del Museo Guatelli
103 Pietro CLEMENTE, I confni del Museo, il Museo dei confni, op. cit., p. 70.
104 Insomma, in quel caso è stata «un’ esigenza pedagogica, non estetica, giustifica il ricorso al bello», ibid., p. 93.
105 La citazione è tratta da un documento reperito online (ad oggi non più accessibile) dal titolo Fare musei pubblicato sul
sito web www.akros.it/amrisorse; per questo testo un riferimento bibliografico è fornito nella Bibliografa a cura di
Jessica ANELLI pubblicata in coda al volume GUATELLI, Il Taro e altre storie, op. cit., p. 248, cfr. Ettore
GUATELLI, Fare musei, in Atti del Convegno Nazionale “Agricoltura, musei, trasmissione dei saperi, Verona
1998”, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 2000, pp. 371-383.
106 Loc. cit..
107 Relazione relativa al sopralluogo per la valutazione scientifca e documentaria della “Collezione Guatelli” di Ozzano Taro, a cura
della commissione incaricata dalla amministrazione provinciale di Parma, composta dai professori A. Cirese, G.
Cusatelli, T. Seppilli, P. Clemente, F. Giusberti (Primavera 1987 – dattiloscritto in n. 10 cartelle), depositato presso
Amministrazione Provincia di Parma, ora pubblicata in Alberto Mario CIRESE, Beni volatili, stili, musei, op. cit., pp.
191-198.
108 Pietro CLEMENTE, I confni del Museo, il Museo dei confni, op. cit., p. 83.
109 Delle difficoltà incontrate nel corso del tempo, del rapporto con le autorità, ma anche coi compaesani e coi
[34]
erano da considerarsi espressione concreta della vocazione artgiana e rurale del loro mondo
di provenienza, e la loro quanttà e ripettvità altro non rappresentava se non il corrispetvo
della «quanttà sociale delle classi produttrici» che andava a comporre «una sorta di di
‘monumento grafco’ al lavoro rurale e artgiano»110.
Per quanto unica ed irripetbile, l'esperienza guatelliana ha arricchito il panorama della
museografa degli ultmi decenni del Novecento di una ulteriore pagina, di un ulteriore modo –
orientato sul versante del monumento111 – di concepire il senso del museo e dell'esposizione
testmonianze di cultura materiale. Guatelli, all'interno del uso Museo, non ha inteso parlare
del ‘come eravamo'; la sua atvità va letta come il desiderio di testmoniare un complesso
patrimonio fatto di saperi, di saper fare, di soferenza e di genialità di cui erano portatori i suoi
familiari e conterranei fno all'epoca della modernizzazione avvenuta negli anni Sessanta ma
anche oltre, e non come il semplice vagheggiare un mondo contadino perduto, cosa che
invece ha caratterizzato molte delle realizzazioni più direttamente riconducibili alla
museografa spontanea contadina.
1.4 MUSEOLOGIA RAZIONALISTA E MUSEOLOGIA ESTETICA
L'inaugurazione del Museo della terra di Latera fu preceduta, nel 1998, da un convegno
dal ttolo Verso il museo della civiltà contadina “Luigi Poscia”. Cultura materiale e beni
volatili112. L'incontro vide la partecipazione di alcuni tra i protagonist della museografa
antropologica laziale nonché del più ampio dibatto nazionale sul tema: la già citata Luciana
Mariot ma anche Quirino Galli, direttore del Museo delle tradizioni popolari di Canepina (VT),
Valeria Petrucci già Sovrintendente al MNATP di Roma e all'epoca Presidente della
Commissione Nazionale per i Beni Demoetnoantropolgici del MIBAC, Sandra Puccini,
antropologa dell'Università di Viterbo così come Marcello Arduini, e Alberto Mario Cirese,
familiari tendenzialmente Guatelli parla diffusamente nel volume Il taro e altre storie, op. cit..
110 Relazione relativa al sopralluogo per la valutazione scientifca e documentaria della “Collezione Guatelli” di Ozzano Taro, op. cit.,
citato in CLEMENTE, I confni del Museo, il Museo dei confni, op. cit., p. 83.
111 Secondo LE GOFF il «monumentum è un segno del passato. Il monumento, se si risale alle origini filologiche, è tutto
ciò che può richiamare il passato, perpetuare il ricordo», cfr. la voce DOCUMENTO/MONUMENTO, Enciclopedia
Einaudi, vol. 5, pp. 38-48, Torino, Einaudi, 1978.
112 Del convegno è rimasta traccia grazie alla pubblicazione degli atti, cfr. Marcello ARDUINI (a cura di), Verso il
museo. Atti del Convegno di Studi Verso il Museo della civiltà contadina “Luigi Poscia”. Cultura materiale e beni volatili.
Latera, 30 maggio 1998, Latera, 1998.
[35]
professore ordinario di Antropologia culturale presso L'Università di Roma “La Sapienza”.
La vicenda del Museo di Latera, per quanto riguarda la sua genesi, la costtuzione della
collezione che ne è alla base, può essere sostanzialmente ricondotta alla museografa
spontanea dal basso. Il modo e i tempi nei quali la collezione è stata raccolta, la fgura del
raccoglitore, le motvazioni di base: tutto coincide. Per quanto riguarda l'allestmento, invece,
l'iniziatva non è stata lasciata agli stessi attori protagonist della fase di raccolta, ma sono stat
chiamat degli addet ai lavori. Piuttosto che mettere in mostra gli ogget all'interno di un
locale qualsiasi e sulla base di un approccio di tpo mimetco (immediata ricostruzione di
ambiente), è stato chiesto esplicitamente l'aiuto di specialist. Siamo a metà degli anni
Novanta del Novecento, e benché siano percepibili i primi segni di cambiamento, l'aderenza
dell'allestmento in questone al classico paradigma razionalistco appare, come già accennato,
tutto sommato forte.
Il fondatore della scuola di museologia antropologica di stampo razionalista è stato Alberto
Mario Cirese113. Il suo primo scritto di argomento museale 114 consiste nella relazione di apertura,
inttolata I musei del mondo popolare: collezioni o centri di propulsione della ricerca? 115, tenuta al
Seminario di studi Museografa e Folklore svoltosi a Palermo nel 1967. Un testo importante dove
fa la sua comparsa la nozione di metalinguaggio museale, un concetto destnato a fare storia nel
campo della museologia, italiana e non solo 116. Secondo Cirese il museo è sempre e solo un
insieme di document. Un qualsiasi oggetto sottratto dal proprio contesto di uso-giacenza 117
113 Nel campo di quelle che a partire dagli anni XX sarebbero state chiamate discipline demoetnoantropologiche,
anche se allora non si chiamavano così, la rifessione sul mondo dei musei rimonta – a voler individuare antenati
ragionevolmente distanti nel tempo – ai primi del Novecento. Per quanto ci riguarda più da vicino, e dunque le
rifessioni circa i criteri di allestimento del Museo di Etnografia Italiana voluto da Lamerto Loria cfr. i volumi già
segnalati Sandra PUCCINI, L'Itala gente delle molte vite, op. cit., Giuseppe COCCHIARA, Storia del folklore in Italia,
op. cit., Massimo TOZZI FONTANA, I musei della cultura materiale, op. cit. Tuttavia, già nel corso della seconda
metà del XIX secolo le vicende relative alla istituzione del Museo Etnografico Presitorico animarono non poco il
dibattito scientifico, ma in questo caso il versante interessato era quello della museografia della paletnologia e
dell'etnografia degli altri continenti, cfr. Carlo NOBILI, Per una storia degli studi di antropologia museale. Il «Museo Luigi
Pigorini» di Roma, «Lares», LVI n. 3, Luglio-Settembre 1990, pp. 321-382 e più in generale, sulla nascita del museo
etnografico, Claudio PIERUCCI, Il museo etnografco: le ragioni di una istituzione, Roma, La Goliardica, 1984.
114 Una bibliografia dei lavori di Cirese è stata pubblicata di recente, vedi Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese,
Bibliografia a cura di Eugenio TESTA, Firenze, Leo S. Olschki, 2011. La lettura del medesimo autorizza a ritenere
quello citato il primo articolo di argomento museale scritto dall'Autore.
115 Pubblicato originariamente su «Architetti di Sicilia», n. 17-18, gennaio-giugno 1968 e raccolto successivamente in
Alberto Mario CIRESE, Oggetti, Segni, Musei, op. cit., con il titolo Le operazioni museografche come metalinguaggio.
116 Cfr. Pietro CLEMENTE, Vent'anni dopo. Alberto M. Cirese scrittore di musei, op. cit., p. 8, dove si legge «il testo di Cirese
è stato infuente anche fuori dei nostri studi, come spesso mi vien ricordato da storici dell'arte e archeologi, che non
hanno una produzione teorica di museografia molto ampia e spesso guardano con attenzione alla nostra letteratura
in merito» e ancora «il 'nutrimento' ciresiano era all'altezza del dibattito internazionale, ed era 'nostro'».
117 Cfr., Alberto Mario CIRESE, Classi astratte e cose concrete, in Pier Giorgio SOLINAS (a cura di), Gli oggetti esemplari,
op. cit., p. 27: «il documento non è dato ma si costruisce; certe cose diventano documento se cambiano contesto».
[36]
non è più soltanto l'oggetto che era prima di essere decontestualizzato, diventa anche
documento. (Cito a memoria tanta è l'importanza che ha rivestto nella mia formazione, e non
solo nella mia ma in quella di generazioni intere di antropologi museali, questo testo.)
Prelevato da una stalla, da una bottega, l'oggetto perde la sua funzione d'uso e ne acquista
una di testmonianza. Document diret dunque (ogget, magari corredat da apparat),
document indiret (fotografe, per esempio), ma sempre e solo di document è fatto il museo,
e per ciò questo tpo di isttuto culturale «può parlare solo la lingua che si parla coi document.
Voglio dire che è impresa assurda il volere che il museo parli il linguaggio della vita quando per
sua natura il museo estrae gli ogget dal contesto vitale» 118. Quello di Cirese è un invito a
rispettare lo status logico e semiologico 119 del museo. Non può esistere, sostene l'Autore, un
museo che imit la vita, che la ricostruisca al proprio interno uguale a sé stessa: «sempre ed in
ogni caso i musei sono una cosa diversa dalla vita: per defnizione immobilizzano ciò che è
mobile, cristallizzano ciò che è destnato a trasformarsi» 120. Quello che il museo artcola è un
metalinguaggio, un linguaggio cioè che ha proprie regole, che funziona diversamente da quello
della vita vissuta e che consente di rifettere su di essa. Il metalinguaggio rende discreto il
contnuum dell'esistenza, e nel far ciò permette alla vita degli uomini di diventare qualcosa di
intelligibile. In queste poche parole è concentrata la critca a quell'ingenuo realismo
museografco in base al quale si cercava 121 di ricostruire scene di vita quotdiana all'interno
delle sale dei musei, non facendo altro che comunicare ai visitatori – e non solo a loro – una
idea di «polverosa inerzia»122. Oltre, e questo è ancora più importante, a non ofrire al fruitore
dell'allestmento chiavi di comprensione di quanto esposto. In questa otca, secondo Cirese,
118 Alberto Mario CIRESE, Condizione contadina tradizione, nostalgia, partecipazione, op. cit., p. 13.
119 Ibid., p. 14.
120 Alberto Mario CIRESE, Le operazioni museografche come metalinguaggio, op. cit., p. 40. Vincenzo PADIGLIONE ha
mosso una critica verso la tesi di Alberto M. CIRESE. Il primo sostiene che «la contraddizione vita/museo sarebbe
dovuta secondo Cirese alla loro appartenenza ad uno status logico e semiologico fatalmente distinto: da una parte,
“vivere” e, dall'altra, “rifettere sul vivere”. Questa diversificazione può essere senz'altro utile, ma credo che molti
come me coltivino la presunzione, o solo forse la speranza, di considerare il rifettere sul vivere un aspetto
inscindibile dal proprio modo di vivere (non è questa una categoria dell'agire dotata di senso? Del processo di
simbolizzazione umana? C'è una complessità di tipi logici nelle pratiche sociali che mi porta a considerare
l'interpretazione di interpretazioni la regola più che l'eccezione)», cfr. Per una centralità dell'etnografa nei musei, in id.
Poetiche dal museo etnografco, op. cit., pp. 100-101.
121 In realtà questo genere di allestimento prospera, i musei che propongono ricostruzioni di ambienti sono moltissimi.
Per rimanere alla provincia di Viterbo, che è quella che conosco meglio, si veda il Museo delle tradizioni popolari
di Canepina tra l'altro riallestito in epoca recentissima (2006). Ben altra cosa è, tanto per fugare il campo da
possibili fraintendimenti, quelle che potrebbero passare per ricostruzioni di ambiente all'interno del Museo del
brigantaggio di Cellere, o anche la Museo delle Terre di Confine di Sonnino, e che invece – per rimanere al primo
esempio – sono allestimenti di tipo scenografico e dal forte potere evocativo, cfr. Vincenzo PADIGLIONE e Fulvia
CARUSO, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi, op. cit., pp. 287-296.
122 Alberto Mario CIRESE, Le operazioni museografche come metalinguaggio, op. cit., p. 39.
[37]
«per aderire alla vita il museo deve trasporre questa nel proprio linguaggio e nella propria
dimensione», scomporla, ricomporla secondo proprie logiche e quindi comunicarla, riuscendo
in questo modo a «rendere comprensibili i nessi che nel vivo vitale restano celat» 123, disporre
il reale «secondo linee di intelligibilità che il reale non ci presenta» 124. Linguaggio, quello
appena richiamato, che coincide con quello della ricerca scientfca, considerato da Cirese e
della sua scuola dell'epoca una «forma di comunicazione forte, seletva, univoca, capace di
arrivare all'interlocutore senza “disturbi” e fraintendiment»125.
L'idea di museo che ne esce è quella di una sorta di grande laboratorio dove vengono
costruite connessioni tra gli ogget e ogget, ogget e contest. Uno spazio dove viene
“smontata” la realtà quale essa appare immediatamente ai sensi e viene ricostruita secondo
regole tali da mettere in evidenza quanto di solito rimane celato allo sguardo, le logiche che
sottendono determinat modi di vita. Ma Cirese immagina anche la disseminazione lungo i
percorsi allesttvi di riproduzioni di ogget, al fne di mostrare il funzionamento di macchine e
attrezzi, nonché di apparat di approfondimento quali dizionari, atlant linguistci ed
etnografci, carte di distribuzione di determinat ogget o fenomeni, grafci. Una museografa,
in defnitva, di chiara impronta razionalistca e sorretta dall'idea di pensare musei fat per
rendere i visitatori protagonist, «sogget e non ogget della visita»126.
Come già detto, l'dea del metalinguaggio museale ha fatto scuola per molt anni. A
partre dagli anni Novanta, tuttavia, inizia ad afacciarsi sulla scena un modo diverso di pensare
al museo. Il movimento che a questo punto intendo fare, per illustrare percorsi centrifughi
rispetto al nocciolo duro del pensiero ciresiano, è quello che consiste nel ripercorrere, per
punt salient, i capitoli che compongono la raccolta di saggi scrit da Clemente e
pubblicata nel 1996 col ttolo Graffiti di museografa antropologica italiana. Tra un saggio e
l'altro di questo volume si coglie il progressivo consumarsi del passaggio da una idea di
museo pienamente aderente al dettato ciresiano a qualcosa di molto diverso, ma anche lo
123 Ibid., p. 48.
124 Ibid., p. 49.
125 Pietro CLEMENTE, I musei: appunti su musei e mostre a partire dagli studi demologici, in id. Graffti di museografa
antropologica italiana, op. cit., p. 78. Nel saggio I beni demologici in Italia e la loro museografa, pubblicato sempre in Graffti,
Cirese scrive difendendo la propria visione di museo e dei linguaggi che al suo interno devono essere utilizzati: «per
me resta fermo il punto che la scienza ha capacità autonome di comunicazione, valide quanto quelle estetiche, ed a
volte altrettanto emozionanti. Né il conoscere razionalmente è bisogno soltanto di pochi eletti chiusi nei loro
gerghi», p. 257.
126 Ibid., p. 54.
[38]
spostamento dell'oggetto di interesse dal museo in senso stretto al patrimonio più
ampiamente inteso. È questo insomma il caso tpico in cui ripercorrendo la bi(bli)ografa di
un autore si può osservare da vicino un progressivo cambiamento di paradigma.
I saggi pubblicat all'interno di Graffiti coprono un arco temporale che va dal 1980 al
1994. Il primo, Appunti e rifessioni sui linguaggi espositivi rimanda all'esperienza della mostra
Il Mestiere del Contadino svoltasi a Buonconvento nel 1979, nata dall'impegno diretto di
ricercatori di provenienza accademica,127 «per me, per noi, la prima mostra, bella e
ciresiana»128 per dirla con le parole stesse di Clemente; una mostra temporanea che precede la
nascita del Museo della mezzadria e che trasforma in percorso tridimensionale e
concretamente esperibile il dettato metalinguistco ciresiano. Si tratta di un saggio, per
esplicita ammissione del suo Autore, «assai ortodosso sulla linea dell'impostazione di A.M.
Cirese»129 dove tornano tut i temi del metalinguaggio.
Il secondo contributo reca in sé già alcune novità. Dopo una iniziale rifessione in merito
ad alcune possibili tpologie museali (il museo-collezione di matrice positvistca, il museodiscorso ciresiano), e dopo un tentatvo di defnizione minima, operatva, di museo come di
uno «spazio artfciale programmato in funzione dell'occhio di persone che ne percorrano il
campo visivo in posizione eretta»130, l'Autore esprime la necessità di non tralasciare – e anzi di
valutare con attenzione – il ruolo che la soggetvità personale dei fruitori di una esposizione
ha nella ricezione del discorso scientfco, quello stesso tpo di linguaggio in base al quale
erano modellate le mostre che venivano progettate sulla scorta del canone ciresiano. È in
questo passaggio che viene a messa a punto la metafora del museo come bazar. Il discorso
razionale, autorevole, univoco, funziona bene all'interno di un laboratorio, ma le mostre –
aferma Clemente – sono rivolte ad un pubblico plurale e sono «ogget possibili di mille diversi
occhi»131. È da questa acquisizione che inizia a farsi strada l'idea che, accanto a forme di
comunicazione altamente schematche e in grado di riprodurre le logiche della ricerca
scientfca, ne possano essere affiancate altre di diverso segno, che «nella museografa può
127
128
129
130
Cfr. l'intervista a Gianfranco Molteni posta in appendice.
CLEMENTE, Vent'anni dopo. Alberto M. Cirese scrittore di musei, op. cit., p. 7.
Pietro CLEMENTE, Introduzione: Graffiti, il libro raccontato, op. cit., p. 33.
Pietro CLEMENTE, I musei: appunti su musei e mostre a partire dagli studi demologici, op. cit., p. 70. Definizione talmente
asciutta da sembrare, tutto sommato, inattaccabile e ineccepibile. Ci fosse stato un riferimento oltre che all'occhio
anche all'orecchio e più in generale al conoscere corpo sarebbe stata estremamente efficace.
131 Ibid., p. 79.
[39]
esservi uno stmolo ad arricchire la comunicazione con immagini che non suppongano di
rivolgersi solo al “pensiero”, ma che cerchino di comunicare con il deposito vivo dei ricordi,
immaginazioni, fantasie, visualità degli interlocutori possibili»132.
Nella seconda sezione, La comunicazione di massa, quanto presente in nuce nella parte
precedente esplode trasformando quello che era un semplice abbozzo di modello in qualcosa
che inizia ad assumere una sua completa fsionomia. L'immagine che emerge è quella di un
museo aperto alla contemporaneità, un campo all'interno del quale si confrontano sogget,
esperienze e intenzioni diverse. Il museo inizia ad essere riconosciuto come uno strumento di
comunicazione
di
massa
che
svolge
una
funzione
pubblica 133,
un
«ambiente
comunicatvamente programmato»134 dove trovano spazio molt media (postazioni
informatche, punt di ascolto, postazioni audiovisive) e dove la «varietà di stli percetvi deve
essere collocata dentro una scelta 'scenografca' unitaria»135. Il tutto in linea con la sensibilità
postmoderna circa la consapevolezza dei limit connaturat al linguaggio scientfco 136. Più che
un museo laboratorio si fa spazio l'idea di un museo come banca dei document, ma anche
«banca di idee e luogo di percezioni»137, una «sala comandi dei percorsi territoriali», un
qualcosa che non si esaurisce tra le quattro mura di un edifcio ma rimanda al fuori e fornisce
chiavi di lettura inedite di quanto sta all'esterno; un luogo da dove «si accede a una nuova
visione della realtà, delle sue tracce di passato e delle mescolanze con il presente»138. Sul piano
dei linguaggi è proprio nel saggio Il museo demologico tra il ricercatore e l'utente che si fa
strada l'idea del museo come luogo della traduzione, luogo cioè dove il linguaggio scientfco
viene tradotto «in forme di comunicazione e percezione che incontrino l'immaginario e la
competenza colletva»139.
In Museografa, estetica, comunicazione, del 1989, vengono sviluppat i temi e le
prospetve che portano a considerare il museo come «luogo di arte applicata alla
132 Loc. cit..
133 Cfr. Pietro CLEMENTE, Il progetto del Museo di Alberese, in Pietro CLEMENTE, Graffti di museografa antropologica
italiana, op. cit., p. 113.
134 Ibid., p. 115.
135 Loc. cit..
136 Ibid., p. 116.
137 Pietro CLEMENTE, Il museo demologico tra il ricercatore e l'utente: problemi di comunicazione e linguaggio, in CLEMENTE,
Graffti di museografa antropologica italiana, op. cit., p. 138.
138 Ibid., p. 133.
139 Ibid., p. 139.
[40]
comunicazione di massa, guidato da argoment emersi dalla ricerca scientfca» 140. Prende
forma l'idea del museo come di «una scatola di iniziazione a esperienze culturali diverse dalla
lettura o dal flm, con proprie convenzioni, dal quale il visitatore deve uscire in qualche modo
trasformato, o almeno arricchito di capacità di comprensione della realtà. Il museo riorganizza
le percezioni corrent del tempo e dello spazio sociale» 141, una visione che poi ricompare nel
saggio Il pubblico di un museo142 dove si parla, questa volta apertamente e compiutamente,
del museo come di una scatola della conoscenza che «non si limita a rendere leggibili gli
ogget, ma l'intero territorio»143. Si consuma in questo modo il passaggio dall'idea di museo
metalinguaggio a quella di metamuseo. Emerge nuovamente, ma in questo caso ma in
maniera più artcolata, il concetto di scenografa museografca e di museo come luogo di
comunicazione di massa «dove idealmente sgombrare il campo dal pieno di ogget» 144 per
lasciare posto alle questoni di cui l'antropologia si occupa e che non sempre trovano
possibilità di essere esperite tramite le cose materiali.
Il terzo principio della museografa, raccolta di saggi pubblicata nel 1999, in qualche
modo arriva a completare e a mettere a sistema molte delle acquisizioni già present in
Graffiti. Nel saggio Il museo, la comunicazione, il pubblico si rintraccia, giunta a completo
sviluppo, l'idea – già presente nel volume del 1996 – del museo come scatola della
conoscenza, dove «entrat, non si può vedere tutto un mondo, ma uscit si riesce a scorgere
qualcosa che prima ero scotomizzato, e si impara a cercare» 145. Museo come macchina del
tempo, come «palcoscenico di altri tempi/spazi culturali» 146 orientato verso il futuro, perché
«le nuove generazioni, incontrando culture e tempi diversi, senza impossibili nostalgie ma con
curiosità, metteranno nel proprio corredo delle esperienze possibili il patrimonio delle
generazioni passate, lo porterà con sé e ne farà liberamente uso» perché «poter tornare al
passato con occhi nuovi aiuta ad essere più ricchi di immaginazione e meno soli nell'afrontare
140 Pietro CLEMENTE, Museografa, estetica, comunicazione, op. cit., p. 149
141 Ibid., p. 151.
142 Pietro CLEMENTE, Il pubblico di un museo, in Gianfranco MOLTENI (a cura di), Il Museo del bosco di Orgia, Siena,
Protagon, 1993, pp. 20-24; la citazione è tratta da pag. 20. Parzialmente rielaborato, lo stesso testo è raccolto nel
volume di CLEMENTE e ROSSI, Il terzo principio della museografa, op. cit., col titolo Il museo, la comunicazione, il
pubblico.
143 Pietro CLEMENTE, La museografa locale: un'identità diffcile, op. cit., p. 173.
144 Ibid., p. 170.
145 Pietro CLEMENTE, Il museo, la comunicazione, il pubblico, op. cit., p.109.
146 Ibid., p. 109.
[41]
il futuro»147. Una visione, questa, che si riconnette poi alla bella metafora del carbone 148
evocata nel primo capitolo e utlizzata per pensare il museo come ad una sintesi di passato e
potenza di futuro. Sul piano del museo quale luogo di comunicazione di massa 149, infne, viene
ribadita la necessità, fatta salvo il principio che il museo deve comunicare conoscenze non
superfciali, di aprire – superato con la sensibilità postmoderna «lo steccato che si era stabilito
tra scienza e arte»150 – a «modi diversi del percepire estetco, al desiderio, all'evocazione, alla
memoria, al sogno, come aspet che non negano ma accompagnano, e talora antcipano o
sollecitano, la conoscenza»151.
Sul piano generale Il terzo principio della museografa testmonia il progressivo
passaggio dell'Autore «dal suggerire museografe [...] ad analizzare le pratche dei musei e
degli ogget come fat culturali» 152. Chiaro esempio di traduzione in pratca di questo
orientamento è costtuito dai due capitoli fnali del volume che rappresentano una lettura
critca, una sorta di “recensione”, di due grandi mostre dedicate una ai Celt, Venezia 1991, e
un'altra ai Normanni, Roma 1994.
1.5
TAGLIO ANTIQUARIO E PROSPETTIVA CONTEMPORANEISTA
A cavallo tra la fne degli anni Novanta e i primi anni del 2000 molte sono state le
realizzazioni che si sono poste nel solco tracciato dall'esperienza dell'Etnomuseo (cfr. par. 1.3).
Sto parlando di una famiglia di musei laziali – l'utlizzo del termine famiglia è giustfcato dal
fatto che tut condividono la medesima paternità progettuale – caratterizzat da una spinta
tematcità153 e da un rigoroso approccio etnografco. Di questa, oltre al Museo del brigantaggio
di Cellere, fanno parte il Museo del brigantaggio di Itri 154, il Museo Etnografco del giocattolo 155
147 Ibid., p. 110.
148 Pietro CLEMENTE, La civiltà contadina come epoca, op. cit., p. 37.
149 Sul museo quale «mezzo impareggiabile di comunicazione che si serve del linguaggio non-verbale, di oggetti e
immagini» cfr. Italo Carlo ANGLE, Introduzione, in id. (a cura di), Musei, società, educazione. Guida per operatori culturali,
Roma, Armando Editore, 1976, p. 17 e oltre.
150 Pietro CLEMENTE, Il museo, la comunicazione, il pubblico, op. cit., p. 115.
151 Loc. cit..
152 Pietro CLEMENTE, Introduzione a Pietro CLEMENTE e Emanuela ROSSI, Il terzo principio della museografa, op. cit.
p. 12
153 Scelta che nasce da una parte per valorizzare quanto i luoghi esprimono ma anche per venire incontro alle
indicazioni della Regione Lazio che attraverso l'istituzione del Sistema museale antropologico DEMOS ha inteso
istituire una rete priva di sovrapposizioni tematiche.
154 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Storie contese e ragioni culturali, op. cit..
155 Vincenzo PADIGLIONE et al., Ludus, museo etnografco del giocatolo di Sezze, «AM-Antropologia Museale», anno 5,
numero 16, estate 2007, pp. 31-36.
[42]
di Sezze – LUDUS, il Museo delle Terre di confne di Sonnino, il Museo dell'inforata di
Genzano, Il Museo delle scritture di Bassiano. Tutte realizzazioni improntate a «superare
l'enfasi sull'oggettuale che spesso è stata associata al fetcismo» 156 sulla scorta delle
sperimentazioni avviate da Hainard presso il Museo di Neuchâtel, un museo quest'ultmo «che
porta avant con persistente ed efficace provocazione una “muséologie de la rupture” protesa
a trasformare l'oggetto da sublime vedette ad elemento di decoro, reso intelligibile all'interno
di una rete di relazioni. Oramai su questa posizione, quella di privilegiare il Discorso rispetto
all'Oggetto, si colloca la museoloogia contemporanea» 157. Questa fase di forte vivacità ha
trovato riscontro anche nella nascita – lo segnalo operando un leggero slittamento di piano –
nel 2002 della rivista «AM-Antropologia museale», strumento che ha inteso proporsi come
una “casa comune” per la comunità degli antropologi museali, e che signifcatvamente sulla
copertna del primo numero porta proprio una immagine della mostra Le musée cannibale
tenutasi a Neuchâtel lo stesso anno.
Anche nel caso della contrapposizione dialetca che dà il ttolo al presente paragrafo
occorre, al pari di quanto detto in generale sui musei etnografci, prestare attenzione e tenere
gli occhi bene apert contro possibili errori prospetci. A determinare un approccio di matrice
“antquaria”, come è stato defnito, non è il contenuto del museo, ma il modo in cui le
collezioni al suo interno sono considerate. La museografa di stampo antquario 158 è quella che
rimanda al modello del museo-collezione, tpologia «che eredita il proprio paradigma
concettuale dal collezionismo privato e – nell'esperienza demologica e etnologica – dagli studi
ottocenteschi. I suoi ogget sono rari o belli, o partcolarmente signifcatvi, ed hanno valore in
quanto tali. La comunicazione del museo-collezione è di tpo estetco o specialistco, per capire
si deve già conoscere, saper apprezzare»159.
Un tema che potenzialmente ben si presta ad un approccio di questo ultmo tpo è il
brigantaggio. Un simile fenomeno, che risale – poniamo mente a quanto messo in mostra nel
Museo di Itri160 – al periodo compreso tra il fnire del 1700 e il primo decennio del 1800,
potrebbe prestarsi bene ad un approccio antquario, collezionistco di base. Il Museo del
156 Vincenzo PADIGLIONE, Musei: esercizi a decostruire già operanti e per volenterosi, in id., Poetiche dal museo etnografco, op.
cit., p. 49.
157 Loc. cit..
158 Arnaldo MOMIGLIANO qualifica la mentalità antiquaria come «amante della classificazione e dei particolari
irrilevanti», cfr. Sui fondamenti della storia antica, Torino, Einaudi, 1984, p. 39.
159 Pietro CLEMENTE, I musei: appunti su musei e mostre a partire dalle esperienze degli studi demologici, op. cit., p. 71
160 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Storie contese e ragioni culturali, op. cit..
[43]
brigantaggio di Itri avrebbe potuto essere un museo giocato sulla pedissequa e “realistca”
ricostruzione della biografa dei brigant locali, accompagnata dall'esposizione di alcuni ogget
esemplari (armi, abit, document d'archivio). In questo modo, attraverso un allestmento
storicistco, scarsamente rifessivo, sarebbe stato possibile raccontare vita, opere e gesta di
Fra' Diavolo e circoscrivere lo sguardo entro gli angust spazi della ricostruzione dell'accaduto.
Lo stesso tema, trattato in una prospetva contemporaneista, prospetva connaturata
all'approccio propriamente etnografco, ha consentto invece di proiettare il brigantaggio
all'interno di scenari più ampi, di tematzzare confit tra le interpretazioni – anche
contemporanee – che sono sorte attorno al fenomeno, di problematzzare la natura dei
document che parlano di brigantaggio161. Stessa cosa dicasi per il Museo del brigantaggio di
Cellere, dove ad essere indagata non è solo la fgura di Tiburzi ma anche i motvi del forte
interesse che la sua fgura suscita oggi, le ragioni del successo commerciale del marchio
brigante. Una delle domande che più frequentemente i visitatori del Museo del brigantaggio di
Cellere pongono è se al suo interno siano conservat o meno ogget realmente appartenut ai
brigant, a Domenico Tiburzi in partcolare. È una questone che rimanda al tema, fortemente
discusso, dell'autentcità162 ma anche della reifcazione della temporalità 163, all'idea cioè che
alcuni ogget rappresentno vere e proprie concrezioni della storia. Il museo antquario
richiama l'idea di un museo come una sorta di grande teca contenente pezzi originali, che
consentono – quasi in virtù di un meccanismo magico 164 – un contatto con le persone alle quali
quegli ogget sono appartenut. Quello etnografco, invece, fornisce gli strument per rifettere
critcamente sulle categorie di autentco, originale, eccetera.
I musei sopra citat e la rivista AM nascono dalla progettualità di Vincenzo Padiglione,
antropologo atvo sia sul fronte della realizzazione dei musei che su quello della rifessione
teorica. Una sintesi del suo modo di intendere i musei è rappresentata da una raccolta di saggi,
molt dei quali comparsi proprio sulla rivista AM, pubblicata nel 2008 165. Il volume è
attraversato da temi ricorrent che aprono a letture profonde e rifessive sul nostro mondo.
161 Ibid. pp. 15-16 e oltre.
162 Cfr. Spencer R. CREW e James E. SIMS, Situare l'autenticità: frammenti di un dialogo, in Ivan KARP e Steven D.
LAVINE, Culture in mostra, op. cit., pp. 75-97.
163 James CLIFFORD, Sul collezionare arte e cultura, in id., I frutti puri impazziscono, op. cit., p. 256.
164 Stando alle categorie classiche dell'antropologia si potrebbe parlare di magia contagiosa basata sulla legge di
contatto, cfr. James George FRAZER, Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione, Torino, Bollati Boringhieri, 1995,
cap. 3.
165 Vincenzo PADIGLIONE, Poetiche dal museo etnografco, op. cit..
[44]
Uno di quest è legato alla visione del museo, al pari della tradizionale scrittura etnografca,
quale luogo non neutro di rappresentazione delle alterità culturali, dove inevitabilmente
vengono messi in scena i modi che di intendere il partcolare oggetto ha chi ha progettato
l'esposizione. Un aspetto molto importante che trova spazio nelle pagine del libro è la
rifessione sulla progressiva difusione delle pratche defnite “paramuseali” 166, il fatto cioè che
il linguaggio espositvo abbia fnito col migrare al di fuori delle mura dei musei e con il dilagare
al suo esterno, nel mondo del commercio e non solo, fno a confgurarsi come una sorta di
«'modello culturale' assai difuso di autocelebrazione e valorizzazione sociale» 167. Sembra cioè
che il museo e le pratche espositve ad esso connaturate abbiano subito il medesimo destno
di molt concet chiave del nostro mondo che in età contemporanea sono stat oggetto di una
«incessante torsione interpretatva perché l'esperienza a cui rinvia[no] va subendo una
vortcosa dilatazione esistenziale, perché a fanco de o in simbiosi con l'immagine data,
sacrale, idealizzata, è cresciuta una miriade di sperimentazioni e banalizzazioni» 168. Altra
immagine forte che emerge dall'opera è quella dei musei come luoghi della negoziazione del
senso, non (non più) luoghi autoritari dove si esercitano poteri classifcatori calat dall'alto;
spazi che devono necessariamente aprirsi a quegli “altri” che abitano le nostre città e
reclamano il diritto di dire la propria in merito alle modalità di rappresentazione della loro
cultura.
Volendo fornire una sintesi estrema del programma dell'Autore, programma che
coincide con quello della museografa etnografca più genuinamente contemporaneista, quello
che è necessario fare oggi è pratcare (soprattutto nei musei) «più etnografa interpretatva,
più antropologia del patrimonio, più ricerca espressiva, più comunicazione critca e rifessiva,
più contemporaneità: sono queste le sfde che l'antropologia museale sta afrontando per
valorizzare la sua specifcità conoscitva ed etca, in grado di sovvertre egemonie consolidate
nell'ambito patrimoniale»; il tutto legato alla proposta di tradurre «in allestment rifessivi
compiute ricerche etnografche focalizzate sul presente culturale e realizzate con pratche
partecipate di arte pubblica»169.
166
167
168
169
Vincenzo PADIGLIONE, Musei: esercizi a decostruire già operanti e per volenterosi, op. cit., p. 39.
Loc cit.
Loc. cit..
Vincenzo PADIGLIONE, Conclusione. Tesi in discussione, in id., Poetiche dal museo etnografco, op. cit., p. 249.
[45]
1.6 MUSEI E PATRIMONIO
Nessun ragionamento sul museo, etnografco e non solo, può essere disgiunto dal
riferimento al più ampio panorama problematco rappresentato dalla nozione di patrimonio. Il
museo sempre più si confgura come uno dei protagonist 170 atvi sulla scena della
patrimonializzazione, della “costruzione” e mediazione del patrimonio culturale. Anche questa
osservazione non è indiferente ai fni della rifessione sulle professioni interne al museo. Se,
come ho avito modo già di afermare, il museo è il luogo della mediazione del patrimonio,
allora il compito di orientare le sue pratche non può che essere affidato a chi, come
l'antropologo, conosce dall'interno quel campo patrimoniale e le sue specifche artcolazioni.
Negli ultmi anni quella di patrimonio è stata una nozione al centro di un vivace
dibatto teorico che ha portato la medesima a perdere, in antropologia e non solo, la sua
connotazione metastorica ed elitaria per assumerne una di tpo dinamico, processuale ed
ermeneutco171. Secondo Poulot «la preoccupazione patrimoniale anima ormai tut i gruppi
sociali, copre tut i periodi e tut gli ogget possibili, dai monument tradizionali agli ogget
minori, alle lingue, alle pratche e agli usi» 172. Vediamo ogni giorno nascere nuovi musei e
nuove iniziatve tese alla messa in valore di svariate cose (collezioni, edifci, parchi). Alla base
del processo di patrimonializzazione c’è una scelta, una selezione delle testmonianze
(materiali per lo più, anche se non esclusivamente) di quello che una comunità, in un dato
momento, ritene importante e degno di essere valorizzato perché rappresentatvo di valori
percepit come fort, fondant. Pertanto la patrimonializzazione, intesa come pratca della
costruzione o ridefnizione del patrimonio, va pensata come un processo seletvo che ha a che
fare tanto la memoria quanto con l’oblio.
Il patrimonio è qualcosa in più che la somma dei singoli beni culturali. Esso è stato
defnito «un insieme signifcatvo di tracce materiali e immateriali che divengono
testmonianze culturali di una colletvità in un momento determinato» 173, e dunque gli si deve
170 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Interpretazioni del patrimonio culturale, in id. Poetiche dal museo etnografco, op. cit., p. 198.
Padiglione riferisce del modo in cui Barbara Kirshenblatt-Gimblett considera i musei, «impegnati a competere o a
fare gioco di squadra con il turismo nella produzione di patrimonio», a «trasformare i luoghi in destinazioni», p.
198.
171 Ibid., p. 182
172 Dominique POULOT, Elementi in vista di un'analisi della regione patrimoniale in Europa, secoli XVIII-XX in AA.VV, Il
patrimonio culturale, «Antropologia», anno 6, numero 7, p. 129.
173 AA.VV. Per l'educazione al patrimonio culturale. 22 tesi, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 19
[46]
riconoscere una natura contestuale 174. «Il patrimonio è costtuito da beni materiali, luoghi,
ambient ed element immateriali […] nonché dalla loro concettualizzazione e interpretazione
come singoli beni e come insieme» 175. Il patrimonio è l’insieme dei beni culturali più il modo in
quest vengono pensat e interpretat in un determinato momento. I suoi attribut più
important sono la polivalenza (i signifcat attribuit ai suoi diversi component possono essere
molteplici) e la relatvità (il patrimonio è contnuamente ripensato al variare delle sensibilità,
degli atteggiament, insomma: di quella cosa che convenzionalmente chiamiamo cultura). E già
da queste prime battute emerge chiaramente il suo «carattere opinabile, modulabile e
negoziato»176.
Secondo Huge de Varine, presidente dell’Internatonal Council Of Museums per undici
anni, «tutto ciò che per noi ha un senso è patrimonio che ereditamo, creiamo, trasformiamo e
trasmetamo»177; esso è il prodotto della creazione «di un gruppo umano eterogeneo e
complesso che vive su un territorio e condivide una storia, un presente, un futuro, modi di
vita, difficoltà e speranze»178, «la carta di identtà della comunità attuale, in una contnuità
senza limit»179. De Varine propone una visione, per così dire, “operatva” del patrimonio,
intendendo quest’ultmo come una risorsa per lo sviluppo. Il patrimonio è visto dal museologo
francese come «un bene comunitario che costtuisce la base e il terreno di coltura del futuro»,
perché «lo sviluppo non si fa “fuori campo” e le sue radici devono nutrirsi di vari element che
in gran parte sono present nel patrimonio culturale: il suolo e il paesaggio, la memoria e i
modi di vita degli abitant, il patrimonio edilizio, la produzione di beni e servizi adattat alle
domande e ai bisogni della gente» 180. Anche da questa visione trapela la natura dinamica del
patrimonio, il suo essere un qualcosa di «ereditato, trasformato, prodotto e trasmesso di
generazione in generazione»181, una realtà che deve essere vissuta e non solo contemplata.
Berardino Palumbo, che si è occupato dei processi di patrimonializzazione in Sicilia
orientale, individua schematcamente, irrigidendo artfcialmente le posizioni per necessità di
174 «Il patrimonio viene riconosciuto da una cultura in un certo tempo e come espressione della sua “coscienza”
attuale», Vincenzo PADIGLIONE Interpretazioni del patrimonio culturale, op. cit., p. 195.
175 Loc. cit.
176 Federico SCARPELLI, La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza, Ospedaletto, Pacini Editore,
2007, p. 13.
177 Hugues de VARINE, Le radici del futuro, op. cit., p. 28.
178 Ibid., p. 29.
179 Ibid., p. 30.
180 Ibid., p. 6.
181 Ibid., p. 8.
[47]
sintesi, tre diversi atteggiament che gli antropologi hanno assunto trattando di patrimonio:
uno di tpo interno, uno di tpo critico e infne uno di tpo partecipativo. Nel primo caso il
riferimento è al lavoro di quegli studiosi che senza porsi troppi interrogatvi rifessivi operano
sulla base di una sorta di «common sens patrimoniale»182 e sgomitano per inserire nel catalogo
del patrimonio ogget che ritengono meritevoli e che rientrano nel proprio ambito di studio.
Nel secondo caso, invece, troviamo al centro dell’interesse dei ricercatori lo studio dei processi
di patrimonializzazione calato «all’interno di una più generale antropologia (politca) della
contemporaneità». Quelle che vengono indagate, in sostanza, sono le retoriche e le strategie
politche soggiacent ai processi di messa in valore di alcuni beni o complessi di beni. L’ultma
modalità di approccio al patrimonio, infne, sembra collocarsi a metà strada tra quelle appena
viste. Essa prende le mosse dalla consapevolezza da parte dell’antropologo del «carattere
politco»183 della propria partecipazione ai processi di patrimonializzazione, consapevolezza
che tuttavia non gli impedisce di «operare con e attraverso le “cose” del campo
patrimoniale»184. Quello che l'Autore propone è uno «studio antropologico dei patrimoni [che]
dovrebbe, in primo luogo, interrogarsi sugli stret rapport esistent tra la costruzione di
ogget culturali e quella di sogget, di identtà colletve (i nostri beni, le nostre chiese, la
nostra lingua, la nostra cultura) e sulla più vasta economia politca all’interno della quale simili
rapport prendono forma»185; un approccio che rimanda sostanzialmente allo studio delle
«politche dello spazio/tempo, dunque [alle] poetche della memoria e dell’identtà» 186,
tematche queste connesse alle rifessioni sullo Stato-nazione che si connettono agli studi
condot da Handler sul Quebec e dai quali emerge una stretta correlazione tra l’idea di
patrimonio culturale e il discorso nazionalista.
Su un versante che sembra accostarsi a quello defnito “partecipazionista” si colloca
invece la posizione di Fabio Dei, il quale pur condividendo la necessità che l’antropologo
prenda le distanze da quelle che sono le pratche locali di patrimonializzazione, dai meccanismi
e dai discorsi “natvi”, sostene la necessità per lo studioso di non trattare «il discorso locale
182 Berardino PALUMBO, L'Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale Roma, Meltemi,
2006, p. 23.
183 Berardino PALUMBO, Patrimonializzare, «AM-Antropologia muselae», anno 8, numero 22, speciale 2009, p.
XXXIX.
184 Loc. cit..
185 Berardino PALUMBO, Patrimoni-identità: lo sguardo di un etnografo «AM-Antropologia muselae», anno 1, numero 1,
maggio 2002, p.16.
186 Ibid., p. 17.
[48]
come un costrutto ideologico, strumentale e irrazionale, che trova la sua ragione d’essere
soltanto nel farsi strumento di potere» 187 e la possibilità per il medesimo, anche in virtù
dell’approccio rifessivo che caratterizza la disciplina che l'antropologo pratca, di schierarsi a
favore di cert processi di patrimonializzazione e contro altri188.
Ma il concetto di patrimonio, fanno notare alcuni, rimanda anche al diritto romano. In
quel contesto esso sta ad indicare quanto trasmesso per via ereditaria da una generazione
(padri e madri) all’altra (fgli). Dunque, come fa notare Poulot, «esso non evoca a priori il
tesoro o il capolavoro - così come non rinvia stricto sensu alla categoria del vero e del falso
cara alle scienze, anche se deve invocare una qualche autentcità» 189. Il patrimonio in questo
senso ha a che fare con una serie di ogget che incarnano dei simboli e dei valori. Dato che
deve esserci coerenza tra i valori che una determinata epoca sceglie di far propri e gli ogget
chiamat a rappresentarli, «ogni atto di formazione del patrimonio è accompagnato da saperi
erudit, specializzat, capaci di legitmare un certo intervento o di combatterlo […] e di
accompagnare così una mobilitazione civica e sociale» 190. Detta altriment «il patrimonio è un
lavoro […] il cui statuto e ambizione dipendono concretamente, secondo i moment storici, dal
posto che occupano antquari, archeologi, storici dell’arte… in seno alla comunità intellettuale
nazionale, in partcolare di fronte ai linguist, folklorist o archivist»191. All'elenco dei costruttori
del patrimonio andrebbero aggiunt a tut gli efet anche i direttori dei musei, dato che – e
questo appare evidente specie nel caso dei musei etnografci – quest non solo documentano e
custodiscono un patrimonio, ma spesso lo creano dando spazio all'interno degli isttut a
“cose” che dall'inserimento in un simile contesto ottengono valorizzazione e visibilità.
Se il patrimonio è «ciò che permette di iscriversi in una fliazione e, di rivendicare una
trasmissione»192 allora si può capire il perché di una generalizzata attenzione nei suoi confront
nella società di oggi, caratterizzata da «culture multple» ognuna delle quali impegnata a
individuare e proteggere la propria fetta di patrimonio e dunque a rivendicare spazi e
occasioni di legitmazione. Infne un ulteriore aspetto. Se quella patrimonializzatrice ha
187 Fabio DEI, Antropologia critica e politiche del patrimonio, «AM-Antropologia museale», anno 1, numero 2, ottobre 2002,
p. 37.
188 Ovviamente il dibattito che ha preso vita sulle pagine di «AM» è molto più ricco e articolato di quanto presentato
in questa sintesi.
189 Dominique POULOT, Elementi in vista di un'analisi della regione patrimoniale in Europa, secoli XVIII-XX , op. cit., p. 132.
190 Idem, p. 134.
191 Loc. cit..
192 Ibid., p. 138.
[49]
assunto le sembianze di una vera e propria «crociata popolare» 193 è anche perché «nelle
nostre società del consumo e della cultura di massa, l’uso del patrimonio, la sua
interpretazione o anche la sua simulazione orma grazie a vari dispositvi virtuali, appare come
strumento spesso decisivo di uno sviluppo locale o nazionale a causa dell’importanza del
turismo e delle pratche commerciali del sapere e del tempo libero»194.
Alla luce di quanto visto sopra è possibile tentare di sintetzzare la nozione di
patrimonio sostenendo che essa «implica in primo luogo un insieme di possessi che occorre
defnire in quanto trasmissibili, implica poi un gruppo umano, una società capace o suscetbile
di riconoscerli come propri, di dimostrarne la coerenza e di organizzarne la ricezione; implica
infne un insieme di valori politci nel senso più ampio del termine, che permette di artcolare il
lascito del passato con l’attesa o la confgurazione di un futuro al fne di promuovere talune
mutazioni e di afermare una contnuità nello stesso tempo»195.
Lo storico e geografo Lowenthal, piuttosto critco verso la «febbre del patrimonio» 196,
ha dedicato attenta analisi alla individuazione dei rischi connessi ai processi di
patrimonializzazione. Il primo è rappresentato dalla fossilizzazione, «un atteggiamento
pedissequamente conservatvo, museale nel senso peggiore del termine, che separa
l'ammirazione del passato dalla usa riformulazione creatva» 197; il secondo dalla chiusura di
tpo nazionalista o etnicista accompagnata dal difondersi di pericolose idee innatstche
(esistenza di DNA culturale e altre simili convinzioni); il terzo della propensione del patrimonio
ad assumere i trat della convenzionalità o a divenire oggetto di mercifcazione. Quella di
Lowenthal sembra essere una posizione piuttosto intransigente, una posizione probabilmente
non condivisibile appieno dagli antropologi. Tuttavia i tre punt appena sopra espost,
dovrebbero (col dovuto senso critco) essere tenut a mente quando si attraversa il campo
della patrimonializzazione ed anche quello del museo (legato al primo da un rapporto
stretssimo).
A rendere la questone della defnizione del patrimonio (di per sé ricca di molteplici
sfumature e di posizioni diversifcate) ancora più artcolata c’è l’adozione di pratche
193
194
195
196
197
Ibid., p. 139.
Loc. cit..
Ibid., p. 139.
Federico SCARPELLI, La memoria del territorio, op. cit., p.63.
Loc. cit..
[50]
patrimonializzatrici, in positvo o in negatvo 198, da parte di culture altre rispetto a quella
all’interno di cui la nozione è nata e si è sviluppata. Le vicende dei Buddah afghani distrut
dalle milizie talebane o, per rimanere al nostro campo, del museo archeologico di Baghdad, o,
saccheggiato dopo l’uscita di scena di Saddam Hussein raccontate da Irene Maffi 199, ma anche
l’utlizzo dell’archeologia in Libano descritta da Lina Gebrail Tahan 200, dicono della
appropriazione di una consapevolezza patrimoniale, nata e plasmata all'interno della cultura
occidentale, da parte di non europei e non occidentali. In quest contest troviamo il
patrimonio vissuto come una delle «forme di legitmazione funzionali al perpetuarsi dello
Stato-nazione, quest’ultmo da intendersi come «una delle eredità politche fondamentali
lasciate dagli antchi colonizzatori»201. Con la fne del colonialismo molt paesi hanno cercato,
sfruttando l’imprintng culturale e politco lasciato delle potenze occidentali, di afermare o
costruire la propria identtà tramite la defnizione e la valorizzazione di un patrimonio culturale
considerato «incarnazione materiale della storia e dell’identtà del gruppo che in esso si
riconosce»202. Nel mondo postcoloniale, dunque, «il patrimonio culturale è diventato
strumento di espressione identtaria»203. Questo processo di appropriazione di categorie
culturalmente ben connotate in altri contest si inscrive in una dinamica di più ampia portata di
cui si occupa Arjun Appadurai relatva all’instaurarsi progressivamente, a patre dal 1500, di
quella condizione «completamente insolita di vicinato, anche con coloro più distant da noi» 204
affiancata e sorretta dalla rapida circolazione delle informazioni, delle merci e degli uomini,
nota come globalizzazione. Appadurai vede il mondo contemporaneo attraversato da fussi
culturali che chiama tecnorami, fnanziorami, mediorami, etnorami e ideorami. Quest ultmi
vengono defnit come «concatenazioni di immagini» che spesso hanno una natura politca «e
hanno di frequente a che fare con le ideologie degli stat e le controideologie di moviment
esplicitamente rivolt a conquistare il potere statale o una porzione di esso» 205. In questa
situazione la nozione di patrimonio (assieme, tra l’altro, a “democrazia”, “libertà”, “sviluppo”)
198 Il patrimonio può essere costruito e plasmato non solo conservando ma anche eliminando testimonianze di eventi o
valori che non si condividono.
199 Cfr. Irene MAFFI, Introduzione, in AA.VV. Il patrimonio culturale, op. cit., pp. 5-18.
200 Cfr. Tahan GEBRAIL, Lina Le politiche del passato in Libano: identità “ferite” in gioco, in AA.VV. Il patrimonio culturale, op.
cit., pp. 93-106.
201 Irene MAFFI, Introduzione, op. cit., p. 9.
202 Loc. cit..
203 Ibid., p. 10.
204 Arjun APPADURAI, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma, Meltemi, 2001, p. 47.
205 Ibid., p. 56.
[51]
si confgura come una delle parole-chiave attorno alle quali gli stat nazionali, compresi quelli
ex coloniali, hanno organizzato la propria cultura.
Gli esit dell’adozione di una attudine patrimonializzatrice li osserviamo nel saggio di
Herzfeld206, dove viene descritto il ricorso da parte della municipalità di Bangkok ad un lessico
fortemente intriso di istanze patrimonializzatrici fnalizzato a costringere la comunità di Pom
Mahakan ad accettare il progetto relatvo alla trasformazione dell'area sulla quale quest'ultma
vive in un parco pubblico. La cosa da sottolineare è che anche la comunità Pom, nel tentatvo
di ostacolare le mire delle autorità pubbliche, è ricorsa al concetto di patrimonio, ma
attribuendo a quest’ultmo una accezione diversa rispetto a quella datagli dalle autorità
comunali e ribaltando totalmente i termini della contesa.
Se allora teniamo conto della faccenda dei Buddah, del Museo di Baghdad, di quanto
avvenuto a Bangkok salta all’occhio in modo evidente il fatto che patrimonio ha assunto lo
status di un «codice transculturale che viene interpretato e declinato in modo diverso in ogni
contesto socio-culturale. Dunque, sia che lo adot, come mezzo di legitmazione sia che lo si
trasformi o vi ci si opponga, […] sembra che il patrimonio culturale sia diventato un paradigma
ineludibile della confgurazione culturale del mondo contemporaneo» 207. Un codice che si
presta tanto ad una applicazione bottom down (assumendo i connotat di uno strumento di
democrazia) quanto start up (diventando in questo caso strumento di potere e di
imposizione).
Una ulteriore possibile sovrapposizione tra l'immagine del museo e quella del
patrimonio la abbiamo se prendiamo la defnizione che vuole quella del patrimonio – e
altrettanto si potrebbe dire a proposito di quella del museo – «un'area di intensi traffici,
animata dai vecchi e nuovi avventurieri, surriscaldata da confit su ciò che va rappresentato e
su come farne un uso pertnente»208. Questo modo di vedere il museo richiama l'idea proposta
da James Cliford della zona di contatto. “Zona di contatto” è una nozione che Cliford dichiara
di prende a prestto dalla studiosa Mary Louise Pratt, che utlizza questa espressione per
indicare «lo spazio di incontri coloniali, lo spazio in cui popoli geografcamente e storicamente
separat entrano in contatto l'uno con l'altro e stabiliscono relazioni corrent, che di solito
206 Cfr. Micheal HERZFELD, Pom Mahakan: umanità e ordine nel centro storico di Bangkok, in AA.VV. Il patrimonio culturale,
op. cit., pp. 19-42.
207 Irene MAFFI, Introduzione, op. cit., p.14.
208 Vincenzo PADIGLIONE, Interpretazioni del patrimonio culturale, op. cit., p. 197.
[52]
implicano condizioni di coercizione, profonda ineguaglianza e confittualità incontrollabile» 209.
Il museo secondo Cliford, è uno spazio di relazioni culturali in cui si incontrano, hanno un
contatto, sogget distant separat da distanze di tpo geografco o storico; un luogo di incontro
con l'alterità. Quello che Cliford invita a fare è considerare «tutte le strategie di raccolta della
cultura come risposte a partcolari storie di dominio, gerarchia, resistenza e mobilitazione» 210,
non un gesto innocente dunque, ma una azione che nasconde precise strategie di dominio, di
appropriazione e di resistenza.
209 Ibid., p. 228.
210 Ibid., p. 253.
[53]
2. LA DIREZIONE DEI MUSEI: LEGISLAZIONI, MUSEOLOGIE, PRATICHE
2.1 MA UN DIRETTORE È NECESSARIO?
Quale sia il proflo professionale più adeguato ad assumere la direzione di un museo
etnografco è una delle questoni principali attorno alle quali verte il presente dossier. Per
afrontare in maniera profcua l'argomento mi sembra opportuno mettere sul tavolo di lavoro
un altro interrogatvo – che, in qualche modo, si colloca a monte rispetto all'oggetto
immediato di indagine – e cercare di dare ad esso una risposta adeguatamente argomentata.
Perché chiedersi chi debba dirigere un museo, quale fgura si addica meglio ad un simile
ufficio, lascia intendere che si dia per scontato, per acquisito, che un museo abbia
necessariamente un direttore. In efet è sufficiente avere un minimo di familiarità con le
isttuzioni culturali per sapere che ogni museo ha un direttore, così come ogni biblioteca o
archivio storico211. Lo dice il senso comune che dietro ogni museo c'è un direttore (anche se,
come vedremo nel par. 2.1 questo a volte è vero solo in parte), ce lo ricordano i mezzi di
comunicazione di massa, i giornali che spesso veicolano appelli e allarmi tanto di dirigent 212 di
important isttuzioni quanto di responsabili di piccole realtà locali. Eppure conviene
chiederselo: perché mai un museo dovrebbe avere un direttore? È indispensabile che un
museo sia dotato di una simile fgura? Non intendo essere provocatorio, tutt'altro. Sono
convinto del fatto che ragionare sopra un simile nodo, e capire a cosa giovi nella vita del
museo la presenza del direttore, quale sia il suo ruolo, aiut a mettere meglio a fuoco il proflo
professionale (specialista della disciplina rappresentata nel museo? manager? specialista della
conservazione?) che più si adatta a rivestre questa funzione all'interno del museo etnografco.
Indicazioni precise circa compit e attribuzioni riconosciute al direttore di museo,
indipendentemente dalla natura dell'isttuto, nonché parametri relatvi ai requisit necessari
(in termini di formazione e di pregresse esperienze lavoratve) per assumere un incarico di
direzione, vengono da alcuni document quali l'Ato di indirizzo sui criteri tecnico-scientifci e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei 213, la Carta Nazionale delle Professioni
211 Cfr. ad esempio la Legge Regionale 42/1997 Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio.
212 Stefano MILIANI, Direttore di museo? No, grazie, «L'Unità» 20.08.2005, ed. Roma.
213 Decreto 10 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 244 del 19 ottobre 2001.
[54]
museali214 e il Manuale Europeo delle Professioni Museali215.
La prima fgura professionale che la Tabella 1 216 dell'Ato di indirizzo217 individua è quella
del direttore, al quale viene riconosciuta la «responsabilità dell’attuazione delle politche
museali e della gestone complessiva del museo, della conservazione, valorizzazione e
godimento pubblico dei beni culturali in esso contenuto». La Carta Nazionale delle Professioni
Museali218 lo defnisce come il «custode e l’interprete dell’identtà e della missione del museo
[…], responsabile della gestone del museo nel suo complesso, nonché dell’attuazione e dello
sviluppo del suo progetto culturale e scientfco» 219. Sulla stessa lunghezza d'onda dei due
document già citat si colloca il Manuale Europeo delle Professioni Museali 220, secondo il quale
«Il/la direttore/trice è responsabile del museo, nel quadro della missione che gli/le è affidata
dall’ente proprietario e/o gestore. Egli/ella defnisce le scelte strategiche per la promozione e
lo sviluppo dell’isttuzione. Egli/ella è responsabile delle collezioni e della qualità delle atvità
214 Disponibile online sul sito web di ICOM-Italia alla sezione (www.icom-italia.org) alla sezione Editoria e documenti.
215 Disponibile online all'indirizzo http://www.comune.torino.it/museiscuola/bm~doc/2008-manuale-europeo-delleprofessioni-museali.pdf.
216 La Tabella si trova a pag. 103 della versione cartacea del documento ed è inserita nell'ambito funzionale IV –
Personale. L'Atto è suddiviso in un totale di otto ambiti dedicati a Status giuridico, Assetto finanziario, Strutture del
museo, Sicurezza, Gestione e cura delle collezioni, Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi, rapporti
con il territorio, ognuno dei quali articolati in una premessa, una norma tecnica e in vari apparati di
approfondimento.
217 Il Decreto, emanato sulla base di quanto previsto dal comma 6 del Decreto legislativo 112 del 1998 Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
stabilisce gli standard minimi da osservare nell’esercizio delle attività trasferite dallo Stato agli enti locali, “in modo
da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione da rischi” » (p.
18 ). Gli standard non rappresentano soltanto un insieme di procedure e modalità di esecuzione di particolari
azioni, ma sono stati persati anche come anche «un’opportunità straordinaria per mettere appunto una “cultura
della gestione” per il sistema dei musei italiani» (loc. cit.).
218 La stesura Carta è stata promossa dalla Conferenza Permanente delle Associazioni museali italiane, AMACI
(Associazione del Museo d’Arte Contemporanea Italiani), AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), ANMS
(Associazione Nazionale dei Musei Scientifici), ANMLI (Associazione Nazionale Musei di Enti Locali e
Istituzionali), ICOM-Italia, SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici). Per
una cronistoria dettagliata dei passi che hanno portato alla stesura del documento cfr. l’Introduzione di Alberto
Garlandini, coordinatore del gruppo di lavoro. La sua elaborazione è stata frutto dell’attività del gruppo di lavoro
interassociativo costituitosi nel corso dell’Assemblea generale del comitato nazionale italiano dell’ICOM svoltasi a
Pesaro nel marzo 2005. L’approvazione definitiva del documento, preceduta dalla produzione di due bozze
discusse prima dagli operatori del settore e poi dai Consigli direttivi delle Associazioni componenti la Conferenza,
risale al 2 ottobre 2006, giorno della II Conferenza dei musei italiani tenutasi presso la Sala dello Stenditoio del
Complesso monumentale del San Michele a Roma (una delle sedi del MIBAC).
219 Carta Nazionale delle Professioni Museali, p. 15.
220 Dall’incontro di Pesaro del 2005 già citato emerse la necessità di capire quanto «la descrizione dell’attività svolta
all’interno del museo, come quella del registar o régisseur, indicasse le medesime funzioni nei diversi paesi» (p. 15).
Per dare una risposta a questo interrogativo, grazie ad un contributo ICOM, è stato istituito un gruppo di lavoro
internazionale per la elaborazione di un manuale europeo delle professioni museali. Il coordinamento del comitato
viene affidato alla presidentessa dell’ICTOP Angelika RUGE, curatrice nel 2008 della pubblicazione definitiva del
Manuale. Il Manuale nasce con l’intento di fissare delle linee guida da intendersi come piattaforma per una
discussione più approfondita e come «riferimento […] base per l’elaborazione dei profili nazionali (e, se necessario,
regionali) rispettando le differenze culturali» (p. 11).
[55]
e dei servizi del museo».
La museologa Anna Maria Visser Travagli sostene che «per diretore non si intende
banalmente solo la fgura che sta a capo di un isttuto, ma in senso più ampio e aderente
all'etmologia stessa del termine la fgura che guida verso una meta, che avvia in una
determinata direzione, che volge ad un fne prestabilito una intera organizzazione. Si tratta di
un compito di estrema importanza e di grande delicatezza, che deve far propri gli indirizzi che
vengono fornit dall'amministrazione e nel contempo deve interpretare il patrimonio museale
per defnire il progetto culturale da realizzare» 221. Il passaggio tocca un po' tut i punt salient
del problema. Il direttore, secondo la lettura appena vista, è l'interprete della missione 222 del
museo, la fgura alla quale è demandato il compito e la responsabilità di fare in modo che il
museo adempia a quelli che sono gli obietvi che si è dato tramite il documento di missione e
che sono dichiarat nella carta dei servizi. Obietvi in parte condivisi da ogni museo 223, in parte
peculiari della singola isttuzione. «È assolutamente irrinunciabile nel museo la fgura del
direttore, un direttore che abbia autonomia e che sia messo in grado con i tempi necessari di
realizzare i programmi e di svolgere l'atvità» 224; quello che viene tratteggiato nelle parole del
presidente ANMLI è un professionista al quale spetta il compito di fare “da cerniera” tra gli
amministratori, da una parte, e le comunità ed i pubblici, dall'altra. Come scrive anche Alberto
Garlandini nel testo di presentazione della Carta Nazionale delle Professioni Museali, il
direttore è il «leader e responsabile ultmo del museo» 225. Il dettato del Codice etco dell'ICOM,
richiamato anche dalla Carta dal Manuale, va nella stessa direzione: «The director or head of
the museum is a key post and when making an appointment, governing bodies should have
regard for the knowledge and skills required to fll the post efectvely. These qualites should
include adequate intellectual ability and professional knowledge, complemented by a high
221 Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Chi deve dirigere il museo? La questione delle professioni, in Fabio DONATO e Anna
Maria VISSER TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi. op. cit., p. 82.
222 Cfr. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifci e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs.
n.112/98 art. 150 comma 6), ambito I.
223 Cfr. la definizione di museo data nel corso della 21esima Conferenza Generale di Vienna: A museum is a nonprofit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires,
conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its
environment for the purposes of education, study and enjoyment, http://icom.museum/who-we-are/thevision/museum-definition.html
224 Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Il punto di vista sulle competenze, in Pietro CLEMENTE (a cura di), Principi,
competenze accesso: un confronto, «AM-Antropologia Museale», anno 4 numero 11 autunno 2005, pp. 39-44. il brano
citato si trova a pag. 41.
225 Carta Nazionale delle Professioni Museali, p. 7.
[56]
standard of ethical conduct»226.
Quanto fn qui riportato consente di registrare una sostanziale convergenza di idee e
posizioni circa il fatto che – se il museo è il luogo all'interno del quale avviene la mediazione
del patrimonio, la sua resttuzione secondo partcolari letture – il ruolo del direttore,
responsabile a cui fanno capo tutte le atvità isttuzionali, consiste nel defnire (tenendo conto
in modo critco delle intenzioni dei progetst e dell'impronta originaria del museo) le linee
guida interpretatve del patrimonio medesimo, nel progettare e dirigere le ricerche 227
necessarie a rendere quel patrimonio intelligibile. Il direttore dell'isttuto è la fgura che
assume su di sé – nei confront della comunità (la comunità locale, il pubblico, la comunità
scientfca) – la responsabilità della rappresentazione che il museo fornisce del patrimonio che
gli è stato affidato – o che ha contribuito a costruire – e che esso conserva. E questo è vero
soprattutto nel caso dei piccoli musei, quelli locali, all'interno dei quali sovente la sola unità di
personale qualifcato è rappresentata da un direttore che assume su di sé altri ruoli strategici
come quello del conservatore, del responsabile dei servizi educatvi, del responsabile della
catalogazione, del fundraiser.
Dalla lettura e dall'accostamento della dichiarazioni document sopra citat è possibile
ricavare non soltanto un panorama piuttosto preciso dei compit che – secondo le tendenze
principali del dibatto museologico contemporaneo – attengono al direttore, ma anche di
rispondere afermatvamente alla domanda iniziale, e cioè sostenere – ora a ragion veduta –
che un direttore è fgura indispensabile all'interno di un museo. Questo a condizione di
pensare al museo non solo e non tanto come una semplice raccolta di ogget – concezione
che dovrebbe essere ormai defnitvamente archiviata – ma come ad un vero e proprio
isttuto228 di cultura, come “un'isttuzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della
società e del suo sviluppo [che] è aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le
testmonianze materiale e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le
226 Cfr. http://icom.museum/who-we-are/the-vision/code-of-ethics.html.
227 Sul ruolo della ricerca all'interno del museo cfr. Pietro CLEMENTE, Il progetto del Museo di Alberese, in id. Graffti di
museografa antropologica italiana, op. cit. p. 111. Cfr. anche Andrea PERIN, Cose da museo. Avvertenze per il visitatore
curioso, Milano, Eleuthèra, 2007, p. 66 dove si torna sul tema del rapporto tra ricerca territoriale e ricerca
universitaria: «la differenza rispetto alle università e ai centri di ricerca è il rapporto continuo che intercorre tra
livello speculativo e quello operativo, con effetti sul modo non solo di produrre la conoscenza ma anche di
conservarla e diffonderla».
228 Cfr. art. 101 comma 1 lettera a del D. Lgs. 22 gennaio 2004,, n. 42; il museo viene definito una “struttura
permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di
studio”.
[57]
conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fni di studio, educazione e diletto” 229
secondo la defnizione dell'ICOM.
Chiarita in prima approssimazione la funzione del direttore, rimangono da sondare
ulteriori questoni che gravitano attorno alla direzione dei musei. Ma a questo punto si impone
l'adozione di una prospetva d'osservazione tale da orientare il prosieguo dell'analisi nella
direzione di un contesto ben defnito. Tenuto conto del valore tendenzialmente universale 230
che aspirano ad avere document come la Carta e il Manuale, document pensat per ofrire
linee di condotta applicabili tanto nei musei grandi come in quelli piccoli, tanto in quelli statali
come in quelli locali, il rischio è quello di attestare la rifessione ad un livello di genericità
assolutamente non conveniente. L'obietvo che mi sono posto infat, ed è bene ribadirlo, è
quello di afrontare la questone della direzione dei musei entro un perimetro segnato da una
specifcità disciplinare (il museo etnografco) e da un ambito isttuzionale (gli isttut che fanno
riferimento ad ent locali). Solo tramite una simile restrizione del focus della ricerca diventa
possibile arrivare a qualche tpo di acquisizione fnale. Detto in altro modo, quello della
direzione dei musei, non solo di quelli etnografci, non può essere argomento da trattare in
maniera svincolata dagli scenari isttuzionali reali all'interno dei quali il lavoro di direzione
trova efetva declinazione. La questone della direzione si pone, per così dire, all'incrocio di
prospetve e ambit aferent sfere diverse che devono essere messe in tensione tra di loro.
Queste sfere sono quella isttuzionale-legislatva, quella museologica nonché quella della
pratca.
2.2 MUSEI INESISTENTI E DIRETTORI INVISIBILI
Riguardo al piano isttuzionale e legislatvo va fatto un grande discrimine. La questone
dell'affidamento di un incarico come quello di direttore assume portata assai diversa se
afrontata a livello di isttuzioni di diretta pertnenza dello Stato oppure di musei pertnenza di
ent pubblici locali (i comuni in partcolare). Nonostante il presente dossier verta attorno alla
229 Va detto che questa, per quando diffusa e condivisa, rimane una definizione che presta il fianco a delle critiche
anche forti; in particolare sulla questione dell'assenza di scopo di lucro cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Musei: esercizi
a decostruire già operanti e per volenterosi, op. cit., pp. 47-48.
230 Un simile taglio è comprensibile e giustificabile, direi irrinunciabile. Esistono talmente tante possibili fattispecie che
la letteratura museologica non può che esprimersi fornendo linee-guida generali, materiale – diciamo così –
“grezzo”, da scalare e adattare alle diverse situazioni.
[58]
fgura del direttore di museo etnografco di ente locale, quella dei musei statali è una
condizione che deve essere conosciuta per meglio comprendere il quadro entro cui le
professioni museali nel nostro paese si sono sviluppate, nonché i motvi che hanno rallentato o
ostacolato il riconoscimento – in partcolare – della fgura del direttore. Va detto, in generale,
che quello dei musei statali rappresenta un universo che ha molto poco a che fare con il
mondo dei musei etnografci, dato che il grosso di quest ultmi è di proprietà comunale e che
soltanto il Museo Pigorini e l'ICDEA sono musei statali (e tra l'altro pertnenza di
Soprintendenze speciali e non di Soprintendenze territoriali).
Elisabetta Mangani segnala che «i musei statali, che dipendono dalle Soprintendenze
territoriali, non hanno neppure un direttore a tempo pieno: nelle Soprintendenze, infat, il
funzionario tecnico che è responsabile della tutela di un territorio è incaricato della direzione
del museo statale che si trova in quel territorio» 231. È questo il caso dei vari musei nazionali
(soprattutto quelli archeologici e storico-artstci, i più difusi) sparsi su tutto il territorio
nazionale. Il motvo di questa che, se letta alla luce di quanto previsto dalla Carta Nazionale
delle Professioni Museale e dagli altri document già citat, appare una vera e propria anomalia,
va rintracciato nel modo in cui nel corso degli anni si è evoluto nel nostro Paese il quadro
normatvo relatvo al settore dei beni culturali (anche quando non si chiamavano ancora in
questo modo232) e dei musei. Volendo compiere un micro-saggio di analisi diacronica, emerge
in maniera piuttosto chiara quanto l'ascesa e il declino della fgura del direttore sia
strettamente connessa con l'acquisizione, prima, e con la perdita, poi, da parte dei musei dello
status di isttuto233.
In conseguenza dell'emanazione delle leggi eversive del 1866 il museo locale viene
chiamato a svolgere un ruolo di «conservazione e di promozione culturale, di pubblica utlità e
benefcio colletvo», e questo senza «distnzioni tra musei di Stato comunali o provinciali»234.
231 Elisabetta MANGANI, L'albo e la carriera dei conservatori dei musei, in Cristiana MORIGI GOVI e Alessandra
MOTTOLA MOLFINO, La gestione dei musei civici. Pubblico o privato, op. cit., p. 87.
232 In Italia l'introduzione del concetto di “bene culturale” è dovuta alla Commissione Franceschini (istituita nel 1964)
che fa esplicito riferimento ad esso nei documenti conclusivi dei suoi lavori(1967); si tratta di una formula che
ripresa dalla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di confitto armato stipulata a L'Aja nel 1954,
cfr. Daniele JALLA, Il museo contemporaneo, op. cit., p. 87.
233 Una condizione che i musei pubblici (comunali, provinciali) acquisiscono a seguito dell'emanazione delle leggi
sovversive e con la conseguente presa in carico di collezioni provenienti dagli enti religiosi soppressi (ibid., cap. 2.3).
Il recupero da parte del museo di questo status rimanda all'approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
del 2004 (cfr. art. 101).
234 Ibid., p. 53.
[59]
In questo frangente il museo assume i trat caratteristci dell'isttuto, viene considerato essere
– cioè – un organismo «dotato di fnalità proprie e specifche»; diventa «attore di politche
educatve e culturali in senso lato assoggettato ad una disciplina specifca, e non mutuata da
altri settori, per quanto contgui, come invece accadrà nei decenni successivi»235. A partre dal
1867 prende via il lento processo di strutturazione di una legislazione di tutela che fnisce,
nell'arco di poco più di un decennio, con l'inglobare e assoggettare totalmente il mondo dei
musei statali. I due percorsi normatvi, il primo avente per oggetto i musei, e il secondo
relatvo alle leggi di tutela, inizialmente procedono in parallelo, e poi in maniera
progressivamente sempre più forte fniscono con l'intrecciarsi per arrivare al punto in cui il
museo fnisce defnitvamente con il «trovarsi inserito progressivamente in una struttura più
ampia di tutela»236. Sul piano delle professioni questo processo ha comportato «il delinearsi
una progressiva unifcazione dei ruoli del personale [di quello addetto al tutela e di quello
addetto ai musei] che preluderà, molt anni più tardi, alla defnitva cancellazione di quelli più
specifci ai musei»237. È a partre dalla legge 242 del 1903, e dal Regolamento attuatvo del
1904, che si ha la defnitva perdita da parte del museo del suo status di isttuto e l'acquisizione
da parte di quest'ultmo di quello di raccolta. Il museo fnisce così con l'essere inteso «come
contenitore di cose e come insieme di beni»238. «Spazio o collezione, totalmente privo di
identtà come isttuzione, il museo statale italiano, a partre dai primi anni del Novecento,
inizia a perdere qualunque rilevanza giuridica» 239, per diventare «un insieme di beni, mobili e
collegat fra loro dall'aver condiviso gli scopi di raccolta e di conservazione di determinate
testmonianze della vita artstca e culturale, piuttosto che come un soggeto di atvità, di
funzioni e relazioni che, atraverso la cura delle opere conservate, risult orientato allo sviluppo
sociale della conoscenza»240. Privato di una propria identtà giuridica, scomparso
dall'ordinamento legislatvo, il museo progressivamente scivola sotto il controllo degli organi
periferici dello Stato ai quali viene affidato il compito di provvedere alla tutela dei beni (le
Soprintendenze) e diventa un semplice ufficio di pertnenza dell'organo territoriale di tutela.
235
236
237
238
239
240
Loc. cit..
Ibid., p. 57.
Loc. cit..
Ibid., p. 77
Loc. cit..
AA.VV. I beni culturali in Italia. Indagine conoscitiva della Commissione Cultura, scienza e istruzione, (dicembre 1988dicembre 1991), vol. II, Roma, Camera dei Deputati, 1992, pp. 365-366 cit. in ibid., p. 77.
[60]
Non essendo più «un isttuto in sé tpizzato, né riconosciuto o distnto a livello defnitorio e
funzionale operatvo»241, esso fnisce sotto la responsabilità del Soprintendente, che pur
delegando le funzioni di direzione a personale interno alla propria struttura rimane sempre e
comunque il responsabile legale della raccolta. Tra le conseguenze – destnate a pesare a
lungo – di questa situazione c'è il fatto che nel campo dei musei «non ha avuto neppure modo
di formarsi una burocrazia tecnica specializzata [...] con competenze e professionalità distnte
e con una capacità di difendere e sostenere le ragioni del museo nei confront dei tut coloro
che hanno responsabilità diretta o indirette del suo difficile stato» 242, e dunque la mancata
individuazione di un proflo professionale ben delineato e di un ruolo netto per i direttori.
Questa la situazione delle strutture statali (con le immaginabili ricadute generali sul modo di
pensare i musei, la loro organizzazione e il loro funzionamento). Per quanto riguarda i musei
civici, i musei di ente locale, la questone della direzione si pone in altri termini dal punto di
vista normatvo e va ricondotta all'evoluzione del quadro legislatvo degli ultmi decenni, il
quale afonda le radici nella Costtuzione della Repubblica.
L’art. 9 della Carta sostene che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientfca e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artstco della
Nazione». L'art. 117 disciplina la potestà legislatva, e prevede che essa venga «esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costtuzione, nonché dei vincoli derivant
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Alla lettera S lo stesso artcolo
affida243 allo Stato la «legislazione esclusiva [in merito alla] tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali» e lascia alle Regioni, la cui isttuzione all’atto della
promulgazione della Carta è prevista dall’art. 114, il compito della valorizzazione. È soltanto
nel 1972, vale a dire subito dopo l’entrata a regime dei queste ultme, che con l’art. 7 del
D.P.R. 3, si provvede al reale trasferimento alle Regioni a statuto ordinario 244 delle «funzioni
amministratve degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di
ent locali». Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernent: «a) l'isttuzione,
l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di ent locali o d'interesse
241 Ibid., p. 32
242 Ibid., p. 34
243 In sede critica è stato riconosciuto che lo spirito che ha portato alla scrittura delle norme sopra citate appare
«caratterizzato da un forte spirito centralista e da una profonda diffidenza nei confronti di una prospettiva di
decentramento alle regioni delle funzioni statali di tutela», ibid., p. 84.
244 Per quelle a statuto speciale, in ragione della loro particolarità, l’iter è stato anticipato.
[61]
locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura isttuit o gestt da
ent locali e gli archivi storici a quest affidat; b) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il
godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di ent locali o d'interesse
locale; c) gl'intervent fnanziari diret al miglioramento delle raccolte dei musei e delle
biblioteche suddette e della loro funzionalità; d) il coordinamento dell'atvità dei musei e delle
biblioteche di ent locali e d'interesse locale; e) le mostre di materiale storico ed artstco
organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di ent locali o d'interesse locale». Lo
Stato (art. 12) contnua a riservare per sé i compit di «indirizzo e coordinamento delle atvità
amministratve delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere
unitario»245, così come la tutela. In sostanza, la legislazione concorrente da parte delle regioni
viene permessa solo in materia di valorizzazione246.
Pochi anni dopo, il Capo VII del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, all’art. 47, in materia di
beni culturali, aferma il principio secondo cui «le funzioni amministratve relatve alla materia
"musei e biblioteche di ent locali" concernono tut i servizi e le atvità riguardant l'esistenza,
la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei […] nonché il
loro coordinamento reciproco con le altre isttuzioni culturali operant nella regione ed ogni
manifestazione culturale e divulgatva organizzata nel loro ambito». Si tratta sostanzialmente
di un provvedimento che ribadisce la competenza degli ent locali nel campo della
valorizzazione. Il Decreto, prodotto in attuazione della legge 382/75 (Norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), rimanda alla stesura ad una
legge generale di tutela la cui emanazione viene prevista entro la fne del 1979 e alla quale
viene affidato il compito (art. 48) di riordinare «le funzioni amministratve delle regioni e degli
ent locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artstco,
archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico». Nonostante la
scadenza data, è soltanto nel 1997 che, con la Legge 59/97, meglio nota come Legge
Bassanini, provvedimento diretto a promuove forme più spinte di sussidiarietà tra Stato e ent
locali, si torna a legiferare con provvediment gravidi di conseguenze per il settore dei musei.
245 Dal 1975 in avanti tramite il neo istituito Ministero per i Beni Ambientali e Culturali.
246 Sulla separazione delle attività di tutela da quelle di valorizzazione cfr. Fabio DONATO e Anna Maria VISSER
TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., cap. 6 Tutela o valorizzazione? Sul concetto di valorizzazione, e in particolare
sul suo rapporto con quanto va sotto la categoria di gestione cfr. Claudio ROSATI, Valorizzazione, «AM-Antropologia
Museale», anno 3, numero 8, 2004, pp. 34-36.
[62]
La legge 59 del 1997, avente per oggetto il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifcazione
amministrativa, prevede il trasferimento di molte funzioni e compit amministratvi a livello di
ente locale, ad esclusione di alcuni elencat in una lista della quale fanno parte, ancora una
volta, quelli relatvi alla tutela dei beni culturali. Il D. Lgs. 112 del 1998, che disciplina il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
atuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è la norma che, per così dire, rende
operatva la legge Bassanini. È all'interno del Capo V – Titolo IV, artt. 148-155, che vengono
afrontat i temi rilevant per il destno dei musei (tutela, gestone, valorizzazione). L'art. 150, in
partcolare, è quello che stabilisce la emanazione dell'Atto di indirizzo di cui ho già parlato nel
paragrafo 2.1.
La revisione del Titolo V della parte II della Costtuzione (Legge costtuzionale 3/2001)
sancisce il defnitvo riconoscimento del ruolo esclusivo dello Stato nella tutela (art. 117,
comma 2) mentre apre alla legislazione concorrente in tema di valorizzazione, ma anche di
promozione e organizzazione delle atvità culturali (comma 3) fermo restando la facoltà del
primo di indicare per quest ambit linee guida di portata generale 247. L'art. 116 della Legge
prevede la possibilità che, sulla base di una concertazione tra ent locali e tra quest e lo Stato,
e sulla base di una volontà specifca, possano essere raggiunte «condizioni di partcolare
autonomia» aferent la valorizzazione, la promozione ma anche la tutela. Da notare che
questa riforma, che in buona sostanza ricalca quanto previsto dal D. Lgs. 112, specie dal Capo
V, non tocca minimamente, neanche citandolo, il tema della gestone (richiamato invece del
D.Lgs. 112 e in partcolare dall’art. 148 248), destnando questa di fatto a fnire in carico
totalmente alle regioni. Nel 2002, attraverso un parere espresso del Consiglio di Stato, questa
atvità è stata riconosciuta azione integrante della pratca di valorizzazione e quindi inserita
nel novero delle materie soggette a legislazione regionale, fermo restando la possibilità da
parte dello Stato di dettare in materia linee guida249.
Per concludere questo breve e non esaustvo excursus storico 250, che si è limitato ad
247 Ibid., p. 115.
248 Dove per gestione si intende «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad
assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di
valorizzazione».
249 Daniele JALLA, Il museo contemporaneo, op. cit., p. 116.
250 Non sono stati toccati alcuni passaggi importanti, come quello rappresentato dal lavoro della Commissione
[63]
una analisi dell’evoluzione legislatva in relazione alle sue ricadute rispetto al campo di
indagine entro cui si muove la presente ricerca, va registrato che – secondo i critci più attent
– «per quanto riguarda specifcatamente i musei, la conseguenza più signifcatva [della
riforma del Titolo V della Costtuzione] è che la legislazione e normatva regionale in materia
acquistano un peso e una rilevanza assolutamente maggiori di quanto non avessero in
passato»; a partre da questa fase è alle regioni che viene affidato «il compito di fornire un
quadro normatvo generale relatvo anche alla gestone dei musei, esteso anche alla
defnizione delle fgure professionali operant al loro interno»251.
2.3 LA
VIA LAZIALE AI MUSEI CIVICI
I musei civici, abbiamo appena visto, sono sogget alla normatva nazionale per quanto
aferisce al campo della tutela, ma a quella regionale per tutto quanto atene la materia della
valorizzazione252, cioè l'insieme delle atvità dirette a «migliorare le condizioni di conoscenza e
conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione»253. Ed è in
questo ambito che viene defnito lo spazio di azione entro il quale può muoversi il direttore del
museo. Dato che la questone della valorizzazione è materia di competenza regionale,
conviene entrare subito nello specifco dell’artcolazione di una specifca normatva regionale
per vedere più da vicino il suo funzionamento.
La scelta cade sulla Regione Lazio e in partcolare sulla Legge Regionale 42/1997 Norme
in materia di beni e servizi culturali del Lazio che disciplina il funzionamento di archivi,
biblioteche e musei (art. 2). La preferenza è motvata in parte da motvi di carattere
contngente, la L.R. 42/1997 è quella che interviene a regolamentare il funzionamento dei
musei in cui lavoro, in parte da motvi sostanziali: quella del Lazio, infat, è la normatva che
viene assunta dagli estensori del capitolo dedicato al Personale del Decreto sugli standard
Franceschini, grazie alla quale nel 1964 entra nel lessico legislativo italiano il concetto di bene culturale e che, a
proposito di professionalità museali, nella Dichiarazione LXXIII afferma la necessità di garantire per i musei
statali una «necessaria autosufficienza per ciò che concerne i servizi essenziali e il personale specializzato».
251 Daniele JALLA, Il museo contemporaneo, op. cit., p. 201.
252 Quello della scissione dell'ambito della tutela da quello valorizzazione e gestione è questione rilevantissima nel
campo dei beni culturali e dei musei. Secondo Alessandra MOTTOLA MOLFINO «tutti coloro che lavorano nei
musei si sono chiesti: come si fa a dividere tutela da gestione e poi da valorizzazione, quando sono cose tutte
totalmente integrate nel nostro lavoro quotidiano?» (id. Leggi, statuti, regolamenti, autonomia, in Alessandra
MOTTOLA MOLFINO e Cristiana MORIGI GOVI, Lavorare nei musei, op. cit. p. 67.
253 Art. 148 D. Lgs. 112 del 1998
[64]
museali254 come esempio di provvedimento legislatvo che fssa palet ben precisi circa i modi
di impiego dei professionist museali nella gestone degli isttut di pertnenza comunale.
La Legge 42 del 1997, tramite apposito piano settoriale triennale, «determina le linee
della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge» (art. 6, comma 1). La
stesura del piano, che stabilisce i «criteri per la localizzazione e la selezione degli intervent
relatvi sia alle strutture culturali e scientfche, sia alla salvaguardia, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali», è previsto che venga realizzata tramite la convocazione di
una conferenza programmatca che vede coinvolt «i competent assessori provinciali e dei
comuni capoluogo, i rettori delle università del Lazio, le organizzazioni sindacali
rappresentatve, nonché quelle dell'imprenditoria, del volontariato e dell'associazionismo a
livello regionale». Il primo piano settoriale risale al 1999-2001, il secondo – tutt'oggi in vigore –
è quello che risale al 2002-2004 e che recepisce le indicazioni del Decreto sugli standard
museali. Al momento risulta in fase di elaborazione un nuovo piano 255, ma l’iter della sua
approvazione sembra essersi fermato. Il primo piano triennale ha riguardato la
riorganizzazione dei servizi esistent e funzionant, attraverso l’isttuzionalizzazione delle
Organizzazioni Regionali (museale, bibliotecaria e archivistca). Il secondo si è posto come
obietvo quello di incrementare i servizi e riqualifcarli (standard di qualità, formazione del
personale) e quello di favorire la nascita di Sistemi museali e bibliotecari.
La legge 42, oltre a disciplinare il funzionamento dei musei accreditat presso la
Regione, provvede anche al fnanziamento di ben determinate tpologie di intervento. Ad
esempio, per rimanere al focus del nostro interesse, l’art. 9 (Piano d’intervento degli ent
locali) al comma d prevede che «i piani comunali possono prevedere la richiesta di
fnanziament per la formazione del personale la formazione e l'aggiornamento degli operatori
impegnat nella gestone dei servizi culturali». L’art. 21 (comma 4, lettera d) avverte che, per
essere accreditato presso l’Organizzazione Museale Regionale, il servizio deve avvalersi di
personale professionalmente qualifcato.
Il primo requisito in ordine di elenco per l’inserimento in OMR, dal che dipende anche
la possibilità che i singoli musei ricevano fnanziament regionali sui capitoli di spesa che la
254 Cfr. Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifci e sugli standard di sviluppo e
funzionamento dei musei (art. 150, comma6, del D.Les. n. 112 del 1998).
255 Cfr. D.G.R. n. 958 del 11.12.2009 Schema di Piano Settoriale Regionale 2010-2012 in materia di beni e servizi culturali, ai
sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 42/1997 - pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 del BURL n. 3 del
21.01.2010.
[65]
Legge 42 prevede e altri benefci (l'inserimento nei sistemi tematci), c’è la presenza «in
dotazione organica […] di un direttore (in possesso del diploma di laurea in disciplina atnente
alla tpologia del museo) e/o di operatori museali (in possesso del diploma di scuola media
superiore) di ruolo e professionalmente qualifcat» 256. Le forme di impiego del personale
variano in funzione di alcuni parametri, tra cui dimensioni del museo e popolazione del
comune al quale esso appartene. Il livello base è costtuito da un operatore museale part-tme
e da un direttore a con contratto a convenzione per i musei fno a 100 mq e una popolazione di
3000 unità; il livello più elevato prevede, per i musei con dimensione superiore ai 400 mq,
indipendentemente dalla dimensione demografca del comune, almeno il direttore ed un
operatore museale. Nella maggior parte dei casi, il direttore di un museo civico della Regione
Lazio è uno specialista legato all’amministrazione comunale da un contratto a convenzione di
durata annuale. La bozza di nuovo piano settoriale prevede una novità importante sul piano
del personale interno ai musei. Al capitolo 6.1, Requisiti per l’OMR e per l’OBR, viene proposto
di affidare la direzione del museo «ad un Direttore tramite stpula di una convenzione purché
non inferiore ad un triennio, al fne di consentre la necessaria contnuità amministratva e
scientfca».
2.4
SPECIALISTA E /O MANAGER
Terminata l'analisi della sfera legislatva torno a quella museologica per afrontare un
sfaccettatura partcolare del problema che sto indagando, quello della formazione specialistca
del direttore e del rapporto tra questo tpo di competenze e quelle di tpo gestonale.
Afermare, come è stato fatto nel paragrafo 2.1, che il direttore è l'interprete della missione
del museo rende talmente tanto evidente la necessità che a dirigere un isttuto di questo tpo
sia chiamata una fgura in possesso di conoscenze specialistche rispetto alla disciplina di cui il
museo è espressione, che diventa difficile argomentare ulteriormente questo principio.
Difficile ma necessario, perché il criterio appena esposto, soprattutto nell'ambito dei musei
etnografci, appare oggetto (suo malgrado) di contnue negoziazioni. Probabilmente il motvo
di ciò va cercato anche nella debolezza isttuzionale che nel nostro Paese hanno le discipline
DEA e chi le pratca.
256 Ibid., p. 68. Sulla questione della direzione dei musei civici del Lazio cfr. l'intervista a Pietro TAMBURINI.
[66]
In quest ultmi anni, in diversi modi, da diverse part e con diverse fnalità, il proflo
professionale del direttore specialista della disciplina è stato oggetto di tentatvi di
ridefnizione. Una delle questoni più delicate attualmente in discussione, e che riguarda anche
i musei locali, è quella relatva alla possibilità, ed alla opportunità, di sosttuire – o
quantomeno affiancare – i direttori specialist (antropologi, ma anche archeologici, storici
dell'arte) con dei manager. L'argomento non può essere liquidato superfcialmente. Utle può
essere, piuttosto che rispondere in maniera corporatvistca per mezzo di una levata di scudi a
difesa del primato dell'antropologo direttore, afrontare il problema con maggiore respiro e
chiedersi se sia sufficiente – oltre che necessario – che a ricoprire un simile incarico venga
chiamato uno specialista “puro”, oppure se per assumere responsabilità diretve servano
competenze che vanno ben al di là di una, seppur approfondita, preparazione specialistca.
Posta la questone in altri termini la domanda potrebbe essere la seguente: essere
antropologo, o essere antropologo direttore di un museo, è la medesima cosa oppure nel caso
in cui si abbia la responsabilità della direzione di un isttuto culturale di tpo museale è
necessario imprimere alla propria postura disciplinare una partcolare torsione e adottare
specifci atteggiament? E se è così, di che tpo deve essere questa torsione?
«Esistono molt modi per dirigere un’azienda e i direttori hanno molt modi di
interpretare il proprio ruolo: c’è chi si chiude in sé stesso, nelle inarrivabili stanze della
direzione, cui si accede solo superando una serie di fltri degni della base di Guantanamo, vi è
chi si ofre solo ai media più important, chi disdegna le feste natalizie con il loro disgustoso
impegno di incontrare i dipendent e – nelle grandi aziende – i loro bambini, chi assume
un’immagine democratca, piegandosi a conoscere i ritmi e le difficoltà della produzione. Oggi i
padri-padroni di un tempo hanno lasciato il posto ai manager che, quanto più sono manager,
tanto più sono distant dalla realtà socio-professionale delle aziende che devono “managing” e
sono conosciut dai loro dipendent solo attraverso i programmi economici o le cronache
mondane dei giornali e delle ret televisive. Nei musei la situazione non è diversa. Anche qui vi
sono direttori che sono uomini di cultura, ciascuno dei quali ha un suo modo di interpretare il
ruolo diretvo, ma essi vengono soppiantat sempre più spesso da manager generalist,
bravissimi a far di conto, ma strutturalmente inidonei a gestre imprese di produzione
culturale, quali sono i musei»257. La citazione è tratta dal volume Animali impagliati e altre
257 Giovanni PINNA, Animali impagliati e altre memorie. Ricordi di un direttore di museo con note di museologia, Milano, Jaca
[67]
memorie, una biografa professionale ricca di aperture a questoni generali riguardant la teoria
e la pratca della museologia scritta da Giovanni Pinna, direttore del Museo di Storia Naturale
di Milano (quindi di un grande e blasonato museo civico), dal 1981 al 1996 nonché presidente
di ICOM-Italia dal 1997 al 2000. Mi è sembrato utle riportarla perché il brano, estrapolato da
un più ampio capitolo dedicato a Il ruolo del diretore fra controllo e comunicazione, coglie uno
dei nodi centrali relatvi al funzionamento dei musei, quello del proflo professionale del loro
direttore in rapporto alla questone manager si, manager no. Il contesto in relazione al quale
Pinna artcola il suo ragionamento è distante da quello che interessa in questo dossier, ma vale
la pena di prestare attenzione a quanto messo in luce dall'Autore.
Il volume pone all’attenzione diverse questoni. Pinna, rappresentante di una categoria
di scienziat molto più forte rispetto a quella degli antropologi, nel prosieguo della sua
argomentazione, scrive che è «impossibile che un manager generalista – anche se laureato in
qualche prestgiosa università economica – sia in grado di gestre un museo» e si dice convinto
che «il direttore di un museo debba essere un autorevole rappresentante di una disciplina
culturale connessa ai contenut e alla vocazione del museo». Sull'argomento si è espresso
anche Michelle Laclotte, storico dell’arte e direttore del Louvre dal 1987 al 1995. Lo cito anche
se valgono le stesse avvertenze poste poco sopra: la realtà che viene presentata da questo
autore è fuori scala rispetto a quella pertnente a questo dossier. Secondo Laclotte le
dimensioni di alcuni grandi musei fanno sì che quest per funzionare necessitno di solide
competenze organizzatve e gestonali da parte dei rispetvi direttori. Il pericolo che egli vede
proflarsi è che, sulla base di questa consapevolezza, i politci e gli amministratori giungano a
considerare un “semplice” conservatore 258 di museo non in grado, a causa della sua
formazione maturata esclusivamente in ambito specialistco, di gestre isttuzioni complesse e
simili per numero di personale impiegato e fondi a disposizione a delle aziende, e che di
questo passo arrivi a pensare come possibile – se non auspicabile – la sosttuzione dello storico
dell'arte (o, per altre realtà, della fgura equivalente) con un manager. Sostene Laclotte «che
amministratori fornit di ampi poteri assistano il patron, come è avvenuto con me e con i miei
successori, niente da dire. Ma soltanto un uomo o una donna della “casa”, storico dell’arte di
formazione, qualcuno che abbia avuto a che fare direttamente con le collezioni, avrà
Book, 2006, p. 108.
258 Quella del Conservateur in Francia corrisponde alla figura del nostro Direttore.
[68]
l’esperienza e i rifessi che occorrono per orientare una politca di mostre, di pubblicazioni
scientfche, di programmi culturali, di allestment museografci. Dovrebbe essere evidente. E
poco importa se qualcuno troverà questa esigenza corporatva!»259.
Per realizzare la propria missione – è stato detto sopra – il museo deve disporre di
personale, competenze e più in generale di mezzi
fnanziari, beni strumentali e
organizzazione260. Questa dichiarazione di principio appare in contraddizione con quanto è
stato possibile osservare negli ultmi decenni nel nostro Paese. A partre dagli anni Novanta,
infat, la vita dei musei e dei loro direttori si è fatta piuttosto fatcosa. A fronte del grande
progresso che in termini quanttatvi e qualitatvi i musei italiani (tanto quelli locali quanto
quelli nazionali) hanno compiuto negli ultmi vent anni, «non ha corrisposto in ugual misura
l'adeguamento delle risorse 261 ordinarie per il funzionamento, la gestone e l'atvità dei musei
nuovi e rinnovat, e di quelli tradizionali. Anche la dotazione di personale – risorsa strategica
per il museo, inteso come isttuto che produce cultura – non è stata adeguata
quanttatvamente e qualitatvamente» 262. Sono anche quest gli efet della crisi dei musei,
almeno stando a come questa viene descritta in un recente volume redatto a quattro mani da
Fabio Donato, esperto di economia delle aziende culturali, e Anna Maria Visser Travagli,
archeologa e museologa. Secondo quest autori, nello scenario dominato dalla crisi, che è al
tempo stesso crisi economica ma anche crisi della tradizionale concezione di museo, l'unica
possibilità di futuro per quest isttut è da ricercare nel dialogo, sgombro da preconcet ed
equivoci, tra museologia e management. Un confronto libero da quegli «idoli retorici che
contrappongono in modo frontale posizioni aprioristche, che alimentano, spesso in modo
sterile, polemiche rovent che dividono la comunità di riferimento e l'opinione pubblica»263.
Secondo la preziosa – e adeguatamente critca – ricostruzione che Donato propone, a
partre dagli anni Novanta la pubblica amministrazione italiana ha subito un processo – non
privo di contraddizioni e di passi falsi – di conversione dal modello così detto burocratico,
attento più alla validità formale delle procedure che alla loro adeguatezza sostanziale e
259 Michel LACLOTTE, Storie di musei. Il direttore del Louvre si racconta, Milano, Il Saggiatore, 2005, p. 279.
260 Alessandra MOTTOLA MOLFINO e Cristiana MORIGI GOVI, Lavorare nei musei. Il più bel mestiere del mondo,
Torino, Umberto Allemandi & C., 2004, p. 10.
261 Su tema delle risorse economiche a disposizione degli istituti culturali, del mecenatismo pubblico e altri connessi
cfr. Christian CALIANDRO e P. Luigi SACCO, Italia reloaded. Ripartire con la cultura, Bologna, Il Mulino, 2011.
262 Anna Maria VISSER TRAVAGLI, La prospettiva musicologica, in Fabio DONATO e Anna Maria VISSER
TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., p. 20.
263 Introduzione, in Fabio DONATO e Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., p.14.
[69]
sostenibilità economica, a quello economico aziendale, basato sul principio che i servizi
pubblici devono essere «realizzat anche in condizione di efficacia, cioè di capacità risposta alle
attese dei cittadini, sotto il proflo quanttatvo e qualitatvo, e in condizioni di efficienza, cioè
con il minor consumo possibile di risorse» 264. Sembra che questo processo, che ha investto in
maniera più o meno diretta i musei (tramite le amministrazioni degli ent locali), abbia
funzionato a metà. Imposto dall'alto, e non accompagnato da un reale processo di
cambiamento di mentalità, il modello ha fnito col vedere fortemente limitate le sue
potenzialità innovatrici. Ma il problema più grave che ha accompagnato il processo di
aziendalizzazione (l'adozione di procedure amministratve e gestonali di tpo economicoaziendale) risiede nel fatto che esso è stato interpretato da più part in termini di
privatzzazione dei servizi pubblici e quindi anche dei musei. Stando alla lettura che del
fenomeno propone Donato, l'intento di questa trasformazione era quella di consentre una
gestone più oculata (sul piano economico ma anche etco e sociale) delle risorse e non di
trasformare, nello specifco, i musei in «imprese orientate a logiche di mercato», perché «il
processo di aziendalizzazione non modifca in alcun modo le fnalità del museo, che rimangono
quelle isttuzionali. Non richiede la ricerca di un proftto, ma piuttosto il raggiungimento di
condizioni di equilibrio economico a valere sul tempo, ossia di sostenibilità economica delle
proprie scelte in una prospetva di breve ma anche di più lungo termine. E inoltre affianca, ma
non sosttuisce, le logiche di mercato a quelle isttuzionali» 265. Prima di proseguire oltre è
opportuno fare una precisazione e scindere il discorso relatvo a quella che poco sopra è stata
defnita “gestone” dei musei in due grandi ambit: la gestone vera e propria delle atvità
isttuzionali (in “economia”, in “concessione a terzi”, per mezzo di una “isttuzione” 266) e quella
che se anche sbrigatvamente viene indicata in questo modo sta in realtà ad indicare la
direzione del museo. In questa sede quello che interessa è la gestone latu sensu intesa come
direzione, e dunque i discorsi sulle implicazioni possibili delle varie forme di gestone, con tut
i problemi connessi (come quello della concessione a privat dei così det servizi aggiuntvi)
non trovano spazio nelle pagine a seguire.
264 Fabio DONATO, I profli economici e manageriali, in Fabio DONATO e Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Il museo
oltre la crisi, op. cit. p. 33.
265 Ibid., pp. 36-37.
266 Fabio DONATO, Le responsabilità istituzionali e l'autonomia gestionale, in Fabio DONATO e Anna Maria VISSER
TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., p. 101.
[70]
Il capitolo 3 Educazione o mercato del volume La crisi dei musei. Dialogo fra museologia
e management individua due diverse strade intraprese dal museo contemporaneo, una
orientata all'educazione e una al mercato. Il primo percorso, legato alla storia moderna di
questa isttuzione, rimanda a idee fort quali quelle di bene pubblico, di democrazia della
conoscenza, di servizio educatvo. Il secondo nasce in epoca più recente 267 e connette il museo
alla sfera del mercato e del consumo del tempo libero. Sul piano delle professioni museali la
distnzione tra un tpo e l'altro porta a individuare due profli ideali diversi di direttore, che nel
primo caso (museo tradizionalmente inteso) non può che coincidere con quello di uno
studioso della disciplina di cui l'isttuto è espressione; nel secondo con quello di un manager.
Ma vanno veramente pensate, queste due, come fgure anttetche? È possibile una qualche
forma di sintesi tra di esse?
Di certo in anni recent è stato il proflo del direttore-manager quello ad aver avuto
maggior fortuna nel dibatto pubblico. All'ascesa di questa fgura, sovente invocata «in modo
fdeistco, come il demiurgo capace di svecchiare rapidamente il sistema museale pubblico
attardato e inefficiente, guidato da fgure inadeguate» 268 ha corrisposto l'opposizione della
comunità costtuta dai professionist atvi nel settore dei musei e del patrimonio, i quali hanno
sentto come minacciata di grave pericolo l'autonomia e la corretta gestone del patrimonio
museale. La svolta “manageriale”, a ben vedere, poggia su un retroterra ben defnito. Nella
prima metà degli anni Novanta una serie di normatve 269 apre la strada al reclutamento di
dirigent dei servizi culturali (musei inclusi) anche non incardinat all'interno degli ent pubblici
ai quali appartengono gli isttut: «dai direttori tradizionali e dalle fgure diretve di ruolo a
tempo indeterminato, reclutat attraverso pubblici concorsi con ttoli e requisit coerent con la
natura dei musei e del patrimonio culturale da avere in cura – vale a dire archeologi, storici
dell'arte, naturalist ecc. – si passa a dirigent nominat dall'amministrazione a tempo
determinato, provenient anche dal settore privato e che possono avere profli molto vari,
prescindendo da competenze disciplinari specifche relatve al patrimonio, perché devono
garantre l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestone, devono far funzionare
267 Cfr. Pietro C. MARANI e Rosanna PAVONI, Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporanea,
Venezia, Marsilio, 2006, cap. 3 e cap. 4.
268 Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Chi deve diriger il museo? La questione delle professioni, in Fabio DONATO e Anna
Maria VISSER TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., p. 84.
269 La Legge 142/1990 Ordinamento delle autonomia locali, la Legge 4/1993 c.d. Legge Ronchey, relativa ai “servizi
aggiuntivi”, il Decreto Legislativo 29/1993 sul pubblico impiego, il Decreto Legislativo 77/1995 sull'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, ibid., p. 85
[71]
l'organizzazione a prescindere dai contenut culturali della stessa, per cui possono essere
giornalist, pubblicitari, espert di marketng, manager con esperienze in settori di mercato
anche molto lontani dal mondo della cultura» 270. La reazione che si è originata dall'interno del
mondo dei musei è stata tutta orientata a ribadire che la direzione di un isttuto «non può
essere avulsa dai contenut culturali specifci ed essere una mera tecnica, che può essere
applicata indistntamente a ogni settore della pubblica amministrazione» 271. La discussione sul
ruolo dei manager alla direzione dei musei è tutt'ora aperta e vede coinvolt molt sogget 272.
Alessandra Mottola Molfno, storica dell'arte direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano,
percepisce come un rischio l'ipotesi che a dirigere i musei possano essere chiamat dei
manager: «per quasi due secoli direttori dei musei sono stat storici, studiosi, specialist e
soprattutto museologi. Nel futuro i musei saranno ancora gestt da loro?» 273. La sua posizione
rispetto al quadro che sembra delinearsi è netta: «uno storico dell'arte può trasformarsi in un
validissimo manager (come dimostrano tant esempi italiani e stranieri); il contrario non è
possibile»274. Che la gestone dei musei sia affidata alle mani di specialist e non di manager
(manager museali, dei servizi culturali), scrive la studiosa, è fondamentale «soprattutto come
garanzia per l'interesse comune di tut i cittadini nella gestone corretta dei patrimoni culturali
pubblici»275. Come fa notare Anna Maria Visser Travagli, il fatto stesso che Mottola Molfno
prenda in considerazione l'idea che uno storico dell'arte, o comunque uno specialista, possa
acquisire competenze manageriali, lascia trasparire una certa disposizione di pensiero ad
immaginare come non troppo lontana una qualche forma di cambiamento e rinnovamento nel
proflo del direttore tradizionalmente inteso, un cambiamento nella direzione dell'acquisizione
di una sempre maggiore familiarità con gli strument gestonali di tpo manageriale, «non per
sosttuirsi a chi ha la competenza professionale specifca, ma per essere in grado di coordinare
con consapevolezza anche questo fondamentale ambito di atvità» 276. Sembra questa una
buona posizione a cui aderire. Anche per sottrarre la cultura delle gestone al monopolio dei
270 Ibid., p. 86.
271 Loc. cit..
272 In questa sede posso soltanto segnalare che sotto questo punto di vista la situazione dei musei italiani ed europei è
diversa da quella dei musei americani, cfr. Alessandra MOTTOLA MOLFINO, Il libro dei musei, op. cit., cap. 8
Musei americani vs musei europei, pp. 171-210.
273 Cfr. La gestione unitaria: uno storico dell'arte può diventare manager; il contrario non è possibile, in Cristiana MORIGI GOVI e
Alessandra MOTTOLA MOLFINO, La gestione dei musei civici. Pubblico o privato?, op. cit., p. 93.
274 Ibid., p. 94.
275 Ibid., p 95.
276 Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Chi deve diriger il museo?, op. cit., p. 92.
[72]
manager e dunque aprire a nuove possibilità di futuro per gli specialist.
A questo punto della rifessione sul problema può essere conveniente provare ad
impostare il ragionamento in maniera speculare rispetto a quanto fatto fnora e chiedersi:
ammesso che il direttore di un museo, e di un museo etnografco nello specifco, debba essere
uno specialista, quale livello di competenze manageriali egli deve possedere? Un direttore
deve saper gestre risorse umane (i suoi collaboratori, chi si occupa delle aperture, della
didatca, le altre unità di personale di cui dispone) e fnanziarie, deve intrattenere rapport con
gli stakeholders, le autorità politche e amministratve locali (i sindaci, gli assessori comunali) e
sovralocali (assessori provinciali, regionali), deve sapere esattamente come progettare e
pianifcare le atvità della struttura affidatagli in modo tale da convincere gli ent fnanziatori
della bontà dei suoi programmi di ricerca, di comunicazione e di organizzazione di event: è
questo il quadro delle mansioni che emerge da una osservazione del lavoro dei direttori 277 e
del funzionamento dei musei.
È innegabile che il museo sia una struttura artcolata, una macchina complessa che
produce cultura impiegando risorse umane e fnanziare e che per far questo, per funzionare al
meglio, debba poter fare affidamento su adeguate competenze manageriali. In questa
direzione si muovono tanto la Carta Nazionale delle Professioni Museali tanto il Manuale
Europeo, seppur con sfumature leggermente diverse. La Carta prevede che tra le
responsabilità che competono al direttore ci sia quella sull’«insieme dei processi gestonali». Il
Manuale sembra più esplicito, arrivando a individuare uno degli ambit di orientamento e
controllo post sotto la responsabilità del direttore in quello «Manageriale: egli/ella coordina i
diferent sevizi museali, ha la responsabilità della gestone delle risorse umane, tecniche e
fnanziarie. Egli/ella garantsce le relazioni con gli ent proprietari. Egli/ella rappresenta il
museo presso le diferent isttuzioni e i partner, pubblici e privat. Egli/ella assicura la
valutazione costante delle atvità del museo». Sul piano della formazione, fermo restando
l'importanza che entrambi i document riconoscono alle esperienze maturate sul campo,
mentre la Carta ritene necessaria una competenza specialistca in museologia e nelle
discipline atnent alla specifcità del museo» e la «laurea specialistca o laurea del vecchio
ordinamento nelle discipline atnent alla specifcità del museo», mentre il Manuale affianca in
277 Cfr. le interviste a Mario Turci, Antonio Riccio e Pietro Tamburini collocate in appendice.
[73]
modo esplicito alla «Laurea di secondo livello in una delle discipline inerent le collezioni del
museo» una «formazione o competenza certfcata in museologia e in management».
Il nocciolo della questone diventa così quello che riguarda il corretto modo di
intrecciare le competenze di tpo specialistco con quelle di tpo gestonale. In questo senso
non sembra troppo azzardata l'idea secondo la quale quello che serve all'interno di un museo
è «un direttore in grado di coniugare in sé competenze diverse: culturali specialistche,
relazionali interne ed esterne, ed economiche e manageriali. È poco credibile, per il futuro, la
visione di un direttore onnisciente che riunisca il sé competenze professionali molto diverse
tra loro. Piuttosto, è prefgurabile la fgura di un direttore che svolga un ruolo di coordinatore e
di integratore di sistemi e di aree di atvità diverse: studio e ricerca; cura e conservazione
delle collezioni; relazioni con gli interlocutori sociali; programmazione, organizzazione e
amministrazione; gestone delle strutture e dei sistemi per la sicurezza» 278. Direttore, dunque,
come armonizzatore di processi, come fgura di raccordo tra diverse istanze. Di questo passo
quella che viene delineandosi come ideale per le direzione di un museo contemporaneo è
«una fgura di direttore con competenze museologiche affiancato da una fgura dotata di
professionalità di tpo economico-manageriale. Ma può anche esservi un direttore con
competenze economiche e manageriali [...] con a fanco un museologo responsabile di ogni
decisione di carattere culturale. Il rapporto tra i due non sarebbe di tpo gerarchico, ma come
in tutte le organizzazioni ad alto contenuto specialistco-professionale, di tpo funzionale. Le
responsabilità delle scelte culturali sarebbe cioè di competenza del museologo mentre il
direttore (quale che sia la sua laurea) avrebbe il compito di garantre la coerenza delle
complessive atvità del museo, oltre che la sostenibilità economica delle scelte» 279. L'unica
perplessità rispetto a questo schema, adattabile – tra l'altro, e per ragioni facilmente intuibili –
soltanto alle grandi isttuzioni (un direttore scientfco affiancato da un direttore
amministratvo all'interno di un comune di mille abitant è impensabile), riguarda il reale
bilanciamento tra il peso dello specialista e quello del manager: tenuto conto del ruolo sempre
maggiore dell'economia in tut i settori della società, il rischio è di veder subordinato il primo
al secondo, lo specialista al manager. Per le piccole realtà, invece, il modello che prevede un
278 Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Chi deve diriger il museo?, op. cit., p. 94.
279 Ibid. pp. 94-95. Non sempre, laddove applicato, questo modello ha dato buoni frutti; è il caso del British Museum,
cfr. Luca DE ZAN, La managerializzazione delle organizzazioni culturali tra usi ed eccessi della retorica del management, in id.,
Economia dei musei e retorica del management, Milano, Mondadori-Electa, 2007, p. 14
[74]
direttore specialista in possesso di fort competenze di tpo gestonale, sembra essere quello
più indicato e adeguato.
Un aspetto che invece pare importante sottolineare è come l 'adozione (critca e non
meccanica) di metodi e pratche di tpo manageriale debba essere visto, Donato ci invita a
farlo, come una scelta carica di implicazioni sociali oltre che economiche: «non è accettabile in
termini sociali un museo che non persegue le proprie fnalità isttuzionali, ma piuttosto
obietvi di proftto utlizzando solo ed esclusivamente logiche di mercato. Ma non è
accettabile in termini sociali neppure un museo che spreca risorse pubbliche, che sottrae
risorse ad altri settori di intervento pubblico, o che trasferisce le proprie inefficienze sulle
future generazioni. In questa prospetva, la conoscenza del management non è più un
“optonal”, come è tutt'oggi talvolta ritenuto, ma una necessità imprenscindibile per poter
svolgere in modo adeguato il ruolo di direttore di un museo»280.
Più utle che contrapporre sul piano generale la fgura del manager a quella dello
specialista, sembra essere chiedersi cosa si nasconda dietro questa parola e soprattutto «quali
siano efetvamente gli strument manageriali più opportuni per un museo» 281. Questo perché la
loro scelta deve essere commisurata, proporzionata, al raggiungimento degli obietvi che il
museo si è dato tramite la propria missione, e poi perché ogni museo è realtà a sé, inquadrata
in un determinato contesto sociale, culturale, economico: partcolare questo che rende
necessario adottare strategie di volta in volta adeguate ai singoli casi. Il principio generale da
rispettare, in questo senso, è quello della gradualità: «non è necessario che un museo
introduca tut gli strument manageriali, congiuntamente e simultaneamente» 282. Tra quelli
che trovano applicabilità più immediata – vale la pena di approfondire – meritano di essere
citat il piano strategico, il budget e infne l'adozione di apposit strument di misurazione dei
risultat raggiunt. I piani strategici sono «quei document che discendono da un processo di
pianifcazione strategica, e che esprimono gli indirizzi da perseguire e le mete da raggiungere
in una prospetva spazio temporale di medio-lungo termine. I piani strategici sono dunque i
document nei quali sono evidenziat la missione e gli obietvi di medio lungo termine […] del
museo, con la specifcazione delle atvità, dei proget e delle iniziatve che devono essere
280 Fabio DONATO, La direzione del museo nella prospettiva economica e aziendale, in Fabio DONATO e Anna Maria
VISSER TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., p. 140.
281 Fabio DONATO, L'introduzione degli strumenti manageriali: una questione soprattutto di competenze, op. cit., p. 160.
282 Ibid., p. 169.
[75]
realizzat, e con una verifca del grado di sostenibilità economica, ossia dei ricavi che si prevede
di poter ottenere e dei cost che si prevede di sostenere» 283. Se la gittata del piano strategico è
quella del medio-lungo periodo, il budget ha una natura diversa; si tratta, infat, di una
«programmazione operatva nella quale sono specifcat gli obbietvi dell'anno e le scelte
gestonali e organizzatve legate alle atvità che si intendono svolgere» 284. L'efficacia e la
sostenibilità tanto del piano strategico quando del budget devono essere messi alla prova di
adeguat strument i misurazione per il controllo dei risultat ottenut dalla loro applicazione,
perché è «solo tramite il confronto tra gli obietvi programmat e risultat conseguit possono
essere avviate le rifessioni sul grado di appropriatezza del sistema gestonale e dell'assetto
organizzatvo in essere»285. L'importanza della corretta valutazione da parte del direttore del
museo è cruciale, perché gli strument manageriali “non hanno valore in sé, bensì solo in
quanto utli a comprendere, rifettere e decidere»286.
In conclusione: è evidente che, per quanto buona da pensare, abbozzare una rigida
dicotomia tra le due sfere (quella del museo e quella del mercato 287, e soprattutto quella degli
specialist e quella dei manager) può essere ridutvo. Nella realtà dei fat le cose sono molto
più sfumate, come accennato poco sopra; perché, e penso non si possa non concordare, «fare
il direttore, e dunque gestre i musei, signifca imparare a essere dei politci culturali e dei
manager della cultura, a fare i museologi, a progettare gli allestment, a leggere i bilanci e a
fare divulgazione intelligente, insomma a essere interpret delle esigenze culturali della
comunità in cui il museo vive»288.
2.5 PROFESSIONE ANTROPOLOGO
Come visto nel paragrafo precedente, il mondo dei musei è attraversato in maniera
trasversale, al di là delle specializzazioni tematche o disciplinari, da problemi e incognite che
investono direttamente i professionist che al loro interno lavorano. La questone dell'entrata
283
284
285
286
287
Ibid., p.162.
Ibid., p.165.
Ibid., p.166.
Ibid., p.167.
Cfr. Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Musei, eventi e grandi mostre, in Fabio DONATO e Anna Maria VISSER
TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., pp. 68-77.
288 Loc. cit. Sul tema delle professioni museali e sul loro rapporto con il management cfr. anche Silvia DELL'ORSO,
Altro che musei, op. cit., e in particolare il cap. 3 Protagonisti vecchi e nuovi.
[76]
in scena dei manager come possibili compettori o sosttut dei direttori specialist è una di
queste, e non è di poco conto. Poi ci sono questoni del tutto peculiari che investono in
maniera esclusiva il nostro – per molt versi fragile – settore.
Prendiamo
il
caso
delle
due
isttuzioni
più
important
del
patrimonio
demoetnoantropologico che esistono nel nostro Paese, il Museo Nazionale delle Art e
Tradizioni Popolari e il Museo Etnografco Preistorico “Luigi Pigorini” di Roma. Il primo,
precedentemente al suo assorbimento e conversione in Isttuto Centrale per la DemoEtnoAntropologia289, è stato diretto per anni da una storica dell’arte 290, Stefania Massari, e prima
ancora da altri studiosi291 che, per quanto attent alle cose DEA – ma l'attenzione è qualcosa di
ben diverso dalla specifca competenza scientfca, dalla competenza che la comunità degli
antropologi riconosce come adeguata a ricoprire un simile ruolo – di certo non aferivano ad
esso direttamente. Discorso del tutto simile per l'altro museo, il Pigorini, tradizionalmente
guidato da soprintendent archeologi. Per non parlare del Museo Nazionale di Antropologia e
Etnologia di Firenze che addirittura è privo di un direttore specifco 292. Si dirà che, nei primi due
casi riportat, sono state le norme del Ministero per i Beni e le Atvità Culturali ad escludere
un antropologo da quell’incarico a causa del mancato riconoscimento di questo specifco
proflo nel suo organigramma. Ma può – come è accaduto – uno storico dell’arte dirigere, e
farlo con proftto, un museo antropologico? Non rischia, questa sosttuzione di fgure, di far sì
che la lettura del patrimonio conservato in un isttuto che porta le insegne del museo
demoetnoantropologico venga sviata su piani non conformi a quello dell'interpretazione
etnografca, come potrebbe essere – ad esempio – quello di natura estetcodecontestualizzante? Chiaramente, la domanda è retorica.
Per un osservatore che vede le cose dall'interno l'impressione, rispetto ai problemi che
l'antropologia e gli antropologi attraversano periodicamente, è che la battaglia che quest
289 Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 7 ottobre 2008, disponibile online.
290 La vicenda della direzione del MNATP ha suscitato gran clamore in casa DEA. Nonostante gli articoli, gli appelli,
i post sui vari blog la vertenza con il Ministero ha segnato una sconfitta per il settore. Vedi
http://pierovereni.blogspot.com/2008/12/una-storia-semplice.html, e anche la Raccomandazione sulla creazione
dell'Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDEA) di ICOM Italia e della Società Italiana per la Museografia e
beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA). Cfr. anche Valeria PETRUCCI COTTINI, I beni culturali nel quadro delle
discipline etnoantropologiche, in Antonino COLAJANNI, Gioia DI CRISTOFARO LONGO e Luigi M. LOMBARDI
SATRIANI (a cura di), Gli argonauti. L'antropologia e la società italiana, Roma, Armando, 1994, p. 241.
291 Stefania Massari è stata preceduta da Valeria Petrucci Cottini e da Jacopo Recupero, storico dell'arte.
292 Il Museo, sezione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, ha un suo “responsabile” (antropologo
fisico) subordinato ad un direttore il quale ha la responsabilità generale di tutte le sezioni (Antropologia e
Etnologia; Geologia e Paleontologia; Botanica; Mineralogia e Litologia; Orto Botanico; Zoologia “ La Specola”)
che compongono l'istituto, cfr. http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-37.html
[77]
studiosi devono fare sia duplice. La prima per far sapere alla comunità chi sono e cosa fanno,
la seconda per veder rispettat quelli che gli stessi percepiscono essere propri spazi. A
diferenza della storia dell'arte, le discipline demoetnoantropologiche nel nostro Paese non
godono di un forte radicamento e di una immediata riconoscibilità da parte dell'opinione
pubblica e dei decisori politci. Tut sanno, almeno per grandi linee cosa fa un archeologo o
uno storico dell'arte, fgure entrate nell'immaginario grazie anche al cinema. Ma cosa fa un
antropologo (un antropologo culturale, un demoetnoantropologo nello specifco)? La scarsa
riconoscibilità di questa famiglia di operatori della cultura vale sul piano professionale in
generale, ed in partcolare su quello museale.
La storia di discipline quali l'antropologia culturale, l'etnologia e la storia delle tradizioni
popolari nel nostro Paese è una storia relatvamente recente 293. L'utlizzo della formula demoetno-antropologia per indicare l'intero campo di studi che esse ricoprono, se da una parte
segna la specifcità di come in Italia si è andato artcolando il quadro degli studi di antropologia
culturale, dall'altra ha reso questo mondo qualcosa di poco facilmente accessibile, non fosse
altro che per il tmore che genera quello che alcuni – con un pizzico di malizia, come
prontamente notato294 – considerano più che una sigla una sorta di scioglilingua. La fatca
incontrata da queste discipline a radicarsi nel tessuto sociale e culturale del nostro Paese –
nonostante una situazione sociale che potrebbe benefciare non poco di una maggiore
presenza dell'antropologia: vedi la portata dei fussi migratori con le reazioni che quest
comportano, gli interrogatvi connessi al processo di globalizzazione – è grande 295. La
dimostrazione arriva non solo dal fronte accademico, attraversato tra l'altro da problemi
interni relatvi a questoni più generali che riguardano il mondo dell'università italiana (carenza
di fondi, mancato ricambio generazionale), ma anche da quello delle isttuzioni pubbliche e dal
mondo del lavoro e delle professioni.
Rispetto alle questoni riguardant la professione dell'antropologo, a partre dai temi
della formazione fno ad arrivare ad una rassegna problematca delle reali occasioni di impiego
e degli spazi che gli antropologi possono conquistare, nel 1989 a Siena si è tenuto un
293 A.A.V.V, L'antropologia italiana. Un secolo di storia, op. cit..
294 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Demo cosa?, «AM-Antropologia Museale», anno 1, numero 2, ottobre 2002, p. 5.
295 Secondo il filosofo José ORTEGA y GASSET «una professione non potrà diventare ufficiale, statale, se non nel
momento in cui l'esigenza collettiva che essa soddisfa si acutizza enormemente, e non viene più sentita come
semplice necessità meccanica, ma come necessità ineludibile», La missione del bibliotecario, Carnago, Sugarco, 1994,
p. 29.
[78]
seminario296. In quella occasione, nel corso della quale i musei non sono stat propriamente al
centro della rifessione, il fronte più signifcatvo della discussione è stato quello rivolto verso il
settore della cooperazione, dell'accademia e in parte delle imprese private. Sul piano delle
questoni fondamentali, molt degli intervent che hanno animato l'incontro hanno concordato
nel sottolineare «le incertezze di statuto disciplinare», che in positvo e in negatvo rendono la
nostra una «disciplina inquieta, quindi aperta, non sclerotca, ricca di interne stratfcazioni» 297.
Questa “incertezza”, se da una parte può essere percepita come una potenzialità, perché in
grado di conferire al nostro sapere quella fessibilità, quella capacità di prestarsi alle analisi e ai
contest applicatvi più diversi, comporta anche degli aspet negatvi. La «non defnizione di un
preciso statuto epistemologico della disciplina pone l'antropologia in serie difficoltà» 298;
«troppo spesso i nostri interlocutori non hanno chiaro il proflo formatvo e l'orizzonte
complessivo in cui si muove la nostra disciplina» e perciò non riescono a desiderarla al punto
tale da richiedere un intervento degli antropologi, perché «per desiderare una cosa bisogna
conoscerla: forse nessuno conosce l'antropologia all'infuori degli antropologi» 299. E d’altro
canto c'è chi quello che ad alcuni appare come un punto di debolezza appare come un punto
di forza: «è immaginabile, lo suggeriscono in molt, che in uno scenario di disillusioni, si
capovolgano le priorità; i limit si rovescino in valori e si cerchino tra gli uomini di confne (tra
scienze e arte, tra conoscenza e vitalismo, tra accademia e controcultura, tra Occidente e
Altrove) risorse e nuovi punt di partenza che altri studiosi, più interni a prospetve disciplinari
di egemonia culturale, non riescono a fornire» 300. Una dichiarazione che sembra promettere
grandi cose al futuro degli antropologi. Eppure ancora oggi si percepisce forte la necessità che
quest si adoperino maggiormente, rispetto a quanto fatto nel passato, per farsi conoscere,
perché «la visibilità pubblica e accademica dell'antropologia, almeno in Italia, è tutt'altro che
rilevante. A diferenza della storia, della psicologia e della sociologia, il suo campo di indagine,
e ancor di più il suo approccio restano lontani dall'esperienza dei più, non facilmente defnibili
296 Gli atti sono stati pubblicati in Pietro CLEMENTE (a cura di), Professione antropologo, «La ricerca folklorica.
Contributo allo studio della cultura delle classi popolari» n. 23, aprile 1991.
297 Pietro CLEMENTE, in CLEMENTE (a cura di), Professione antropologo, op. cit., p. 6. Al 1995 risalgono le parole di
Clifford GEERTZ che più o meno nello stesso modo si esprimono a proposito dell'antropologia come disciplina,
cfr. id. Oltre i fatti. Due paesi, quattro decenni, un antropologo, 1995, Bologna, Il Mulino, cap. 5 Discipline.
298 Tullio SEPPILLI, in Pietro CLEMENTE (a cura di), Professione antropologo, op. cit., p. 9.
299 Paolo APOLITO, in Pietro CLEMENTE (a cura di), Professione antropologo, op. cit., p. 34.
300 Vincenzo PADIGLIONE, Ritratto da etnografo, in id. (a cura di) Tra casa e bottega. Passioni da etnografo, Roma, Kappa,
pp. 7-19, citazione tratta da pp. 13-14.
[79]
in modo intuitvo»301.
Anche di formazione si è parlato nell'incontro senese. Uno degli auspici espressi da
Cirese302 a margine del seminario è stato esaudito pochi anni oro sono, con la isttuzione delle
Scuole di specializzazione 303 in antropologia dedicate in partcolare al settore dei beni e del
patrimonio. Il processo che ha portato alla loro creazione merita di essere visto più da vicino,
dato che investe direttamente il problema del riconoscimento del proflo scientfco di questo
specialista da parte degli organi dello Stato.
Sul fnire degli anni Novanta la situazione del mondo delle professioni antropologiche
inizia a dare segni di promettent e signifcatve evoluzioni. Con il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
lo Stato riconosce per la prima volta la specifcità dei beni demoetnoantropologici e li inserisce
nel novero dei beni culturali 304. Nasce in conseguenza di ciò l'esigenza di avere personale
specifcamente formato nell'ambito del riconoscimento, tutela e mediazione del patrimonio
DEA. In contemporanea, il D.M. 509 305 del 3 novembre 1999 avvia una ridefnizione dei
percorsi accademici di studio che porta alla confgurazione di un «sufficientemente ampio [...]
quadro delle opzioni per ora oferte a chi voglia acquisire competenze che, innervandosi su
nozioni antropologiche di base, spazino dalle metodologie della ricerca sul campo alle tecniche
di documentazione e classifcazione ai principi della didatca e della comunicazione in ambito
museale, oltre che alle pratche di allestmento e ai criteri di gestone di musei e centri di
documentazione»306. Il tutto in attesa dell'atvazione di ulteriori livelli di formazione superiore
(soprattutto le Scuole di specializzazione). Nonostante gli entusiasmi suscitat dal tanto atteso
301 Ibid, p. 18.
302 Alberto Mario CIRESE, Le discipline umanistiche: l'antropologia, in CLEMENTE (a cura di), Professione antropologo, op.
cit., p. 84. Il breve scritto di Cirese merita attenzione anche perché in un passaggio del medesimo trova ulteriore
conferma quanto affermato nel paragrafo 2.1, quello relativo al lavoro del direttore quale “interprete” del
patrimonio custodito all'interno del museo. Scrive Cirese: «l'esigenza di operatori qualificati è palese. Ma sembra
anche evidente la necessità di una preparazione specialistica in qualche modo a sé. [...] La differenza tra una
angolatura archeologica, poniamo, ed una demologica, sta nell'ottica con cui si compie l'operazione di
contestualizzazione e valutazione dell'oggetto che non nella strumentazione materiale e concettuale del
rilevamento» (loc. cit.) cioè, come visto in Oggetti, segni, musei, dell'operazione di prelievo dell'oggetto-documento dal
proprio contesto di uso-giacenza.
303 La prima ad essere stata istituita è stata quella che ha visto consorziarsi le università di Perugia, Siena e Firenze con
sede a Castiglione del Lago (Pg) e che è partita nell'a.a. 2009/2010. Nell'a.a. 2011/2012 presso “La Sapienza”
Università di Roma ne è stata attivata un'altra.
304 Cfr. Ferdinando MIRIZZI, Patrimoni demoetnoantropologici e formazione universitaria, AM-Antropologia Museale, anno 1,
numero 1, maggio 2002, pp. 42-43. Cfr. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59" art. 148. Sul tema della formazione universitaria cfr. anche Silvia DELL'ORSO, Altro che musei. La
questione dei beni culturali in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2002 e in particolare il cap. 3 Protagonisti vecchi e nuovi.
305 Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei.
306 Ferdinando MIRIZZI, Patrimoni demoetnoantropologici e formazione universitaria, op. cit., p. 43.
[80]
riconoscimento statale dei beni DEA, la situazione in prima battuta risulta ancora incerta sotto
molt aspet. Tanto per fare un esempio, il Testo Unico sulla tutela 307 (L. 490/1999) lascia
presagire la possibilità della libera alienazione dei beni demoetnoantropologici (non risultando
quest tra quelli sogget a forme di restrizione riguardant la loro commercializzazione) 308.
Inoltre, fort dubbi provengono anche dal mondo degli addet ai lavori in merito alla gestone
di quest beni e al tema collegato delle professionalità.
Ulteriori sviluppi rimandano al 1998, con la riforma del Ministero per i Beni Ambientali
e Culturali e la sua trasformazione in Ministero per i Beni e le Atvità Culturali. In questo
contesto viene approvato un Regolamento che assegna alla Direzione Generale per il
Patrimonio Storico e Artstco competenze anche su quello Demoetnoantropologico, con
conseguente ampliamento dello spettro di beni sottopost agli organi periferici, le
Soprintendenze, la cui denominazione a partre da quel momento inizia a comprendere
accanto ai beni storici e artstci anche quelli demoetnoantropologici. Il tutto senza prevedere
alcuna forma di reclutamento di specialist competent per materia 309, specialist di fatto
inesistent sul piano burocratco a causa della mancato riconoscimento del loro peculiare
proflo disciplinare. Proflo che per la prima volta viene riconosciuto nel 2006 310 ai funzionari
già in forze all'amministrazione (presso il MNATP o presso il Museo Pigorini) anche se quest
rimangono inserit nel ruolo degli storici dell'arte (i primi) o degli archeologi (i secondi). Sul
fronte della formazione, la legge 23 febbraio 2000 n. 29, all'art 6. apre al strada alla isttuzione
di Scuole di specializzazione nel settore dei beni culturali (tra le quali, dunque, anche quelle di
tpo DEA); Scuole che consentono di avviare la formazione di antropologi destnat a ricoprire
posizioni presso la pubblica amministrazione 311 con il compito di svolgere atvità di
«individuazione, tutela, conservazione, restauro, gestone e valorizzazione del patrimonio
DEA»312. Il conseguimento del ttolo di ”specialista”, infat, rappresenta il requisito
307 Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali,
a
norma
dell'articolo
1
della
legge
8
ottobre,
n.
352"
pubblicato
nella
Gazzetta Uffciale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 229.
308 Cfr. Luciana MARIOTTI, Patrimonio e infrastrutture: due s.p.a. per i beni culturali, «AM-Antropologia Museale», anno 1,
numero 3, inverno 2002-2003, pp. 68-71 in particolare p 68.
309 Cfr. Vito LATTANZI, Beni culturali: lo stato delle cose, «AM-Antropologia Museale», anno 5, numero 16, estate 2007,
p. 5.
310 Vito LATTANZI e Luciana MARIOTTI, Questioni di proflo professionale, «AM-Antropologia Museale», anno 8,
numero 23/24, autunno-inverno 2009, p. 96.
311 Luciana MARIOTTI, Una scuola di specializzazione desiderata, «AM-Antropologia museale», anno 2, numero 4, estate
2003, pp. 45-46.
312 Ibid., p. 45.
[81]
fondamentale per rendere conforme il percorso formatvo degli antropologi al proflo
scientfco previsto dal Ministero e per accedere, al pari di quanto accade per storici dell'arte
ed archeologi, alle posizioni previste all'interno degli organi del MIBAC (quali ad esempio le
Soprintendenze). Il passaggio mancante, in questo percorso, per giungere a compimento del
processo che consente l'accesso degli antropologi all'interno dell'amministrazione dello Stato
è l'isttuzione del ruolo, vale a dire l'individuazione esatta delle posizioni da chiamare a
ricoprire nell'organigramma del Ministero e delle sue propaggini. Ma non si deve pensare che
tutto in quest anni sia proceduto in maniera lineare; tutt'altro. Il cammino è stato ondivago,
fatto di passi avant e retromarce clamorose. Nel 2007 le soprintendenze «mancano ancora di
fgure professionali organiche»313, mentre il decreto che nel 2008 isttuisce l'ICDEA, art. 3
comma 2, riconosce in quello di storico dell'arte il proflo adeguato ad assumere la direzione
della neonata struttura. A inizio 2010, dopo aver difeso il proflo del demoetnoantropologo
dall'assorbimento in quello di storico dell'arte – la qual cosa avrebbe signifcato un grave passo
indietro rispetto alle conquiste nel frattempo ottenute – si è presentato il rischio di vedere il
medesimo fuso, non si sa sulla base di quale criterio logico e scientfco, con quello degli
antropologi fsici. A seguito di ulteriori battaglie, che hanno visto schierarsi in prima linea le
associazioni scientfche (SIMBDEA, ANUAC, AISEA) si è arrivat alla defnitva ratfca da parte
del MIBAC del proflo professionale demoetnoantorpologico 314, inserito tra quelli della III area
funzionale “Servizi tecnico-scientfci per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la
fruzione del patrimonio”315. Per quanto riguarda l'isttuzione dei ruoli, e quindi l'individuazione
del possibile collocament degli antropologi nell'organigramma del Ministero, al momento –
vista anche la partcolare congiuntura economica – non ci sono novità di rilievo.
Da quanto riportato sopra emerge chiaramente le difficoltà che gli antropologi hanno
incontrato per afermare la loro posizione sul versante statale e nazionale dei beni culturali.
Ma a livello locale le difficoltà che questa comunità ha incontrato e vive tutt'ora non sono
minori. Non sono pochi i musei di ente locale (musei civici) che sono diret da personale non
adeguatamente qualifcato, con grave pregiudizio del ruolo culturale e sociale che gli isttut
dovrebbero svolgere. Se regioni come il Lazio hanno legiferato in materia di valorizzazione in
maniera tale da, se non obbligare, almeno incentvare i comuni a dotare i musei di direttori
313 Vito LATTANZI, Beni culturali: lo stato delle cose, op. cit., p. 5.
314 Vito LATTANZI, Finalmente ratifcato il proflo professionale del demoetnoantropologo, AM, anno 9, speciale 2010, p. LVIII.
315 Http://online.cisl.it/beniculturali/I0DB259AD.2/all.2.pdf .
[82]
con laurea atnente al tpo di museo, altre 316 non si sono ancora mosse in questa direzione.
Oppure, ed è il caso di quanto sta accadendo in Toscana 317, hanno addirittura compiuto – o
rischiano di farlo – clamorosi passi indietro.
2.6 TERRENI INCERTI
Per avviare a conclusione questo capitolo e creare contemporaneamente una
connessione con i prossimi due, dedicat – specie il quarto – alla pratca della direzione, rilevo
che esiste uno scollamento non irrilevante tra la teoria e la pratca nella direzione dei musei
etnografci di proprietà comunale (in partcolare mi riferisco a quelli laziali). Uno iato tra quelle
che sono le condizioni di lavoro che i direttori vivono e quanto gli stessi apprendono dalle
riviste di museologia dalla letteratura specialistca: document dai contenut saldamente
fondat sul piano scientfco ed etco ma che però trovano difficoltà di applicazione nella
pratca professionale. Difficoltà le cui cause afondano in terreni diversi e che sono ascrivibili –
senza necessariamente trare in ballo la catva volontà dei singoli – in parte alla mancanza di
risorse economiche, in parte alla scala dei contest entro i quali i musei si trovano (piccoli
paesi, lontani dai circuit di maggior richiamo), in parte dall'ordinamento legislatvo.
Consideriamo quest'ultmo punto in relazione alla situazione del così detto museo-ufficio, cioè
quel tpo di museo “pubblico o privato – che essendo parte di una struttura più ampia, ne
dipende gerarchicamente e il cui ordinamento interno corrisponde a quello dell'ente di
appartenenza, di cui esso costtuisce una semplice artcolazione»318, che poi è la situazione
tpica del museo civico gestto in forma diretta 319. Quando «il direttore di museo civico non ha
316 Anna Maria VISSER TRAVAGLI sostiene che, in merito alle normative che regolano il funzionamento dei musei,
specie per quanto riguarda l'aspetto delle professioni museali, le regioni si sono mosse in ordine sparso: «Nelle
regioni settentrionali, dove c'è la maggior concentrazione di musei civici, con istituti di grande rilievo nella maggior
parte delle città, la direzione museale ha un profilo specifico e una tradizione storica. Invece in regioni del centro e
del sud, con le dovute eccezioni, dove minore è il numero dei musei degli enti locali, e in ogni caso nelle zone
decentrate de paese, dove i musei “gravano” su comuni troppo piccoli, la direzione non è attivata e, cosa ancor più
negativa, non è neppur percepita come necessaria da parte delle amministrazioni responsabili», cfr. Chi deve dirigere i
musei? La questione delle professioni, in Fabio DONATO e Anna Maria VISSER TRAVAGLI, La crisi dei musei, op. cit.,
p. 83.
317 La riorganizzazione della Fondazione Musei Senesi prevede la sostituzione dei direttori specialisti con dei manager.
La prima vittima di questa nuova fase è stato Gianfranco Molteni, direttore del Museo della mezzadria di
Buonconvento e di altri piccoli istituti. La vicenda è all'ordine del giorno delle associazioni di settore e non è
possibile al momento prevedere sviluppi definitivi.
318 Daniele JALLA, Il museo contemporaneo, op. cit., p. 27 e cap. 1.2.
319 Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio «la gestione diretta è svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finaniaria e
contabile, e provviste di idoneo personale tecnico», art. 115.
[83]
alcun controllo sulla spesa del personale e non conosce i cost “mut” del proprio isttuto (ad
esempio le spese per l'energia, il il telefono, l'informatca eccetera)»320, come può improntare
il funzionamento dell'isttuto che gli è stato affidato a principi di sostenibilità economica? E
soprattutto: come è possibile valutare i merit e le responsabilità del direttore di fronte alla
comunità cui appartene il museo se il suo è un potere limitatssimo? Il direttore di un museo
comunale, allo stato attuale delle cose, può soltanto esercitare forme di persuasione verso la
propria amministrazione di riferimento. Ogni atto amministratvo che un direttore promuove,
dall'invio di una richiesta di contributo all'impegno di spesa per l'utlizzo di un fnanziamento
ricevuto, passa attraverso il parere vincolante di un sindaco che può frmare o anche non farlo;
passa attraverso le deliberazioni di una giunta comunale (democratcamente espressa da una
comunità) che può – legitmamente – tanto accogliere gli indirizzi propost dal direttore
quanto rigettarli. A questo quadro va aggiunta la totale assenza di potere negoziale del
direttore, che essendo il più delle volte legato all'amministrazione da contrat estremamente
fragili, di certo non riesce ad avere la forza necessaria per esercitare pressione sui politci
locali. Questo fa sì che divent veramente difficile la corretta valutazione della performance
professionale prodotta dal direttore, valutare – cioè – l'efficacia del lavoro che questo ha
svolto. Senza contare gli efet che la sostanziale deresponsabilizzazione provoca in termini di
impegno e di entusiasmo profuso nel lavoro.
Sotto questo punto di vista, e in relazione a quanto scritto poco sopra, può essere
interessante rifettere su quella che è la possibilità che alcuni important document redat allo
scopo di migliorare il servizio dei musei vengano recepit dalle amministrazioni responsabili dei
musei. È il caso della Carta Nazionale delle Professioni Museali e del Manuale Europeo della
Professioni Museali; dichiarazioni di principio destnate a rimanere tali. La loro importanza
risiede nel fatto che una volta redat, quest strument, diventano suscetbili di orientare
future scelte, di suggerire soluzioni a problemi, ma difficilmente riescono a svolgere altra
funzione. È difficile che una amministrazione comunale sia disposta a recepire con atto
ufficiale un documento del genere. A volte part di queste dichiarazioni vengono fatte entrare
dai direttori, quasi clandestnamente, nei Regolament che i musei si dànno, ma è una
soluzione di ripiego che apre questoni piuttosto delicate di correttezza ed etca professionale.
Le migliori pratche di direzione che la letteratura presenta, così come tutte le forme di
320 Alessandra MOTTOLA MOLFINO e Cristiana MORIGI GOVI, Lavorare nei musei, op. cit., p. 77.
[84]
partecipazione della comunità locale alla vita ed alle atvità del museo, si scontrano con le
difficoltà oggetve di applicazione nelle quali i piccoli musei civici incappano, specie quelli
etnografci, così portat per propria natura a uscire fuori dalle mura dei loro contenitori e a
porsi come centri di incontro, discussione, confronto con realtà culturali altre, e dunque ad
essere vivaci ed efervescent.
Altro aspetto che non può essere taciuto è quello delle modalità di incarico di direttori, i
quali normalmente sono legat alle rispetve amministrazioni tramite contrat a progetto della
durata annuale. Convenzioni che anche quando vengono rinnovate non danno comunque la
possibilità di mettere in campo progettualità di lungo periodo. La conseguenza immediata è la
programmazione di iniziatve che richiedono uno sforzo organizzatvo limitato, il tutto a
detrimento di proget spesso validi e di idee di alto livello.
Insomma, terreni precari, fragili, sul piano normatvo ed economico, generano pratche
incerte o quantomeno deboli.
[85]
3. VOCI DAL CAMPO
Particolare scandalo hanno in effetti suscitato alcuni
studi «etnografici» che, invece di interessarsi a culture
«primitive» o, eventualmente, di settori marginali delle
società occidentali, hanno osato rivolgere la loro
attenzione alla «tribù degli scienziati, come se fosse un
sistema sociale qualsiasi, come ad esempio una tribù
di cacciatori e raccoglitori o un villaggio di pescatori »321.
3.1 INTERVISTARE ANTROPOLOGI DIRETTORI
La fase preliminare alla stesura di questo dossier mi ha visto impegnato nella
realizzazione di alcune interviste con colleghi direttori di museo. Tutte, tranne una, hanno
avuto come interlocutore un direttore di museo etnografco 322. L'eccezione è rappresentata da
quella che ha visto coinvolto un archeologo 323. La scelta delle persone da intervistare è stata
orientata da valutazioni aferent piani diversi. Il criterio dell'esperienza è stato quello
determinante. Inoltre ho pensato di chiamare in causa fgure legate a diverse tpologie di
isttuto, dal museo di piccolissime dimensioni fno ad arrivare ad organismi più complessi ed
artcolat, pur rimanendo sempre nell'ambito dei musei locali. Infne, ho dovuto fare i cont con
alcune considerazioni di tpo pratco legate alla possibilità concreta di contattare e raggiungere
con facilità i prescelt. Ho coinvolto in questa ricerca antropologi, o comunque direttori, ai
quali sono legato dalla comune appartenenza alla Società Italiana per la Museografa e i Beni
DemoEtnoAntropologici, dalla frequentazione di luoghi e occasioni comuni di incontro e
discussione, ma anche da vincoli di reciproca stma contrat durante il mio percorso
formatvo, da pregressi rapport lavoratvi nonché dalla condivisione di contest lavoratvi. Mi è
sembrato utle muovermi in questa direzione, scegliere portatori di esperienze diverse e a loro
modo esemplari, per verifcare se – ed eventualmente capire in quale misura – il mestere del
direttore di museo etnografco risente del contesto all'interno del quale chi lo pratca è calato;
per capire come questa atvità trova declinazione partcolare in funzione dello specifco
scenario isttuzionale e culturale all'interno del quale essa trova occasione d'esercizio. Anche
321 Mario BUNGE, A Critical Examination of the New Sociology of Science, in «Philosophy of the Social Sciences», Part I,
XXI, pp. 524-560, p. 551, citato in Luca GUZZETTI, L'etnografa del laboratorio scientifco, in Alessandro DAL LAGO
e Rocco DE BIASI (a cura di), Un certo sguardo. Introduzione all'etnografa sociale, Roma-Bari. Laterza, 2002, pp. 57-80,
p. 62.
322 Giovanni KEZICH, Gianfranco MOLTENI, Vincenzo PADIGLIONE, Antonio RICCIO e Mario TURCI.
323 Pietro TAMBURINI.
[86]
altri interrogatvi mi hanno guidato in questa fase; essi hanno rappresentato una sorta di
tracciato che mi è servito per conoscere il modo in cui alcuni colleghi, con più anni di atvità
alle spalle e maggiore esperienza, interpretano la propria professione, il modo in cui la
pensano e la rappresentano.
In che misura la specializzazione disciplinare di un museo rende diferente, segna o
condiziona l’operare del suo direttore? Che diferenza c’è tra dirigere un museo archeologico e
uno etnografco? In quale modo un direttore di museo etnografco è partcolare? Cosa può
fare uno specialista delle discipline DEA alla guida di un museo che un’altra fgura non sarebbe
in grado di portare a termine? E ancora: chi oggi dirige isttut DEA, tramite quale percorso è
arrivato a rivestre quell'incarico? Altro aspetto della questone da valutare in relazione alla
fgura del direttore è quello che riguarda le dimensioni del museo e la sua natura giuridica. Che
diferenza c’è tra dirigere una grande struttura, grande non solo nella superfcie espositva ma
complessa nella sua artcolazione, dotata di servizi diversi e organizzat (didatca,
catalogazione, ricerca), da un piccolo museo (quale la maggior parte dei musei etnografci
italiani è)? In che modo cambia – se cambia – il lavoro del direttore all’interno dei due diversi
contest? Utlizzando queste domande come delle “sonde” ho inteso mettere il naso,
curiosare, nella cassetta degli attrezzi 324 di alcuni direttori; conoscere l'armamentario
concettuale al quale essi si appoggiano per orientare le proprie azioni, ma anche le pratche
che essi mettono in campo per svolgere il proprio lavoro. Altre domande avrei potuto inserire
all'interno della scaletta di massima predisposta per condurre l'intervista. Non ho chiesto ai
direttori, o l'ho fatto indirettamente, quali aspet del loro lavoro ritengono essere più
interessant, più stmolant o delle vere seccature; non ho chiesto loro di illustrarmi un
esempio di quella che considerano essere una buona pratca nella direzione. Interessante
avrebbe potuto essere sapere come si svolge una giornata “tpo” del direttore di museo. Tutte
domande la cui risposta avrebbe potuto rimandare ad altri temi important ed aprire
interessant squarci sulla realtà indagata, ma che sono sorte a posteriori rispetto allo
svolgimento delle interviste e che quindi non ho avuto modo di porre. Non è detto che in
futuro, qualora il dossier dovesse avere un esito ulteriore, non possa tornare sul campo ad
approfondire alcune questoni non adeguatamente afrontate.
324 Piego alle mie esigenze la metafora del bricoleur messa a punto da Claude LÉVI-STRAUSS ne Il pensiero selvaggio,
Milano, Il Saggiatore, 1964. Cfr. anche Marco AIME, Sarà poi davvero un mestiere? In Marc AUGÉ, Il mestiere
dell'antropologo, Torino, Boringhieri, 2001, 2007, p. 44.
[87]
Lo strumento di indagine tpico dell'etnografa, l'intervista, in questo caso ha trovato un
campo di esercizio, non dico inusuale, ma che comunque ha reso necessaria – in fase
applicazione, e ancor di più in fase di analisi – una partcolare sorveglianza critca. Il fatto è che
oltre ad essere colleghi direttori di museo, gli interlocutori ai quali mi sono rivolto sono tut –
tranne nel caso di Pietro Tamburini caso – a loro volta etnograf (o comunque antropologi).
Questo dettaglio mi è stato chiaro fn da subito, eppure soltanto giunto alla fne della – seppur
concentrata e, per cert versi, circoscritta – ricerca sul campo, nel momento della rilettura a
freddo del materiale prodotto, la portata di questa circostanza mi si è fatta evidente con tutto
il suo carico di implicazioni. Condividere con gli intervistat un comune orizzonte scientfco ha
determinato una evidente immediatezza nel dialogo. Questo si è tradotto, ad esempio, nella
necessità di illustrare ai direttori il perché di una intervista su determinat temi senza tuttavia
dover spiegare loro il senso stesso dell'utlizzo di un simile strumento di indagine; nel dare per
scontat alcuni passaggi come l'autorizzazione a registrare la conversazione; nel non aver
dovuto negoziare in modo partcolare l'accesso al campo 325. Una spontaneità che, a rifetterci
sopra rileggendo la sbobinatura, non ha giovato alla ricerca. Quello che è accaduto, infat, è
stato che partendo dal presupposto della comune appartenenza disciplinare e della
condivisione di una serie di riferiment teorici, non ho sentto sul momento l'esigenza di
problematzzare il signifcato di concet, di alcune parole chiave quali museologia,
museografa, allestimento e museo (tanto per fare un esempio), che abbiamo utlizzato nella
conversazione dando il più delle volte per condiviso e scontato il loro senso. Il tutto,
inevitabilmente, con esit assai poco rifessivi. Cerco di supplire a questa carenza nella sezione
successiva, la 4, dedicata alla lettura critca dei contenut delle interviste. Interviste e
trascrizioni che non considero delle pure e semplici «“prove” incontrovertbili»326 di cosa
signifchi fare il direttore, delle incombenze che questa professione comport, ma come
«“tracce” che in qualità di ricercatore sono stato chiamato «a seguire [...] al fne di costruire la
più vasta “provincia fnita di signifcato”»327.
Il mio posizionamento, rispetto al contesto che mi sono trovato ad attraversare, è stato
non tanto quello dello «straniero interno»328 – la posizione che il più delle volte l'etnografo as325
326
327
328
Cfr. Andra COZZO, La tribù degli antichisti. Un'etnografa ad opera di un suo membro, Roma, Carocci, 2006, p. 29.
Attila BRUNI, Lo studio etnografco delle organizzazioni, Roma, Carocci, 2003, p. 41.
Loc. cit..
Vincenzo PADIGLIONE, Dietro lo sguardo, in id. (a cura di), Tra casa e bottega. Passioni da etnografo, Roma, Kappa,
[88]
sume – , quanto piuttosto quella di chi straniero non è, perché interno al mondo che studia, e
deve cercare di rendersi tale. Trovarmi nella condizione di «uno-tra-gli-altri»329 mi ha obbligato
ad imprimere alla mia postura e al mio sguardo una torsione tale da consentrmi di
guadagnare rispetto all'oggetto di studio quella distanza che rende possibile la
defamiliarizzazione dell'esperienza, un modo per «rivedere il proprio operato e arricchire la
scena di dettagli oscurat, tramite altre voci e con altri occhi»330. In questa ricerca sono stato
un «osservatore inscindibile dal sistema osservato»331 almeno in due diverse accezioni, a due
livelli: non solo come appartenente alla medesima cultura, vale a dire al medesimo spazio
tempo, alla medesima temperie storica degli intervistat, alla rete di signifcat 332 che con gli
uomini miei contemporanei condivido, ma anche in quanto collega antropologo e collega
direttore.
La stretta vicinanza con i miei interlocutori, per altri versi, mi ha messo nella condizione
di indirizzare le interviste in modo tale da toccare il terreno dove stazionano «quegli aspet
della propria appartenenza culturale che risulta difficile condividere sulla scena pubblica»333 e
che sono ricompresi sotto la nozione di intimità culturale334. Pensata come strumento
concettuale per rifettere sulle identtà culturali nazionali, la nozione di intmità culturale
329
330
331
332
333
334
2007, pp. 21-56, citazione tratta da p. 34. Cfr. anche il paragrafo 2 (Posizionamento da straniero interno e alleanza tra
“scissi”) del saggio Assumere la psicologia come oggetto della ricerca etnografca di Vincenzo PADIGLIONE e Alessandra
FASULO contenuto nella stessa raccolta.
Loc. cit.. Vale anche, per questo caso, l'immagine dell'etnografo nativo, cfr. Vincenzo PADIGLIONE e Alessandra
FASULO, Assumere la psicologia come oggetto della ricerca etnografca, in Vincenzo PADIGLIONE (a cura di), Tra casa e
bottega, op. cit., pp. 119-127. La mia è stata la posizione di «un membro effettivo della tribù che cerca di osservare
autorifessivamente i costumi di quest'ultima», parole con cui un grecista, Andrea Cozzo, si è autodefinito
presentando una ricerca etnografica (anche se non condotta da un etnografo stricto sensu è stata realizzata con molta
attenzione e sguardo rifessivo) sulla comunità degli studiosi di filologia greca cfr. id., La tribù degli antichisti, op. cit.,
p. 29.
Vincenzo PADIGLIONE, Marilena FATIGANTE, Sabina GIORGI, Sulla soglia. Costruire la relazione, in Vincenzo
PADIGLIONE e Sabina GIORGI (a cura di), Etnograf in famiglia. Relazioni, luoghi e rifessività, Roma, Kappa, 2010,
p. 47.
Vincenzo PADIGLIONE, Defamiliarizzare l'esperienza. Introduzione alla prospettiva etnografca, in Vincenzo
PADIGLIONE e Sabina GIORGI (a cura di), Etnograf in famiglia, op. cit., p. 16.
Cfr. Clifford GEERTZ, Interpretazione di culture, op. cit..
Vincenzo PADIGLIONE, Marilena FATIGANTE, Il percorso di restituzione. Dalla documentazione al patrimonio, in
Vincenzo PADIGLIONE e Sabina GIORGI (a cura di), Etnograf in famiglia, op. cit., p. 186.
Micheal HERZFELD, Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2003. Scrive a
questo proposito Corrado Ziglio: «in tutti i contesti professionali esistono degli ambiti dei quali ufficialmente non si
parla mai perché, molto spesso, sono imbarazzanti: le invidie professionali, le carriere realizzate attraverso metodi
non proprio ortodossi, le relazioni gerarchiche, le furbizie, i sotterfugi, le drittate ecc.: tutte cose che
apparentemente non sono importanti, ma che in realtà hanno delle ricadute sul proprio operare professionale.
Questi aspetti sotterranei, che possono motivare emotivamente i comportamenti professionali, richiamano ciò che
gli etnografi considerano i “ruoli taciti” che guidano i comportamenti e che consentono una conoscenza culturale
indigena di quel determinato contesto professionale», cfr. id. (a cura di), Etnografa delle professioni. Il caso della Polizia
di Stato, Roma, Armando, 2000, p. 27.
[89]
secondo Herzfeld rimanda a quegli aspet dell'identtà culturale, che qui possiamo considerare
anche in modo lato come “identtà professionale”, «considerat motvi di imbarazzo con gli
estranei, ma che nondimeno garantscono ai membri la certezza di una socialità condivisa»335.
Una occasione, detta altriment, per cercare di far venir fuori, al di là dell'autorappresentazione che ogni direttore ofre del proprio ruolo e della propria posizione, sensazioni, desideri,
impressioni che in contest pubblici sovente vengono censurat. Il criterio al quale ho cercato
quanto più possibile di ancorare la lettura delle interviste è stato quello della «fedeltà
all'interpretazione dei natvi ma non necessariamente alla loro auto-immagine»336. Ho tentato
cioè di comprendere come i direttori vedono, pensano il proprio ruolo e la propria professione
senza tuttavia necessariamente condividere o avallare l'immagine che essi hanno di loro stessi
e trasmettono verso l'esterno.
Le interviste mi sono servite per costruire il mio oggetto di indagine, un oggetto
partcolare, perché quello con cui si trovano a lavorare «gli antropologi non è mai un dato
bruto: semmai è qualcosa che da una parte incorpora le interpretazioni natve, e dall'altra è
costruita ex novo dallo stesso processo di ricerca. Noi antropologi dobbiamo interpretare le
interpretazioni altrui, ovvero utlizzare gli schemi del ricercatore, per tradurre e interpretare gli
schemi concettuali dei natvi»337, dove per natvo va inteso «chiunque, abitando contest
specifci diventa portatore-produttore di valori e signifcat partcolari. Ovvero abbia
riconosciuta una competenza culturale in un dato contesto che vede la presenza dell'etnografo
nel ruolo conoscitvo complementare di colui che vuole apprendere quella competenza,
intende cioè conoscere e tradurre in un altro linguaggio quei signifcat che localmente
vengono mediante simboli espressi»338. Ho dovuto, detto altriment, ascoltare la voce dei
direttori come se mi trovassi di fronte ad una «conoscenza locale»339 classicamente intesa
(“esotca”, o comunque connessa ad uno dei settori usuali della ricerca etnografca). Ciò senza
mai tralasciare la consapevolezza del fatto che, al pari del mondo della scienza e di chi la
pratca340, quello delle professioni è un mondo fatto di «contest, di biografe, di isttuzioni e
335
336
337
338
339
Ibid., p. 19.
Vincenzo PADIGLIONE, Dietro lo sguardo, in id. (a cura di), Tra casa e bottega. Passioni da etnografo, op. cit., p. 27.
Vincenzo PADIGLIONE, Defamiliarizzare l'esperienza. Introduzione alla prospettiva etnografca, op. cit., p. 13.
Vincenzo PADIGLIONE, Dietro lo sguardo, op. cit. pp. 34-35.
Vincenzo PADIGLIONE, Ritratto da etnografo, in Vincenzo PADIGLIONE (a cura di), Tra casa e bottega, op. cit., p.
11.
340 Cfr. Alessandro DAL LAGO e Roberto DE BIASI (a cura di), Un certo sguardo. Introduzione all'etnografa sociale, RomaBari, Laterza, 2002 (in particolare il saggio di Luca GUZZETTI, L'etnografa del laboratorio scientifco, pp. 57-80) e
anche Andrew PICKERING (a cura di), La scienza come pratica e come cultura, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
[90]
comunità (anche quelle scientfche e universitarie sono mondi di appartenenza) e di fatali
relazioni solo in parte riducibili a saperi, e tanto meno a pensieri astrat. All'interno di una
comunità scientfca [quale quella dei direttori è ] esistono poteri, convenzioni che sono anche
essi il prodotto di storie e contest. Quindi le nostre parole stanno dentro queste appartenenze
e noi dobbiamo contnuamente rimetterle in discussione. L'incontro etnografco serve per
tematzzare quel mondo che anche da intellettuali viviamo come scontato»341.
Una cosa importante da dichiarare è che nel realizzare queste interviste sono stato
guidato non solo dalla volontà di realizzare una etnografa del mestere del direttore di museo,
ma anche dal vibrante desiderio di apprendere dalle esperienze e dalle idee altrui, di capire
come alcuni illustri colleghi hanno dato risposte a problemi comuni relatvi alla gestone dei
musei. Dunque ho cercato di sfruttare l'occasione fornitami dalla necessità di produrre un
simile elaborato per apprendere insegnament utli allo svolgimento delle mie mansioni nella
vita lavoratva di tut i giorni.
Sulla base delle possibilità e delle esigenze materiali, alcune interviste le ho potute
fare in maniera tradizionale, faccia a faccia col mio interlocutore. Questo il caso del colloquio
con Gianfranco Molteni, con Vincenzo Padiglione, Antonio Riccio e Pietro Tamburini. Altre,
quella a Mario Turci e quella a Giovanni Kezich sono stato costretto a farle avvalendomi di
espedient tecnologici: via Skype la prima e per posta elettronica la seconda. Quest'ultma è
stata preceduta da colloqui diret avut, in varie occasioni, con il direttore del MUCGT pochi
mesi prima della formalizzazione del testo.
4.1 APPUNTI DI ANTROPOLOGIA DELLE PROFESSIONI
Una prospetva ricca di spunt interpretatvi entro la quale leggere la questone della
direzione dei musei etnografci, e dunque le interviste che seguono, è quella che viene oferta
dall'antropologia delle professioni, un campo in stretta connessione con l'antropologia delle
organizzazioni e con la sociologia del lavoro. La strada che questo indirizzo suggerisce di
percorrere è quella che porta a considerare il lavoro in generale, e dunque anche quello del
341 Ibid., p. 16. Cfr. anche Vincenzo PADIGLIONE e Alessandra FASULO, Assumere la psicologia come oggetto della ricerca
etnografca, in Vincenzo PADIGLIONE (a cura di), Tra casa e bottega, op. cit., pp. 119-127.
[91]
direttore, come un qualcosa che non ha a che fare soltanto con il soddisfacimento di esigenze
primarie, con la necessità di doversi procurare un reddito per vivere. L'invito, piuttosto, è a
prendere in considerazione i gruppi professionali e vedere in essi non il risultato della semplice
«divisione del lavoro, ma l'efetto di più ampi processi sociali, che coinvolgono il potere, il
prestgio e più in generale il ruolo a cui un individuo è chiamato a rispondere all'interno di una
data società. In altre parole, il lavoro […] colloca l'individuo in una posizione che ha un preciso
signifcato sociale, prima ancora che produtvo»342. In questo senso, ad esempio, può essere
molto utle focalizzare i contorni della cultura professionale dei direttori343, valutare cioè il
grado di condivisione, da parte di questa classe di lavoratori, non soltanto di un saper fare, ma
anche di modi di relazione e di atteggiament verso il mondo esterno. Un approccio, quello
scelto, che suggerisce di analizzare le stesse carriere come «non [...] semplicemente una
successione di promozioni e incarichi all'interno di una data professione, ma un percorso di
apprendimento e partecipazione alla culture e alle pratche sociali condivise da un gruppo»344.
«L'etnografo delle professioni» è un ricercatore che «si trova di fronte a tante abitudini, codici,
linguaggi, che […] deve imparare a cogliere e interpretare usando una partcolare
attenzione»345. Egli deve indagare i modi in cui le professioni vengono rappresentate da chi le
pratca, nonché le scatole degli attrezzi a cui gli attori sul campo ricorrono, e questo non per
vagliare l'utlità o la validità tecnica degli “arnesi” in esse contenut, ma considerando i medesimi al
pari di «credenze che funzionano o mutano a seconda dei contest storici e geografci, in quanto
credenze che fanno sistema con cert modi di vivere» 346. L'obietvo dell'etnografa delle
professioni, detto in altro modo, non è quello di valutare se uno strumento, un approccio, un
metodo, un certo modo di intendere la propria atvità sia migliore di un altro o più efficace,
quanto piuttosto mettere a fuoco «il regime di verità»347 entro il quale ognuno di quest element
342 Attila BRUNI, Lo studio etnografco delle organizzazioni, op. cit., 17.
343 La prospettiva etnografica adottata in questo dossier vuole indagare «Il modo in cui incorporano saperi,
significano luoghi e persone costruendo la loro identità», in questo caso, di direttori, cfr. Vincenzo PADIGLIONE
e Alessandra FASULO, Assumere la psicologia come oggetto della ricerca etnografca, op. cit., p. 126.
344 Ibid., pp. 18-19. Il caposcuola di questo modo di pensare il lavoro è un sociologo americano, Everett C. Hughes,
che si esprime a proposito in questo modo: «Jobs are not only the accepted evidence that one can “put himself
over”; they also furnish the means the means whereby other things that are significant in life may be procured. But
the career is by non means exhausted in a series of business and professional achievements. There are other point
at which one's life touches the social order, other lines of social accomplishment – infuence, responsibility, and
recognition»; Everett CHERRINGTON HUGHES, Institutional offce and person, in id., Men and Their Work, London,
The Free Press of Glencoe Collier-Macmillan Limited, 1958.
345 Pierre TELLERI, “A volo d'aquila” per scoprire il diffcile lavoro del poliziotto, in Corrado ZIGLIO (a cura di), Etnografa
delle professioni, op. cit., p. 89.
346 Andrea COZZO, La tribù degli antichisti, op. cit., p. 24.
347 Ibid., p. 23.
[92]
acquisisce senso.
Tra le parole chiave da impiegare in questo tpo di indagini c'è la nozione di ruolo così
come questa emerge nel lavoro di Gofman 348. Il sociologo canadese, di questo strumento
concettuale, propone una lettura non totalizzante, lo presenta come una dimensione del
comportamento degli attori sociali che può assumere trat a volte anche plurali e
contraddittori (è possibile che un soggetto assuma su di sé più ruoli a seconda delle
circostanze e dei moment e che quest possano anche essere in confitto tra di loro). È utle
rifettere sul ruolo, perché se da una parte esso «richiede all'individuo di assumere determinat
comportament; dall'altro ognuno di noi nel momento in cui veste un ruolo ha il potere di
interpretarlo diferentemente, e dunque di modifcarlo. Ma fare qualcosa di diverso da ciò che
gli altri si aspettano vuol dire rompere un rituale e obbliga a una nuova negoziazione dei
signifcat e, dunque, all'elaborazione di un nuovo frame in cui inserire la propria azione»349. In
altre parole, interpretare a proprio modo un ruolo, come potrebbe essere quello del direttore,
richiede la proiezione di un modello, del proprio modello, del proprio stile350 di direzione,
all'interno di una partcolare cornice di senso. Così il proprio modo di interpretare il ruolo
assuma coerenza con questa cornice diventa l'oggetto di una possibile etnografa delle
professioni.
Dal mondo della pedagogia, invece, prendo in prestto la nozione di comunità di pratica,
la quale ha trovato ambit di applicazione anche nel mondo della sociologia e più in generale
della comunicazione. Così le defnisce Etenne Wenger: «Communites of practce are formed
by people who engage in a process of collectve learning in a shared domain of human
endeavor: a tribe learning to survive, a band of artsts seeking new forms of expression, a
group of engineers working on similar problems, a clique of pupils defning their identty in the
school, a network of surgeons exploring novel techniques, a gathering of frst-tme managers
helping each other cope. In a nutshell: communites of practce are groups of people who
share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they
interact regularly»351. Il concetto richiama alla mente una idea con la quale gli antropologi
348 Cfr. Erving GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 1969.
349 Attila BRUNI, Lo studio etnografco delle organizzazioni, op. cit., p. 20.
350 Sullo “stile professionale” cfr. Vincenzo PADIGLIONE e Alessandra FASULO, Assumere la psicologia come oggetto della
ricerca etnografca, op. cit., p. 126.
351 Http://www.ewenger.com/theory/index.htm. «Le comunità di pratica, nella definizione “classica” di Wenger,
[93]
hanno familiarità da diversi anni, quella di comunità di interpretazioni o comunità
interpretante, quelle comunità di cui parla Appadurai 352 e che possono essere defnite come
«un gruppo di persone che attribuiscono signifcat simili ai medesimi event, senza
necessariamente presupporre che queste stesse persone si riconoscano come un noi,
condividano un'identtà colletva»353. Lo sforzo immaginatvo che possiamo fare è quello di,
generalizzando ed astraendo per un istante, pensare a quella dei direttori come una comunità
di pratca nella misura in cui essa si confgura come una «aggregazione informale defnita non
solo dai suoi membri, ma dal modo condiviso in cui quest agiscono e interpretano la
realtà»354; di valutare in che misura all'interno di questo gruppo «le relazioni si costruiscono
attorno alle atvità e queste sono frutto di relazioni sociali» 355, quanto «il modo in cui gli attori
agiscono è appreso all'interno di specifche esperienze e diventa parte dell'identtà di chi
partecipa alla comunità»356. Anche sulla base di questo modello può essere immaginato il
gruppo dei direttori di museo etnografco: un insieme di persone che condividono – e di capire
con quali eventuali scostament è compito affidato al capitolo successivo e alle trascrizioni
presentate in appendice – un modo di intendere la professione museale e la relazione
etnografa-museo.
Il tema della formazione professionale, invece, mi sembra che possa essere agganciato
a quello dell'apprendimento situato nella pratica, legato a sua volta a quello più ampio della
partecipazione legitma e periferica. “Apprendimento situato” è una formula che sta ad
indicare il fatto che «l'apprendimento è sempre situato nella pratca e, da un un punto di vista
etnografco, è rintracciabile nell'osservazione delle forme di accoglienza e partecipazione
riservate ai nuovi arrivat»357. La partecipazione periferica deve essere intesa come il primo
step di un processo che porta alla partecipazione legitma, che porta cioè al progressivo
coinvolgimento dei novizi nelle pratche della comunità fno ad arrivare al loro pieno
352
353
354
355
356
357
sono definibili come gruppi di persone che hanno in comune un interesse o una passione per qualche cosa e che in
base a questo interesse interagiscono con una certa regolarità per migliorare il loro modo di agire», Giuditta
ALESSANDRINI, Il costrutto delle comunità di pratica, in id. (a cura di), Comunità di pratica e società della conoscenza,
Roma, Carocci, 22007, p. 32. Il tema delle “comunità di pratiche scientifiche” è toccato anche in Vincenzo
PADIGLIONE e Alessandra FASULO, Assumere la psicologia come oggetto della ricerca etnografca, op. cit., p. 120.
Arjun APPADURAI, Modernità in polvere, op. cit., p. 11.
Vincenzo PADIGLIONE, Dietro lo sguardo, op. cit., p. 27.
Attila BRUNI, Lo studio etnografco delle organizzazioni, op. cit., p. 50.
Loc. cit..
Loc. cit
Loc.cit..
[94]
assorbimento al suo interno. Un coinvolgimento che passa attraverso la conoscenza e la
successiva condivisione di storie, di un gergo partcolare, dell'“etchetta” che normalmente
regola i rapport tra chi è già dentro un determinato universo. In questo senso un buon
contesto di osservazione – da prendere in considerazione come possibile sviluppo di questo
lavoro – potrebbe essere rappresentato proprio dalle dinamiche che si atvano tra direttori
all'interno di SIMBDEA, del DEMOS 358, oppure in contest più eterogenei come quello
rappresentato dall'assemblea dei direttori dei musei civici del Lazio.
Il modo in cui intendo utlizzare i concet e le idee appena sopra esposte è volutamente
di tpo sensibilizzante e non defnitorio, nel senso che tramite di essi non cerco di incastrare la
realtà all'interno di rigidi schemi interpretatvi o di dare conto in modo esaustvo dei fenomeni
osservat, quanto piuttosto di suggerire – a me stesso e al lettore – «direzioni lungo le quali
cercare»359. Il che tra l'altro spiega anche il perché del carattere frammentario con il quale
convoco di volta in volta autori, campi di indagine e teorie.
Prima di proseguire oltre ribadisco che la prospetva entro la quale mi sto muovendo
nella stesura di questo dossier è di più ampio respiro rispetto al quadro di indagine appena
prospettato, e che l'etnografa delle professioni rappresenta un passaggio di un percorso che
spazia tra etnografa e museologia. Questo signifca, e lo dichiaro subito, che non potrò fornire
una esaustva analisi etnografca della professione di direttore ma solo alcuni spunt di
rifessione.
358 Sistema museale antropologico del Lazio.
359 Herbert BLUMER, Symbolic Interactionism: Perspective and Method, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969, pp. 148-149
cit. in Giampietro GOBO, Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografco, Roma, Carocci, 2001, p. 60.
[95]
4. CHI
4.1
LO FA, COME LO FA. PERCORSI, ESPERIENZE, PROSPETTIVE
FORMAZIONE E APPRENDISTATO
Volendo afrontare una lettura del modo in cui la fgura e il ruolo del direttore di museo
etnografco emergono dalle interviste svolte, e avendo facoltà di ordinare il materiale a
disposizione secondo il modo che più mi sembra opportuno, individuo il punto dal quale
iniziare nella questone relatva all'acquisizione del sapere necessario a svolgere questa
partcolare atvità.
«Io non ho imparato, ho rubato con gli occhi, dalle mail, leggendo i programmi di colleghi che sono
più qualifcat di me. Dico per tut Mario Turci, Gianfranco Molteni».
In questo modo Vincenzo Padiglione sintetzza il percorso che lo ha portato a dirigere il primo
museo etnografco che egli stesso ha progettato. Questo dell'apprendimento “sul campo”,
osservando gli altri al lavoro, è un luogo comune che torna nelle testmonianze di –
pratcamente – tut i direttori che ho ascoltato; non soltanto – come ci si potrebbe aspettare –
in quelle degli antropologi, ma anche nell'esposizione dell'archeologo Pietro Tamburini:
«Il lavoro del museologo in Italia è un po’ come quello del genitore. Il lavoro del genitore è un
lavoro difficilissimo, da svolgere nel migliore dei modi. Viene pratcato da quanto è nato l’uomo ma
con gli esit più diversi. Lo vediamo soprattutto oggi, che le notzie circolano rapidamente. Il
genitore... chi t insegna a farlo? […] Come il genitore non ha preventvamente un corso che gli
insegni a farlo, il direttore di museo non ha un corso che gli insegni a farlo. Non l’ha mai avuto. Non
esiste una facoltà di museologia e di museografa in Italia, esistono solo degli insegnament, che
normalmente quando uno va a vedere da vicino si rende conto che non sono quello che dichiara il
ttolo. […] Quello che manca fondamentalmente è una preparazione preliminare allo svolgimento di
questo tpo di atvità. Uno si laurea e viene buttato allo sbaraglio alla direzione di un museo».
Stupisce non poco questa testmonianza interna ad un mondo, quello dell'archeologia, che –
almeno dall'esterno – viene percepito come un settore con alle spalle una tradizione di
museografa più solida rispetto al mondo dell'antropologia. Un apprendimento, quello situato
nella pratca, che rimanda ad una sostanziale assenza – almeno nel passato – di corsi organici e
strutturat di studio di indirizzo museologico e museografco. Eppure l'apprendimento diretto
del mestere si presenta come una prassi consolidata che sembra mantenere ancora una oggi
[96]
una sua validità, nonostante l'atvazione di alcuni corsi di studio che vanno proprio in quella
direzione360. L'apprendistato sul campo, aferma Mario Turci
«è stata la regola per il passato beh, adesso ci sono dei corsi, ci sono dei master, dove un po’ t
insegnano a gestre gli isttut; quando ho cominciato io non c’era nulla, non c’era una scuola come
c’è in Francia. Adesso ci sono, ormai da anni, master di management dei beni culturali,
pubblicazioni. Però a fare il direttore lo impari sul campo, ecco, assolutamente».
L'aspetto che fa del mestere del direttore un qualcosa che – al di là della formazione
teorica – si deve imparare sul campo, che per essere appresa necessita di un attento trocinio
sul campo, ha a che fare con la complessità della macchina museale, con il fatto che sono
molteplici le incombenze – alcune anche di natura meramente pratca e routnaria – alle quali
un direttore deve necessariamente saper far fronte (direttamente o delegando, ma avendo
comunque cognizione del da farsi). Questo è testmoniato dalle parole dello stesso Turci, il
quale aferma:
«io penso che il lavoro di direttore sia tra quei lavori che comportano la capacità di esser
preoccupato, giusto per volgarizzare, dal fatto che nei bagni ci sia la carta igienica e che gli standard
dei bagni siano di qualità, fno a saper gestre un gruppo di ricercatori. Io devo dar delle risposte sul
restauro, per esempio. Ma non sono un restauratore. Devo sapere come si restaura, come ci si
comporta… Il lavoro del direttore ha uno spettro amplissimo di intervento. Deve sapere tanto».
E per “sapere tanto” non occorre soltanto aver conseguito prestgiosi ttoli, ma è
indispensabile aver maturato esperienze dirette. Anche perché, rispetto a determinat ambit
di atvità, come potrebbe la sfera del rapporto con gli stakeholder, è solo tramite la pratca e
l'esperienza diretta che è possibile acquisire competenze e abilità, capacità relazionali,
attudini al dialogo.
Una solida esperienza sul campo è – per l'accesso all'incarico – quanto prescrivono, o
almeno suggeriscono, tanto la Carta delle Professioni Museali quanto il Manuale per l'accesso
alla direzione. La prima auspica che il candidato direttore abbia alle spalle una «esperienza
pluriennale in ambito museale pubblico o privato o in isttut affini», il secondo parla di una
«esperienza pluriennale in un museo o in un’isttuzione pubblica o privata similare». La
necessità di mettere nel conto della formazione questo forte contatto con il campo scaturisce
360 Vedi per esempio l'attivazione di ben due scuole di specializzazione in beni DEA attivate di recente la prima presso
l'Università di Perugia e la seconda presso l'Università di Roma.
[97]
dal fatto che ogni singolo isttuto ha una sua fsionomia partcolare, è un fenotpo – rimaniamo
al caso dei musei aferent il medesimo ambito disciplinare – la cui specifcità è data dal
sovrapporsi e dall'intrecciarsi di più fattori tra i quali determinat asset amministratvi e
organizzatvi, le dimensioni della struttura, il contesto all'interno del quale ogni singolo isttuto
è calato. E l'unico modo per capire come, in ogni singolo caso, le varie dimensioni sopra
richiamate si intrecciano è fare esperienza diretta del museo. La pratca di campo può essere
una otma palestra per prendere coscienza del fatto che quanto di condiviso ci può essere
nella formazione di un professionista di museo (la museologia teorica) va poi declinato in un
contesto (sia disciplinare, sia isttuzionale e spazio/temporale) partcolare (museologia di
campo, o militante).
Nella formazione degli aspirant direttori, il peso che gli intervistat attribuiscono alla
dimensione pratco-operatva della preparazione rispetto a quella teorico-speculatva è
diverso. A determinare il rapporto tra le quanttà intervengono fattori che sembrano
rimandare al posizionamento degli stessi. Chi lavora in maniera esclusiva o preponderante nei
musei, ed è quindi abituato ad afrontare direttamente problemi di natura contngente, spinge
di più nel senso di una formazione – diciamo – orientata al pratco, al concreto; mentre i
direttori che operano anche in campo accademico, invece, tendono a rivendicare ed
enfatzzare l'importanza della solida formazione di tpo teorico. Secondo Molteni, per
esempio,
«una parte della museografa italiana è una museografa che è al di fuori dei musei. Intendimi bene.
Mi va benissimo, molto spesso possono avere delle idee, degli stmoli notevoli, però se io devo
pensare, se devo suggerire un percorso a un giovane, gli direi “fai uno stage presso un museo che
viene costruito, impara cosa signifca integrare l’elettricista col muratore, coordinare i tempi in
modo da…”: questo iter permette, un domani, di conoscere il museo e, secondariamente, di capire
l’integrazione tra i vari aspet che lo compongono. [...] Oggi come oggi bisognerebbe iniziare a
pensare a far fare degli stage ai giovani proprio partendo dagli allestment, ma con un occhio anche
alla gestone».
Ci si legge un invito rivolto agli aspirant direttori a “sporcarsi le mani” in modo diretto nei
musei, ma anche una critca velata rivolta verso una dimensione esclusivamente teorica del
pensare e fare i musei, verso quelli che Mario Turci defnisce i «direttori artstci». È questa la
visione di chi pratca una museologia, chiamiamola militante, sul campo; di chi i musei li ha
progettat, ne ha seguito l'allestmento e ne conserva la direzione.
[98]
Sul versante di chi invece è più vicino al mondo della ricerca, e considera in maniera più
spinta i musei come una occasione di sperimentazione di linguaggi e di traduzione delle
etnografe non in test ma in allestment sensibili, l'attenzione è rivolta verso la necessità di
una solida formazione di tpo etnografco e prettamente atnente alle esigenze di tpo
comunicatvo del museo. Padiglione ritene che il luogo fondamentale di plasmazione di un
direttore sia
«dentro una scuola e dentro una formazione specifca: l’antropologia deve essere intesa come uno
strumento forte e non annacquato. Poi nei trocini che insegnano non soltanto la gestone ma
anche la composizione museale. Per poter fare il direttore è necessario conoscere il mestere del
montaggio video per esempio. Se fai il direttore e non sai di didatca dell’esperienza, se non sai di
montaggio video, se non sai di font orali, se non sai di composizione museale, se non hai fatto
contnua esperienza e se non t sei messo a fare i cont su come fare i proget, su come gestre un
progetto e su come fare dei rendicont... Quest sono i tant mesteri che uno deve conoscere, e
deve conoscerli per poter richiedere qualità ai suoi collaboratori, per richiedere un rigore. Un
aspirante direttore deve essere un grande curioso del settore dei linguaggi antropologici».
Questa testmonianza ofre l'occasione per ribadire ed esplicitare un aspetto – cruciale – della
formazione e del proflo dei direttori. Nel capitolo 2 si è insistto sulla necessità che a dirigere
un museo etnografco sia chiamato un demoetnoantropologo, un soggetto cioè che abbia
avuto una formazione nel campo – fondamentalmente – dell'etnografa e dell'antropologia
culturale. Inoltre si è detto dell'importanza per un direttore di avere nozioni di management,
di possedere competenze da potere mettere a valore nella gestone di tut gli aspet della vita
del museo che richiedono rapport con le amministrazioni responsabili degli isttut, con il
mondo dei fnanziatori, con quello della burocrazia. Ma quello che mi sembra opportuno fare
in questo passaggio è ricordare che di pari importanza rispetto ai primi due ambit, quello
specialistco e quello manageriale, è quello museologico, laddove per museologia si intende
«una scienza sociale, non esclusivamente riferita al campo dell'arte o della critca d'arte, che,
congiunta a un sostrato di conoscenze specialistche o scientfche, cerca di afrontare i
contenut immateriali del museo, obietvi, funzioni, vincoli e potenzialità comunicatve»361. In
questo senso museologo, che nella testmonianza di Pietro Tamburini sosttuisce in maniera
frequente la formula “direttore di museo”, «designa il responsabile scientfco, che conosce la
natura e le vocazioni delle raccolte, i principi e i metodi della loro valorizzazione, che possiede,
grazie a una formazione supplementare, la capacità di elaborare la flosofa del proprio museo
361 Maria Laura TOMEA GAVAZZOLI, Manuale di museologia, op. cit., p. 5.
[99]
e i suoi programmi e che deve curare l'attuazione dei proget connessi» 362. Il direttore deve
non solo saper fornire una lettura del patrimonio che interseca il museo e saper far funzionare
il museo sul piano organizzatvo. Deve anche sapere come tradurre in allestmento dei
concet, deve avere conoscenze nel campo della cultura visuale, deve padroneggiare diversi
codici della comunicazione in modo tale da rendere fruibile ai pubblici del museo i contenut
che esso mette a disposizione.
Antonio Riccio tocca un altro aspetto, un'altra dimensione della formazione, quella
relatva alla necessità per i direttori di avere una preparazione adeguata nel campo della
pubblica amministrazione. Il direttore del Museo della pietra lamenta di non aver avuto
l'opportunità di fruire di una adeguata
«formazione tecnico-burocratca, qualcuno che mi spiegasse come funzionano le leggi, quali e
quante leggi ci sono, altriment uno fnisce con l'essere in balia del funzionario, il quale avendo
capito che di questo non sai nulla t raggira in tut i modi possibili. Leggi, scadenze: sì, su questo
aspetto devi essere informatssimo. Secondo, una maggiore capacità di formart sul piano dei modi,
delle possibilità; qualcuno che t dica come fare per organizzare un convegno, trovare fondi per un
evento, presentare libri, video: a chi chiedere fondi, come, dove, perché….. Nel mio caso hanno
supplito le conoscenze individuali: Quirino Galli mi dice “io faccio così…”, però se non te lo dice
nessuno non t viene in mente, specialmente a me che sono una persona poco pratca. Di queste
cose perché non ne facciamo tesoro? Il modello Canepina funziona così, il modello Ausonia
funziona così…, il modello Cellere, o Latera, allora capito? Una esperienza condensata in pillole, una
bella dose, una cura di questo tpo ci farebbe bene».
Rispetto alla opportunità o meno di disporre di percorsi formatvi strutturat Giovanni
Kezich esterna delle perplessità:
«Non sono partcolarmente convinto che vi possa essere un percorso formatvo strutturato per
questa partcolare professione, che invece ha tutto da guadagnare dalle specifche ecletcità dei
sogget che vi si afacciano: semmai, è giusto esigere che le amministrazioni dichiarino con
trasparenza quello che cercano, e che la formazione antropologica, per i musei etnografci, si
afermi comunque come un valore imprescindibile di riferimento. Questo sarebbe un obietvo
minimale, che è però ancora piuttosto lontano».
Tra le righe di questa afermazione si intravede, specie nel passaggio dove si fa riferimento alla
ecletcità, o comunque al contributo individuale che possono apportare museo i singoli,
traccia dell'eredità šebestana. Come se le competenze, le attudini, le inclinazioni molteplici e
originali del direttore, proprio come quelle di Giuseppe Šebesta, riuscissero ad aprire al museo
nuove potenziali strade ed opportunità. Kezich, anche chiamando a testmonianza il proprio –
362 Loc. cit..
[100]
ancora una volta: ecletco – percorso, sottolinea l'importanza per un direttore di aver
compiuto molte esperienze e di riuscire a mantenere una forte dutlità. Il suo, ad esempio, è
stato un percorso di studi e lavoratvo lo ha portato a studiare
«antropologia a Siena, per una Laurea in flosofa, e poi a Londra (UCL), per un Post-Graduate
Diploma in Material Culture (che non esiste più) e poi per un Ph. D. in Social Anthropology. Molto
prima di laurearmi, avevo già accumulato una certa esperienza sul campo, sotto l'ombrello del folk
revival sessantottesco nella sua versione militante, esperienza sulla quale avrei basato i miei lavori
di tesi prima, e di dottorato poi. Finit gli studi, non trovando subito una collocazione plausibile in
ambito universitario, mi sono occupato a lungo di editoria locale, e ho insegnato a scuola.[...] Ho
avuto stmoli molto eterogenei, a cominciare dalla lunga frequentazione dei musei nell'infanzia, di
cui ho già parlato, e se vogliamo anche dalla raccolta dei francobolli e qualche anno di atvità nei
gruppi archeologici. Poi il lavoro in casa editrice, importantssimo (il computer, la grafca...), ma
soprattutto per il fatto che il manager museale, di fatto, è a tut gli efet un editore, anche se non
necessariamente di libri. E, con l'editore, deve condividere una certa ecletcità di fondo e una certa
versatlità nel trattare fornitori e utent di ogni genere. Poi mi è servita l’esperienza a scuola e un
po' paradossalmente, anche molto l’aver fatto il servizio militare, l’artglieria da montagna: una
scuola impareggiabile di relazioni gerarchiche, da gestrsi quotdianamente con una certa dose di
humor»
Tut i passaggi elencat vengono valutat ed apprezzat da Kezich quali esperienze
propedeutche alla buona riuscita successiva vita in museo; vita in museo che, tuttavia, sembra
essere vissuta un po' come una sorta di ripiego rispetto alla carriera accademica. Del percorso
formatvo e lavoratvo del direttore del MUCGT hanno fatto parte moment la cui importanza
alla fne del lavoro in museo emerge in maniera chiara: il tpo di studi (incentrat sulla cultura
materiale), l'atvità in campo editoriale (in fn dei cont un museologo è un po' un editore:
sceglie cosa comunicare e come), la scuola (connessione con la sfera della didatca), la
frequentazione dei musei d'infanzia. Il potenziale rappresentato da quest ultmi è un tema
che ritrovo anche in altri autori. Per esempio Padiglione nei suoi scrit fa spesso riferimento ai
children museum quali espressione di quel «metcciato tra scienza (storia, antropologia, ed
arte, tra didatca e spettacolo) che costtuisce la formula ormai vincente di una grande parte
di esposizioni; formula polisemica di cui va crescendo con la pratca anche la
consapevolezza»363.
Utle per capire quale percorso formatvo meglio si adat a conferire all'aspirante
direttore tutte le competenze, ma anche tutte le astuzie, necessarie a guidare un museo
etnografco è cercare di mettere a fuoco in cosa risiede la sua specifcità, comprendere come
la partcolare combinazione di un isttuto culturale che rimanda a forme generali, il museo, e
363 Vincenzo PADIGLIONE, Musei: esercizi a decostruire già operanti e per volenterosi, op cit., p. 71 e seguenti.
[101]
uno specifco disciplinare, in questo caso le discipline demoetnoantropologiche, si coniugano,
con quali esit e generando quali partcolari esigenze.
«Marco D'Aureli: quale partcolare torsione imprime la sua formazione al ruolo che svolge? in che
misura, per fare un esempio, il direttore di museo antropologico è diverso dal direttore di museo
naturalistco o archeologico o storico artstco? per questoni prettamente disciplinari o anche per
altro? in altre parole: esiste una anthropological way alla direzione del museo?
Giovanni Kezich: per me è diverso nel senso che la competenza antropologica spinge naturalmente
all'analisi del sistema di relazioni che si artcola intorno al museo stesso, secondo prospetve che gli
altri specialist probabilmente non hanno. Se confrontato con il museo naturalistco o quello
storico-artstco o archeologico, fondat su delle epistemologie di riferimento un po’ più solide, nel
museo etnografco la natura prettamente ideologica degli exhibits e dei valori rappresentat si
staglia in modo lampante, il che rende pratcamente indispensabile la posizione dell'antropologo
quale decodifcatore, mediatore ed interprete».
Lo stralcio di intervista a Giovanni Kezich apre a diversi possibili approfondiment.
Innanzitutto viene sottolineato come il museo sia al centro di un “sistema di relazioni”. Non è,
il museo etnografco – ammesso che quelli di altra disciplina lo siano –, un contenitore che
raccoglie, conserva e interpreta degli ogget, delle porzioni di patrimonio che hanno del tutto
reciso i rapport, i collegament, con quanto accade fuori dalle mura dell'isttuto. In questo
senso l'immagine più immediata alla quale le parole del direttore del MUCGT rimanda è quella
del bazar364, del museo come luogo di convergenza di intensi traffici. Nel brano si fa anche
riferimento alla diversa natura della museologia archeologica o storico-artstca rispetto a
quella etnografca, fatta quest'ultma di musei che segnano più di altri il primato
dell'interpretazione sul dato bruto. Quello che invece mi sembra opportuno sottolineare, per
quanto sia un tema anch'esso già afrontato, è il discorso relatvo al ruolo che svolge
l'antropologo all'interno del museo, il suo essere interprete, decodifcatore e mediatore del
patrimonio.
«Marco D'Aureli: e passando dal direttore alla struttura, quale è la specifcità di un museo
etnografco in relazione alla sua missione, alla sua gestone...
Mario Turci: mi sembra così ovvio che non riesco a capire il quesito che mi poni; un museo di
antropologia, un museo etnografco è un museo che non si interessa di ogget, ma si interessa degli
ogget in quanto orme dell’umano, delle relazioni, delle umanità che stanno dietro; non dico
dell’uomo, eh!, dico delle umanità. E questo è il carattere del museo etnografco. Il museo
etnografco è un museo che dovrebbe essere non tanto interessato alla storia degli ogget, a come
gli ogget sono la prova testmoniale di un fatto avvenuto; dovrebbe piuttosto essere interessato
agli ogget quali testmoni, al fatto che quegli ogget hanno partecipato a delle biografe, a delle
umanità».
364 Cfr. capitolo 1.2
[102]
Una attenzione, questa verso gli ogget “testmoni” e non semplicemente “prove”, verso gli
ogget intesi come “orme”, forme plastche 365 dell'agire, del pensare e del sentre, in grado di
segnare la diferenza tra quello che è il ruolo e lo statuto che gli stessi rivestono all'interno di
un museo etnografco rispetto ad altri contest. Ed utle anche per far uscire defnitvamente i
nostri musei fuori dalla dimensione della civiltà contadina. Finita la fase “eroica” della raccolta
e della conservazione, approdato a una fase matura e rifessiva, il fronte dei musei etnografci,
affinché le tessere che lo compongono possano essere presentante legitmamente come tali,
deve orientarsi verso un alto livello di professionalizzazione degli operatori che lavorano al suo
interno. Ciò tenuto conto soprattutto del fatto che «professionalizzazione non significa tuttavia
standardizzazione, bensi rappresenta lo stimolo per non lasciare cadere nella routine e nella
ripetitività il lavoro all’interno del museo»366.
«Marco D'Aureli: quale partcolare torsione imprime il fatto che sei un antropologo alla funzione
che svolgi? Cosa aggiunge (o quali limit comporta) il tuo essere antropologo al ruolo di direttore?
Questa partcolare formazione che abbiamo rende il lavoro del direttore diverso, in qualche modo?
Una attenzione in più nei confront degli altri…
Mario Turci: mi verrebbe da dirt di si ma non te lo dico, nel senso che un antropologo o un
sociologo o uno storico o un botanico che in ogni caso ha a cuore il patrimonio che si trova a gestre
è comunque chiamato ad avere uno sguardo politco su quell’oggetto. È chiaro che l’antropologo,
l’etnografo, quando guarda l’oggetto vede le umanità che stanno dietro quell’oggetto, se vogliamo
può essere più preparato, attento, alla dimensione umana, e quindi della relazione, sa cosa è una
relazione, sa quale è il valore di una relazione, no? Però penso che se l’antropologo è più capace
di… lo è ma, diciamo, limitatamente. Per me è di ogni disciplina; ogni disciplina deve vedere, ogni
disciplina applicata al museo, deve saper vedere l’umano che sta dietro. Questo è quel che penso ».
Fare l'antropologo all'interno di un museo, o farlo in un contesto diverso, come
potrebbe essere quello accademico, è qualcosa di profondamente diverso. Non solo, come già
detto nel cap. 2, lo specialista deve imparare a gestre una struttura in tut suoi aspet, anche
quelli minimi, ma deve anche adeguare i propri strument concettuali al contesto entro cui si
trova a prestare la sua opera. Ad esempio, uno degli aspet che fa la diferenza tra i due
contest citat, quello museale e quello accademico, è il diverso modo di intendere la pratca
della ricerca. Il primo non è il luogo della ricerca pura, ma di quella applicata, territoriale.
Come scrive anche Clemente «la ricerca universitaria non si lega primariamente al territorio,
ma al lavoro per la conoscenza, alla sperimentazione metodologica, all'approccio teorico e
365 Mario TURCI, Cultura materiale, in «AM-Antropologia museale», anno 8, numero 22, speciale 2009, p. 27-29.
366 Manuale Europeo delle Professioni Museali.
[103]
interpretatvo»367. Quella che promuovono i musei, o che almeno dovrebbero farlo, è una
ricerca diversa, fortemente ancorata al territorio e fnalizzata a produrre letture utli ad
interpretare il patrimonio. Giovanni Pinna, in relazione al ruolo della ricerca all'interno dei
musei scientfci scrive: «per divenire strument di difusione del pensiero scientfco, ai musei
non è sufficiente trovare mezzi di espressione adeguat; è indispensabile che essi acquisiscano
anche la capacità di elaborare critcamente le conquiste della scienza prima di esporle al
pubblico, abbandonando il sensazionalismo tpico di altri tpi di media […]. Tuttavia, un’analisi
critca che preceda la costruzione delle esposizioni è possibile solo se i musei sono dotat di
una struttura di ricerca scientfca, e se tale struttura organizza direttamente, o collabora
strettamente, alla costruzione delle esposizioni. […] Si otterranno così due risultat important
ai fni dello sviluppo futuro di queste isttuzioni: la giustfcazione dell’esistenza di costose
organizzazioni di ricerca all’interno dei musei, e un ruolo più alto nella difusione del pensiero
scientfco. Se invece i musei fronteggeranno le difficoltà economiche riducendo il contenuto
scientfco delle esposizioni a vantaggio della spettacolarità e del gioco, agiranno esattamente
come le televisioni commerciali: daranno al pubblico ciò che il pubblico vuole e non
contribuiranno alla crescita culturale della società» 368. Parole che, fatte le dovute calibrazioni,
possono essere applicate anche nel nostro campo. La situazione dei musei etnografci locali,
sotto questo punto di vista appare difficilmente generalizzabile. Esistono musei che svolgono
atvità di documentazione in relazione la proprio territorio di appartenenza, ci sono musei che
non svolgono questa atvità a nessun livello (è il caso di quei musei della civiltà contadina
inaugurat ma mai realmente atvat) e ci sono musei che hanno fatto della ricerca qualcosa di
fondante (è il caso della nuova generazione di musei sort proprio nel Lazio).
Una questone che se afrontata può arricchire la comprensione del tema in analisi, può
allargare i possibili orizzont di rifessione, è quella del modo di intendere il lavoro del
direttore. Si avvicina di più all'idea di mestere o a quella di professione? Il contnuo
riferimento alla modalità di formazione tramite la pratca, l'osservazione diretta e l'imitazione
sembra rimandare ad un paradigma di tpo artgiano. «Il direttore è un artgiano che deve
conoscere dell’oggetto che tratta tutte le dimensioni», aferma Mario Turci, che sollecitato a
valutare quanto il lavoro del direttore sia un mestere e quanto una professione sostene che
367 Pietro CLEMENTE, Il progetto del Museo di Alberese, op. cit., p. 111.
368 Giovanni PINNA, Animali impagliati e altre storie, op. cit..
[104]
«è un po’ uno e un po’ l’altro. È un mestere, nel senso che tu di un oggetto devi conoscere tutto;
dell’oggetto che ho di fronte devo sapere come conservarlo, quanto vale, come prestarlo, chi
potrebbe fare una ricerca, come valorizzarlo inserendolo in un discorso più ampio, come tutelarlo,
quale è il suo valore politco… Quindi è un mestere. Diventa professione quando gli aspet del
mestere diventano un modo di saper fare che in ogni caso tu puoi trasmettere o confrontare con
gli altri. Diciamo che si apprende come mestere, poi diventa una professione. Essere professionista
poi vuol dire che questa cosa io la applico fuori, anche se non posso applicarla fuori del tutto perché
ogni realtà è diversa».
Il mestere, secondo il senso comune, consiste in «ogni atvità, di carattere
prevalentemente manuale e appresa, in genere, con la pratca e il trocinio, che si esercita
quotdianamente a scopo di guadagno»369. In linea generale, quando si parla di artgianato il
riferimento più immediato è al lavoro di chi produce ogget fat a mano o di un certo pregio.
Eppure, almeno secondo la lettura che propone il sociologo Richard Sennett 370, quella
dell'artgiano è una disposizione trasversale, una attudine 371 che è possibile riscontrare tanto
nel lavoro del falegname, tanto in quella del tecnico di laboratorio oppure del direttore
d'orchestra.
Marco Aime recentemente, in un saggio che accompagna un testo di Marc Augè, si è
interrogato sulla natura dell'atvità dell'antropologo: «sarà un vero mestere quello
dell'antropologo? Un mestere richiede la conoscenza di regole comuni, un sapere condiviso,
una fnalità comune»372. In passato, sostene Aime, quando il mondo aveva un altro assetto,
tutto era più chiaro: da una parte chi osservava, dall'altra chi era osservato, e il lavoro
dell'antropologo aveva una sua ben defnita fsionomia. Era chiaro chi-faceva-cosa. Secondo
l'antropologo torinese c'è «qualcosa che rende il lavoro dell'antropologo simile a un mestere,
nel senso più popolare del termine: una certa propensione alla dimensione artgianale del
proprio operare. Spesso si muove in contest circoscrit, marginali, quelli che Lévi-Strauss ha
chiamato “le pattumiere della storia”, lavora su dat minimi, li sviscera, li modella, lima,
rifnisce per dare loro forma di teoria. Un serio artgiano, insomma, anche se spesso un po'
litgioso con i suoi colleghi, perché geloso della propria originalità, del proprio metodo, pur
concordando, come la maggior parte dei suoi, che l'antropologia è una disciplina che non ha
369 Http://www.treccani.it/vocabolario/mestiere/
370 Richard SENNETT, L'uomo artigiano, Milano, Feltrinelli, 2010.
371 Per il resto l'argomentazione di Sennett appare piuttosto debole, nella misura in cui egli descrive gli artigiani come
attori a cui «sta a cuore il lavoro benfatto per sé stesso. Svolgono una attività pratica, ma il loro lavoro non è
semplicemente un mezzo per raggiungere un fine di un altro ordine. […] L'artigiano è la figura rappresentativa di
una specifica condizione umana: quella del mettere un impegno personale nelle cose che si fanno», pp. 27-28.
372 Marco AIME, Sarà poi davvero un mestiere?, in Marc AUGE', Il mestiere dell'antropologo, a cura di Marco AIME, Torino,
Bollati Boringhieri, 2007, p. 43.
[105]
un metodo vero e proprio. Insomma, quella degli antropologi è una corporazione un po' sui
generis. Come ogni buon artgiano che si rispet ognuno di loro si reca sul campo con una
valigetta degli attrezzi, più o meno simili, ma mai del tutto uguali» 373. Il riferimento a LeviStrauss chiama in causa l'immagine del bricoleur, elaborata dal padre dello strutturalismo
antropologico per spiegare il modo in cui lavora il mitografo. Qualcuno potrà non riconoscersi
in questo spaccato, eppure esso sembra descrivere bene non solo e non tanto il mestere
dell'antropologo in generale, ma anche – forse soprattutto – quello dell'antropologo museale,
dell'antropologo che lavora nel museo. «Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di
compit diferenziat ma, a diferenza dell’ingegnere, egli non li subordina al possesso di materie
prime o di arnesi, concepit e procurat espressamente per la realizzazione del suo progetto: il suo
universo strumentale è chiuso e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre
all’equipaggiamento di cui dispone, cioè ad un insieme via via “fnito” di arnesi e materiali,
peraltro eteroclit, dato che la composizione di questo insieme non è in rapporto col progetto del
momento, né d’altronde con nessun progetto partcolare, ma è il risultato contngente di tutte le
occasioni che si sono presentate di rinnovare o di arricchire lo stock o di conservarlo con i residui
di costruzioni o di distruzioni precedent. […] Il suo modo pratco di procedere è inizialmente
retrospetvo: egli deve rivolgersi verso un insieme già costtuito di utensili e di materiali, farne o
rifarne l’inventario, e infne, soprattutto impegnare con esso una sorta di dialogo per inventariare,
prima di sceglierne una, tutte le risposte che l’insieme può ofrire al problema che gli vien
posto»374. La descrizione del modo in cui opera il bricoleur può essere utlizzata per pensare, in
analogia, il lavoro del direttore del museo etnografco. Tanto nel primo quanto nel secondo caso,
infat, alcune abilità (adattarsi, far tesoro di esperienze pregresse) sembrano avere la medesima
importanza per il raggiungimento dell'obietvo fnale.
L'antropologo, e l'antropologo direttore di museo in partcolare, fno ad oggi ha dovuto
ricorrere all'arte di “arrangiarsi” 375 per quanto riguarda tutto quel settore che esula dalla sua
competenza
scientfca
specifca,
dunque
il
campo
della
comunicazione
visuale,
dell'educazione, dell'expografa, dell'amministrazione. Una abilità 376 che i direttori dei musei
etnografci sembrano aver appreso direttamente, ereditato, dai mondi messi in mostra
373 Ibid., p. 44.
374 Claude LÉVI-STRAUSS, Il pensiero selvaggio, Milano, Il saggiatore, 1964, pp. 30-31.
375 Cfr. Pietro CLEMENTE, Pezze e rimasugli: note per un'ermeneutica dell'accomodare, in Pietro CLEMENTE e Emanuela
ROSSI, Il terzo principio della museografa, op. cit., pp. 41-48.
376 «Un insieme di modi di fare che forse sono riconoscibili dal tipo di finalità», ibid., p. 42.
[106]
all'interno dei loro musei («l'aggiustare, l'accomodare sono una delle modalità fondamentali
della vita delle società pretecnologiche» 377), e che trova spazio nella cronica mancanza di
risorse nella quale frequentemente versano i musei, specie locali.
4.2 COMPETENZE
SPECIALISTICHE E COMPETENZE GESTIONALI
Un dato interessante emerge dalla interviste. Tut i direttori riconoscono, seppur con
sfumature diverse, con intensità diverse, che quello del direttore di museo è un lavoro che
chiama in causa competenze diversifcate. Da una parte quelle di tpo specialistco, da una
parte quelle di tpo gestonale.
«Marco D'Aureli: [...] perché è importante che un museo antropologico sia diretto da un
antropologo? Cosa può dare un antropologo in più rispetto ad altri specialist?
Mario Turci: il direttore antropologo sa, conosce lo statuto del patrimonio che è chiamato a gestre.
E conosce la sostanza dello statuto del patrimonio etnografco. Le sue scelte politche, le sue
valutazioni sono strettamente legate a quella missione che è propria della valorizzazione dello
statuto dell’oggetto, se vogliamo. Lo stesso penso che si potrebbe dire a proposito di un naturalista
in relazione al patrimonio naturale. Diverso è il discorso per quel che riguarda il manager, perché se
tu devi valorizzare una latna di birra o una zappa non lo puoi fare allo stesso modo; valorizzare
vuol dire entrare nella sostanza delle cose, utlizzare i paradigmi di approccio a quel patrimonio. In
una grossa struttura ci può essere un manager che non conosce nulla del patrimonio ma che si
occupa della parte della gestone, che fa funzionare bene il personale, che sa come si fanno i
contrat; però solo le grandi strutture possono permettersi i direttori scientfci e dei direttori,
chiamiamoli, “amministratvi”. Mentre nelle realtà più piccole il direttore è scientfco e
amministratvo insieme».
Tra le due, quella ad essere percepita come caratterizzante sembra essere la prima. La
competenza gestonale, in altre parole, viene considerata come un qualcosa che deve
innestarsi entro un solido retroterra specialistco.
«Marco D'Aureli: è importante, e quanto, che un museo sia diretto da uno specialista della
disciplina di cui il museo è espressione? quanto un direttore deve essere specialista di una certa
disciplina e quanto manager culturale?
Giovanni Kezich: per me un museo lo si giudica dalla quanttà di pensiero che si può intuire alle
spalle dei suoi allestment: che di per sé, sono sempre inadeguat. E' ovvio che a produrre questo
pensiero, deve esserci qualcuno che se intende. Su questo non ho dubbi, lo diceva anche Šebesta:
«Guai alla mancanza di profonde conoscenze programmatche, verrebbe fuori un pastccio informe,
di cui si accorgerebbe anche il profano…!». Se poi lo specialista è anche un buon comunicatore e un
buon manager, tanto meglio».
377 Ibid., p. 41.
[107]
Se essere specialist della disciplina è condizione necessaria per dirige un museo, per
interpretare il patrimonio, va però pure detto che non è sufficiente questo tpo di
preparazione. Occorre che questa sia completata da altre competenze in grado di mettere in
condizione il direttore di far sì che il museo adempia a tutte le sue funzioni precipue. Perché
qualsiasi lettura del patrimonio deve poi essere validamente comunicata ai visitatori.
«Marco D'Aureli: sulla base di quello che mi hai detto sono due gli aspet che voglio approfondire:
innanzitutto questa dimensione della professione, del saper gestre. Quanto è importante per un
direttore di museo etnografco?
Mario Turci: è fondamentale, etnografco o non etnografco è fondamentale. Gli strument del
mestere sono quest. Se valorizzare un bene oppure valorizzare una ricerca signifca saper trovare
le risorse, saper dialogare con il territorio, con la politca, trovare i modi… La gestone tecnicaorganizzatva di un museo è quello strumento che dà la possibilità di gestre il patrimonio. È
fondamentale per un direttore di museo. Un direttore di museo non è un intellettuale, solo. Uno
che fa l’antropologo sarà capace a fare l’antropologo, ma se vuole fare il direttore del museo non
gli basta conoscere l’antropologia, deve conoscere le forme di gestone, come si fanno le leggi,
come si fanno i bilanci, le economie, i risparmi, come si scrivono le richieste di contributo, come si
gestsce il personale, che cosa è la qualità. Se no fai il direttore artstco, scusa il termine. Il direttore
artstco è quello che ha l’intuizione, sa vedere le cose, poi le fa gestre a qualcun altro.
Marco D'Aureli: bisogna conoscere la natura dell’isttuzione che t è stata affidata, capire quali sono
i suoi meccanismi, i suoi funzionamento per farla operare al meglio…
Mario Turci: ma questo fa un direttore di museo, eh! Nel senso che quella del direttore di museo è
una professione, e il direttore deve essere capace di gestre un isttuto. Prima di tutto. Poi ha una
sua provenienza disciplinare che lo porta a gestre anche altre dimensioni del museo. Io devo
sapere come si fa il restauro, devo sapere come si fa un preventvo per richiedere un restauro, devo
sapere valutare i preventvi, devo conoscere le leggi sul lavoro, devo saper fare un contratto, devo
saper fare una gara, saperla valutare, devo… questo è ciò che deve fare direttore. Il suo lavoro
consiste in questo».
Tra le competenze che vanno oltre quelle disciplinari, partcolare rilevanza gli
intervistat riconoscono a quelle connesse alla sfera della gestonale, manageriali.
«Marco D'Aureli: quanto è importante l’aspetto puramente gestonale?
Vincenzo Padiglione: è fondamentale. Quest sono aspet che si devono imparare facendo
trocinio. Io penso che sia indispensabile fare un trocinio presso un museo medio, artcolato, dove
impari a fare un budget. Mario Turci ci ha insegnato a fare un budget sociale. Tu stai nel museo e
fai il tuo lavoro, magari fai straordinari senza che t vengano retribuit: nel budget lo met tutto
questo. Il museo, per fare un esempio, ha avuto un budget di 5.000 euro, ma la prestazione che ha
dato è di 40.000 €, e io agli amministratori presento tutte e due quest calcoli. E loro li devono
conoscere quest cont».
Leggermente diversa la posizione di Tamburini, che sbilancia l'indicatore del rapporto tra le
due dimensioni a favore di quella gestonale.
«M.D.: qui torniamo a una questone importante: il direttore, in quanto a competenze, deve essere
un mix tra specialista e manager, ma come lo doserest questo mix?
[108]
P.T.: deve essere sbilanciato a favore dell’aspetto manageriale, perché le disciplina rappresentate
nei nostri musei sono tantssime, ma c’è un aspetto che è comune a tut che è quello della
gestone. Se al Museo di Cellere il direttore fosse un manager, del tutto privo di conoscenze
antropologiche, che avesse te come collaboratore, avremmo risolto nel migliore dei modi…
[...]
P.T.: possiamo fare una scala gerarchica che va dal meglio al peggio. Il meglio è quello che ho detto
prima, cioè un museo diretto da un manager che può avvalersi di tutte le professionalità necessarie
M.D.: diciamo un direttore e tant conservatori
P.T.: bravo, come al Louvre… c’è il conservatore en chef e i vari conservsateur delle varie sezioni
museali. Il subordine successivo è che ci sia un manager che potrebbe anche essere una fgura già
esistente all'interno di un comune, un manager che fosse in grado anche di gestre un museo
sapendo anche di chi avvalersi...
M.D.: un super-segretario comunale, un super ufficio tecnico, che ne so…
P.T.: poi ancora in subordine si potrebbe considerare una soluzione accettabile quella che dicevi tu
prima. Allora, il museo antropologico con il direttore che ha capacità manageriali e che se non gli
vengono insegnate deve averle insite in sé».
La fgura del direttore è per molt versi assimilabile o sovrapponibile a quella del broker
in cultura del territorio così come questa è delineata da Antonio Riccio, un proflo
professionale pensato per avviare economie marginali e territori in crisi verso forme di
sviluppo sostenibile e compatbile con dei contest così partcolari (piccoli, geografcamente
marginali) come quelli che ospitano i piccoli musei etnografci. Il broker culturale è un
professionista, un «mediatore esperto, la cui missione privilegiata è nell'individuare,
promuovere, e valorizzare le potenzialità e le risorse culturali locali, atvando circuit virtuosi
di relazione e scambio con il più ampio contesto socioeconomico “esterno” (regionale,
interregionale, nazionale ed internazionale), ma suscitando nel contempo processi di
elaborazione e creazione di nuova cultura. Una fgura capace di coniugare spiccate
competenze etnografche (di studio, documentazione e studio sui patrimoni locali, nelle loro
composite ed artcolate emergenze) con competenze comunicative, relazionali, e di marketing,
unite ad una forte capacità progetuale grazie alla quale convocare le energie ed il “capitale
sociale” degli attori locali»378.
Se la dimensione manageriale viene percepita come fondamentale nella vita del
direttore di museo, al tempo stesso delle cautele circa possibili eccessi di entusiasmo vengono
comunque espresse.
378 Antonio RICCIO, Il Broker in cultura del territorio. Un mediatore per lo sviluppo turistico-culturale dei Monti Lepini, in id.
Identità e territorio, op. cit., p. 113.
[109]
«Giovanni Kezich: il futuro in questo momento non lascia presagire niente di buono, per le troppe e
contnue ingerenze della politca locale, che sui musei è veramente scatenata. I musei vanno lasciat
stare, soprattutto: altriment la loro funzione, che è diretta soprattutto al futuro, viene bruciata
subito. Stesso pessimismo per quanto riguarda i direttori, che fniranno nelle teche, come i
dinosauri, soppiantat da una nuova generazione di manager bocconiani, che è già alle porte. Ma
quello che non è chiaro a quest signori è che la natura specialissima dei prodot culturali, per il
come vengono selezionat, individuat e riconosciut nel corso delle epoche, e la capricciosità della
loro resa nel tempo, non soggiacciono a nessuna razionalità evidente, e sfuggono a qualsiasi
previsione. Quello che piace oggi, domani non piacerà più, non interesserà più. Eppure, le scelte
della cultura non sono mai prive di senso, anche se è un senso che sfugge agli econometrist dei
fussi turistci e agli amministratori politci. Come la rocca di Gibilterra, il museo, una volta formato,
deve avere la forza di contrastare l’erosione del tempo, e di riuscire a sopravvivere anche –
ipotetcamente – a zero visitatori. Questo sarà un buon Museo, e le generazioni future ce ne
saranno grate. Forse».
4.3 QUALE
FUTURO?
Il tema del futuro dei musei, inevitabilmente intrecciato a quello del futuro dei loro
responsabili, è sentto da tut gli interlocutori come di partcolare rilevanza. A determinare
una così forte sensibilità rispetto all'argomento è, probabilmente, la percezione di fort pericoli
che vengono intravist all'orizzonte.
«Antonio Riccio: Pietro Clemente ci ha illuminato con la lettera di De Varine sul futuro dei musei…
io c’ho pensato… è una bella domanda, a qualcosa è servito leggere quello che dice De Varine.
“Quale futuro vedi per i musei?”; io direi per i piccoli musei, perché i grandi avranno altro respiro.
La prima risposta che t darei è che la vedo nera che più nera non si può. A Pastena mi dice Simona
che non le hanno rinnovato il contratto; ad Emilio di Fazio a Riofreddo non l’hanno rinnovato ed
hanno inserito un direttore archeologo. In provincia di Frosinone c’è solo un museo DEA ancora
atvo, il mio. Vedo un futuro di feroce “selezione naturale”: dipenderà dalla tigna (come dicono a
Viterbo) dei direttori. Ad Ausonia dico: « non te lo faccio questo favore…», questo museo lo tengo
in vita fno a quando ce la faccio. Come? Inventando tutto e di più, sopravvivendo, anche contro
l’andazzo generale. Al limite faccio a meno della legge 42, attraverso il volontariato, attraverso altre
risorse, forse private. Forse, se tolgono la 42 ci spronano veramente a fare il nostro mestere?
Marco D'Aureli: e se non basta?
A.R.: che crolli tutto a volte penso sia anche utle. Se non succede niente vorrà pure dire che questo
museo contava poco per quella comunità… Non vorrei sentrmi come quegli impiegat inutli della
Grecia che hanno afossato il loro paese pur di mantenere lo stpendio, nel mio caso una isttuzione
sostenuta dallo Stato, alla fne. Se invece c’è solo la tua tigna, vuoi vedere che da qualche parte si
sprigionano forze ed energie? Io non ci ho mai provato, ma credi che non troveremmo degli
sponsor sulla piazza? […]».
Risuonano in queste afermazioni di Antonio Riccio quanto scrive de Varine, e che mi
sembra un buon antdoto contro qualsiasi tendenza a bloccare, fssare, una certa visione e una
certa conformazione del patrimonio: «il museo comunitario può morire, poiché corrisponde a
[110]
un momento della vita della comunità, quand'essa ha bisogno di quello strumento per esistere
ai proprio occhi, per pacifcare i rapport tra le sue diverse component, per mobilitare i
cittadini intorno a un progetto di sviluppo, per svelare a se stessa la propria identtà attraverso
le diferenze del patrimonio, per farsi conoscere all'esterno ecc. Una volta raggiunto l'obietvo
iniziale, almeno parzialmente, una volta “digerite” le diverse conseguenze secondarie il museo
andrà a poco a poco perdendo la sua funzione, almeno per la comunità»379. Certo, dato anche
l'investmento pubblico, utle sarebbe rinnovare il museo piuttosto che chiuderlo, trovare
nuove strade entro le quali incanalare le sua atvità, aprirlo a nuove sfde, a inedit e attuali
scenari culturali. Tuttavia il ragionamento di de Varine ha una sua fondatezza. Se il patrimonio
(di cui il museo è un dispositvo) ha una natura contestuale, se la sua conformazione cambia al
cambiare del modo in cui la comunità di riferimento si pensa, a come essa immagina sé stessa,
il proprio passato e il proprio futuro, allora pensare al museo come ad una isttuzione
immutabile, data una volta per sempre, appare un vero controsenso.
«Antonio Riccio: il futuro lo vedo in mano nostra. Non nel senso di padroneggiarlo, ma di esserne
responsabili. Non siamo impotent, secondo me, se non perdiamo di vista la realtà, se ci
impegniamo con la passione che ci abbiamo messo fnora, e se la comunità lo percepisce. Non
credo che siamo destnat ad essere esclusi, o almeno lo spero. Nel frattempo, prepariamoci a
combattere l’inverno che si annuncia».
Sono due le sfde che il mondo dei musei locali deve afrontare. Da una parte c'è quella
legata alla sopravvivenza materiale degli isttut, questone che chiama in causa il problema di
non poco conto della sostenibilità dei musei, soprattutto di quelli immersi in realtà periferiche
e piccole. Che è un problema che i progetst spesso afrontano dopo aver realizzato la propria
opera: «nella costruzione di un nuovo museo (così come nella riprogettazione di uno già
esistente) i profli architettonici, quelli museologici e quelli manageriali devono essere
considerat congiuntamente e contemporaneamente. Invece, molto spesso, si procede
dapprima al progetto architettonico e solo in un secondo momento alla lettura museologica e
all'analisi economica, organizzatva e gestonale. Dal punto di vista economico questo rischia di
creare delle “bombe a orologeria”. Ossia, delle strutture progettate a prescindere dalle
possibili scelte gestonali e organizzatve, e che non considerano quali saranno i cost di
gestone del museo in funzionamento. In queste circostanze tpicamente accade che, a pochi
379 Hugues de VARINE, Le radici del futuro, op. cit., p. 167.
[111]
anni dalla loro inaugurazione, tali musei dimostrano la loro insostenibilità economica,
attraverso l'emergere di contnui “buchi” di bilancio. E in quest casi, fatalmente, le scelte
sono: la riduzione delle atvità; oppure la scadimento qualitatvo delle iniziatve; oppure il
procrastnarsi della copertura delle perdite sino a una situazione irreparabile con la
conseguente socializzazione delle perdite; oppure, infne, la chiusura del museo. Tutte
soluzioni, quindi, non solo economicamente ma anche socialmente e culturalmente non
auspicabili»380
Hugues de Varine nel maggio del 2011, nel corso di un incontro sul tema I Musei locali
del futuro, ha tracciato un quadro dei possibili scenari che si delineano all'orizzonte 381.
Secondo il museologo francese, la situazione attuale dei musei locali è caratterizzata da alcune
(apparentemente inarrestabili) dinamiche quali: l'invecchiamento delle isttuzioni, la
rarefazione del volontariato, l'incremento dei cost di gestone e il progressivo disimpegno
delle amministrazioni pubbliche rispetto al sovvenzionamento degli isttut. Eppure, rileva de
Varine, nonostante la progressiva eclissi dei fnanziament pubblici e la disafezione
manifestata dagli stakeoholders strategici, e mentre alcuni musei locali isttuit nei decenni
scorsi vanno incontro a lenta estnzione, sono molt quelli nuovi che vengono inaugurat sotto
la spinta di una sorta di “bolla” simile a quella esplosa recentemente in campo immobiliare o
fnanziario. Di fronte ad una simile situazione, quello che l'Autore propone è di bandire una
vera e propria moratoria avente per oggetto i piccoli musei locali, e di avviare –
contemporaneamente – una attenta opera di censimento di tutte le emergenze del patrimonio
culturale, legate o meno ai musei: «ciò permetterà non solo di fare un “inventario” ma anche
di conoscere e raccogliere un primo gruppo di persone motvate e a vario ttolo capaci di
svolgere un ruolo in una futura strategia patrimoniale». Se vogliono contnuare ad esistere,
sostene da tempo de Varine382, i musei locali (ma lo stesso discorso vale più in generale per tutta
la sfera del patrimonio) devono proporsi come una risorsa per lo sviluppo dei territori, un qualcosa
di rilevante non solo sul piano prettamente culturale e identtario, ma utle, necessario, alla società
e al suo sviluppo. Secondo il museologo francese, «ogni livello del territorio (comune, provincia,
regione etc.) dovrebbe dotarsi di un dispositvo di governance del patrimonio, comprendente non
380 Fabio DONATO, L'introduzione degli strumenti manageriali: una questione soprattutto di competenze, in Fabio DONATO e
Anna Maria VISSER TRAVAGLI, Il museo oltre la crisi, op. cit., pp. 163-164.
381 Il testo dell'intervento è circolato in maniera informale tra le caselle di posta elettronica delle varie reti di direttori.
382 Hugues de VARINE, Le Radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, Bologna CLUEB, 2005.
[112]
solo i monument e i sit, ma anche tutto il patrimonio difuso materiale e immateriale, i paesaggi e
tutte le isttuzioni che su questo patrimonio intervengono (musei, biblioteche, archivi, centri
culturali, parchi e riserve naturali)». È in questo spazio che i direttori dei musei locali, musei
etnografci compresi, ognuno con la propria competenza specifca, dovrebbero ricavare uno
spazio di azione. È in questo impegno teso alla individuazione delle risorse, alla creazione di
ret, al trovare il modo migliore di mettere gli isttut al servizio dello sviluppo locale senza che
questo comport per i musei una rinuncia alla propria missione culturale, che i direttori
dovrebbero profondersi, per garantre un rinnovamento dei musei e per garantre a sé stessi e
alla categoria che rappresentano un ruolo per il futuro.
Ma, e de Varine ne è ben consapevole, neanche questa opera di monitoraggio e di
risposta alle esigenze dello sviluppo locale basterà « a fornire risposte a quest problemi. La
politca del patrimonio, il museo, l'eco-museo e tutte le strutture di questo genere dovranno
adattarsi al ciclo delle generazioni, dunque rimanere vivi e periodicamente trasformarsi, o
rassegnarsi a sparire». Il futuro dei musei e quindi anche dei loro direttori, è legato alla capacità
che i primi (ma anche i secondi) avranno di stare al passo con i tempi. Che non signifca acritco
appiatmento sulle tendenze mutevoli del momento, ma capacità di scegliere temi e
strument comunicatvi in grado di far percepire i musei come indispensabili alla comprensione
delle dinamiche che attraversano il nostro mondo contemporaneo. Una sfda, quella della
contemporaneità, di cui da molto tempo si parla ma che trova ancora difficoltà ad essere
afrontata direttamente tanto è forte l'imprintng della civiltà contadina nella museografa di
matrice demoetnoantropologica.
«Gianfranco Molteni.: il futuro dei musei dipende da quanto noi saremo in grado di guardare alla
contemporaneità. Siamo nat con lo sguardo al passato. O noi, la mia o la tua generazione, ma più la
tua della mia, capiamo che siamo in un momento in cui dobbiamo volgere lo sguardo al presente, o
altriment tut i musei DEA chiudono. Vedi il caso del Museo della Mezzadria senese. In tutta la
Toscana penso che i mezzadri sopravvissut non arrivino a dieci. Ci sono ancora le generazioni dei
fgli, ma tra vent anni non c’è più neanche quella. È un mondo scomparso. Il che signifca fare un
museo di fantasmi. O noi riusciamo a far dialogare il Museo della Mezzadria con la realtà delle
campagne di oggi, indicare le cesure, le fratture, però rappresentare anche la campagna, anche il
contemporaneo, altriment chiudiamo…
Marco D'Aureli: o diventamo musei archeologici
G.M.: esattamente, una archeologia di passato prossimo. Tu prova a pensar cosa succede quando
non ci saranno più le generazioni che di questo fenomeno hanno sensibilità, conoscenza. Dobbiamo
riuscire a fare quello che ho detto poco fa, e lo possiamo fare in due modi, o con il loro intreccio.
Uno è che noi siamo in grado di essere iconoclast rispetto alla concezione del museo e usare
tecniche diverse, forme di rappresentazione diverse, una delle quali è la sensorialità. Noi possiamo
[113]
far sì che chi entra nel nostro museo abbia nella tecnicità legata alla sensorialtà un elemento di
dinamicità, di presentazione delle realtà in modo vivo, contemporaneo, che ci aiuta molto. L’altro è
di fare uno sforzo, farci venire il torcicollo, e di guardare anche al presente. In questo una scelta che
io ho fatto sull’alimentazione è proprio in rapporto a questo. Qualche anno addietro mi sono posto
il problema che i musei devono avere un futuro, e l’unico modo di futuro è: sappiamo che dalla fne
della mezzadria a oggi c’è stata una cesura? Benissimo, documentamo questa cesura. Sappiamo
che il gusto e l’alimentazione della mezzadria erano diversi da quelli di oggi, anche se t trano fuori
le ricette della nonna o del contadino, benissimo! Documentamoli. D’altra parte il nostro compito è
quello. Non invidio Mario Turci con il Museo Guatelli, per esempio, perché quello è un monumento
pressoché immodifcabile nel tempo. Io penso, ma non glielo dico, tra tre generazioni che
succederà? Tre generazioni sono sessant’anni. Se io ho fatto un investmento di alcuni miliardi, per
quanto tempo l’investmento ha senso? Ecco perché io sostengo che il Museo Guatelli diventare
una cosa che va al di là, e qui dico una bestemmia, dello stesso Guatelli. Diventare il museo della
creatvità, della ingegnosità, della capacita di… lasciando pian piano Guatelli sullo sfondo come
colui che ne è simbolo eccetera ma… Lo stesso per i miei musei, devo far sì che il Museo del tartufo
divent il tartufo domani, il tartufo che deve cominciare a porsi il problema del DNA e via di seguito,
di tutto ciò che signifca; che il Museo della Mezzadria parli dell’agricoltura oggi, dei contadini oggi.
Ho fatto una intervista, credo la presenterò a Santarcangelo, in cui c’era un giovane contadino,
agricoltore, il quale è venuto all’intervista con una maglietta Lacoste; l’abbiamo fatta in quel giorno
lì perché la setmana dopo partva per una crociera. Se io penso ai contadini che intervistavo
trent’anni fa allora mi rendo conto che è fnito un mondo e che ce ne è un altro di mondo. Niente di
male, è la realtà, dobbiamo accettare al realtà. Renderci conto che i passaggi che l’Italia ha avuto
dal punto di vista quanttatvo a metà degli anni Cinquanta… il superamento dell’industria
sull’agricoltura, gli efet sul piano culturale li abbiamo oggi. Il mondo dell’alterità delle campagna,
t parlo del microcosmo toscano, è un’altra cosa, è scomparso».
Sul tema del futuro dei musei 383 e di quello del personale che lavora al loro interno è
intervenuto di recente anche Alberto Garlandini. Il presidente di ICOM-Italia segnala 384 il forte
incremento quanttatvo nel numero degli operatori che lavorano nel campo delle professioni
della conoscenza. Eppure, a fronte del dato (apparentemente) incoraggiante, emerge una
forte disagio da parte di chi (lavoratori del mondo dello spettacolo, della ricerca,
dell'audiovisivo) appartene a questa categoria. Se da una parte gli operatori «si sentono parte
di uno strato sociale aperto al rischio di impresa, alla meritocrazia, all’innovazione», per altri
versi gli stessi denunciano «di non riuscire a lavorare in modo contnuatvo. Ciò è vero in
partcolare in Italia, dove i professionist intellettuali lavorano in modo indipendente in
percentuale quasi doppia rispetto alla media europea. La maggior parte di loro [...]
fronteggiano una crescente difficoltà ad essere considerat dei professionist a pieno ttolo, a
vedere rispettate le competenze professionali, a ottenere retribuzioni corrispondent
all’elevato livello di istruzione». All'interno di questo scenario di grande precarietà si collocano
«i professionist del patrimonio culturale [i quali rappresentano] una piccola parte delle
383 Sull'argomento cfr. anche Sandra FERRACUTI (a cura di), Il futuro dei musei etnografci. Intervista a Pais de Brito, «AMAntropologia Museale», anno 5, numero 16, estate 2007, pp. 44-54.
384 I brani attribuiti a Garlandini provengono dalla bozza della relazione scritta in occasione della VII conferenza
nazionale delle associazioni museali (Milano, 21 novembre 2011).
[114]
professioni della conoscenza. Si tratta dei lavoratori più direttamente impegnat nelle atvità di
tutela, valorizzazione e gestone dei beni culturali, e cioè quant lavorano per i musei, le
biblioteche, gli archivi, gli isttut culturali e a favore del patrimonio difuso, materiale e
immateriale». A questo gruppo appartene la gran parte dei direttori di museo etnografco e
più in generale dei direttori (o di altre fgure di professionist: conservatori, addet alla
didatca) atvi all'interno dei musei locali italiani.
Per il prossimo decennio, sostene Garlandini, sono prevedibili fort cambiament nel
settore delle professioni legate al patrimonio: «sino a qualche anno fa si poteva individuare
una professione museale, quella esercitata dai direttori e dai conservatori, specialist di una
singola disciplina con il compito di studiare e conservare le collezioni a loro assegnate. Oggi il
lavoro nei musei è diventato plurale, si è professionalizzato e specializzato e, al contempo,
multdisciplinare. Si sono trasformate le professioni tradizionali – il direttore del museo, il
conservatore, il bibliotecario, l’archivista – e sono nate nuove professioni trasversali,
esercitate in tut i servizi culturali e relatve ai servizi al pubblico, all’educazione, alla
comunicazione, alla mediazione, all’accoglienza, alla gestone, al marketng, al fundraising».
Il tema del rapporto tra le generazioni di professionist museali è partcolarmente
rilevante.
«Marco D'Aureli: quale è il futuro che vedi per i musei e per i direttori?
Mario Turci: alla luce della situazione attuale, che è fortemente condizionata, nel senso che se i
direttori si formano sul campo in una realtà che vede i direttori in carica invecchiare, e più invecchi
e più sei rigido, e ai giovani che dovrebbero in ogni caso avvicendarli, “imparare da”, non gli si dà la
possibilità di imparare perché non gli si da lavoro, io penso che presto ci troveremo di fronte a un
vuoto generazionale dove ci saranno direttori che andranno in pensione e giovani che non hanno
avuto la possibilità di formarsi e che dovranno ripartre da zero. Questo nella prospetva che ci sia
posto e le cose possano andare avant. Io vedo un buco, un vuoto generazionale, che ci porterà a
dissipare saperi pratci, perché i saperi di un direttore, in molta parte, sono saperi pratci che tu puoi
trasmettere solo tramite lavoro comune da fare assieme. Il futuro dei musei di etnografa dipende
dalla capacità che quest avranno di resistere alla tempesta, e penso che molt riusciranno a
resistere se troveranno un puntello nel volontariato. Molt musei oggi rimangono apert perché
subentrano volontari, i volontari che si organizzano. Però ci sarà una moria, sicuramente. Questo è
il dato. Vedo un futuro con un vuoto, mancherà un anello».
Un aspetto che va bene messo a fuoco è quello relatvo alla “frattura generazionale”
che sembra essersi creata all'interno di questo mondo. Mentre gli ultracinquantenni (sempre
secondo la lettura proposta da Garlandini) ricoprono incarichi pubblici e godono delle garanzie
[115]
connesse al proprio tpo di impiego (anche se sofrono dell'esser privat di grandi prospetve
di mobilità o di carriera), per gli under quaranta la situazione si prospetta ben diversa. Quest,
come risulta da indagini statstche citate da Garlandini, «vivono una situazione
socioeconomica e lavoratva simile a quella degli altri professionist della conoscenza. La
maggior parte cerca l’autonomia, ma vive pericolosamente tra un lavoro precario e l’altro, con
incarichi temporanei e sottopagat, spesso più vicini ad una dimensione di neoproletariato
intellettuale che di imprenditorialità culturale. Investono molto sulla professionalità e sul
lavoro interdisciplinare, e vivono la professione museale come una scelta di vita, come
peraltro i loro colleghi più anziani. Sofrono il mancato riconoscimento della professione e le
chiusure e rigidità del mercato del lavoro. Condividono con i colleghi occupat a tempo
indeterminato le competenze, le aspirazioni, i metodi di lavoro, gli standard di qualità
professionale, il codice etco, ma vivono una realtà lavoratva ben diversa». E per il futuro le
cose non sembrano avviarsi verso una piega migliore: «come evolveranno le professioni dei
musei? E’ prevedibile che nel 2025 pochi museali saranno dipendent pubblici. La grande
maggioranza sarà costtuita da liberi professionist, con un lavoro simile a quello dei creatvi di
oggi. Lavoreranno full time e senza orario, per più musei e più datori di lavoro, con difficoltà a
distnguere tra lavoro, studio e tempo libero. Per molt aspet rappresenteranno una sorta di
nuovi artgiani dell’immateriale, produttori di qualità e portatori di saperi innovatvi e
personalizzat. Saranno specialist, ma anche mediatori culturali. Saranno estranei ad ordini e
organizzazioni corporatve o sindacali, e in maggioranza si riconosceranno in libere e volontarie
associazioni professionali riconosciute. Secondo la maggioranza degli analist i lavoratori della
conoscenza occuperanno la parte centrale del mercato del lavoro, quella più garantta e
meglio retribuita, e ciò dovrà valere anche per i professionist dei musei e degli isttut
culturali».
Al momento tuttavia, la condizione dei professionist di nuova generazione, nonostante
le previsioni fn troppo otmistcamente positve, sembra essere altra. E quanto riportato nei
capitoli precedent, in partcolare nel 2, lo dimostra.
[116]
5. TESI IN DISCUSSIONE
5.1 ETNOGRAFIA:
IL SUO POSTO NEI MUSEI
Giunto alla fase fnale di questo percorso di rifessione sulla fgura del direttore di
museo etnografco, è mia intenzione intrecciare tra di loro i ragionament – spesso
palesemente interlocutori – propost fnora e mettere a proftto le acquisizioni tesaurizzate al
fne di contribuire alla discussione relatva al problema indicato nella parte introdutva del
dossier. Nel primo capitolo, abbozzando uno stato dell'arte della museologia e della
museografa di matrice DEA in Italia negli ultmi quaranta anni, ho cercato di mettere bene in
evidenza cosa rende etnografco un museo, in cosa risiede la specifcità della museologia
demoetnoantropologica. Sento ora l'esigenza di rendere evidente e marcare una distnzione,
quella che passa tra l'etnografa strettamente intesa e l'antropologia culturale; un distnguo
che ha efet di ricaduta signifcatvi nel campo museale.
Mi sono reso conto di avere fno ad ora usato frequentemente il sostantvo museo (e i
derivat museografa e museologia) in connessione con l'aggetvo “etnografco”,
“antropologico” e “demoetnoantropologico” come se quest ultmi fossero intercambiabili o
signifcassero esattamente la medesima cosa. I manuali di avviamento allo studio
dell'antropologia culturale – specie quelli un po' datat – propongono una distnzione piuttosto
netta tra etnografa, demologia (o folklore, storia delle tradizioni popolari), etnologia e
antropologia culturale. A seconda degli orientament teorici, diversi autori – in diverse epoche
– hanno defnito quest tre approcci in maniera diferente proponendo ora distnzioni di
oggetto e metodo di studio, ora di livello della ricerca 385. In alcuni casi a fare la diferenza è
stata assunta la dimensione geografca del vicino e del lontano rispetto a noi-occidentali.
Cirese, nel suo manuale, spiega come tradizionalmente in Italia e in Europa per etnologia sia
stato inteso lo studio delle «società “primitve”» e che l'etnografa sia stata considerata
l'aspetto propriamente descritvo di questo tpo di studi. Secondo il disegno ciresiano, alla
demologia spetta di studiare i dislivelli culturali interni alle società superiori e all'etnologia
quelli esterni386; per quanto riguarda l'antropologia culturale – nell'edizione del 1973 di
385 Cfr. le voci ETNOGRAFIA e ANTROPOLOGIA CULTURALE del Dizionario di Antropologia a cura di Ugo FABIETTI e Francesco
REMOTTI, Bologna, Zanichelli, 1997.
386 Cfr. Alberto Mario CIRESE, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo, 1973, p. 21.
[117]
Cultura egemonica e culture subalterne – l'Autore si limita a registrare che il campo di indagine
di quest'ultma spazia dalla «grandissima generalità» alla «più specifca delimitazione»387.
Claude Lévi-Strauss in Antropologia struturale scrive che l'etnografa «corrisponde ai primi
stadi della ricerca: osservazione e descrizione, lavoro sul terreno (feld-work)»; l'etnologia,
invece, la defnisce come «un primo passo verso la sintesi» (di tpo geografco, sistematco o
storico). L'antropologia, sociale o culturale, rappresenta «una seconda e ultma tappa della
sintesi, che ha per base le conclusioni dell'etnografa e dell'etnologia», e nei paesi
anglosassoni, specifca, «mira a una conoscenza globale dell'uomo, abbracciando l'argomento
in tutta la sua estensione storica e geografca aspirando ad una conoscenza applicabile
all'insieme dello sviluppo umano»388. Il modo di considerare il rapporto tra etnografa e
antropologia culturale ha subito variazioni in funzione del susseguirsi e dell'avvicendarsi dei
paradigmi che negli ultmi anni sono sort. Le diferenze permangono, e per capire quali siano
basta aprire uno qualsiasi dei manuali di antropologia culturale attualmente in circolazione in
Italia e scorrerne l'indice. Facendolo si percepisce immediatamente una tensione
dell'antropologia verso la comparazione, tanto che in alcuni test questa viene presentata
come una disciplina che «mira a descrivere nel senso più ampio possibile cosa signifchi essere
uomini»389. Accanto a quella comparatvistca, l'antropologia culturale ha da sempre una forte
impronta di tpo olistco, prospetva che la porta ad «integrare tutte le conoscenze sugli
esserei umani e le loro atvità al livello più alto e comprensivo»390. Nel panorama attuale delle
scienze sociali, l'etnografa non è più considerata la semplice pratca di ricerca sul campo
tramite la quale portare a casa document da sottoporre successivamente ad un processo di
astrazione. La svolta rifessiva che ha attraversato questo campo di studi, la critca che ha
investto il concetto di autorità etnografca 391, l'emergere di approcci interpretatvi e dialogici
ha comportato una vera e propria rivoluzione disciplinare. Geertz, ad esempio, ha proposto
una riformulazione dello statuto dell'etnografa che condensa in queste parole: «occorre dire
che non si tratta di una questone di metodo. Dal punto di vista dei manuali, fare etnografa
387 Ibid., p. 74.
388 Claude LÉVI-STRAUSS, Posto dell'antropologia nelle scienze sociali, in id. Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore,
1998, pp. 389-390.
389 Emily A. SCHULTZ e Robert H. LAVENDA, Antropologia culturale, Bologna, Zanichelli, 1999, p. 5
390 Loc. cit.
391 Cfr. James CLIFFORD e George E. MARCUS (a cura di), Scrivere le culture, op. cit., e anche Ugo FABIETTI e
Vincenzo MATERA, Etnografa. Scritture e rappresentazioni dell'etnografa, Roma, NIS, 1997.
[118]
signifca intrattenere rapport, scegliere degli informatori, trascrivere test, ricostruire
genealogie, tracciare mappe di “campi”, tenere un diario e così via. Ma non sono queste cose,
queste tecniche e procedure convenute che defniscono l'impresa. Ciò che la defnisce è
l'atvità intellettuale in cui consiste: un complesso avventurarsi, per usare il termine di Gilbert
Ryle, in una “Thick description”»392. Lla descrizione densa, una rappresentazione
interpretante393, è una descrizione che cerca di ricondurre gli event sociali ed i comportament
entro un quadro che consenta di cogliere le stratfcazioni di signifcato, i rapport e la ret che
collegano ogni elemento di quella cosa che chiamiamo cultura a tut gli altri che rientrano nel
medesimo insieme. Fare etnografa oggi, abbandonate le opzioni oggetvistche, signifca
lavorare nella direzione di una puntuale contestualizzazione dei fenomeni osservat, signifca –
sulla scorta del dettato geertziano – produrre interpretazioni di interpretazioni.
James Cliford, che fa notare come l'antropologia sia sempre stata un ambito di studi di
natura interdisciplinare, si chiede: «che cosa è che ancora contraddistngue questa
disciplina?»394. Uscito di scena il “primitvo”, e aperto il campo di indagine ad ambit
difficilmente immaginabili solo qualche decennio fa, diventato anacronistco parlare di uomo e
di scienza dell'uomo, quello che secondo lo storico della conoscenza americano rimane a
caratterizzare la disciplina nel suo complesso è «una pratca di ricerca ben distnta», cioè la
ricerca sul campo «intensiva, interatva e organizzata intorno alla “fnzione seria” di un
“campo”». L'etnografa appunto, o etnografa antropologica, per distnguere questa pratca
dalle etnografa pratcate ormai anche da altre discipline; un esercizio al centro di mille
negoziazioni ma il solo in grado di qualifcare in maniera puntuale il nostro campo di studi.
Così, mentre l'antropologia culturale invita ad uno «sguardo slargato, storicocomparatvo sulle diferenze e somiglianze culturali, sulla contemporaneità»395, l'etnografa
spinge verso «un occhio da orefce che si soferma su usi, storie minute e situate, su
personaggi, memorie e luoghi»396. È l'etnografa contemporanea che, smentendo la possibilità
di riprodurre in maniera fedele la Realtà e la Totalità 397, ha spinto i musei di area DEA verso
una sensibilità antessenzialista e antnaturalista. Sono, i musei dove l'etnografa è stata
392 Clifford GEERTZ, Verso una teoria interpretativa della cultura in id. Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1988, p.
12.
393 Cfr. Mariano PAVANELLO, Fare antropologia. Metodi per la ricerca etnografca, Bologna Zanichelli, 2010, p. 114.
394 Ibid., p. 23.
395 Vincenzo PADIGLIONE, Conclusione – Tesi in discussione, in id. Poetiche dal museo etnografco, op. cit. p. 251.
396 Loc. cit..
397 Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Presentazione, op. cit., p. 20.
[119]
assunta a prospetva di riferimento, isttut dove le categorie fort costruite dalle nostre
discipline (identtà, appartenenza, tradizione) piuttosto che essere utlizzate in maniera
scontata vengono problematzzate, analizzate; musei, dunque, come dispositvi che
propongono uno sguardo straniante su ogget (concret e non) familiari, spazi che mettono in
scena punt di vista locali e polifonici rifutando qualsiasi forma di realismo ingenuo398.
Ma l'approccio etnografco ha diritto di cittadinanza e può portare un sostanziale
contributo soltanto nelle isttuzioni dichiaratamente di area DEA, oppure l'adozione della
medesima può risultare fruttuosa anche in altri settori del complesso e variegato mondo dei
musei?
5.2 A SCUOLA DALL'ETNOGRAFO
Nel secondo capitolo ho afrontato la questone della direzione del museo etnografco
collocando quest'ultma all'interno della triplice cornice entro cui essa si inscrive, cioè la
dimensione museologica, quella legislatva e quella pratca. Quest'ultma, sotto forma di
esperienza mediata dalla rifessione e dal racconto, si riafaccia prepotentemente nella
trascrizione integrale delle interviste che sono proposte in appendice. Rispetto ad essa, il
capitolo 3, di impronta più marcatamente metodologica, ha assolto al compito di presentare il
“contratto” che ho stretto coi miei interlocutori. Le questoni nodali afrontate nel capitolo 2
riguardano il ruolo della dimensione specialistca nella formazione del direttore; detto in altri
termini: perché è importante che a dirigere un museo etnografco sia chiamato un etnografo.
La seconda riguarda un altro aspetto di rilievo: la necessità che un direttore oltre a
competenze specifcatamente scientfche e disciplinari (etnografche, museologiche) abbia
anche competenze gestonali e manageriali. Questo perché il compito che pertene ad fgura
simile è quello di guidare una isttuzione complessa e artcolata che fa, sì, ricerca, ma accanto a
questa anche molte altre atvità (esposizione, didatca, educazione) che richiedono un sapere
e un saper fare del tutto partcolare.
Ma sembra esserci spazio per l'etnografa anche fuori dai DEA-musei. C'è una strada
che – in questo senso – suggerisce Pietro Clemente e che vale la pena di battere in maniera
approfondita: «recentemente mi è capitato di rifettere sulla possibilità che SIMBDEA coordini
398 Ibid., p. 18.
[120]
– per cominciare, in Toscana – non solo i musei demo-etno-antropologici, ma anche quelli
“fuori settore” che non hanno alle spalle la potenza delle soprintendenze e sono un po' in balia
degli ent locali: musei storici, archeologici, musei d'arte contemporanea, parchi-museo
territoriali. Sono realtà che vivono spesso in una totale solitudine e incertezza, con
amministratori locali che nel taglio dei bilanci li mettono tra i primi, musei che devono tremare
a ogni cambio di assessore. D'altro canto i musei storici e archeologici, i musei d'arte
contemporanea sia perché danno valore alle autobiografe e alle memorie, sia perché cercano
di fare immaginare forme della vita quotdiana e sistemi simbolici sono naturali interlocutori
dell'antropologia museale»399. Parole che fanno risuonare nelle orecchie quanto già afermato
anche da James Cliford, cioè che «le idee antropologiche viaggiano nelle discipline» 400, e che
aprono nuovi e interessant scenari all'applicazione del sapere dell'antropologia in campi ed
essa contgui.
Secondo Vincenzo Padiglione una competenza di
tpo rifessivo è bagaglio
indispensabile per ogni curatore di museo, al di là della natura disciplinare del singolo isttuto.
È stata – come fa notare l'Autore – la New Museology a far emergere questa necessità, che ha
spinto i professionist museali ad abbandonare le preoccupazioni esclusivamente
tecnicistche401 e li ha portat ad «interrogarsi sul senso del loro operato, sui rapport di potere
e di egemonia inscrit nelle loro pratche» 402, a prendere in considerazioni e ad interrogarsi sui
«presuppost culturali dei musei» 403. Questo tpo di competenza, di sensibilità, è quella che
contraddistngue l'etnografa contemporanea. L'approccio che essa propone è quello che
consente di atvare «uno sguardo estraniato a casa propria, sulla quotdianità del proprio
operato […]. Come dire che solo una prospetva (quale l'etnografa), in grado di capire, ad un
tempo, come si costruisce il valore culturale dell'oggetto nel percorso espositvo e come si
confgura il suo uso da parte del pubblico, riesce a rendere meno astratta l'idea di museo e ad
incardinarne il ruolo nella dinamica sociale e culturale» 404. L'opinione di Padiglione, in
sostanza, è che è proprio «nel metodo etnografco che sono riposte gran parte delle speranze
399 Cfr. l'intervista a Pietro CLEMENTE, Pietro Clemente: antropologia, linfa dei nuovi musei) raccolta nel volume di Silvia
Dell'Orso, Musei e territorio. Una scommessa italiana, Milano, Electa, p. 183
400 James CLIFFORD, Ai margini dell'antropologia. Interviste, Roma, Meltemi, 2003, p. 13.
401 «The 'old' museology […] is too much about museum methods, and too little about the porposes of museum», cfr.
Peter VERGO, Introduction, in id. The New Museology, op cit., p. 3.
402 Vincenzo PADIGLIONE, Per una centralità dell'etnografa nei musei, in id. Poetiche dal museo etnografco, op. cit., p. 93.
403 Ibid., p. 94.
404 Ibid., p. 94-95.
[121]
di un incremento di rifessività all'interno dei musei» 405. Una solida preparazione etnografca, o
comunque l'adozione di una prospetva di questo tpo, diventa lo strumento in grado di
consentre ai responsabili culturali dei musei (di qualsiasi impianto disciplinare) di cogliere la
dimensione politca, ideologica o estetca del collezionare e dell'esporre, le motvazioni che
stanno alla base della selezione di cert ogget destnat ad essere preservat per i posteri, i
criteri in base ai quali gli ogget vengono considerat di interesse artstco o di interesse
storico406. Questo a tutto vantaggio dell'isttuzione singola, dell'intero gruppo di isttut
culturali dello stesso genere, e delle funzione sociale e culturale che il museo è chiamato a
svolgere.
Ma che la museologia e il mondo dei musei vengano attraversat dal sapere
dell'etnografa appare vantaggioso anche sotto altri punt di vista. Proviamo a pensare al
museo – come ci suggerisce di fare de Varine – come ad uno strumento dello sviluppo.
L'obietvo del museo territoriale, museo «espressione del territorio, qualunque sia il soggetto
che prende l'iniziatva di costtuirlo e che lo gestsce […] è la valorizzazione di tale territorio e
da questo punto di vista, esso è efetvamente uno strumento dello sviluppo». Sostene de
Varine che «la comunità non è un oggetto del museo, così come i suoi membri non sono
semplici visitatori, un pubblico come un altro, paragonabile ai turist o alle comitve
scolastche, ma sono sogget del museo e attori. Non basta quindi trattarli come informatori,
come un “campione” in senso etnografco o sociologico. Il museo deve piuttosto integrarli in
tutte le fasi del processo di crescita e della sua vita solo a queste condizioni assolverà la sua
funzione al servizio dello sviluppo» 407. Ora, al di là dell'utlizzo un po' sospetto di cert termini
(comunità), e al di là della discutbile immagine che de Varine sembra aver dell'etnografa,
quanto afermato dallo studio francese è utle a dimostrare, quanto meno a confermare
autorevolmente, l'idea che le pratche dell'etnografa contemporanea (l'ascoltare, il cogliere il
punto di vista dell'altro, il predisporre analisi contestuali) rappresentano delle risorse
strategiche per il museo locale (e questo al di là di qualsiasi specializzazione questo possa
avere, il discorso vale per il museo archeologico, storico artstco e così via) alle quali atngere
per rendere veramente il museo attore dello sviluppo locale.
405 Ibid., p. 95.
406 Cfr. Peter VERGO, Introduction, op. cit., p. 2.
407 Hugues de VARINE, Uno strumento per lo sviluppo: il museo, in id. Le radici del futuro, op. cit., p. 159.
[122]
5.3 VERSO
UN'ETICA DELLA RESPONSABILITÀ
Soprattutto dalla lettura del paragrafo 2.5 emerge una sensazione di difficoltà, di fatca.
Una difficoltà che non è solo quella di dirigere un museo locale, ma è anche quella di essere un
antropologo direttore di museo, vale a dire uno scienziato – per usare una categoria forte
entro la quale forse non tut gli interessat si riconoscono – che pratca un sapere che rimane
in parte esoterico agli occhi delle comunità nelle quali lavora o che attraversa e marginale
rispetto al quadro delle altre discipline accademiche e scientfche. Così, nonostante i buoni
proposit, nonostante le pratche partecipatve di ricerca tendent all'inclusione, nonostante in
quest ultmi anni il numero delle pubblicazioni accessibili al grande pubblico sia aumentato
rispetto al passato408, gli antropologi vivono, o quantomeno percepiscono di vivere, in una
condizione di marginalità isttuzionale e scientfca 409. Ancora oggi, come fa notare Allovio, «gli
antropologi nel confronto con gli studiosi di altri ambit accademici (scientfci e umanistci) si
sentono percepit come fossero Pigmei: necessitano di riconoscimento e di essere presi sul
serio con la loro mercanzia di stranezze, con il loro metodo traballante e con le loro teorie
sflacciate e poco rassicurant»410. I demoetnoantropologi che lavorano in museo percepiscono
amplifcata questa sensazione di irrilevanza; il fattore di moltplicazione è dato da motvi
diversi. Contano la perifericità geografca del dislocamento dei musei, lontani rispetto ai grandi
centri più vivaci sul piano delle iniziatve culturali; la lontananza che i professionist del museo
sentono rispetto alle sedi dove il dibatto teorico è più avanzato e le risorse più generose (o
meno esigue). La gran parte degli antropologi museali lavora nei musei in maniera il più delle
volte precaria, occasionale. Lo scollamento, come già accennavo, tra come le cose dovrebbero
andare e come vanno è forte. Come dovrebbero andare: ogni museo dovrebbe – condizionale
obbligatorio più che mai – avere un responsabile scientfco posto in condizione materiale di
fare ricerca; organizzare i servizi educatvi ad ampio raggio (diret a scuole, adult, gruppi di
stekeholders); pianifcare ricerche; pensare allestment tramite i quali resttuire le
408 Utilizzo questo termine in maniera tutt'altro che dispregiativa. Penso in particolare ad alcuni volumi di Marco
AIME o agli scritti di Franco LA CECLA apparsi su quotidiani come Il Sole 24 Ore.
409 Sull'argomento cfr. di Fabio DEI, Sull'uso pubblico delle scienze sociali, dal punto di vista dell'antropologia, «Sociologica», 2,
2007.
410 Stefano ALLOVIO, Pigmei, europei e altri selvaggi, Roma-Bari, Laterza, 2010. Il riferimento ai Pigmei nella citazione,
rispetto al testo che precede e segue, può apparire spiazzante; il fatto è che l'Autore nel suo libro ha dedicato una
attenta analisi alla costruzione del pigmeo, alla marginalità attribuita a questa cultura e alla rifessione, al
confronto, tra questa marginalità e quella degli antropologi rispetto ad altri settori disciplinari e scientifici.
[123]
interpretazioni del patrimonio; disporre di un adeguato numero di unità di personale
qualifcato. Come vanno: nei musei che dipendono dalle amministrazioni locali, e che dunque
sono sogget a normatve regionali che nelle migliori delle ipotesi prevedono (in maniera più o
meno perentoria e prescritva) che ogni isttuto sia dotato di un direttore, quest ultmi sono il
più delle volte impegnat a tempo parziale, privi di adeguato riconoscimento professionale,
legat a contrat generalmente annuali che prevedono un rimborso spese o piccoli compensi, e
costret a mille incombenze diverse. Il tutto, specie in quest ultmi temi di retorica trionfante
del rigore e della razionalizzazione, sotto la minaccia costante della sosttuzione con un
manager. Il fatto è che fn quando l'esigenza che a dirigere un museo etnografco sia chiamato
uno specialista viene percepita soltanto da chi dovrebbe ricevere l'incarico e dalla comunità
scientfca alla quale egli appartene, cosa che agli occhi di qualcuno potrebbe far apparire il
discorso come fortemente motvato da interessi corporatvistci, non si fanno passi avant.
Occorre che ad essere consapevole di questa necessità sia la colletvità, siano i pubblici, la così
detta società civile. Che si riesca a far passare l'idea che un museo gestto da un direttore che
abbia padronanza sulla materia trattata dal museo e sulla prospetva adottata da
quest'ultmo, competente nella gestone di un simile isttuto culturale, è un museo più
efficiente, che ofre un prodotto culturale migliore, che impiega le risorse in modo otmale. E
affinché questa condizione si realizzi è necessario che, nei nostri paesi, nelle nostre città, la
gente inizi ad avere sete di etnografa e di antropologia. Che queste discipline non siano
considerate un lusso, un di più di cui si può fare a mano, un giocattolo nelle mani di una élite
intellettuale, ma che vengano percepite come una risorsa, un potenziale conoscitvo del quale
non privarsi. Perché che questo lo dicano gli antropologi, come fa Cliford, il quale ritene «che
l'antropologia non sia un ambito le cui risorse, il cui pubblico e i cui interlocutori sono o
dovrebbero essere esclusivamente o fondamentalmente antropologi»411, è un conto. Ma esiste
una richiesta di antropologia proveniente dal di fuori del ristretto ambito degli addet ai
lavori? Cosa fanno gli antropologi per stmolare questa sete? Cosa fanno per creare premesse
tali conferire solidità a qualcosa che ha consistenza tanto sfumata ma che, almeno all'interno
della comunità scientfca, è tanto atteso?
411 James CLIFFORD, Ai margini dell'antropologia, op. cit., p. 26.
[124]
5.4 BUONE
PRATICHE E MODESTE PROPOSTE
Trovare una soluzione a tut i problemi richiamat fno a questo punto appare difficile.
Difficile – soprattutto – perché ognuno di essi aferisce a sfere distnte. Molt chiamano in
causa svariate agenzie e dispositvi di eterogenea natura: ent locali, professionist, associazioni
di settore, artcolazioni dello Stato centrale; attori che seguono ognuno proprie procedure,
proprie logiche, propri disegni politco-culturali. Alcuni risentono in maniera forte della
contngenza economica e sociale del momento: il taglio dei trasferiment dal governo centrale
agli ent locali, la riduzione di spesa per settori considerat improdutvi. Altri sono problemi di
lunga durata difficili da risolvere, come la scarsa penetrazione dell'antropologia nel tessuto
culturale e sociale italiano. Non tutto, in conclusione, dipende dall'impegno e dalla volontà dei
soli addet ai lavori. Questo però non deve e non può rappresentare una comoda via d'uscita
rispetto alle responsabilità che gli antropologi devono assumersi. Ciò che in questo momento
appare necessario ed urgente è uscire dall'otca del malcontento e della protesta ed entrare
in quella del progetto. Volgere in positvo una situazione che, comunque la si declini, ha una
fortssima connotazione negatva. Scommettere su di un esito riguardo la vertenza che investe
il settore dei musei etnografci e in partcolare la questone della loro direzione. Sostenere, in
modo chiaro, che se i musei etnografci sono i nostri musei, e nostri non per proprietà o per
forme malcelate di narcisismo, ma per il lavoro, l'impegno, la passione e le risorse
immaginatve che come categoria spendiamo al loro interno e nella loro costruzione, allora è a
noi, noi demoetnoantropologi, che spetta il compito di pensare ad un futuro sostenibile per
queste strutture, di escogitare formule in grado di mettere gli isttut in condizione di svolgere
al meglio la propria missione. Si tratta, per quanto forse in modo indiretto, di operare nella
direzione che suggerisce Fabio Dei, il quale vede come possibile che «una etnografa o
antropologia critca del patrimonio possa legitmamente impegnarsi e compromettersi nella
elaborazione delle politche culturali»412. Gli antropologi museali, devono fare pressione sui
tecnici e sui politci (responsabili degli uffici musei delle varie regioni, assessori, sindaci)
tramite le associazioni di settore, devono riuscire a spingere in maniera tale da orientare (o
costruire, laddove assente) una politca culturale tesa a mettere in condizione i musei di
412 Fabio DEI, Antropologia critica e politiche del patrimonio, «AM-Antropologia Museale», anno 1, numero 2, ottobre 2002,
p. 37.
[125]
adempire alla propria missione. In questa prospetva pare utle segnalare una serie di possibili
obietvi sui quali puntare l'attenzione:
–
Valorizzare le buone pratche e le esperienze positve.
L'esperienza maturata nell'ultmo decennio entro i confni della Regione Lazio racconta di
piccoli musei etnografci sort in luoghi geografcamente marginali. Il Museo del brigantaggio di
Cellere e prima ancora di Itri, il Museo delle scritture di Bassiano, L'Etnomuseo dei Mont
Lepini, il Museo etnografco del giocattolo di Sezze, il Museo dell'inforata di Genzano sono
musei che dimostrano come alla marginalità geografca non corrisponda sempre e
necessariamente una marginalità o scarsa originalità/qualità della proposta culturale. Anzi, è
forse anche grazie a questa perifericità, che per cert versi ha consentto una certa libertà di
sperimentazione, che sono stat inaugurat musei frutto di una rigorosa ricerca etnografca tesi
a mettere in valore, rifessivamente e critcamente, tramite nuovi linguaggi, patrimoni locali
secondo sguardi situat ed estetche locali. Musei che rappresentano l'espressione della
museografa e della museologia etnografca più avanzata, vere e proprie scatole della
conoscenza fortemente proiettate sulla contemporaneità; isttut in grado di mettere in
connessione locale e globale, di dare visibilità ai fussi culturali, di idee e di immaginari che
attraversano il mondo interconnesso e in grado anche di costtuire un grande richiamo per
varie fasce di pubblico, da quello scolastco (di ogni ordine) a quello meno facilmente
connotabile. I risultat raggiunt da quest musei, la capacità che hanno dimostrato di saper
dialogare con le “comunità” locali (le virgolette stanno ad indicare l'utlizzo di una accezione
desaturata della nozione), suggeriscono di contnuare in questa direzione. Gli etnomusei laziali
sono innovatvi anche su un altro piano, quello del personale impiegato al loro interno. Pur se
con forme contrattuali assolutamente non vantaggiose, e che anzi necessitano di una
improcrastnabile e radicale ridiscussione e ridefnizione, sono musei diret da una nuova
generazione di ricercatori di solida formazione accademica e con alle spalle esperienze di
progettazione, ricerca e lavoro nel campo dei musei e del patrimonio maturate anche in
campo internazionale.
–
Puntare sulle competenze in costtuzione.
Valorizzare la formazione che sta prendendo corpo entro le neonate scuole di specializzazione
tramite la elaborazione di un progetto formatvo orientato in modo netto. Le Scuole, nate
soprattutto per rispondere ad una esigenza curricolare legata al riconoscimento del proflo del
[126]
demoetnoantropologo entro il MIBAC, rappresentano al momento l'unico a mezzo a
disposizione di chi voglia intraprendere un percorso di studi di alto livello sul tema dei
patrimoni DEA e quindi anche dei musei. È per questo che è necessario che l'intero corso di
studi appaia strutturato in maniera estremamente coerente e fnalizzato, improntato ad un
progetto formatvo stlato in maniera rigorosa e secondo gli standard riconosciut (un progetto
cioè che valut attentamente obietvi formatvi, possibili sbocchi professionali, bacino di
utenza dei fruitori, portata reale della richiesta di determinate fgure professionali). Ma se le
Scuole rappresentano delle isttuzioni necessarie, esse non sembrano sufficient a rispondere
alle domande formatve che vengono dal fronte degli addet ai lavori. Lasciando per un atmo
sullo sfondo tutto il discorso relatvo alla formazione e all'aggiornamento nel campo della
gestone, sembra importante poter disporre di moment formatvi, a frequenza periodica, di
natura laboratoriale, che riguardino l'antropologia dei patrimoni, la museologia. Un ambito
emergente di partcolare interesse è quello delle art etnografche, che è connesso con le
pratche di traduzione e comunicazione visuale, o comunque attraverso forme alternatve al
tradizionale testo scritto, di esit di ricerche etnografche da resttuire tramite allestment
museali.
–
Responsabilizzare gli ent locali.
Ancora una volta non posso che citare il caso della Regione Lazio, visto che in riferimento ad
altre situazioni potrei parlare solo dopo attente analisi di politca culturale locale. Tramite
fnanziament regionali, in parte di provenienza Europea, La Regione ha consentto, ofrendo
un contributo fnanziario, la costtuzione di molt musei locali. Lo ha fatto conoscendo bene le
realtà dove quest musei andavano a installarsi, spesso piccoli paesi a rischio spopolamento, in
declino demografco, privi di oferte lavoratve per le nuove generazioni. L'ente ha quindi una
responsabilità nei confront di queste realizzazioni. Ma non bisogna scaricare sulla Regione
tutte le aspettatve. È opportuno, ed anche in questo caso qualcosa ha iniziato a muoversi, che
i musei trovino una propria strada verso la sostenibilità economica. Dove invece risiede la
responsabilità della regione è sul piano legislatvo; è necessario che l'ente elabori norme di
tpo virtuoso che migliorino il quadro attualmente in vigore, per la verità non proprio scadente,
adattandolo ai nuovi contest e ai nuovi scenari che si pongono al mondo dei musei.
–
Valorizzare le esperienze maturate in campo associatvo.
SIMBDEA rappresenta l'interlocutore naturale tanto per i musei quanto per i direttori. La
[127]
Società costtuisce un punto di riferimento per gli operatori del mondo dei musei DEA; di fatto
essa raccoglie, anche se non al completo, una parte signifcatva della comunità scientfca di
riferimento degli antropologi museali. SIMBDEA rappresenta la più grande associazione di
categoria per i museologi di area DEA, ha svolto e svolge un ruolo di politca della cultura, ha
organizzato convegni, workshop, corsi di formazione con pubbliche amministrazioni. Nel Lazio,
SIMBDEA ha curato la fase iniziale del progetto teso alla realizzazione del Sistema museale
antropologico DEMOS. SIMBDEA ha il know-how necessario anche a svolgere atvità di tpo
formatvo utli ai direttori, dai corsi di aggiornamento ai workshop su temi specifci
(museologia, legislazione, museotecnica).
Sul piano specifco della direzione, infne, appare utle ribadire
–
il ruolo della formazione specialistca
Connesso con l'ambito della ricerca, della promozione della partecipazione, delle forme della
resttuzione (art etnografche, linguaggi audiovisivi);
–
il ruolo della formazione museologica (museografca e museotecnica)
Connesso com la sfera della comunicazione, della valorizzazione;
–
il ruolo della formazione gestonale
Connessa con l'ambito dell'economia applicata ai beni culturali e ai musei, con quello della
gestone delle risorse umane, della programmazione sul medio-lungo periodo, della
promozione, del rapporto con le autorità locali.
[128]
-» Bibliografa «Aa.Vv., L'antropologia italiana. Un secolo di storia, Bari, Laterza, 1985
Aa.Vv., Il patrimonio culturale, «Antropologia», anno 6, numero 7, Roma, Meltemi, 2006
Aa.Vv., Per l'educazione al patrimonio culturale. 22 tesi, Milano, Franco Angeli, 2008
AIME Marco, Sarà poi davvero un mestiere?, in Marc AUGÉ, Il mestiere dell'antropologo, Torino, Boringhieri, 2007, pp. 43-60
ALESSANDRINI Giuditta, Comunità di pratica e società della conoscenza, Roma, Carocci, 2007
ALLOVIO Stefano, Pigmei, europei e altri selvaggi, Roma-Bari, Laterza, 2010
ANGLE Carlo, Introduzione, in id. (a cura di), Musei, società, educazione. Guida per operatori culturali, Roma, Armando Editore,
1976
APPADURAI Arjun, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma, Meltemi, 2001
ARDUINI Marcello (a cura di), Verso il museo. Atti del Convegno di Studi Verso il Museo della civiltà contadina “Luigi Poscia”.
Cultura materiale e beni volatili. Latera, 30 maggio 1998, Latera, 1998
Marc AUGÉ, Il mestiere dell'antropologo, Torino, Boringhieri, 2007
BALFET Hélène, L'analisi etnologica degli oggetti tecnici, in Pier Giorgio SOLINAS (a cura di), Gli oggetti esemplari. I documenti
di cultura materiale in antropologia, Montepulciano, Edizioni del Grifo, 1989, pp. 17-26
BINNI Lanfranco e PINNA Giovanni, Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal '500 a oggi, Milano, Garzanti,
1989
BRAVO Gian Luigi e TUCCI Roberta, I beni culturali demoetnoantropologici, Roma, Carocci, 2006
BRONZINI Giovanni Battista, Homo laborans. Cultura del territorio e musei demologici, Galatina, Congedo Editore, 1985
- id. L'avventura etnomuseografca di G. Šebesta, «Lares», n. 58, pp. 499-513
BRUNI Attila, Lo studio etnografco delle organizzazioni, Roma, Carocci, 2003
CABASINO Emilio, I mestieri del patrimonio. Professioni e mercato del lavoro nei beni culturali in Italia , Milano, Franco Angeli,
2005
CALIANDRO Christian e P. Luigi SACCO, Italia reloaded. Ripartire con la cultura, Bologna, Il Mulino, 2011
CALVINO Italo, La poubelle agréée, in id., La strada di San Giovanni, Milano, Mondadori, 1995
CARUSO Fulvia (a cura di), Chi lavora sotto un tetto è benedetto. Artigianato a Latera nel Ventesimo secolo, Latera, 2004
- id. (a cura di), Il Museo della terra di Latera. Oggetti, riti, storie di una realtà contadina, Bolsena, Quaderni del Sistema museale
del Lago di Bolsena, 2007
CIRESE Alberto Mario, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna di studi sul mondo popolare tradizionale, Palermo,
Palumbo, 1973
- id., Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, Torino, Einaudi, 1977
- id., Classi astratte e cose concrete, in SOLINAS Pier Giorgio (a cura di) Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in
antropologia, Montepulciano, Editori del Grigo, 1989, pp. 27-40
- id., Le discipline umanistiche: l'antropologia, in CLEMENTE Pietro (a cura di), Professione antropologo, «La ricerca folklorica.
Contributo allo studio della cultura delle classi popolari» n. 23, aprile 1990, pp. 79-86
- id. I beni demologici in Italia e la loro museografa, in CLEMENTE Pietro, Graffti di museografa antropologica italiana, Siena,
Protagon, 1996, pp. 249-262
- id., Beni immateriali o beni inoggettuali?, in «AM-Antropologia museale», anno 1, numero 1, maggio 2002, pp. 66-69
- id., Beni volatili, stili, musei. Diciotto altri scritti su oggetti e segni, Prato, Gli Ori, 2007
[129]
CLEMENTE Pietro (a cura di), Professione antropologo, «La ricerca folklorica. Contributo allo studio della cultura delle
classi popolari» n. 23, aprile 1991
- id., Graffti di museografa antropologica italiana, Siena, Protagon. 1996
- id., La vita come uso. Scenari epocali della museografa antropologica italiana, in Franca DI VALERIO (a cura di), Contesto e
identità. Gli oggetti fuori e dentro i musei, Bologna, CLUEB, 1999, pp. 73-90
- id., I Dea-musei, «AM-Antropologia Museale», anno 4, numero 12, inverno 2005, pp. 33-37
CLEMENTE Pietro e ROSSI Emanuela, Il terzo principio della museografa. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci,
1999
CLIFFORD James, I frutti puri impazziscono. Etnografa, letterature e arte nel XX secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1999
- Ai margini dell'antropologia. Interviste, Roma, Meltemi, 2004.
CLIFFORD James e MARCUS George E., Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell'etnografa, Roma, Meltemi, 2005
COCCHIARA Giuseppe, Storia del folklore in Italia, Sellerio, Palermo, 1981
COZZO Andrea, La tribù degli antichisti. Un'etnografa ad opera di un suo membro, Roma, Carocci, 2006
CREW Spencer R. e SIMS James E., Situare l'autenticità: frammenti di un dialogo, in Ivan KARP e Steven D. LAVINE (a
cura di), Culture in mostra. Poetiche e politiche dell'allestimento museale, Bologna, CLUEB, pp. 75-97
CUISENIER Jean e VIBAEK Janne (a cura di), Museo e cultura, Palermo, Sellerio, 2002
DEI Fabio, Antropologia critica e politiche del patrimonio, «AM-Antropologia Museale», anno 1, numero 2, ottobre 2002,
pp. 34-37
- id., Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi Editore, 2007
- id., Sull'uso pubblico delle scienze sociali, dal punto di vista dell'antropologia, «Sociologica», 2, 2007
DELL'ORSO Silvia, Altro che musei. La questione dei beni culturali in Italia, Roma-Bari, Laterza, 2002
de VARINE Hugues, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, Bologna, CLUEB,
2005
DE ZAN Luca, Economia dei musei e retorica del management, Milano, Mondadori-Electa, 2007
DONATO Fabio e VISSER TRAVAGLI Anna Maria, Il museo oltre la crisi. Dialogo fra museologia e management, 2010,
Mondadori Electa, Milano
ELSNER John and CARDINAL Roger (edited by), The Cultures of Collectig, London, Reaktion Book
FABIETTI Ugo e MATERA Vincenzo, Etnografa. Scritture e rappresentazioni dell'etnografa, Roma, NIS, 1997
FERRACUTI Sandra (a cura di), Il futuro dei musei etnografci. Intervista a Pais de Brito, «AM-Antropologia Museale», anno
5, numero 16, estate 2007, pp. 44-54
FERRETTI Alessandro, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli, Edizioni giuridiche Simone, 2010
FRAZER James George, Il ramo d'oro. Studio sulla magia e la religione, Torino, Bollati Boringhieri, 1995
GEBRAIL Lina, Le politiche del passato in Libano: identità “ferite” in gioco, in AA.VV, Il patrimonio culturale, «Antropologia»,
anno 6, numero 7, Roma, Meltemi, 2006, pp. 93-106
GEERTZ Clifford, Opere e vite. L'antropologo come autore, Bologna, Il Mulino, 1990
- id., Interpretazione di culture, Bologna, il Mulino, 1998
- id., Antropologia interpretativa, Bologna, Il Mulino, 2001
- id., Oltre i fatti. Due paesi, quattro decenni, un antropologo, 1995, Bologna, Il Mulino
GOBO Giampietro, Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografco, Roma, Carocci, 2001
[130]
GOFFMAN Erving, La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 1969
GUATELLI Ettore, Il Taro e altre storie, Reggio Emilia, Diabasis, 2005
- id., La coda della gatta. Scritti di Ettore Guatelli. il suo museo i suoi racconti (1948-2004). Nuova edizione aggiornata e ampliata , a
cura di Vittorio FERORELLI e Falvio NICCOLI, Bologna, IBC, 2005
GUZZETTI Luca, L'etnografa del laboratorio scientifco, in DAL LAGO Alessandro e DE BIASI Rocco, Un certo sguardo.
Introduzione all'etnografa sociale, Roma-Bari. Laterza, 2002, pp. 57-80
HERZFELD Micheal, Pom Mahakan: umanità e ordine nel centro storico di Bangkok, in AA.VV, Il patrimonio culturale,
«Antropologia», anno 6, numero 7, Roma, Meltemi, 2006, pp. 19-42
HUGHES Everett Cherrington, Institutional offce and person, in id., Men and Their Work, London, The Free Press of Glencoe
Collier-Macmillan Limited, 1958
Il patrimonio museale antropologico. Itinerari nelle regioni italiane. Rifessioni e prospettive, Roma, Cangemi Editore, 2008
JALLA Daniele, Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo sistema museale italiano, Torino, UTET, 2006
KARP Ivan e LAVINE Steven D. (a cura di), Culture in mostra. Poetiche e politiche dell'allestimento museale, Bologna, CLUEB,
1995
KEZICH Giovanni, Il museo selvaggio. Note per uno studio di antropologia museale, in Giovanni KEZICH e Mario TURCI (a
cura di), Antropologia museale. Caratteri, rappresentazioni e progetti dei musei antropologici, demologici ed etnografci, Atti del 1°
Seminario nazionale di antropologia museale, Roma-San Michele all'Adige, giugno-settembre 1993, «SM – Annali di S.
Michele», n. 7, 1994
KEZICH Giovanni e TURCI Mario (a cura di), Antropologia museale. Caratteri, rappresentazioni e progetti dei musei antropologici,
demologici ed etnografci, Atti del 1° Seminario nazionale di antropologia museale, Roma-San Michele all'Adige, giugnosettembre 1993, «SM – Annali di S. Michele», n. 7, 1994
KEZICH Giovanni, EULISSE Eriberto e MOTT Antonella, Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina. Nuova guida
illustrata, San Michele All'Adige, MUCGT, 2009
KIRSHENBLATT-GIMBLETT Barbara, Destination culture. Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley, University of
California Press, 1998
LACLOTTE Michel, Storie di musei. Il direttore del si racconta, Milano, Il Saggiatore, 2005
LATTANZI Vito, Beni culturali: lo stato delle cose, «AM-Antropologia Museale», anno 5, numero 16, estate 2007, pp. 5-6
- id., Finalmente ratifcato il proflo professionale del demoetnoantropologo, AM, anno 9, speciale 2010, p. LVIII
LATTANZI Vito e MARIOTTI Luciana, Questioni di proflo professionale, «AM-Antropologia Museale», anno 8, numero
23/24, autunno-inverno 2009, pp. 96-98
LE GOFF Jacques, Documento/Monumento, Enciclopedia Einaudi, vol. 5, pp. 38-48, Torino, Einaudi, 1978.
LÉVI-STRAUSS Claude, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1964
- id., Posto dell'antropologia nelle scienze sociali, in LÉVI-STRAUSS Claude Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1998,
pp. 389-390
MIRIZZI Ferdinando, Patrimoni demoetnoantropologici e formazione universitaria, AM-Antropologia Museale, anno 1, numero
1, maggio 2002, pp. 42-43
- id., Giovanni Battista Bronzini scrittore e progettista di musei, in MIRIZZI Ferdinando, Storie di oggetti Scritture di musei. Rifessioni
ed esperienze tra Puglia e Basilicata, Bari, Edizioni di Pagina, 2008, pp. 25-55
MONTELLA Massimo, Musei e beni culturali. Verso un modello di governance, Milano, Mondadori-Electa, 2003
LUGLI Adalgisa, Museologia, Milano, Jaca Book, 1996
[131]
LUMLEY Robert (a cura di) L'industria del museo. Nuovi contenuti, gestione, consumo di massa, Genova, Costa & Nolan, 1989
MAGNI Catia e TURCI Mario, Il Museo è qui. Il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro, Ginevra-Milano, Skira, 2005
MARANI Pietro C. e PAVONI Rosanna, Musei. Trasformazioni di un'istituzione dall'età moderna al contemporaneo, Venezia,
Marsilio, 2009
MARIOTTI Luciana, Patrimonio e infrastrutture: due s.p.a. per i beni culturali, «AM-Antropologia Museale», anno 1, numero
3, inverno 2002-2003, pp. 68-71
- id., Una scuola di specializzazione desiderata, «AM-Antropologia museale», anno 2, numero 4, estate 2003, pp. 45-46
MONTELLA Massimo, Musei e beni culturali. Verso un modello di governance, Milano, Mondadori Elcta, 2003
MORIGI GOVI Cristina e MOTTOLA MOLFINO Alessandra (a cura di), La gestione dei musei civici. Pubblico o privato?,
Torino, Allemandi & C., 1996
MOTTOLA MOLFINO Alessandra, Il libro dei musei, Torino, Umberto Allemandi & C., 1998
MOTTOLA MOLFINO Alessandra e MORIGI GOVI Cristiana, Lavorare nei musei. Il più bel mestiere del mondo, Torino,
Umberto Allemandi & C., 2004
NOBILI Carlo, Per una storia degli studi di antropologia museale. Il «Museo Luigi Pigorini» di Roma, «Lares», LVI n. 3, LuglioSettembre 1990, pp. 321-382
ORTEGA y GASSET José, La missione del bibliotecario, Carnago, Sugarco, 1994
PADIGLIONE Vincenzo, Presentazione, in Sezione di Antropologia museale dell'A.I.S.E.A. (a cura di), L'invenzione
dell'identità e la didattica delle differenze, Atti della sessione “Antropologia Museale” al II Congresso Nazionale A.I.S.E.A.
Identità differenze confitti, Roma, 28-30 settembre 1995, Milano, Edizioni ET, 1999, pp. 13-26
- id., Interpretazione e differenze. La pertinenza del contesto, Roma, Edizioni Kappa, 1996
- id., L'EtnoMuseo dei Monti Lepini, ovvero scegliere l'etnografa come prospettiva museale, in Sandra PUCCINI (a cura di), Beni
culturali e musei demoetno-antropologici, Atti della Giornata di Studi Viterbo e Canepina, 9 maggio 1997, Roma, CISU,
2001
- id., Ma chi mai aveva visto niente. Il Novecento, una comunità, molti racconti. Catalogo EtnoMuseo Monti Lepini, Roccagorga,
Roma, KAPPA, 2001
- id., Storie contese e ragioni culturali. Catalogo Museo demoentoantropologico del Brigantaggio di Itri, Itri, Odisseo, 2006
- id., Tra casa e bottega. Passioni da etnografo, Roma, Edizioni Kappa, 2007
- id., Poetiche dal museo etnografco. Spezie morali e kit di sopravvivenza, Imola, La Mandragora Editrice, 2008
- id., Installazione etnografca: un genere di comunicazione visivo, in «AM-Antropologia museale», anno 8, n. 23/24, autunnoinverno 2009, pp. 99-101
PADIGLIONE Vincenzo e GIORGI Sabina (a cura di), Etnograf in famiglia. Relazioni, luoghi e rifessività, Roma, Edizioni
Kappa, 2010
PADIGLIONE Vincenzo e CARUSO Fulvia, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi. Catalogo del Museo del brigantaggio di
Cellere, a cura di Marco D’AURELI, Effigi, Arcidosso, 2011
PALUMBO Berardino, Patrimoni-identità: lo sguardo di un etnografo, «AM-Antropologia muselae», anno 1, numero 1,
maggio 2002, pp. 14-19
- id., Patrimonializzare, «AM-Antropologia muselae», anno 8, numero 22, speciale 2009, pp. XXXVIII-XL
- id., L'Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale Roma, Meltemi, 2006
PAVANELLO Mariano, Fare antropologia, Bologna, Zanichelli, 2010
PERIN Andre, Cose da museo. Avvertenze per il visitatore curioso. Milano, Eleuthera, 2007
PETRUCCI COTTINI Valeria, I beni culturali nel quadro delle discipline etnoantropologiche, in COLAJANNI Antonino, DI
CRISTOFARO LONGO Gioia e LOMBARDI SATRIANI Luigi M., Gli argonauti. L'antropologia e la società italiana,
Roma, Armando, 1994, pp. 239-248
[132]
PICKERING Andrew (a cura di), La scienza come pratica e cultura, Torino, Edizioni di Comunità, 2001
PIERUCCI Claudio, Il museo etnografco. Le ragioni di una istituzione, Roma, La Goliardica, 1984
PINNA Giovanni, Animali impagliati e altre memoria. Ricordi di un direttore di museo con note di museologia, Milano, Jaca Book,
2006
PIROVANO Massino, Le parole del museo DEA. Civiltà contadina, tradizioni popolari ed etnografa: campi e discipline per un museo
etnoantropologico, in PIROVANO Massimo e SIMONI Carlo (a cura di), Cose e memorie in scena. Strumenti ed esperienze per i
musei della cultura materiale, Brescia, Centro Servizi Museali della Provincia di Brescia, 2006, pp. 11-28
POULOT Dominique, Elementi in vista di un'analisi della regione patrimoniale in Europa, secoli XVIII-XX, in AA.VV, Il
patrimonio culturale, «Antropologia», anno 6, numero 7, Roma, Meltemi, 2006, pp. 129-154
PUCCINI Sandra, L'Itala gente dalle molte vite. Lamberto Loria e la Mostra di etnografa italiana del 1911, Roma, Meltemi, 2005
- id., Raccogliere oggetti demologici, storia e signifcati, http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/130/1/puccini_
oggetti_demologici.pdf
- id., Le sentinelle della memoria. Per una tipologia del collezionismo antropologico, http://dspace.unitus.it/bitstream/
2067/127/1/puccini_sentinelle_memoria.pdf
PUCCINI Sandra, CATALDI Pier Luigi e BRANDIZZI Maria Teresa, I musei etnografci del Lazio. Collezioni, raccolte e
musei della cultura contadina, Viterbo, Agnesotti, 2002
PULINI Ilaria, Musei etnografci, in L'arte. Enciclopedia tematica aperta, Milano, Jaca Book, 1993, pp. 342-436
RIBALDI Cecilia, Introduzione, in id. (a cura di), Il nuovo museo.Origini e percorsi. Vol. 1, Milano, Il Saggiatore, 2010
RICCI Antonello, Maremme in leggìo, Manziana, Vecchiarelli editore, 2000
RICCIO Antonio, Identità e territorio. Un etnografo nei Monti Lepini, Roma, KAPPA, 2007
ROSSI Adolfo, Nel regno di Tiburzi, Roma, Perino, 1893
SCARPELLI Federico, La memoria del territorio. Patrimonio culturale e nostalgia a Pienza, Ospedaletto, Pacini Editore, 2007
SCHEUERMEIER Paul, Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Svizzera italiana e retoromanza ,
a cura di Michele DEAN e Giorgio PEDROCCO, Milano, Longanesi, 1981, 2 voll.
SCHULTZ Emily A. e LAVENDA Robert H., Antropologia culturale, Bologna, Zanichelli, 1999
ŠEBESTA Giuseppe, Scritto etnografci, San Michele all'Adige, MUCGT, 1991
- id., In forma di museo. Il flm dei primi anni nei ricordi del fondatore, San Michele all'Adige, MUCGT, 1998
SENNETT Richard, L'uomo artigiano, Milnao, Feltrinelli, 2010
SETTIS Salvatore, Italia S.P.A.. Assalto al patrimonio culturale, Torino, Einaudi, 2007
SOLINAS Pier Giorgio (a cura di), Gli oggetti esemplari. I documenti di cultura materiale in antropologia, Montepulciano,
Edizioni del Grifo, 1989
STOCKING George W. jr. (a cura di), Gli oggetti e gli altri. Saggi sui musei e sulla cultura materiale, Roma, EI Editori, 2000
TESTA Eugenio (a cura di), Scritti e altri lavori di Alberto Mario Cirese, Firenze, Leo S. Olschki, 2011
TOGNI Roberto, FORNI Gaetano e PISANI Francesca, Guida ai musei etnografci italiani. Agricoltura, pesca, alimentazione e
artigianato, Firenze, Leo S. Olschki, 1997
TOMEA GAVAZZOLI Maria Laura, Manuale di museologia, Milano, ETAS, 2003
TOZZI FONTANA Massimo, I musei della cultura materiale, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1984
[133]
TURCI Mario (a cura di), Storia di un museo. Il Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romanga. 1971-2005, Imola, Editrice
La Mandragora, 2005
- id. (a cura di), Antropologia museale, «La ricerca folklorica», numero 39, aprile 1999
TURCI Mario e FOSCHI Federica, MET. Museo degli Usi e Costui della Gente di Romagna. Guida catalogo, Rimini, Provincia
di Rimini, 2007
VERGO Peter (edited by), The New Museology, London, Reaktion Book, 1997
VOGEL Susan, Sempre fedeli all'oggetto, a modo nostro, in KARP Ivan e LAVINE Steven D. (a cura di), Culture in mostra.
Poetiche e politiche dell'allestimento museale, Bologna, CLUEB, 1995, pp. 119-136
ZIGLIO Corrado (a cura di), Etnografa delle professioni. Il caso della Polizia di Stato, Roma, Armando, 2000
[134]
APPENDICE
[135]
Intervista con Vincenzo Padiglione
Progettista e direttore dell’Etnomuseo Monti Lepini
del Museo del brigantaggio di Itri
Direttore della Rivista AM – Antropologia museale
“La Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Psicologia
Roma, 13 09 2011
Marco D’Aureli: come ti sei avvicinato al mondo dei musei? Tramite quale percorso?
Vincenzo Padiglione: il percorso è semplice, almeno nel mio ricordo. Nelle pratiche
sicuramente è stato qualcosa di più complesso. Tuto ha avuto inizio con una richiesta. Mi
chiesero di progetare un museo delle tradizioni equestri in Sardegna. Ciò avvenne intorno alla
metà degli anni Otanta; prima di allora non avevo avuto alcun interesse specifco per i musei.
In quegli stessi anni, come antropologo, ero molto interessato alla ricerca intorno al rapporto
uomo-animale, come testimoniano anche i miei scrit sulla caccia al cinghiale 1 e sul circo2.
Inoltre collaboravo con testate giornalistiche, come Cavallo magazine e Airone. Il rapporto
uomo-animale mi interessava molto. L’occasione che mi venne oferta da un Istituto regionale,
che mi chiedeva un progeto sulle tradizioni equestri sarde e sull’importanza del cavallo in
Sardegna per allestire un museo regionale del cavallo, mi fece pensare come antropologo, ma
anche come appassionato di cavalli, che immaginare un museo di quel tipo mi sarebbe
piaciuto. Fortuna volle che in quel periodo mi capitasse di frequentare gli Stati Uniti. Nel
Kentucky, che è la patria delle corse di cavalli e dei grandi allevamenti, vidi musei che trovai
particolarmente suggestivi. A Louisville visitai un museo sulle corse, un museo che con un
taglio molto legato a una sensibilità etnografca raccontava, tramite un diorama avvolgente,
una sorta di anello, una giornata all’ippodromo. Visitai anche un altro museo sul tema del
cavallo, che aveva un taglio di tipo esperienziale. Capii che si potevano fare musei diversi da
quelli tradizionali, e che la museografa che a me non piaceva poteva essere messa alle spalle.
Mi andai a informare a Neuchatel e in altri musei europei, e compresi che quello che mi
sembrava un abbassamento, cioè il raccontare una ricerca tramite un allestimento museale,
poteva essere un potenziamento, o comunque un modo diverso di comunicare gli esiti di una
1
2
Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Il cinghiale cacciatore. Antropologia simbolica della caccia in Sardegna, Roma, Armando
Editore, 1994.
Cfr. Vincenzo PADIGLIONE (a cura di), Gente del circo. Bestiari e altra umanità, Roma, Armando, 1986.
[I]
ricerca. Un modo che forse poteva risultante coinvolgente per tante persone. Mi si aprì un
mondo. In quel periodo era in ato anche una svolta rifessiva in campo museale, erano gli anni
della Nuova Museologia, e quindi c’era una sperimentazione incredibile. Questo mi
avvantaggiò molto.
M.D.: il Museo poi si è fato?
V.P.: no, tuto rimase a livello di progeto. Feci un periodo di soggiorno nel posto dove doveva
sorgere, Foresta Burgos, però poi per l’incapacità dell’ente di gestirlo, nonostante gli incontri e
le riunioni che organizzammo, non si partì.
M.D.: questo è stato il primo passo di un percorso più ampio…
V.P.: poi nacque la proposta di Roccagorga. Là c’era il progeto di un museo a tuto campo,
generalista, che la Regione Lazio non apprezzava. Forte della precedente esperienza cercai di
fare un progeto più specifco, consapevole che avrei dovuto dare spazio sia alla dimensione
partecipativa che a quella immaginifca. Ecco l’idea della grande foto 3 con cui partimmo,
proprio per favorire un coinvolgimento nel progeto della popolazione. Ero dell’idea che la
popolazione doveva essere socializzata al Museo. Quella foto è stata scatata nel 1992, ma il
Museo è stato inaugurato nel 1999. Cosa avevo tra le mani io nel 1992? Avevo solo il progeto
che stava per essere fnanziato. In quella occasione, con Donatella Occhiuzzi e con Antonio
Riccio, iniziammo una ricerca che vide anche il coinvolgimento di un mio amico pubblicitario
insieme al quale realizzammo la foto a cui facevo riferimento poco fa. Partii subito alla grande
con la volontà di atvare eventi che consentissero di fare la ricerca, e di creare afezione verso
il museo. Tuto si inflò per il meglio. Ci fu poi il lavoro dell’atelier per realizzare i quadret con
i soprannomi al quale parteciparono i giovani; contemporaneamente si realizzò un altro
laboratorio per la produzione di video e di artefat. Questo perché, come d’altra parte era
accaduto anche in Sardegna, partivo senza una collezione.
Pietro Clemente in un suo testo4 defnì il progeto del Museo di Roccagorga il primo esempio di
museografa etnografca postmoderna. Per me fu importante quel riconoscimento. All’epoca
non potevo contare sull’ausilio di AM 5, la sezione di antropologia museale dell’AISEA, e il
rapporto con Pietro Clemente era ancora inesistente. Non sarei andato avanti se non avessi
3
4
5
Cfr. Vincenzo PADIGLIONE, Ma chi mai aveva visto niente, op. cit., p. 18.
Cfr. Pietro CLEMENTE, L’Etnomuseo tra Roccagorga e Parigi: una conversazione, in Vincenzo PADIGLIONE, Ma chi mai
aveva visto niente, op. cit., pp. 190-191.
Sulla nascita della sezione di Antropologia museale all’interno dell’AISEA cfr. Vincenzo PADIGLIONE,
Presentazione, op. cit., pp. 13-26.
[II]
avuto una sponda, uno scambio continuo di confronto. In pratica è nei primi anni Novanta che
si costituì questa costola dell’AISEA. Io ero partito prima, Pietro Clemente pure si occupava di
musei da prima, come anche Mario Turci, Vito Latanzi. Nel fratempo negli Stati Uniti il
dibatto stava riesplodendo atorno al tema della collaborazione nei musei; Aldona Jonaitis,
per esempio, curò una bellissima mostra a New York che si basava sui materiali riguardanti il
Potlach raccolti da Boas e che era caraterizzata da una forte partecipazione dei nativi. In quel
momento ci incontrammo, e seppur con molte titubanze, ci rendemmo conto che, pur non
essendo alcuni di noi etnologi, riuscivamo a fare un lavoro di cooperazione importante.
M.D.: È in quel periodo che nasce questa rete di contat tra te Clemente… nell’ambito della
sezione di antropologia museale dell’AISEA?
V.P.: si, poco prima con Pietro. Poi devi pensare che la formazione di questa sezione interna
all’AISEA è stata vissuta come uno strappo dagli accademici. Io ero l’unico che stava
nell’Università, e ero un ricercatore peraltro. Antropologia museale fu uno strappo, però ci
permeteva di metere insieme gli studi sul e nel museo, e questo fu importante. In
quell’occasione ci scambiammo le posizioni, perché c’era Vito Latanzi da una parte che veniva
da un flone legato all’approccio storico-culturale romano; Carlo Nobili che era interessato al
punto di vista degli etnologi e in quel periodo era presente e leggeva molto; Mario Turci aveva
questa bella esperienza di diretore di un museo dove si faceva didatca e partecipazione
seriamente6; e io che ero forse il più spiccatamente legato alla ricerca, perché non ho mai
rinunciato, pur facendo museografa, a proseguire la ricerca. Quindi si metevano insieme
tradizioni diverse. C’erano anche quelli che venivano dal setore delle tradizioni popolari, ma
sempre con un piede dentro e un piede fuori
M.D.: viene messo in valore l’esperienza di AM e nascono altri musei…
V.P.: Roccagorga nasce senza fnanziamento europeo, ma nel fratempo altri proget
cominciarono a ricevere fondi da questi canali. È in questo modo che vennero realizzati il
Museo della Terre di confne di Sonnino, il Museo del brigantaggio di Cellere e il Museo delle
scriture di Bassiano. Anche il Museo del brigantaggio di Itri si fece con fnanziamento
europeo. Itri fu il secondo museo nella cui progetazione fui coinvolto, perché il collega che mi
aveva preceduto non se la sentiva di andare avanti: c’erano dei problemi, e là con un po’ di
coraggio presi di peto un tema molto grosso e poi insomma…
6
Il riferimento è al Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna di Santarcangelo di Romagna.
[III]
M.D.: grosso e delicato…
V.P.: si. Quello che ho sempre tentato, immaginando di dover aprire una strada, incontrando
molte difcoltà ma spesso riuscendoci, è stato porre la seguente questione: i musei si possono
fare in tanti modi e in tante prospetve; io sono un antropologo, e quindi devo cercare di fare
musei che possano essere a misura dell’antropologia e a misura dell’etnografa. Quello che
odio di più è l’approccio totalizzante, quando ti dicono “questa è la verità”, quando ti
raccontano una storia a tuto campo. Uno dei limiti che ritrovo nell’idea di ecomuseo è quello
di una cità ricostruita da innumerevoli punti di vista. Non approvo questo modello, perché è
più facile in questa maniera raccontare banalità e semplifcare a uso didatco. Non che questo
non possa essere utile, che non è quello che ama la gente, però io non necessariamente do
alimenti che la gente ama. Mi piacciono i musei parziali, volutamente non neutrali,
espressione di una prospetva circoscrita, per cui a Cellere ti racconto la storia di questo
Domenico Tiburzi atraverso la narrazione del giornalista Adolfo Rossi 7. È un taglio, ce ne
potevano essere tanti altri: uno storico probabilmente non sarebbe partito di lì. Poi ti racconto
la patrimonializzazione di questo brigante, e anche questo credo che sia un approccio nostro.
Se dovessi trovare elementi forti nel mio operato aggiungerei anche la dimensione
partecipativa, che laddove è stato possibile ho cercato sempre di favorire. Tuto questo è
dentro alla prospetva che come Antropologia museale abbiamo sempre coltivato,
intendendo il museo non come il luogo della perentorietà, dove dall’alto si dicono cose che
diventano i nuovi valori. Siccome la nostra è una società anomica, laica, dove perdono valore i
principi generali, si pretende che in qualche modo i musei siano luogo di una
patrimonializzazione e di recupero dei fondamenti. Con la scusa della memoria. Io penso che
sia sempre centrale l’elemento della rifessione.
M.D.: quando li progetavi, questi musei, pensavi a cosa sarebbe accaduto dopo
l’inaugurazione?
V.P.: questa è una bella domanda. Probabilmente, se avessi pensato a quello che sarebbe stato
il loro destino, alcuni non li avrei fat neanche.
M.D.: quanto conta la progetazione rispeto alla direzione nella vita di un museo?
V.P.: la progetazione è una scommessa, e lo è stata specie a Roccagorga o a Sonnino, che non
sono assolutamente luoghi turistici, non sono luoghi di passaggio, sono posti dove ci devi
7
Cfr. Vincenzo PADIGLIONE e Fulvia CARUSO, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi, op. cit..
[IV]
andare intenzionalmente. Se tu da quei paesi togli i musei non rimane alcuna “destinazione” 8,
non c’è in qualche modo costruzione di un luogo dove valga la pena andare. Poi andandoci
scopri che ci sono degli elementi interessanti, però non li trovi a portata di mano. In questo
senso il progeto di realizzare musei, anche sapendo o presupponendo la difcoltà di portarci
le persone, è stata la scommessa di immaginare uno sviluppo diverso.
M.D.: di atvare un circuito…
V.P.: si, ma con lentezza. Così è stato, si può dire tranquillamente, per Roccagorga e per Itri.
Hai visto a Itri che sviluppo? Le persone si sono afezionate al Museo. Si può fare questo in
altre parti? È come se tu lanci un sasso nello stagno, smuovi qualche cosa. Il museo lo si
costruisce come un dispositivo che tende alla partecipazione, anche se non è che la realizza
sempre. È un dispositivo di cui le persone tendono ad avere orgoglio, per cui capita il paesano
che viene dagli Stati Uniti e lo portano al museo, capita che il sindaco ci porti l’assessore, il
politico. Entra tra le cose di cui si può essere orgogliosi, e dopo dieci volte che uno ci va alla
fne ha anche leto qualche cosa. E un giovane, in qualche modo, crescendo dentro inizia ad
apprezzarlo, anche perché tendenzialmente le estetiche di questi musei tendono a combinare
un linguaggio di arte contemporanea con un linguaggio delle estetiche locali. Questa
combinazione è come una miccia che, anche se non sempre, può però funzionare.
M.D.: poi però fnita la progetazione, e dopo l’inaugurazione, inizia la vita ordinaria del
museo…
V.P.: è una fatica immane in una situazione di penuria economica e di devastazione politica
drammatica in cui versano questi piccoli paesi che uno neanche si immagina in fase di
progetazione. Le persone a volte hanno un piacere per confggere che gli fa perdere di vista i
contenuti. Questa situazione rende difcilissima la vita ai piccoli musei, per i quali non ci sono
mai fondi a disposizione anche se spesso sono oggeto di grande atenzione. L’esempio più
classico è che gli amministratori vogliono fare tuto all’interno di questi musei. Hai un tema,
che può essere quello del confne, della scritura, beh, cerca di giocartelo, perché se te lo
giochi ci fai anche un festival; invece no, si disperdono in infnite iniziative perché tendono ad
accontentare un po’ tut. Allora, in questo senso, penso che forse bisognerebbe fare una
valutazione preventiva dell’impato sociale che ha la nascita di un nuovo museo.
M.D.: c’è una cifra carateristica del “nostro” modo di progetare musei?
8
Cfr. Barbara KIRSHENBLATT GIMBLETT, Destination Culture, op. cit..
[V]
V.P.: Il modo in cui noi facciamo musei fa sì che le persone intanto apprezzino altre persone.
Una delle cose di cui vado più orgoglioso è che tut i collaboratori che hanno realizzato i musei
che abbiamo fato hanno mantenuto dei buoni rapporti e hanno inscrito una corretezza, e
anche una gratuità di interesse conoscitivo, nel lavoro che hanno svolto. Questo rispeto
invece ad altre esperienze in cui vengono avviati proget con spirito colonialista, come capita
di fare ai progetsti architet. Noi abbiamo un altro tipo di temperamento, anche quando le
cose non ci riescono perfetamente creiamo almeno dei legami che poi servono al museo.
M.D.: per tornare al ragionamento di prima, e per dirla con una batuta, è più facile progetarli
o dirigerli i nostri musei?
V.P.: più facile progetarli. Per realizzarli ci vuole, a mio avviso, una grande determinazione,
anche narcisistica se vuoi, perché uno deve pensare che la propria idea, il modo in cui sta
guardano le cose, sia quello giusto. Ci vuole una grande pazienza di intessere relazioni con tut
gli stakeholders e in qualche modo riuscire ad essere un interlocutore anche laddove si
prendono porta in faccia. L’esempio più classico è quello di Roccagorga. Il Museo di
Roccagorga nasce come polo etnografco del Sistema museale dei Lepini previsto dalla
Regione, e nel giro di un anno il presidente del consorzio che gestisce il Sistema si fa un suo
museo etnografco della civiltà contadina. Roccagorga doveva essere la “soprintendenza” di
riferimento per tute le emergenze patrimoniali di tipo etnografco, e invece si è creata questa
situazione. Sono porte in faccia. Anche perché poi chi ha realizzato l’altro museo è un preside
che crea un indoto con le scolaresche sotraendole all’altra strutura.
Il pensare come costruire l’oggeto, come modellare l’oggeto perché possa essere in un
museo e poi realizzarlo, indirizzare una compagine di persone nella ricerca, che poi è il motivo
per il quale siamo antropologici, fare ricerca, pur litigando, confggendo con architet, è il
momento migliore. Poi, nell’ultima fase, nella direzione, sei drammaticamente solo. Quella
della progetazione è una bellissima fase, un processo creativo quotidiano. Francamente devo
dire di essere molto legato a questo momento, che per me è proprio una droga allo stato
puro. La direzione è un’altra storia: non hai una lira, devi rincorrere dietro proget che
soltanto dopo un lungo periodo di tempo puoi scoprire se e quanto vengono fnanziati. Devi
limitare gli spazi di creatività. E devi servire dei padroni. Mentre nella fase di progetazione
immagini una installazione, che puoi anche sbagliare, ma se funziona ti prendi un bel
[VI]
vantaggio: la popolazione ci viene, si ritrova, i colleghi antropologi ci si riconoscono. Nella
direzione invece sei solo, sei drammaticamente solo e con una limitata possibilità di innovare.
M.D.: ma dove si impara a fare il diretore?
V.P.: io non ho imparato, ho rubato con gli occhi, dalle mail, leggendo i programmi di colleghi
che sono più qualifcati di me. Dico per tut Mario Turci, Gianfranco Molteni. A me ha
impressionato la capacità di Fulvia Caruso di trasformarsi in una buona diretrice 9. Sai, il
diretore deve essere sistematico, io tendo ad essere confusionario. Il diretore ha più capacità
di rapporto stabile con il territorio, io sono stato e sono più legato alle questioni della ricerca,
ad otenere delle collezioni, quindi ho fato molta fatica e quello che sono riuscito a far bene è
immaginare non tanto la quotidianità quanto degli eventi, come realizzare del teatro
comunitario, nuove ricerche. Ecco, in questi casi come diretore credo di aver dato il meglio.
Per il resto mi sono costruito uno schema una ingegneria organizzativa di cui forse ti devo
parlare. Non so quanti altri, o prima di me, abbiamo immaginato questo tipo di schema sul
ruolo del diretore. È una triangolazione dove c’è il diretore, l’operatore museale e
l’associazione. Questa modalità di lavoro forse oggi è diventata prevalente, ma quando ho
iniziato io non lo era. Questo modello si basa sulla legge 42 10, che poggia su due cardini:
operatore museale e diretore. In pianta stabile il primo (sesto, setmo livello), e un diretore
esterno a contrato. Ho costruito questo modello su Roccagorga e su Itri. A Itri volendo,
volendo e volendo sono riuscito a otenere un operatore museale. A Roccagorga invece ce l’ho
avuto da subito, un ex bibliotecario che faceva funzione da operatore. Come funziona questa
triangolazione? L’Associazione si occupa della normale amministrazione, cura le aperture e le
chiusure, sta dentro il Museo e deve gestirne il funzionamento. L’associazione è controllata,
supervisionata e orientata oltre che dal diretore dall’operatore museale. L’operatore museale
chi è? È l’interfaccia del Museo e del diretore con l’amministrazione. Il diretore chi è? Nel
caso mio è un assente, una persona alla quale viene dato un rimborso spese, quando viene
dato, di circa 1.000,00 euro l’anno, per cui devo circoscrivere e limitare la mia presenza sul
luogo. Però io controllo, in qualità di diretore, l’operatore museale, seguo le domande di
fnanziamento, curo i rapporti con la Regione. Sono presente, a livello di Regione, a quel tavolo
dove bisogna essere estremamente qualifcati e dove i discorsi che si fanno sono di caratere
9
10
Fulvia Caruso è stata direttrice del Museo della terra di Latera (VT) e del Museo del brigantaggio di Cellere (VT)
dalla sua inaugurazione (avvenuta nel 2007) al 2009.
Legge regionale 27 novembre 1997 n. 42 Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio.
[VII]
scientifco e culturale. In quel contesto la fgura del diretore è centrale. Se da una parte mi
sento di essere defcitario, -rispeto a quei pochi soldi che mi danno, dal punto di vista della
mansione più generale di diretore fornisco però ipotesi strategiche di funzionamento,
controllo la qualità delle esposizioni, faccio -riunioni con i diretori e con la Regione ad alto
livello e riesco ad orientare fondi che permetono a noi di fare delle cose, sia in termini di
didatca sia in termini di iniziative, sia in termini di iniziative pubblicazioni, performance,
ricerche sopratuto. M.D.: quindi il mestiere del diretore è come un mestiere artigiano, si impara a farlo “rubando
con gli occhi”. Ma cosa deve saper fare il diretore di un museo?
V.P.: il diretore deve orientare la prospetva entro la quale le atvità del museo e deve dar
bataglia se necessario. A Itri continuamente ricevo proposte di fare mostre dentro al museo, e
quindi continuamente sono sollecitato a capire se quella mostra non possa danneggiare il
museo dal punto di vista dell’immagine. Per me il diretore deve indicare la prospetva entro
la quale indirizzare le atvità del museo. Ma non solo. A livello di Sistema museale, di tavolo
dei diretori, deve rivendicare la strategica rilevanza, dal punto di vista patrimoniale, della
prospetva antropologica. Un Sistema può avere dei soldi da destinare, per fare un esempio,
allo studio delle capanne, ma se tu non fai presente che le capanne sono un tema importante
che parla del patrimonio contemporaneo, nessuno ti cede parte del fnanziamento per curare
quel versante della ricerca. E con quella ricerca tu fai lavorare l’associazione Monti Lepini, che
ha dentro antropologi, perché l’ho pensata come un luogo dove, per restare al caso reale, una
giovane antropologa può fare atvità di presentazione e guida, di didatca ma anche di
ricerca. Oltre a dare l’orientamento strategico, il diretore dovrebbe saper fare dei piani dove
c’è ricerca, dove c’è didatca; esplorare, prevedere mostre, immaginare una innovazione
continua, estensioni del museo, dialogo con collezionisti e storici locali, riuscire a far sentire a
casa chi si occupa del patrimonio, e chi pur non avendo la nostra specifca professionalità è
però curioso del setore. Dobbiamo trovare il modo di far sentire a casa gli storici locali, gli
storici di tradizioni popolari che sono a noi vicini e che molto spesso snobbiamo. Anche loro si
devono socializzare al museo. Ho sempre avuto l’idea che accogliendo le persone non soltanto
le socializzi a questa cosa strana – sopratuto in provincia – che è un museo, ma gli crei degli
interlocutori che possono fargli fare passi avanti. Se tu li socializzi, e questo deve essere
costante, con iniziative che piacciono a loro ma che sono congruenti (ecco il lavoro del
[VIII]
diretore), che non sono un abbassamento di livello, determini un avvicinamento di
esperienze. Come avviene secondo Geertz la descrizione? La descrizione è un costante
rapporto tra concet vicini e concet lontani dall’esperienza. Che vuol dire? Se io faccio una
etnografa locale devo fare in modo che le persone sentano quanto propongo loro vicino e
lontano; questa tensione tra mondo vicino e mondo lontano, straniamento e intimità, credo
che sia una cifra fondamentale dei nostri musei. Almeno, è la cifra che io ho sempre ricercato.
Le persone dentro al Museo di Roccagorga, un museo strambeto, penso che abbiano la
percezione in parte di riconoscere cose loro, in parte di sentirsi straniati. Se no gli dici soltanto
le cose che hanno sempre saputo.
M.D.: se il ruolo del diretore è dare la direzione, signifca che il diretore deve avere una
formazione specifca. Quale è, allora, il proflo ideale di un diretore di museo etnografco?
V.P.: beh, è dentro una scuola e dentro una formazione specifca: l’antropologia deve essere
intesa come uno strumento forte e non annacquato. Poi nei tirocini che insegnano non
soltanto la gestione ma anche la composizione museale. Per poter fare il diretore è necessario
conoscere il mestiere del montaggio video per esempio. Se fai il diretore e non sai di didatca
dell’esperienza, se non sai di montaggio video, se non sai di fonti orali, se non sai di
composizione museale, se non hai fato continua esperienza e se non ti sei messo a fare i conti
su come fare i proget, su come gestire un progeto e su come fare dei rendiconti... Questi
sono i tanti mestieri che uno deve conoscere, e deve conoscerli per poter richiedere qualità ai
suoi collaboratori, per richiedere un rigore. Un aspirante diretore deve essere un grande
curioso del setore dei linguaggi antropologici. A Cellere hai visto che a un certo punto
abbiamo chiesto a quel meraviglioso uomo di teatro che è Antonello Ricci una trasposizione di
una storia di Tiburzi. Ma se io non avessi visto all’opera Antonello, se non avessi fato leture
su Turner, se non avessi avvicinato il teatro antropologico di Barba, avrei pensato che queste
cose sarebbero state distanti e improponibili. Se il diretore è stato formato anche
all’etnomusicologia, al teatro, ha un po’ il controllo dei diversi linguaggi, perché il museo è uno
spazio multimediale. E poi devi avere capacità di saper gestire gruppi, persone
M.D.: quanto è importante l’aspeto puramente gestionale?
V.P.: è fondamentale. Questi sono aspet che si devono imparare facendo tirocinio. Io penso
che sia indispensabile fare un tirocinio presso un museo medio, articolato, dove impari a fare
un budget. Mario Turci ci ha insegnato a fare un budget sociale. Tu stai nel museo e fai il tuo
[IX]
lavoro, magari fai straordinari senza che ti vengano retribuiti: nel budget lo met tuto questo.
Il museo, per fare un esempio, ha avuto un budget di 5.000 euro, ma la prestazione che ha
dato è di 40.000 €, e io agli amministratori presento tute e due questi calcoli. E loro li devono
conoscere questi conti.
M.D.: cosa può fare SIMBDEA per i diretori di musei etnografci, e cosa possono fare i diretori
per SIMBDEA?
V.P.: questo è un problema complesso. Noi come associazione abbiamo pensato a un
organismo all’interno di SIMBDEA che fosse la rete dei diretori. Per confit interni questa
rete non è riuscita a decollare. Però SIMBDEA dovrebbe essere la rete dei diretori, e non è
deto che non lo diventi. SIMBDEA si è sempre pensata come un luogo di aggiornamento. La
rivista AM ha questa funzione, creare una serie di connessioni, per esempio con l’arte
contemporanea, che potessero consentire questo. Ci siamo riusciti? Non lo so. Un dato da
sapere è che la gran parte dei diretori dei musei etnografci non legge la rivista AMAntropologia Museale; noi non facciamo una rivista per i diretori. Perché? Probabilmente
perché la stragrande maggioranza dei diretori dei musei di civiltà contadina non sono
interessati all’antropologia. Sono interessati magari alla storia locale. Qua sta la bataglia che
ho fato all’interno di SIMBDEA, quella per potenziare la prospetva antropologica. Anche in
seno a organismi internazionale di museologia si tende a volte a stemperare la prospetva
etnografca.
M.D.: il diretore a chi deve rendere conto?
V.P.: beh, intanto alla sua amministrazione di riferimento, dal punto di vista dell’atvità; poi dal
punto di vista etico alla comunità dei museali e alla comunità di appartenenza. Che non è
marginale. Io non avrei potuto fare il diretore e neanche il progetsta se non ci fosse stata
SIMBDEA. Perché? Perché la nostra azione è eticamente sensibile. Che cosa vuol dire? Io sono
un appassionato di maschere, sono appassionato di certi temi. Ma è giusto che ci faccia un
museo? Mi incuriosiscono i banditi, ma ci faccio un museo? Tu pensa bene, il potere che può
avere un professore universitario investito da un sindaco. Un professore universitario può
permetersi il lusso di costruire un museo a suo piacimento, con tematiche che gli interessano,
con una chiave di interpretazione originale? Quante volte leggendo libri troviamo erroroni
prospetci? È la comunità scientifca alla quale tu appartieni che ti controlla e ti convalida in
parte. Nel mondo postmoderno, fato di verità plurali, rischi di essere solipsistico,
[X]
soggetvista. Vedi una cosa, la descrivi, e convinci un Comune a spendere un milione: il ruolo
di una comunità scientifca invece è quello di essere il luogo dove, insieme con la popolazione,
si esercita un controllo sul nostro operato. Io credo molto in questo. In questo sta la funzione
di SIMBDEA, che è il luogo dove si dibatono, si criticano certe prospetve. A -me sembra in
questo senso sia un luogo insopprimibile.
M.D.: quale è il bello di fare il diretore di un museo?
V.P.: c’è un bello narcisistico, perché tu ti appropri di cose che sono degli altri. Quante volte
uno, afermando una cosa non giusta, dice «il mio museo»? Il museo è di tut quelli che hanno
contribuito con te a farlo, è della comunità che ti ha dato afdato la storia. Però è anche vero
che in questo “mio” infantile, molto infantile, narcisistico e infantile, c’è il fato che ti hanno
oferto una occasione per metere insieme rigore e creatività, e questa è una bella cosa.
M.D.: a volte ti scappa questo “mio” perché il diretore spesso si trova a fare tuto al suo
interno… a prendersene cura in modo totalizzante…
V.P.: si, ma questo è un coltivare una onnipotenza che può essere pericolosa, per questo ci
vuole una comunità di controllo. Perché magari quello che tu dai al museo e senti come vitale
permete al museo di sopravvivere ma gli impediscono di fare altro. Quante volte mi sono
posto il problema: «ma perché sto mantenendo la direzione»? Io dovrei soltanto dire che il
museo non può andare avanti così, che è inutile, che non sono un buon diretore. «Avete i
soldi? Se no lo chiudete», punto e basta. Su Roccagorga c’è un testo 11 che mi paragona a
Fitzcarraldo… questa idea di imprese impossibili. Tuto questo coltiva in senso forte la nostra
onnipotenza. Questo “mio” può essere molto pericoloso. Però io ci vedo il piacere un po’
infantile di costruire castelli, di fare il meccano, di fare delle cose. Se tuto questo poi, quel
sogno che sei riuscito a fare, ha il compiacimento, la benedizione, il sorriso di colleghi e
sopratuto della comunità e di giovani in quella comunità allora sei l’uomo più felice del
mondo.
11
Lorenzo PIZZI, Come un film che ricordo, in Vincenzo PADIGLIONE, Ma chi mai aveva visto niente, op. cit., p. 218.
[XI]
Intervista con Gianfranco Molteni
Direttore Museo della Mezzadria senese di Buonconvento
Direttore del Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso
Direttore del Museo della terracotta di Petroio
Direttore del Museo d’arte sacra della Val d’Orcia
Siena, 17 10 2011
Gianfranco Molteni: il Museo della Mezzadria è un museo provinciale perché è stato fato
dalla Provincia, la quale ha reperito i fondi, ha istruito le pratiche, le gare e poi ha fato una
convenzione con il Comune di Buonconvento che, dalla sua, ha messo i locali. La convenzione
risale a metà anni Novanta, il Museo ha aperto nel 2002, e con essa l’amministrazione
provinciale assicurava di provvedere all’allestimento degli spazi dell’edifcio, operazione che ha
fato nel giro di cinque anni circa, e che è stata particolarmente doviziosa, nel senso di
onerosa, perché è costata non poco sia per quel che riguarda la parte struturale sia per
quanto riguarda l’allestimento vero e proprio. Il presidente della Provincia credeva molto nello
sviluppo della museografa senese, e ci ha investito parecchio; era un’epoca, quella, in cui il
Monte dei Paschi dava fnanziamenti alle province oltre che ai comuni, come suo costume, in
quanto ente che devolve gli utili agli enti locali. A un certo punto il presidente, dopo un viaggio
fato per andare a vedere alcuni musei in Inghilterra, si è innamorato della possibilità di avere
un livello multimediale elevato e ha costreto me e gli architet, ma in particolare gli architet,
a rifare il progeto per passare da un museo di impianto tradizionale, come era previsto
originariamente nel piano che avevamo fato alla fne degli anni Novanta, a un museo
multimediale come quello che abbiamo inaugurato. Questo ha signifcato, per dire della mole
dell’intervento, cablare tuto il Museo quando già erano state fate le tracce eletriche. Il fato
che sia un museo provinciale non solo ci avvantaggia perché è inserito nel PEG della Provincia,
ma perché noi oteniamo qualche fnanziamento aggiuntivo legato al PEG stesso. In particolare
ora, a nove anni dall’apertura, abbiamo un problema di rete e di gestione di tuta la parte
multimediale, e su questo argomento ho avuto di recente un incontro con il presidente della
Provincia e con l’assessore alla cultura. Pur con qualche taglio qua e là rispeto alle mie
richieste però, riconosco, interverranno per consentire operazioni di manutenzione
straordinaria. Correvamo il rischio di avere un museo spento, che signifca avere qualcosa
[XII]
come quaranta apparecchi fuori uso per quanto riguarda l’allestimento più altri venti per
quanto riguarda i servizi e la parte didatca: rischiavamo di avere sessanta apparecchi
multimediali spenti. La Provincia è già intervenuta in questo ambito quatro anni fa, sempre a
livello straordinario, sostituendo metà dei computer. Per quanto riguarda l’altra metà, le mie
collaboratrici – io non sono tecnicamente adeguato – cannibalizzano le macchine, nel senso
che utilizzano pezzi sotrat ad alcuni computer per farne funzionare altri. Se non avessi avuto
questi due interventi sulla parte informatica sarei veramente nelle pesti.
La Provincia considera il Museo della Mezzadria senese il suo fore all’occhiello, ed è il museo
“suo”; gli altri invece li considera musei della Fondazione Musei Senesi, Fondazione che è stata
fata, mi pare nel 2004, per la gestione dei musei, per aiutare gli enti locali dal punto di vista
fnanziario, innanzituto, e poi anche sul piano tecnico e della promozione. Io sono abbastanza
perplesso sugli esiti di questo provvedimento. Ci sono state due gestioni a partire dalla sua
istituzione. La prima è durata fno a due anni fa, dal 1975 circa; in questa fase l’azione non è
stata guidata da specifche competenze di museografa, si è tratato di una gestione in cui si
dava abbastanza autonomia ai diretori dei musei e magari si concedeva un’atenzione
privilegiata verso alcuni ambiti in virtù del fato che la diretrice dell’epoca era una storica
dell’arte e chiaramente tendeva a sviluppare il suo setore di competenza. Non ha afrontato,
quella gestione, a mio parere, il grosso nodo che è quello del rapporto tra i singoli musei, con
tute le atvità che essi portano avanti: la ricerca, la creazione di mostre o di singoli eventi, la
didatca e quant’altro mai, e il discorso di una programmazione complessiva. È il vecchio
problema degli USA tra federalismo da una parte e confederalismo dall’altra, cioè: quale deve
essere il ruolo del centro rispeto alla periferia, che è un ruolo molto complesso ma che non
viene, secondo me, afrontato con sufciente lucidità e analisi. Questo fa sì che le potenzialità
che ci possono essere nei singoli musei, tendenzialmente, non vengono sviluppate a meno di
avere personaggi che per età, per ruolo o per caratere sono abbastanza ribelli o possono
giocare sul loro, e allora a questo punto la gestione dei musei è autonoma rispeto alla
Fondazione. Afnché questo si realizzi però bisogna che abbiano strumenti i diretori, i quali
possono essere dipendenti comunali e pertanto con un certo status di autonomia, oppure
possono avere una autonomia propria sia dal punto di vista anagrafco sia lavorativo – è il mio
caso – che permete loro di sviluppare la propria operazione senza dover dipendere da un
centro che è abbastanza irreale nelle sue soluzioni. Sulla Fondazione, sui musei, c’è un
[XIII]
problema di fondo: tut i musei senesi sono territoriali, ma occorre lavorare sul conceto di
museo territoriale, capire realmente cosa vuol dire museo territoriale. Il museo territoriale
può essere un museo che ofre un punto di vista archeologico sulla storia antica di un certo
territorio; può ofrire un punto di vista storico-artistico, e anche in questo caso abbiamo un
passato remoto, per lo più; oppure può, come i musei DEA, ofrire una letura di quel territorio
dal punto di vista della contemporaneità o del passato prossimo. Ma avere dei rapporti coi
reperti, col territorio, signifca aver rapporti con la cultura del territorio e signifca, o dovrebbe
signifcare, tendere a sviluppare lo stesso rapporto nel presente: il museo territoriale deve
essere un ponte tra il passato, magari specifco per quel setore, e il presente. Non deve
chiudersi in sé stesso, deve avere atvità rivolte non soltanto al passato ma anche al presente.
Il museo territoriale, se perde di vista il territorio, fnisce per essere un nonsenso: ecco perché
il coordinamento dei musei non può prescindere dal fato che i musei sono territoriali. L’ultima
cosa che signifca: fare una programmazione particolarmente complessa, perché signifca
partire dal territorio e andare oltre il medesimo. Quando abbiamo, l’anno scorso,
programmato, due anni fa, il discorso sull’Anno dei mezzadri, la questione partiva dal territorio
per investire almeno tuta la regione. Quest’anno abbiamo fato un lavoro sui mezzadri, sui
contadini e il Risorgimento, e anche in questo caso ci siamo posti l’obietvo di partire da alcuni
documenti del territorio ma andare oltre il territorio, cioè vedere come i contadini si sono
mossi rispeto al Risorgimento. Son troppo lungo nelle risposte?
M.D.: no, va bene, in questa fase stiamo inquadrando il problema
G.M.: come è nato il tuto? Partiamo da questo che ti può servire. Vediamo come la
museografa senese si è sviluppata negli ultimi trent’anni. Per il setore DEA tuto è nato con
un rapporto iniziale tra l’Università di Siena e l’amministrazione provinciale. Questo rapporto
si è sviluppato fno a inizi anni Otanta in modo totalmente interrelato. In questa fase va
collocata la nascita di un centro di documentazione, il CEDRAC, nel quale lavoravano Pietro
Clemente, Piergiorgio Solinas, Maria Luisa Meoni, tut docenti universitari. Al suo interno, poi,
hanno cominciato a lavorare alcuni, allora, giovani: io, Vera Pietrelli, lo Scopolini, che o si
erano laureati o stavano laureandosi e che erano le seconde o terze linee. A un certo punto,
all’inizio degli anni Otanta c’è stata una operazione tra università e amministrazione
provinciale, nel senso che l’università ha voluto recuperare la sua autonomia e ha continuato a
mantenere rapporti tra il CEDRAC, di cui sono diventato responsabile, solo per singoli proget.
[XIV]
Non rientrava più, l’università, nella gestione complessiva del CEDRAC, ma rientrava in
rapporto ai proget che il CEDRAC elaborava, si sviluppavano delle sinergie su proget
specifci. Si lavorava insieme. Questo ha signifcato due aspet. Una maggiore operatività del
CEDRAC, ma anche, lo riconosco, debolezza politica. Perché precedentemente noi avevamo il
supporto dell’università, successivamente non avevamo altro che la longa manus della
Provincia: siamo diventati un centro della Provincia fnanziato dalla Provincia, che aveva
nell’università l’interlocutore; questo ha reso più debole il CEDRAC, tanto che negli anni, nella
seconda metà degli anni Otanta, c’è stata una erosione continua per quanto riguarda il suo
budget. Contemporaneamente, una volta diventato responsabile, ho portato avanti una
politica di valorizzazione del lavoro di documentazione che era stato fato e abbiamo iniziato a
cercare di avere un minimo di relazione con i comuni senesi puntando a, nei vari centri, creare
delle mostre temporanee. Così abbiamo fato a Sovicille, a Buonconvento: abbiamo fato delle
mostre in modo da legarci di più al territorio, perché il CEDRAC, inizialmente, essendo
provinciale, non aveva un legame territoriale ristreto, e così abbiamo iniziato ad avere i primi
rapporti…
M.D.: getare i primi semi di museografa insomma
G.M.: esatamente, e da lì è nata l’esigenza di portare dalle mostre ai musei. Tuto è nato da
una mostra che volevamo fare in cità e a cui, giustamente, teneva molto Maria Luisa Meoni.
Questa mostra non riuscì, ma per motivi di apatia politica dell’amministrazione comunale di
Siena dell’epoca. A mio parere, secondo me la cità è antirurale; la cità di Siena è altro rispeto
alla campagna, direi che fondamentalmente non la ama neanche particolarmente pur avendo
sempre vissuto grazie alla campagna. Allora ricordo che c’era Barzanti, che quando sentiva
parlare di una mostra sui mezzadri in cità gli venivano i capelli drit!
M.D.: eppure so che questo è stato un Comune storicamente di sinistra
G.M.: si, si, ma era proprio un problema di lungo periodo del rapporto cità-campagna che
dura dal Duecento, quindi era un po’ dura riuscire a cambiarla in breve tempo. Fallito il
tentativo della mostra abbiamo ripiegato sul tentativo di fare un museo invece che
raccogliesse la documentazione della provincia. C’era un gruppo di ricerca, nel gruppo c’era sia
Pietro Clemente sia Piergiorgio Solinas e poi anche due giovani architet molto volenterosi e
capaci. A un certo punto cambiò la giunta provinciale, cambiò come personale politico, perché
[XV]
nel senese la continuità per quanto riguarda l’appartenenza partitica è costante, e il nuovo
presidente bloccò il progeto, ma quando ormai erano state fate le gare. A questo punto ci fu
un grosso scontro e alla fne concordammo di fare un museo DEA sulla mezzadria senese ma
altrove rispeto a dove era stato programmato, cioè a Palazzo al piano, presso alcuni poderi
che erano la dependance della casa del conte Chigi. È in quel momento che viene fata la
scelta di andare a Buonconvento. Direi che la scelta è stata giusta, perché un museo isolato è
più problematico nella gestione, mentre Buonconvento poteva essere considerato il centro
della mezzadria senese. In più ci hanno proposto un paio di sedi, una più bella dell’altra, per
cui la cosa è andata bene. Da lì è nato, metà anni Novanta, il progeto del Museo di
Buonconvento e contemporaneamente quello della realizzazione di una serie di piccoli musei
che facessero un sistema unitario basato su due elementi: Buonconvento come elemento
centrale, io lo chiamo…
M.D.: musei satellite quasi…
G.M.: esato, “casa madre” perché, generalista, si sarebbe occupato di tuto, e gli altri specifci
in rapporto alle peculiarità del territorio. Per cui abbiamo fato a Sovicille il Museo del bosco,
perché lì c’era come elemento caraterizzante il rapporto tra mezzadria e bosco; a Serre di
Rapolano, il Museo sull’olio e sull’olivo; a Petroio il Museo sulla terracota e, ultimo nato, il
Museo del tartufo a San Giovanni d’Asso: ciascun museo con un elemento distinto, che ci
permete di fare un discorso Buonconvento come elemento centrale anche dal punto di vista
delle struture, mentre questi altri musei come elementi che documentano…
M.D.: dei link col territorio
G.M.: si… Il fato che io sia diventato diretore del primo museo e poi degli altri, ogni tanto
minaccio i comuni di dimetermi ma tre ancora li dirigo, dipende dal fato che sono stato il
coordinatore del CEDRAC e pertanto sono quello che ha portato avanti il passaggio dal centro
di documentazione ai musei, cioè da una fase di documentazione a una di valorizzazione.
Questo ha fato sì che si costituisse questa situazione. Poi non sono riuscito a far sì che ci fosse
un collegamento direto… dimenticavo tra l’altro tra i musei che abbiamo fato quello di
Monticchiello, TETRAPOS, probabilmente è stata una dimenticanza freudiana, perché è stato il
più complicato, il più difcile, quello che tut’ora… io non lo gestisco, ma ha maggiori difcoltà.
Nella gestione ad oggi la situazione è abbastanza positiva, nel senso che l’anno scorso
Buonconvento ha toccato i 6000 visitatori, tenendo presente che è un comune di 3100
[XVI]
abitanti. Lo stesso, veleggiamo sui 2000 a Rapolano, eravamo particolarmente alti a San
Giovanni d’Asso, raggiungevamo i 4000, poi abbiamo avuto la soppressione di una linea
ferroviaria speciale che ci ha tagliato le gambe. Ma riusciamo ad arrivare ugualmente ai 3000,
e tenendo presente che l’intero Comune di San Giovanni fa 900 abitanti e il centro 450, che è
fuori dai circuiti… è l’esempio che facendo iniziative continue si riesce a far sì che il museo sia
frequentato. Tutavia questo discorso è pericoloso, perché il Museo è come una carrozza a più
cavalli, bisogna evitare di dare troppe frustate a un unico cavallo. Bisogna, cioè, che tut i
cavalli corrano allo stesso modo. Se si fanno eventi devo fare in modo che ci siano
contemporaneamente i laboratori didatci e educativi che procedono, che la ricerca vada
avanti, che la programmazione di mostre vada avanti. Ciò a cui bisogna stare molto atenti è
che ogni tanto, e a me capita, lo riconosco, è uno dei miei tanti limiti, preso magari da una
mostra che mi sta piacendo particolarmente, che considero valga la pena di butarcisi a corpo
morto… anche perché in ogni museo sono io con un collaboratore, ecceto a Buonconvento,
dove i collaboratori sono due, perciò non è che ci sia un organico particolarmente… bisogna
evitare di spingere troppo su un cavallo lasciando indietro gli altri.
M.D.: da chi è composto il vostro pubblico?
G.M.: il pubblico è abbastanza variegato. In parte è legato ai laboratori educativi, e di questo
l’80% è scolastico, mentre il restante 20% è un pubblico che partecipa alle diverse iniziative
che promuoviamo: dai corsi sul vino a quelli sulla cucina, perché nel Museo della Mezzadria
abbiamo messo una cucina e faremo i corsi di cucina. Lo stesso per quanto riguarda il Museo di
San Giovanni d’Asso e per quanto riguarda il Museo di Rapolano, dove abbiamo organizzato
tuta una serie di corsi per assaggiatori d’olio. Allora, con le atvità educative conquistiamo da
un quarto a un terzo del pubblico. Ed è per quel pubblico che si lavora molto in continuità. Noi
quando progetamo una iniziativa cerchiamo di vedere al di là del solipsismo del diretore, del
suo narcisismo, vogliamo che abbiano riscontro immediatamente in alcune categorie del
pubblico. Abbiamo anche del pubblico legato a specifci eventi: mostre, spesso degustazioni,
iniziative nel corso delle quali registriamo un elevato tasso di partecipazione da parte dei
locali, con aggiunte di turisti che casualmente vengono. Poi c’è un terzo pubblico legato
genericamente alla Provincia, nel senso che in anni ci siamo fdelizzati parecchi visitatori che
contatamo tramite mail e altro. Ho delle collaboratrici abbastanza giovani che lavorano su
[XVII]
sistemi di informazione dinamici per cui si riesce a contatare un gran numero di persone. I
turisti, invece, sono quelli meno facilmente raggiungibili…
M.D.: capitano
G.M.: se io dovessi, se il Museo dovesse vivere solo del turismo credo che avremo solo un
decimo dei visitatori. Questo è anche perché siamo deboli nella promozione. Questa è una
delle pecche del rapporto tra musei e Fondazione, il cui lavoro dovrebbe essere quello di
coordinare iniziative, promuoverle, mentre invece questo avviene molto poco: il logo che
metamo tut'al più riempie di orgoglio, ma non aiuta l’iniziativa né economicamente né dal
punto di vista operativo. Atualmente siamo riusciti a creare dei canali con la stampa locale,
con alcuni programmi televisivi rispeto ai quali, questo per il Museo del tartufo ma anche per
il Museo della Mezzadria, il nostro rapporto è che se ci chiamano noi immediatamente
smetamo quello che stiamo facendo e di corsa andiamo a Roma a farci intervistare. Questo,
naturalmente, comporta essere abbastanza dipendenti e non riuscire a gestire in prima
persona, atvamente, un progeto di comunicazione. Allora noi abbiamo, in questa fase,
puntato a una comunicazione in cui la mostra o l’evento permete di far sì che il museo sia
frequentato e conosciuto. Non è la strada maestra, ma è quanto possibile fare, e qualche volta
bisogna ragionare su quanto è fatbile…
M.D.: non su quello che andrebbe fato
G.M.: non su quello che andrebbe fato. Non so se ti ho risposto su tuto o c’è qualche punto
che non ho toccato.
M.D.: Dove ha imparato a fare il diretore? Quali modelli? C’è stato un tirocinio particolare?
G.M.: Mi sento abbastanza self made man, cioè l’elemento fondamentale è venuto dalla
pratica, dall’esperienza, magari beccando qualche legnata e dando qualche testata. Ho avuto
dei vantaggi innegabili. Mia moglie era, ed è, diretrice della Pinacoteca di Siena, pertanto
avevo chi ha una esperienza di un grosso museo con cui dialogare. L’elemento fondamentale è
aver imparato da subito l’importanza nel lavoro museale del metodo del progeto, cioè di
immaginare il museo come un progeto suddiviso all’interno in tanti proget. Per capire
questo mi è servito molto aver partecipato alla creazione del museo; creare musei signifca
rendersi conto che non esiste soltanto ciò che appare al visitatore, che è la punta dell’iceberg,
ma esiste sopratuto ciò che non appare al visitatore. Creando il museo e litigando,
[XVIII]
polemizzando, amichevolmente, con gli architet si capisce l’importanza della parte
struturale, impiantistica, e via di seguito; e si capisce immediatamente che il museo ha
bisogno di una continua manutenzione e controllo in quello che io chiamo l’hardware. Il
problema è che l’hardware non si vede, e se io chiedo soldi per l’hardware faccio fatica doppia
che se chiedo soldi per una mostra. Cosa ho imparato allora? Che spesso i proget in un
museo devono avere una doppia valenza, da una parte esser proget che innovano il museo,
una mostra, una nuova sezione, ma dall’altro devono avere un quid nella progetualità che
interviene in quello che chiamo l’hardware del museo e che mi permete pertanto di… Ad
esempio: ho un problema nella nuova sezione per quanto riguarda la parte di illuminazione?
Devo rivedere tuta l’illuminazione del museo grazie a questo nuovo progeto. E via di seguito.
Questo signifca avere sempre in mente il “progeto museo” e far sì che ogni setore, dalla
gestione del personale a tuto, in realtà sia un intreccio di elementi; è questo che consente di
far in modo che la gestione del museo sia dinamica. Il museo muore se non c’è gestione
dinamica. La gestione statica è la morte del museo, da tut i punti di vista. Io purtroppo non
ho un budget. In tut i miei musei non ho più un budget e devo inventarmelo. Inventare un
budget signifca iniziare a chiedersi quali siano i bisogni del museo a partire dall’hardware: c’è
il teto da sistemare, ho problemi con la grondaia, devo trovare il modo per convincere
l’Ufcio tecnico a mandare un operaio, il che non è semplice, perché non son lì che mi
aspetano, anzi! Allora dobbiamo studiare un progeto per cui una volta l’anno c’è una cena
dedicata all’Ufcio tecnico, a tut gli operai, per creare un intreccio tra museo e quel setore
dell’amministrazione, in modo tale che il nostro non sia un dialogo tra estranei ma sia tra
coloro che partecipano allo steso progeto. Questo è un esempio che è moltiplicabile. Quando
io non faccio questo avverto che il Museo fnisce con l’essere per il Comune un peso. Perché se
io non motivo continuamente quelli che lavorano nel Comune a farsi carico dei problemi del
museo divento «quel rompiscatole del diretore», ma non solo: «che palle avere il Museo…».
E’ un lavoro continuo, di coinvolgimento. Ecco perché deve essere dinamico, perché se io
penso che l’aver fato a maggio una cena con l’Ufcio tecnico o con gli ufci amministrativi
m’abbia risolto il problema sarei veramente un illuso.
M.D.: ha avuto modelli a cui ispirarsi?
G.M.: direi di no, se non un modello tipicamente antropologico che è quello di concepire il
museo come un megamodello dinamico, quello sì. Gli studi mi hanno aiutato in questo.
[XIX]
Secondo me l’aspeto fondamentale, di questo sono molto sicuro, almeno fno a oggi, è il fato
di essermi sporcato sempre le mani nei musei che io poi ho direto; “sporcato le mani” nel
senso di aver preso parte alla loro realizzazione. Ho imparato tuta una serie di elementi
tecnici facendo quello, che poi mi sono serviti. Spesso, a mio parere, una parte della
museografa italiana è una museografa che è al di fuori dei musei. Intendimi bene. Mi va
benissimo, molto spesso possono avere delle idee, degli stimoli notevoli, però se io devo
pensare, se devo suggerire un percorso a un giovane, gli direi «fai uno stage presso un museo
che viene costruito, impara cosa signifca integrare l’eletricista col muratore, coordinare i
tempi in modo da…»: questo iter permete, un domani, di conoscere il museo e,
secondariamente, di capire l’integrazione tra i vari aspet che lo compongono. Questo è
importante, non pensare mai che il museo sia un elemento concluso, con un suo centro. Mi
sembra che sia stato Le Corbusier a defnire il museo una macchina; io credo molto nella
macchina museale, che è di una complessità spaventosa per cui io sostengo che noi negli
ultimi trent’anni abbiamo creato dei musei senza averne la consapevolezza di cosa signifcasse
creare un museo. Oggi, che si è un po’ fermata questa tendenza molto forte che c’era negli
anni Novanta a creare musei, si punta più alle mostre, e bisognerebbe fare una bella
rifessione ad esempio sul fato che non ha più senso fare l’iter che ho fato io e che è stato
casuale… Ho avuto la fortuna di avere Cirese a Siena, poi Pietro Clemente, mia moglie: ho
avuto una serie di fortune, in più sostengo che essendo io lombardo-milanese ho l’operatività
nel sangue, e questo mi aiuta. Oggi come oggi bisognerebbe iniziare a pensare a far fare degli
stage ai giovani proprio partendo dagli allestimenti, ma con un occhio anche alla gestione.
M.D.: a proposito di stage… il suo percorso di studi quale è stato? Formativo, in generale…
G.M.: io vengo da una famiglia di medici: nonno medico, papà medico, per cui sono venuto a
Siena a studiare medicina, poi mi sono accorto che caraterialmente i malati mi creavano dei
problemi, da un lato, dall’altro non amavo la medicina, per cui sono passato a flosofa.
Probabilmente nell’antropologia culturale sono venuti fuori due aspet: un aspeto legato alla
personalità di Cirese, c’era Cirese quando sono passato all’antropologia, anche se non son
passato per Cirese, l’ho conosciuto dopo; l’altro legato al fato che io considero un aspeto
importante dell’antropologia la dimensione operativa nella ricerca sul campo, che nel caso mio
caso diventa quella della ricerca e della gestione della realtà museale. Per il caratere che ho, il
momento teorico deve essere accompagnato dal momento della operatività. Successivamente
[XX]
il CEDRAC è stato il contesto in cui la mia atvità di ricerca e documentazione si è formato.
Devo molto a Maria Luisa Meoni, a Piergiorgio Solinas: poi a un certo punto è iniziato, dopo gli
anni Otanta, un sodalizio con Pietro Clemente che è andato avanti nonostante le sue
peregrinazioni nella diverse università. Pietro mi ha anche chiesto di scrivere la prefazione di
quello che io considero il suo testo più complesso, Graft di museografa antropologica
italiana12. Ricordo una volta, lui non se ne è mai occupato molto di Buonconvento, perché era
già a Roma… una volta Pietro Clemente è venuto insieme a me a vedere il cantiere di
Buonconvento ed è rimasto stupito del fato che io parlassi di questioni eletriche con
l’eletricista, con l’idraulico… e cioè che io dialogassi con loro di questioni operative e pratiche.
Questa è una cosa che ogni tanto tiro come amichevole e bonaria batuta a Paolo De Simonis,
che è uno che ha fato musei ma non vuole gestirli: fosse per me stabilirei per legge che gli
architet e i curatori scientifci dovrebbero essere obbligati a gestire il museo per almeno tre
anni dopo l’inaugurazione, per rendersi conto degli errori commessi
M.D.: una paternità imposta
G.M.: anche perché quando noi quando facciamo il museo abbiamo due sguardi. Uno è quello
dell’inaugurazione, l’altro è quello della gestione. Se noi non abbiamo il problema della
gestione, il nostro sguardo è quello dell’inaugurazione, che è quello degli architet. Ho avuto
la fortuna di lavorare con gli architet bravi, che mi hanno dato, mi hanno arricchito, però il
loro difeto quale è? Sfotendo dico: voi avete in mente il museo del taglio del nastro, però
non tenete nel giusto conto il fato che in questo museo passeranno un tot persone e che
pertanto i materiali vanno considerati per tot persone. […] Altro esempio per quel che riguarda
la parte acustica. Se noi vediamo il museo e lo percepiamo sulle piante degli architet abbiamo
un museo silenzioso, quando invece arriva il giorno dell’inaugurazione il museo viene invaso
dal caos. Ma solo se giriamo per le sale in un giorno qualsiasi quando ci sono i visitatori
iniziamo a percepire il rapporto tra i rumori e il museo; questo può accadere solo a chi il
museo lo gestisce e lo vive quotidianamente. Io sostengo che la gestione ti da la vista lunga,
che invece la non gestione non ti da. Poi intendiamoci, dato che io dirigo i musei porto acqua
al mio mulino.
M.D.: al momento dirige Buonconvento e altri tre, giusto?
12
Pietro CLEMENTE, Graffiti di museografia antropologica italiana, op. cit..
[XXI]
G.M.: atualmente… Mi son dimesso a febbraio dal museo di Rapolano, per uggia nei confronti
della giunta. Dirigo Buonconvento, San Giovanni d’Asso, il Museo della terracota (anche se
con periodi durante i quali l’incarico non è rinnovato) e poi il Museo dell’arte sacra della Val
d’Arbia, un museo storico-artistico che ha fato mia moglie e chiaramente lì metamo le due
competenze: lei la parte scientifca, io quella gestionale. Dovrei dirigere, con coerenza con
quanto deto poco fa, il Museo della miniera di Caviglia che dovremmo aprire tra poco tempo.
Riesco a fare tuto questo, contemporaneamente insegnando a scuola, perché in realtà i musei
che ho atualmente sono gestiti dalla stessa cooperativa, e questo aiuta molto. A Rapolano
avevo una cooperativa diversa e la fatica era notevole, perché hai interlocutori diversi. L’idea
mia è che piano piano voglio riuscire un atmo a capire come creare persone che prendano il
mio posto. Su questo spero di cominciare un percorso virtuoso con Fabio Mugnaini in modo da
vedere nel tempo se riusciamo a creare delle fgure di diretore del museo, a stimolare qualche
ragazzo a far qualche stage.
M.D.: nella direzione del museo ci sono due aspet fondamentali da controllare, quelli
gestionali e quelli scientifci. Come vanno mescolati questi? Come vanno mantenuti in
equilibrio? In generale: cosa deve saper fare un diretore di Museo?
G.M.: l’equilibrio dipende dal discorso che facevo prima in merito al conceto di progeto. Se il
progeto è dinamico la gestione non può che essere stretamente collegata alla scientifcità,
all’indirizzo scientifco; se il progeto è statico e ci si accontenta di gestire il museo così come è,
allora prevale la dimensione gestionale: penso ai bigliet, cerco di avere più visitatori e così
via. Ma se, come è il caso dei nostri musei, il progeto è dinamico, devo far sì che progeto
scientifco e gestione siano interrelati. Banalizzo e cerco di spiegarmi meglio. Il 2015 con l’expo
di Milano dovrebbe diventare un obietvo scientifco e un obietvo gestionale; io con Mario
Turci e altri vorremmo vedere di far sì che nel discorso sul cibo locale, uno dei temi dell’expo, i
musei DEA divenissero interlocutori importanti. L’idea è: sviluppiamo questo setore scientifco
dell’alimentazione, che tra l’altro ci permete di approfondire tuta una serie di nodi teorici; ci
permete di avere un pubblico, perché oggi il turismo gastronomico aggrega molto e piace;
contemporaneamente ci poniamo un obietvo che condensa i due elementi di essere presenti
con le capacità di presentare forme di documentazione e valorizzazione delle alimentazioni o
delle cucine locali. Ecco, in questo senso a mio parere non esiste una cesura neta. Sai dove c’è
cesura? A mio parere proprio nel dire: il museo ha come, diciamo, "missione", riprendiamo
[XXII]
questo termine che è andato un po’ fuori moda, quella della documentazione. Questo è
l’elemento più scientifco che c’è, indipendentemente dal fato che tuto venga valorizzato.
Noi stiamo adesso lavorando su un progeto di catalogazione online di oto musei della
Toscana, e questo è un elemento pretamente di documentazione scientifca che non è
diretamente legato alla valorizzazione, poi avrà delle ricadute… è un elemento di scientifcità
autonoma rispeto alla valorizzazione; fa parte di quello che prima ti chiamavo all’hardware
del museo. Il museo deve essere l’elemento che documenta. È stata superata in questi ultimi
dieci anni la vecchia concezione per cui il museo è il luogo dell’oggeto materiale, e dato che
oggi è diventato senso comune che il museo sia immagine, sia audio, sia immateriale, abbiamo
la possibilità di creare una documentazione materiale e immateriale che ne fa l’elemento
scientifco… Questo non è che risolva tuta la scientifcità del museo, però può fare una cosa.
Siccome il museo non è una catedra universitaria, fornisce il materiale al pubblico per poter
approfondire, fare analisi… Su questo il mio sogno, e rimarrà un sogno, è quello di creare una
grande rete, adesso la faremo per oto musei, tale per cui i documenti circolino online e uno
possa vederseli autonomamente…
M.D.: un sistema museale tematico…
G.M.: un sistema museale che abbia una documentazione che permeta a ciascuno di entrarne
in possesso… Sono un fruitore del museo e voglio studiare l’alimentazione? devo avere la
possibilità che tut i documenti materiali e immateriali presenti nel museo siano accessibili;
questo arricchirebbe chiunque, perché un sistema simile deve essere aperto a tut, da dentro
e da fuori li museo. A questo punto abbiamo creato per quel museo la spina dorsale della
documentazione che può servire, si spera, a tut, perché il Museo è nato con la Rivoluzione
francese come momento di democrazia e di partecipazione democratica.
M.D.: quali opportunità ofre il museo all’antropologia?
G.M.: uno è quello che ho appena deto, la documentazione a 360 gradi. L’antropologia, a mio
parere, ogni tanto, ma in realtà ogni spesso, si dimentica che è necessario, Cirese
approverebbe, stabilire delle regole oggetve. Le regole oggetve, su questo Cirese è stato
mio maestro, signifca che noi dovremmo cominciare a ragionar sul fato che la ricerca può
essere specifca, idiografca, di un singolo evento eccetera, va benissimo, però dobbiamo
cominciare, visto che oramai lavoriamo da anni, a creare un tessuto connetvo di sfondo dove
inserire meglio le nostre piccole ricerche che spesso sono isolate rispeto al contesto. Sono
[XXIII]
nato in un periodo in cui l’antropologia era legata al marxismo. Mi sono fato i miei bravi
seminari di antropologia e marxismo all’Istituto Feltrinelli, poi abbiamo superato molte cose,
alcune categorie interpretative di caratere complessivo non sono più state un elemento di
grande rifessione; ed è stato positivo, perché abbiamo cominciato a lavorare sulla
soggetvità. Ma questo non signifca che noi non dobbiamo, a un certo punto, porci il
problema che la soggetvità è il risultato anche di molte soggetvità, per cui di recuperare la
vecchia strada del comparativismo, delle presenze che non siano del singolo… La ricerca sullo
specifco va sempre bene, intendiamoci, a pato che sia una ricerca alla quale abbiamo noi
afdato un valore euristico importante, al di là del singolo. Vedo che molto spesso le ricerche
fniscono con essere ricerche “chiuse”, sul singolo evento.
M.D.: quanto la natura disciplinare del museo condizione il diretore. Esiste un modo
particolare di essere diretore di un museo antropologico?
G.M.: bella domanda. Io sostengo che a un certo punto c’è una componente comune a tut i
diretori di musei e che esiste un minimo comun denominatore che è quello di essere
museograf. Indipendentemente “da”. Però atenzione, poi c’è il fato che ogni fenomeno che
io documento ha una sua sensibilità, una logica. E lì c’è una diferenza. Nel senso che io posso
fare, e ogni tanto cerco di farlo, nel museo d’arte sacra posso cercare di metere l’occhio
dell’antropologo, però questo accade all’interno di un allestimento che è comunque un
allestimento storico-artistico. Atenzione: l’hardware vale per tut i musei. Ci sono delle
specifcità. Pensa alla luce; la questione della luce in un museo storico-artistico quanto è
diversa rispeto alla luce di un museo antropologico! Però il museo storico-artistico, con la sua
esperienza estremamente grande sui temi della museotecnica, ci può aiutare, da questo punto
di vista può essere per noi un vaso comunicante. Così come il museo archeologico, penso a
Carandini e ai suoi lavori sulla cultura materiale, ugualmente ci serve. Io penso che alla fne
occorrerebbe preparare in modo comune persone che abbiano una cultura diversa (storici,
archeologi, antropologi) con un corso di museografa che dovrebbe essere per il 75% comune.
C’è stato un periodo un po’ radicale in cui dicevo che la museografa era predominante su
tuto, adesso sono più moderato. Poi facciamo degli esempi. Il museo deve oggi confrontarsi
con forme di comunicazione estremamente diverse. È chiaro che, per quanto riguarda il visivo,
è dominante il setore storico-artistico, per via della luce eccetera. Invece per il setore
acustico secondo me dominante deve essere il setore DEA; perché il setore DEA lavora con la
[XXIV]
voce, e qui secondo me siamo ancora indietro. Dato che noi lavoriamo con interviste e
crediamo nella voce, dobbiamo sulla voce andare molto avanti. Io sono dell’idea che i botanici
ci dovrebbero aiutare molto più di quanto ci aiutano atualmente per il setore dell’olfato,
perché il setore sensoriale è quello dove i musei italiano sono più deboli. Purtroppo abbiamo
poche occasioni per atvare un sistema di vasi comunicanti; li abbiamo su altre cose che sono
state importanti in passato, pensiamo agli allestimenti; adesso forse dovremo un atmo dire:
«signori, perché non lavoriamo un atmo ofrendo ciascun setore un punto su cui
dialogare?». Io sostengo che chi fa un percorso di museografa debba conoscere la storia della
museografa, senza dubbio, perché dalla storia delle museografa vengono fuori problematiche
centrali, che debba conoscere anche i nodi teorici della museologia, se vogliamo usare la
vecchia distinzione, ma debba anche farsi dei corsi e degli stage per quanto riguarda la
gestione.
M.D.: e poi, oltre alla formazione codifcate l'osservazione, perché mi sembra che il lavoro del
diretore è come un mestiere artigiano, si ruba con gli occhi, si impara facendolo…
G.M.: si ruba con gli occhi e con le orecchie, perché senti anche come il diretore trata il
sindaco una volta in un modo e una volta in un altro. Nel senso che hai bisogno di capire che
tu, da tut i punti di vista, hai un sistema di relazioni a cui far riferimento, e quel sistema devi
saperlo gestire, devi capire che a un sindaco non sempre devi rispondergli di sì, devi sapere
che l’Ufcio tecnico è un elemento che non puoi permeterti di avere contro. Se hai contro
l’Ufcio tecnico è meglio cambiare mestiere. Son radicale, ma è per capirci. Puoi fare la litigata
con il sindaco, ma con l’Ufcio tecnico non ti conviene. Puoi litigare con l’amministrativo, ma
se non ti mandano gli operai a ripararti le cose sono problemi grossi.
M.D.: ci sono diferenze tra gestire un museo piccolo e un museo grande oppure tut e due…
G.M.: c’è una bella diferenza, tra tut i punti di vista. Il museo piccolo è un disgraziato, perché
ha problemi da museo grande però non ha le risorse da museo grande, non ha personale da
museo grande e non ha la visibilità del museo grande. Insomma, i problemi sono gli stessi,
però ti trovi di fronte a possibilità di intervento diverse. E questo obbliga a lavorare con
maggiore impegno. Io sostengo che se dovessi dirigere un museo più grande rispeto ai miei mi
riposerei. Un museo piccolo, compreso quello di Buonconvento che avrà circa 2000 mq di
superfcie, con tuto che ha due persone, e il sabato e la domenica solo una, mi costringe a
fare molte cose in prima persona, perché un disgraziato di operatore non può stare dietro al
[XXV]
bancone, rispondere al telefono, fare bigliet, fare ricerche al computer, poi si spara… Io
spesso devo fare le visite guidate, faccio… In realtà come diretore non hai ruolo reale,
d’accordo? Non ti limiti al lavoro dietro le quinte... Poi ci sono altre cose. Per esempio siamo
gemellati col museo Guatelli, e andremo su a novembre… cosa ho fato? Io cerco, per quanto
posso, di far sì che i miei collaboratori partecipino anche atvamente, presentino relazioni,
cioè: che non siano operatori museali operativi e basta, ma facciano anche rifessioni. Le mie
collaboratrici sono due, una che lavora sulla didatca e una che lavora nel setore
multimediale: a entrambe ho chiesto di presentare una relazione al prossimo convegno. Ti da
più soddisfazione alla fne il museo piccolo, perché io sono dell’idea che è bello riuscire a
gestire tute le varie parti.
M.D.: per quello che è la mia esperienza il diretore è diretore, eletricista, operatore della
didatca, giardiniere, grafco, addeto alle pulizie...
G.M.: apparecchia i tavoli… però questo è il piccolo museo. Ma è anche il bello del piccolo
museo, perché alla fn fne hai competenze su tuto
M.D.: sì, però poi non ci si arriva fsicamente a volte...
G.M.: io sto facendo una operazione di tipo schizofrenico: da una parte i miei collaboratori
sono abituati a far tuto, facciamo insieme tuto. Dall’altra li vorrei specializzare, e di fato lo
sto facendo: chi si occupa più della didatca, chi più della multimedialità…
M.D.: pensa che sia necessario che un museo antropologico sia direto da un antropologo?
Perché? In parte lo abbiamo già sforato questo argomento.
G.M.: sostengo che i migliori museograf tendono ad essere antropologi, non perché abbiamo
uno stigma particolare, ma perché hanno una visione del complesso, mentre invece molto
spesso archeologi, storici dell’arte, hanno una visione dello specifco, perdono il tuto, non
hanno una visione sistemica. Anche a livello progetuale, tendono a fare proget specifci. Noi
nel nostro caos, per cui il buon Cirese ci rimproverava di essere un po’ faciloni, in realtà
riusciamo a gestire la complessità. Bene, male, però la gestiamo. Uno dei complimenti
maggiori che mi ha fato Sandra Becucci è quello di avergli insegnato, quando dirigevo il
Museo del bosco e lei era mia collaboratrice, l’arte della direzione; un’arte che lei ha imparato
rubando con gli occhi, empiricamente. A questo punto però abbiamo fnito l’epoca eroica, in
cui ci si inventava… forse varrebbe la pena di fare una rifessione maggiore. Per segnalare il
[XXVI]
livello di difcoltà che atraversa la museografa DEA noto questo: da una parte noi abbiamo, a
mio parere, un gruppo di persone che fanno i diretori a tempo pieno (Turci, Kezich, Perco). Mi
sembra di notare che si sia formato di fato, senza volontà, il gruppo dei diretori di museo che
spesso sono a sé stanti e chiusi nel museo perché il museo non gli permete di respirare.
Dall’altra parte vedo i teorici, i catedratici. Bisogna un atmo riuscire a intrecciarsi di più. I
diretori devono riuscire ad imporsi di aver tempo per uscire dalle loro problematiche
quotidiane e i teorici devono un po’ di più sporcarsi le mani. Perché se no si rischia di parlare di
due cose diverse.
M.D.: uno scollamento tra questioni di caratere teorico e …
G.M.: noi abbiamo avuto una fortuna fno a adesso: le elaborazioni di Cirese prima e Clemente
dopo… che sono due che non hanno mai direto musei. Cirese non so se ha fato musei,
secondo me no; Pietro era diretore di un museo mai nato ad Alberese, poi ha la responsabilità
(lo dico afetuosamente) di un museo che non è riuscito: TETRAPOS, perciò appartiene… e
inoltre era coordinatore con me e con De Simonis per il Museo della piana di Lucca. Deto così,
ma non vorrei che lo fosse, sembra proprio la classica barzelleta dell’ingegnere spaziale che
non sa metere insieme due cavi eletrici. Però c’è questo diverso approccio, diversa logica.
Intendiamoci: è bene che ci siano, però devono mischiarsi un po’ di più. […]
M.D.: al di là del cambiare lampadine e del fare tuto, che tipo di rapporto la lega
all’amministrazione? C’è un mansionario?
G.M.: io sono anarchico nei comportamenti e mi afdo a due o tre cose. Ho imparato, facendo
il diretore self made man, che è fondamentale fare una doppia programmazione, una di lungo
periodo sui tre-cinque anni, l’altra annuale, e ho cercato di costringermi a formalizzarla in un
progeto da dare ad assessori e sindaci. Sono convinto che non le hanno mai lete, però io la
faccio ugualmente. Una forma di autocostrizione a rifetere. Io uso generalmente il periodo di
Natale per fare due operazioni: incamerare i dati dell’anno passato (presenze, spese) e l’altro
per vedere la programmazione dell’anno successivo del programma quinquennale che mi sono
dato. Io credo che elemento fondamentale sia fare una programmazione e tenerla in mente
senza diventarne schiavo totale, nel senso che le innovazioni, le improvvise cose che ci sono,
ben vengano. Il problema nostro è che facciamo programmazione senza avere un budget: io
meto all’incirca dei costi che sono variabili e che dipendono dalla mia capacità di trovare il
[XXVII]
fnanziamento. Mi chiedevi ricerca, gestione: io meterei un terzo elemento, che diventa
sempre più forte e rischia di diventare la metà del lavoro; io lo defnisco, per scherzarci sopra,
fare il frate elemosiniere. Sempre più devo andare in giro a cercar soldi. Se no non mi arrivano.
Se non riesco a otener fondi tuto il discorso sul museo dinamico salta. […]
M.D.: il rapporto con l’Amministrazione è annuale o pluriennale?
G.M.: né annuale, né pluriennale. Ci sono due aspet, uno giuridico e uno reale. L’incarico è
annuale e in futuro dovrà essere triennale. Atualmente siamo in prorogato da un anno e
mezzo. Io sono una fgura forte, perciò non ho problemi; sono musei che ho fato io, o me ne
vado io o non mi butano fuori. Gli altri diretori sono in una situazione di maggiore difcoltà,
di fragilità. Oggi come oggi c’è una situazione caotica dal punto di vista della gestione. La
Fondazione Musei Senesi, riceve i soldi dal Monte dei paschi, al 90%; li altri li prende dalla
Provincia. La gestione è concepita così: il 70% del costo del personale lo paga la Fondazione, il
30% i comuni; le utenze le pagano i comuni. Il comune fnisce per pagare intorno al 55% del
totale. Poi ci sono altre due voci grosse: manutenzione ordinaria e straordinaria, che paga il
comune. Alla fn fne se met insieme tute le voci il comune è quello che paga di più. La
Fondazione ha fato una politica per non farci chiedere diretamente soldi a Regione e
Provincia: da questi enti i soldi se li becca lei. Capisci che quando dico frate elemosiniere
signifca che io devo andare a cercare non presso le struture istituzionali, che mi sono
precluse, ma atraverso altri canali, inventarmi cose. L’ultima è stata la fliera corta per
Buonconvento, che mi ha consentito di otenere alcuni fnanziamenti che mi permetono di
continuare a fare iniziative.
M.D.: quale è il bello di dirigere un museo?
G.M.: il bello di unire la parte della documentazione a quella… Riuscire a far sì che… Io
sostengo che il museo è un momento di divulgazione. Il suo essere momento di divulgazione fa
sì che… diceva la pedagogia barocca, di dare la medicina amara nel bicchiere zuccherato.
Quando io vedo che riusciamo a far capire ai visitatori elementi che altrimenti sembrerebbero
noiosi, perché atraverso l’uso del museo, delle forme, del linguaggio del museo, riusciamo ad
appassionarli, questa è la soddisfazione maggiore. Tieni presente che il mio primo vestito è
quello di essere insegnante, e credo che me lo porto dietro anche come diretore del museo.
Dare a valori che considero importanti delle forme di comunicazione che siano piacevoli e che
[XXVIII]
arrivino. Ecco la mia bataglia contro i musei scrit. Dopo il terzo pannello non legge più
nessuno.
M.D.: mi parla di una duplice veste, quella di insegnante e quella di diretore: che rapporto c'è
tra le due? Lavorare in un museo cosa signifca per lei?
G.M.: lo considero una parte intrecciata della mia vita. Anche perché qualche volta le unifco le
due questioni. Insegno in un istituto tecnico, l’anno scorso quando ho pensato la mostra sul
Risorgimento ho ideato un pannello eletrico che poi è stato realizzato dai miei alunni di
quinta; adesso faremo un lavoro sull’alimentazione in cui coinvolgerò gli alunni di quinta
informatica. Cerco di collegare. E poi ripeto: credo che il museo sia un momento di
divulgazione. C’è il momento di ricerca teorica, e d’accordo, a monte, però è anche bello il
momento successivo di divulgazione.
M.D.: quale futuro per i musei e per i diretori?
G.M.: il futuro dei musei dipende da quanto noi saremo in grado di guardare alla
contemporaneità. Siamo nati con lo sguardo al passato. O noi, la mia o la tua generazione, ma
più la tua della mia, capiamo che siamo in un momento in cui dobbiamo volgere lo sguardo al
presente, o altrimenti tut i musei DEA chiudono. Vedi il caso del Museo della Mezzadria
senese. In tuta la Toscana penso che i mezzadri sopravvissuti non arrivino a dieci. Ci sono
ancora le generazioni dei fgli, ma tra venti anni non c’è più neanche quella. È un mondo
scomparso. Il che signifca fare un museo di fantasmi. O noi riusciamo a far dialogare il Museo
della Mezzadria con la realtà delle campagne di oggi, indicare le cesure, le frature, però
rappresentare anche la campagna, anche il contemporaneo, altrimenti chiudiamo…
M.D.: o diventiamo musei archeologici
G.M.: esatamente, una archeologia di passato prossimo. Tu prova a pensar cosa succede
quando non ci saranno più le generazioni che di questo fenomeno hanno sensibilità,
conoscenza. Dobbiamo riuscire a fare quello che ho deto poco fa, e lo possiamo fare in due
modi, o con il loro intreccio. Uno è che noi siamo in grado di essere iconoclasti rispeto alla
concezione del museo e usare tecniche diverse, forme di rappresentazione diverse, una delle
quali è la sensorialità. Noi possiamo far sì che chi entra nel nostro museo abbia nella tecnicità
legata alla sensorialità un elemento di dinamicità, di presentazione delle realtà in modo vivo,
contemporaneo, che ci aiuta molto. L’altro è di fare uno sforzo, farci venire il torcicollo, e di
[XXIX]
guardare anche al presente. In questo una scelta che io ho fato sull’alimentazione è proprio in
rapporto a questo. Qualche anno addietro mi sono posto il problema che i musei devono
avere un futuro, e l’unico modo di futuro è: sappiamo che dalla fne della mezzadria a oggi c’è
stata una cesura? Benissimo, documentiamo questa cesura. Sappiamo che il gusto e
l’alimentazione della mezzadria erano diversi da quelli di oggi, anche se ti tirano fuori le ricete
della nonna o del contadino, benissimo! Documentiamoli. D’altra parte il nostro compito è
quello. Non invidio Mario Turci con il Museo Guatelli, per esempio, perché quello è un
monumento pressoché immodifcabile nel tempo. Io penso, ma non glielo dico, tra tre
generazioni che succederà? Tre generazioni sono sessant’anni. Se io ho fato un investimento
di alcuni miliardi, per quanto tempo l’investimento ha senso? Ecco perché io sostengo che il
Museo Guatelli diventare una cosa che va al di là, e qui dico una bestemmia, dello stesso
Guatelli. Diventare il museo della creatività, della ingegnosità, della capacita di… lasciando pian
piano Guatelli sullo sfondo come colui che ne è simbolo eccetera ma… Lo stesso per i miei
musei, devo far sì che il Museo del tartufo diventi il tartufo domani, il tartufo che deve
cominciare a porsi il problema del DNA e via di seguito, di tuto ciò che signifca; che il Museo
della Mezzadria parli dell’agricoltura oggi, dei contadini oggi. Ho fato una intervista, credo la
presenterò a Santarcangelo, in cui c’era un giovane contadino, agricoltore, il quale è venuto
all’intervista con una maglieta Lacoste; l’abbiamo fata in quel giorno lì perché la setmana
dopo partiva per una crociera. Se io penso ai contadini che intervistavo trent’anni fa allora mi
rendo conto che è fnito un mondo e che ce ne è un altro di mondo. Niente di male, è la realtà,
dobbiamo accetare al realtà. Renderci conto che i passaggi che l’Italia ha avuto dal punto di
vista quantitativo a metà degli anni Cinquanta… il superamento dell’industria sull’agricoltura,
gli efet sul piano culturale li abbiamo oggi. Il mondo dell’alterità delle campagna, ti parlo del
microcosmo toscano, è un’altra cosa, è scomparso.
M.D.: rapporti con le Soprintendenze?
G.M.: ho la fortuna che mia moglie lavora in Soprintendenza, per cui direi in generale positivi.
Se c’è qualcosa ci avvertono, sono persone che conosco da quarant’anni. A me adesso hanno
chiamato, l’altro giorno, per dirmi che c’era una persona interessante da intervistare; mi han
chiesto di fare una perizia per quanto riguarda il valore di un museo dell’Amiata in merito al
quale c’è un contenzioso tra gli eredi di chi lo aveva fato e il comune. I rapporti sono buoni
anche sul piano della catalogazione. È chiaro che loro sono storici dell’arte, per cui non posso
[XXX]
pretendere che loro mi diano… Se fanno fare cento schede di catalogo al massimo me ne
fanno fare dieci.
M.D.: a chi è che deve rendere conto il diretore del museo etnografco? alla comunità, alle
comunità, agli amministratori, alla comunità scientifca?
G.M.: a tut questi, ma a furia di rendere conto a tanti non si rende conto a nessuno. Questo
deto sotovoce. Sicuramente dal punto di vista giuridico all’amministrazione in quanto
espressione della comunità, perché quello del diretore è un incarico giuridico pubblico. Come
deve render conto dei risultati raggiunti. Deve render conto alla comunità perché il museo
costa (e caro) alla comunità, e con la crisi che c’è qualche volta si mete a rischio qualche
intervento sociale, e quindi la responsabilità che ha sulle spalle è enorme. Come io rendo
conto alla comunità? A due livelli. Uno è quantitativo: il museo deve avere un minimo di
visitatori. L’altro: devo creare delle situazioni (mostre, eventi) in cui la comunità partecipa. La
comunità è il riferimento etico del diretore di museo, il sindaco lo è sul piano giuridico. La
comunità scientifca è un elemento, almeno per me e in questo momento, legato a sistemi di
relazione. Nel senso che viene Jalla, guarda il museo, mi dice quello che pensa e via di seguito,
però diciamo è più di fato un incrociarsi di sistemi di relazione. Qui emerge il mio isolamento
rispeto alla comunità scientifca. Io mi son posto sempre… mi sono costruito l’alibi: quando
fnalmente i musei che dirigo saranno solidi, riuscirò… però ho il complesso di colpa di scrivere
poco per AM, che non vado a molti convegni dove mi invitano, e questo è un elemento di cui
mi rendo conto (a volte partecipo scrivendo le relazioni mentre vado, per cui mi rendo conto
che il mio apporto può essere relativo). Però contemporaneamente la comunità scientifca è
abbastanza poco solida, un po’ sflacciata.
M.D.: a proposito di comunità scientifca: le associazioni, cosa fanno per i diretori? SIMBDEA,
ICOM…
G.M.: do una risposta molto laica. Per me la SIMBDEA è Pietro. Ogni tanto mi rimbrota, come
fa lui, che poi non rimbrota mai nessuno… ricordandomi che sono tra i soci fondatori. Cosa
faccio io? Cerco di inserirla sempre come logo delle mie iniziative e quando mi riesce cerco di
fare iniziative in collaborazione. Noi (io Pietro e Paolo) abbiamo giocato spesso con le sigle. Le
cose le facevamo noi ma appariva le sigle IDAST, Museo della Mezzadria, SIMBDEA. Sono
consapevole che è molto poco, però è un modo per ricordare presenze. Credo che sarebbe
opportuno che i diretori facessero una rifessione per quanto riguarda il fato che non
[XXXI]
possiamo esistere senza una associazione, e magari dedicarci un po’ più di tempo di quanto si
fa. Però su questo… noi viviamo un tourbillon talmente continuo e spaventoso… adesso ho la
rotura di scatole degli Angeli; il diretore della Fondazione ha chiesto, e ha fato bene, di avere
il servizio civile. Ok. Però non è che ci abbia consultato; ci arrivano adesso due persone su un
progeto assurdo senza averci interpellato… se fai il progeto su un museo di cui c’è un
diretore abbi almeno il bon ton di interpellare il diretore…
M.D.: in sintesi, il lavoro del diretore in cosa consiste oltre che nel risolvere problemi creati da
altri?
G.M.: fa due operazioni diverse: io grazie a Dio invento cose e le faccio, poi meto toppe.
Adesso ho questa toppa dei due che mi arriveranno. Due più due… devo fare in modo che non
si sovrappongano… con tuta una serie di questioni, per cui c’è una normativa che se vengono
da fuori devono essere ospitati dal comune; ti immagini? il comune non ha una lira per far
nulla…
M.D.: Metere toppe e fare il post-it vivente, ricordare all’amministrazione scadenze obblighi…
fature da pagare… e contemporaneamente partecipare a proget (pensarli, atuarli) per avere
soldi necessari all'adempimento delle atvità di istituto… Sul piano della legislazione regionale
come funzionano le cose in Toscana?
G.M.: in epoca grassa Rosati ha portato avanti la questione degli standard. Sono stati un
otmo punto di riferimento, però c’è un problema. Gli standard funzionano con l’arma del
ricato: tu comune se non segui gli standard non appartieni alla fascia A. Ma cosa deve
signifcare appartenere alla fascia A? Finanziamenti di un certo tipo rispeto agli altri. Ma se i
fnanziamenti non ci sono tu capisci che è volontaristico lo standard. Noi seguiamo gli
standard, ad esempio riguardo agli orari. Anzi, Buonconvento li supera, con 2200, ore di
apertura annuale. Tre anni fa ne avevo 4000, l’anno prossimo 1248, il minimo previsto dagli
standard. Poi ce ne è uno a favore dei diretori: il museo deve avere il diretore. Però non
spiegano, gli standard, che tipo di contrato o incarico debba avere il diretore. Tu capisci che
defnire la presenza senza defnire le condizioni giuridiche e economiche… Poi ci sono le cose
giuste per l’handicap e per la presenza della didatca museale. Gli standard vanno bene ma la
Regione dovrebbe avere o la rivoltella puntata o un piato da fornire perché si dica «va bene,
val la pena». Se non dai questo… la regione Toscana è stata più prudente di altre, come la
[XXXII]
Lombardia, sapendo bene quale è la situazione della museografa sopratuto DEA, perché se
veniva applicato il sistema che ho deto sopra subito due terzi dei musei sarebbero saltati.
[XXXIII]
Intervista con Mario Turci
Direttore Istituto Musei Comunali di Santarcangelo di Romagna
Direttore Museo Guatelli
on skype, 22 11 2011
Marco D’Aureli: il motivo di questa chiacchierata te lo avevo accennato. Tuto si inserisce
all’interno del lavoro che sto producendo per la Scuola di specializzazione. L’oggeto di cui mi
sto interessando è la fgura e il ruolo del diretore del museo etnografco. Ho pensato di fare la
campagna di interviste all’interno della quale questa si inserisce per raccogliere l’esperienza di
chi questo lavoro lo fa, per conoscere dei punti di vista che provengono dall’interno di questo
mondo, per conoscere le tante e diverse storie che stanno alle spalle di quanti fanno questi
lavoro. Quello che percepisco, anche senza particolari indagini, è che ognuno dei diretori di
museo etnografco che conosco è arrivato a svolgere questa atvità, questa professione o
questo mestiere, lo vedremo bene poi, atraverso percorsi del tuto originali, non omologabili.
Nel nostro campo abbiamo fgure diverse che lavorano a titolo diverso in istituzioni diverse e
da diverso tempo, per cui il quadro si presenta come estremamente articolato e disomogeneo.
Ti ho mandato una scaleta di massima delle domande che ti vorrei sotoporre; nella mia
mente queste sono divise in due grandi blocchi. Da una parte ti chiedo informazioni sul
percorso fato per arrivare a ricoprire gli incarichi che hai; altre sono domande di portata più
generale che riguardano quello che signifca essere antropologo in un museo. Possiamo fare
così: un po’ mi racconti la tua vicenda personale, e poi magari passiamo a domande di più
ampio respiro. Inizierei con il fare una fotografa dell’esistente, dell’atuale. Quindi ti chiedo:
quanti anni sono che svolgi il ruolo di diretore? Ricordo che le struture che gestisci sono due,
il Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romanga a Santarcangelo e il Museo Guatelli a
Ozzano Taro, e quindi sarebbe utile istituire un confronto tra queste due esperienze.
Mario Turci: quest’anno raggiungo i trent’anni di direzione. Praticamente sono diretore del
Museo etnografco [Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romanga] dal 1981, e lo sono in
virtù di una selezione pubblica. In quell’anno vinsi il concorso che venne bandito
dall’amministrazione comunale e da allora ho seguito praticamente tuta l’evoluzione del
Museo di Santarcangelo, perché nell’anno stesso in cui assunsi il mio incarico venne aperta la
prima sezione dell’esposizione. Ma già collaboravo al Museo da qualche anno prima, dal 1976[XXXIV]
1977. Poi piano piano sono diventato diretore dell’Istituto dei musei comunali, e quindi
diretore di un istituto che comprende anche il museo storico-archeologico. Mentre al Museo
Guatelli sono alla direzione dal 2001, dopo essere stato chiamato dall’amministrazione
pubblica per elaborare, assieme a Pietro Clemente, un progeto di passaggio dal privato al
pubblico, che era anche un progeto di gestione, di rilancio e di riapertura del Museo. In
questo caso diedi la mia disponibilità ad accetare l’incarico anche perché mi sembrava
stimolante lavorare assieme a Pietro. Presentato il progeto mi chiesero di rimanere, di
assumere la direzione per tre anni per poter avviare il Museo. Dopo i primi tre anni mi
chiesero di prorogare la mia permanenza ed io, entusiasta, perché è stata ad è una bella
avventura, accetai. A questo seguì un incarico della durata di 5 anni, tut’ora in corso. Quindi
diretore al Guatelli si può dire che lo sono da quasi 10 anni. Mentre presso il Comune di
Santarcangelo sono di ruolo, perché ho vinto un concorso, al Museo Guatelli, che è gestito da
una fondazione di partecipazione, sono stato chiamato come professionista e quindi sono
incaricato della direzione.
M.D.: questo secondo me apre lo spazio per una domanda: diferenti rapporti con le
amministrazioni di riferimento signifca anche un diverso modo di essere diretore?
M.T.: in maniera sfumata si, perché come dipendente pubblico sei in qualche maniera
assoggetato a tuta una serie di normative e in più dipendi molto dalla politica: dipendi da un
assessore, che dipende da una giunta, da linee programmatiche, da una politica culturale alla
quale, a seconda della sensibilità dell’amministrazione, sei chiamato a partecipare, e quindi il
lavoro come diretore di un ente pubblico è un lavoro molto tagliato sulla gestione del
patrimonio pubblico. Questo, se vogliamo, è vero anche per il Museo Guatelli, ma lì ho a che
fare con un consiglio di amministrazione e con un presidente che sono, sì, espressione di enti
pubblici, però in quel caso il mio rapporto con il referente è più professionale. Per farti un
esempio: a Santarcangelo non posso sbatere la porta e andare via, o minacciare di andare via.
Non dico che questo accada col Guatelli, però al Guatelli il mio rapporto è paritario: se un
giorno non dovessi condividere le linee programmatiche e gli obietvi io potrei sempre, come
professionista, lasciare, andarmene. Tu dirai: «puoi farlo anche a Santarcangelo», ma questo
signifcherebbe licenziarmi da un posto di ruolo con tuto quello che ciò comporta. Si insatura
un rapporto più paritario tra amministratori e diretori là dove sei chiamato in qualità di
[XXXV]
professionista. Anche perché al Guatelli mi hanno scelto e mi hanno voluto, a Santarcangelo
ho scelto io di partecipare a un concorso. In questo caso i rapporti sono leggermente diversi.
M.D.: forse c’è anche un diverso potere contratuale sul piano delle scelte, un diverso peso,
essendo tu in qualche modo interno alla strutura comunale a Santarcangelo...
M.T.: molto è legato anche al fato che vinsi il concorso che avevo 27-28 anni, e all’esperienza
che mi sono fato negli anni a seguire. Al Guatelli sono arrivato in piena maturazione
professionale, con una capacità di gestione della mia professionalità ben diversa, già maturo.
Per poter seguire il Guatelli come va fato, ho chiesto alla mia amministrazione di cambiare
contrato: sono rimasto un dipendente pubblico però con un impiego part time del 50% che mi
consente di svolgere atvità professionale. Anche se il mio part time vorrebbe da norma la mia
presenza a Santarcangelo per 18 ore setmanali questo parametro non riesco a rispetarlo, nel
senso che non si può gestire un museo lavorando 18 ore. Io lavoro molto di più, e questo non
mi è riconosciuto come straordinario; sono io che, in qualche maniera, devo fare i salti mortali;
sono io che, in qualche modo, riesco a tenere una direzione che penso sia signifcativa a
Santarcangelo e al Guatelli. Poi come gestire il tempo è questione che devo sbrigare da me.
Lavoro una cinquantina di ore e più setmana, ecco, tra l’uno e l’altro.
M.D.: nel caso del Guatelli le scelte vanno sotoposte al Consiglio di amministrazione…
M.T.: si, ma è diversa la cosa, perché nell’ente pubblico il Consiglio di amministrazione e le
scelte sono valutate in tute le loro parti, nel senso che quando faccio un progeto devo
sotoporlo (giustamente, anche perché uso denaro pubblico) al Consiglio di amministrazione
dell’ente pubblico, mentre al museo Guatelli sono molto più libero. Il Consiglio di
amministrazione del Museo Guatelli si riunisce due volte l’anno, mentre quello di
Santarcangelo si riunisce una volta al mese. Del Guatelli conosco quali sono gli indirizzi di tipo
generale, mi assumo la mie responsabilità, i proget li approvo io: chiamo il Presidente, lo
meto al corrente delle mie scelte, lui le valuta e poi si procede oltre; a Santarcangelo avere
una idea vuol dire passare in Consiglio, fare una delibera, poi fare una determina, poi verifcare
la copertura… Anche al Museo Guatelli devo verifcare la copertura, la congruità,
l’allineamento del mio progeto con gli indirizzi, però in quel caso la negoziazione è sui
contenuti, mentre a Santarcangelo devo seguire una procedura normativa più articolata.
[XXXVI]
M.D.: mi interesserebbe conoscere un po’ più nel detaglio quale è il percorso formativo che ti
ha portato alla direzione del Museo etnografco di Santarcangelo, il tipo di studi, l’
apprendistato…
M.T.: i miei interessi sul progeto culturale hanno origine da tuta una atvità di politica della
cultura svolta al Liceo Artistico, laddove, in qualche maniera, il movimento studentesco si
interessava di questi argomenti. I primi momenti della mia formazione culturale e politica sono
da rintracciare nella frequentazione del Liceo artistico a Ravenna. Finiti i quatro anni di Liceo,
e potendolo fare, mi iscrissi alla Facoltà di Architetura di Firenze, dalla quale uscii con uno
studio legato al recupero territoriale di una area interessata da mulini e case coloniche. Per
realizzare la tesi studiai lo sviluppo della casa colonica, lo sviluppo del rapporto tra casa
colonica e mulino. Il mio interesse era centrato sul piano territoriale in senso ampio. Appena
laureato in architetura feci conoscere ai miei amministratori, come tut fanno, il lavoro che
avevo svolto e subito dopo mi iscrissi a Sociologia a Urbino. A sociologia ero uno studente già
vecchioto rispeto agli altri, e già con un minimo di esperienza; in quell’occasione feci,
all’epoca si poteva fare, il libero assistente: studiavo ma incontravo anche gli studenti, facevo
qualche lezione, però senza essere incardinato. Ce ne erano tanti di assistenti volontari. A
Sociologia biennalizzai gli esami di Storia delle tradizioni popolari, Antropologia I e
Antropologia II e mi orientai fortemente, laddove il piano di studi me lo permeteva, verso
l’antropologia, l’etnografa, le tradizioni popolari. Mi laureai con una tesi che fu praticamente
lo sviluppo di quella già fata per Architetura: ripresi quel testo e lo riscrissi in una chiave
etnografca. La ricerca aveva come argomento la casa colonica, il suo sviluppo e il suo rapporto
con il territorio ma prendeva in considerazione gli elementi legati in modo particolare al rito,
l’uso simbolico dell’abitazione. Quel lavoro divenne un libricino dal titolo La dimora dei rit, un
volume dove la casa veniva assunta a contenitore simbolico dei riti del ciclo della vita. Nel
fratempo seguivo i lavori di Tullio Seppilli e i suoi incontri sull’antropologia medica. A
Senigallia partecipai a un convegno di due o tre giorni su questo argomento e lì incontrai
Francoise Lutz che era una ricercatrice famosa e lavorava al CNRS presso il Musée des ATP.
Approftai di quei tre giorni per parlare con lei e alla fne mi propose uno stage al Musée des
ATP. Io immediatamente presi la palla al balzo e cominciai a prendere contat, fnché trovai il
modo di organizzare un soggiorno in Francia. All’epoca ero già dipendente comunale, questo
lo dico perché l’amministrazione mi diede la possibilità di otenere un permesso di formazione
[XXXVII]
per passare tre mesi a Parigi per seguire questo stage ufciale. Così andai a Parigi. A Parigi
collaborai con la Lutz, in più ebbi modo di frequentare un italiano, Severi, di Carpi, che
lavorava al Musée de l'Homme. Io stavo cercando un rapporto con l’università per
approfondire i temi sviluppati nella mia seconda tesi, chiedendo, telefonando, mandando la
mia tesi a vari docenti: a Seppilli, a Lombardi Satriani, le persone che si conoscevano. Non ebbi
risposta da questi, e della cosa mi lamentai nel corso delle chiacchierate che facevo nei bar
parigini con Severi, il quale mi disse: «perché non provi qui? perché non spedisci la tua tesi
qui?». In maniera spudorata spedii la tesi, accompagnata da una letera, a tre professori: Marc
Augè, Claude Levi-Strauss e Chiva. Mi risposero tut e tre dopo un mese. Chiva dicendo che
non era assolutamente interessato. Anche Levi-Strauss mi scrisse che non era interessato alla
cosa, però mi rispose, mentre in Italia nessuno lo aveva fato; se uno ti risponde vuol dire in
ogni caso che ha leto quello che gli hai inviato, che ti rispeta, magari ti dice «guardi, il suo
lavoro fa schifo, si vergogni» però te lo dice. Marc Augè mi rispose «venga su la setmana
prossima a Parigi». Presi il treno immediatamente, andai da lui, ne parlai, e lui mi propose di
iscrivermi alla École des Hautes Études ad un DEA. Pagai 36.000 lire e mi iscrissi; cominciai a
seguire con Augè ricerca che poi approdò su questioni ben diverse dalla tesina che avevo
portato, perché passai alle questioni legate all’occhio, al potere dell’occhio, al malocchio.
All’epoca, come deto, ero già diretore del Museo. Per andare a Parigi prendevo il treno alla
sera da Bologna, dormivo in treno, arrivavo a Parigi la matna, incontravo Marc Augè, gli
sotoponevo per le revisioni il mio lavoro e poi nel pomeriggio riprendevo il treno per essere la
matna del giorno dopo a Bologna e andare a lavorare nel pomeriggio. E questa è stata la mia
formazione. Nel fratempo lavoravo con Šebesta. Si può dire che ho lavorato con Šebesta dal…
adesso sai, le date precise… dal 1977 fno al 1983. Mi formò molto sui temi dell’ergologia;
cominciai a rifetere e a sofrire su che cosa è un museo e su che cosa è la ricerca, fnché
alcune mie scelte mi portarono in confito con lo stesso. Lui personalizzò molto il nostro
rapporto, nel senso che io, sì, gli facevo da assistente, però lui chiedeva una fedeltà, voleva un
discepolo, ed è chiaro che personalizzando il rapporto a quel punto il contrasto di opinioni fnì
col diventare un contrasto personale e quindi lui in qualche maniera mi disconobbe come
discepolo (Šebesta utilizzava questi termini). Io continuai a mantenere un rapporto… gli
dovevo molto, i maestri, anche per la loro anzianità, vanno sempre rispetati. Mi prendevo le
sue bordate fnché ad un certo punto fu impossibile… ogni telefonata diventava uno scontro e
[XXXVIII]
allora lo lasciai. L’incontro con Seppilli e con Parigi mi permise di scoprire la scuola di Cirese e
la comunità che in qualche modo nasceva dal suo modo di vedere il mondo. Si può dire che lo
scoprii molto il Francia Cirese; in Francia Cirese era ed è molto leto e discusso. E Cirese mi
portò a Pietro Clemente. Conobbi ancor più Pietro negli anni della costituzione della sezione di
Antropologia museale all’interno dell’AISEA, anche perché Pietro aveva delle opinioni sue che
mi interessavano.
Oggi sento che la mia identità professionale si gioca su tre ambiti. L’allestimento, che
tecnicamente mi arriva dall’architetura e nella dimensione poetica e nelle forme di scritura
mi arriva dall’etnografa e in modo particolare da Cirese, da Pietro e da tuta quell’esperienza.
L’altra mia anima è nella gestione del Museo, perché son trenta anni che svolgo questa
atvità: ho gestito un museo-ufcio, l’Istituto dei musei comunali, oggi sono diretore di una
fondazione di partecipazione, quindi sono diventato uno specialista, nel senso che mi hanno
chiamato per proget di gestione, legati alla fatbilità economica, conosco i bilanci... La terza
anima è quella legata all’etnografa, allo sguardo etnografco sui fat, sulle persone. Questa è
la mia professionalità, che mi ha dato modo poi di aprirmi a una serie di possibilità di lavoro.
M.D.: sulla base di quello che mi hai deto sono due gli aspet che voglio approfondire:
innanzituto questa dimensione della professione, del saper gestire. Quanto è importante per
un diretore di museo etnografco?
M.T.: è fondamentale, etnografco o non etnografco è fondamentale. Gli strumenti del
mestiere sono questi. Se valorizzare un bene oppure valorizzare una ricerca signifca saper
trovare le risorse, saper dialogare con il territorio, con la politica, trovare i modi… La gestione
tecnica-organizzativa di un museo è quello strumento che dà la possibilità di gestire il
patrimonio. È fondamentale per un diretore di museo. Un diretore di museo non è un
intelletuale, solo. Uno che fa l’antropologo sarà capace a fare l’antropologo, ma se vuole fare
il diretore del museo non gli basta conoscere l’antropologia, deve conoscere le forme di
gestione, come si fanno le leggi, come si fanno i bilanci, le economie, i risparmi, come si
scrivono le richieste di contributo, come si gestisce il personale, che cosa è la qualità. Se no fai
il diretore artistico, scusa il termine. Il diretore artistico è quello che ha l’intuizione, sa vedere
le cose, poi le fa gestire a qualcun'altro.
M.D.: bisogna conoscere la natura dell’istituzione che ti è stata afdata, capire quali sono i
suoi meccanismi, i suoi funzionamento per farla operare al meglio…
[XXXIX]
M.T.: ma questo fa un diretore di museo, eh! Nel senso che quella del diretore di museo è
una professione, e il diretore deve essere capace di gestire un istituto. Prima di tuto. Poi ha
una sua provenienza disciplinare che lo porta a gestire anche altre dimensioni del museo. Io
devo sapere come si fa il restauro, devo sapere come si fa un preventivo per richiedere un
restauro, devo sapere valutare i preventivi, devo conoscere le leggi sul lavoro, devo saper fare
un contrato, devo saper fare una gara, saperla valutare, devo… questo è ciò che deve fare
diretore. Il suo lavoro consiste in questo.
M.D.: la tua doppia formazione coma ha infuito su questo aspeto? L’esperienza…
M.T.: l’aspeto della gestione me la sono fata sul campo. Perché io sono arrivato con delle
capacità tecniche da architeto, e con un abito mentale del progetare: come si fa un progeto,
come si formalizza, quali sono le parti che lo costituiscono. Dentro di me sento che c’è un
modo di progetare, forse a volte eccessivamente schematico, non lo so, ma viene
dall’architetura. La sociologia e l’etnografa mi hanno formato sugli aspet della politica, in
senso ampio, e della poetica del museo. Mentre l’architetura sulla tecnica. Quindi tecnica,
politica e poetica…
M.D.: che in qualche modo si incrociano
M.T.: il resto della formazione sulla gestione me la sono fata sul campo.
M.D.: quello di lavorare nel museo è stato un obietvo che hai perseguito consapevolmente,
oppure è capitato per caso, è stato un ripiegamento iniziale…
M.T.: io sono uscito da Architetura con la chiara idea che non avrei fato l’architeto, nel senso
che di quella professione non mi piaceva la dimensione del fare il progeto per la famiglia, le
negoziazioni e le furbizie con il commitente… Non dico che siano negative, a me però
interessava lo spetro urbanistico sociologico, lo studio del territorio: è questo che mi portò
alla sociologia. Il museo capitò. Io volevo occuparmi delle cose che ho appena deto, poi
incontrai una amministrazione, misi al corrente la medesima del mio lavoro e del mio
desiderio di interessarmi di territorio, di progetazione del rapporto tra territorio… volevo fare
l’urbanista, se vogliamo. Poi mi chiamarono per fare l’assistente di Šebesta, ma già ero
orientato sulla sociologia, tanto che la stavo studiando all’università. Poi tuto mi portò al
patrimonio. Non è che volessi fare il diretore di museo; non volevo fare l’architeto come è
convenzionalmente pensato, un commitente che ti viene e ti chiede di fargli la casa. Questo
[XL]
non mi interessava (anche se mi ero iscrito all’Ordine degli architet, avevo superato l’esame
di Stato, perché, ovviamente, uno studia per lavorare e per mantenersi). Poi iniziai a lavorare
in qualche studio, ma con una certa soferenza. Se non avessi trovato altre strade avrei
lavorato in uno studio di architetura, avrei progetato case, condomini.
M.D.: l’approdo al museo è stato felice, ti ha consentito di approfondire quegli aspet legati a
quella dimensione…
M.T.: io sono stato fortunato, perché mi è capitato questo e poi ho trovato sulla mia strada dei
maestri. A Sociologia a Urbino incontrai un certo Marzocchi, che era un assistente che
aspetava di essere confermato e gestiva la catedra di Storia delle tradizioni popolari; non mi
insegnò molto, però mi diede la possibilità di esprimermi. Questo fu il mio primo maestro. Poi
un secondo maestro è stato Šebesta, che mi insegnò molto, che mi fece conoscere il suo
museo. Un altro grande maestro che mi diede la possibilità di portare a maturazione il mio
percorso è stato, ed è, Pietro Clemente. Pietro è mio maestro. E quindi penso di aver avuto
questi tre maestri. Poi ho incontrato Augè, ma Augè è stata un’altra persona che mi ha dato la
possibilità di esprimermi, di afacciarmi a un mondo. I maestri della mia formazione sono stati
loro.
M.D.: questo ci porta alla domanda che sto per farti; in parte mi hai già risposto, ma vediamo
se c’è qualche cosa d’altro da dire. Dove e come hai imparato a fare il diretore? Quali modelli
hai avuto? Chi sono i tuoi maestri lo abbiamo deto, ma nel caso specifco della direzione?
M.T.: noi ci trovavamo a costruire nel deserto… i modelli sono stati quelli della Pubblica
amministrazione, si tratava di aderire alle normative che la Pubblica amministrazione ti
meteva a disposizione. Un altro modello è stato quello del museo šebestiano. Il primo museo
importante che ho conosciuto dal di dentro è stato il Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina. Altro modello è stato il Musée des ATP di Parigi, un modello principalmente legato
alla ricerca, all’atenzione sull’oggeto, al lavoro sull’oggeto. Dal punto di vista amministrativo
il punto di riferimento rimane l’ente pubblico, l’evoluzione della normativa e poi alla fne il
TQM, il Total Quality Management che mi ha aiutato a impostare il mio lavoro sul fronte della
qualità molto prima che si parlasse degli standard di qualità, e così via…
M.D.: quindi la normativa che è seguita e che va presa a riferimento, come il Decreto
Ministeriale sugli standard. Ma Šebesta è stato anche diretore del Museo…
[XLI]
M.T.: no, mai…
M.D.: di nessuno dei due?
M.T.: Šebesta arrivò a Santarcangelo chiamato con una idea di progeto, un desiderio; gli
furono dati degli obietvi e sulla base di questi cominciò a impostare il progeto di
allestimento. Fece ricerca, e ha lasciato - se vogliamo - un museo che rispeto all’atuale era
solo il 30%, però l’impostazione, il modello di rapporto tra il patrimonio e il museo, è fruto del
suo impianto. Il primo diretore del Museo a Santarcangelo sono stato io
M.D.: era solo per capire se da Šebesta avevi anche appreso i rudimenti del mestiere della
direzione…
M.T.: no, no… ha direto il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ma lo ha fato
privilegiando tantissimo la parte della ricerca, la parte intelletuale; altri facevano la parte
pratica. Šebesta non è stato un diretore manager…
M.D.: è stato un diretore artistico, per tornare alle categorie di prima…
M.T.: si, anzi, ha soferto un po’ il rapporto con i laccioli che limitavano i suoi movimenti.
M.D.: dalla nostra discussione esce l’idea del lavoro del diretore come di un qualcosa che si
apprende sperimentandolo e sul campo, che poi tra l’altro è anche la mia di esperienza; l’idea
dell’acquisizione di un sapere e di un saper fare atngendo dall’esperienza altrui e rubando
con gli occhi, in qualche modo…
M.T.: beh, adesso ci sono dei corsi, ci sono dei master, dove un po’ ti insegnano a gestire gli
istituti; quando ho cominciato io non c’era nulla, non c’era una scuola come c’è in Francia.
Adesso ci sono, ormai da anni, master di management dei beni culturali, pubblicazioni. Però a
fare il diretore lo impari sul campo, ecco, assolutamente.
M.D.: emerge un po’ un paradigma artigiano del fare…
M.T.: il diretore è un artigiano che deve conoscere dell’oggeto che trata tute le dimensioni.
M.D.: ero un po’ indeciso se considerare quello del diretore un mestiere o una professione
M.T.: è un po’ uno e un po’ l’altro. È un mestiere, nel senso che tu di un oggeto devi conoscere
tuto; dell’oggeto che ho di fronte devo sapere come conservarlo, quanto vale, come
prestarlo, chi potrebbe fare una ricerca, come valorizzarlo inserendolo in un discorso più
ampio, come tutelarlo, quale è il suo valore politico… Quindi è un mestiere. Diventa
[XLII]
professione quando gli aspet del mestiere diventano un modo di saper fare che in ogni caso
tu puoi trasmetere o confrontare con gli altri. Diciamo che si apprende come mestiere, poi
diventa una professione. Essere professionista poi vuol dire che questa cosa io la applico fuori,
anche se non posso applicarla fuori del tuto perché ogni realtà è diversa, anche se poi io ho
potuto applicare in parte sul Guatelli cose apprese…
M.D.: alcuni principi…
M.T.: là sono comparso come un professionista, quando qui sono diventato un professionista
atraverso il mestiere .
M.D.: quindi la tua testimonianza è che c’è una profonda diferenza da quando lo hai
imparato tu ad oggi, nel senso che sono nate delle scuole, la formazione è più struturata,
sono nate delle istituzioni che consentono un percorso più standardizzato, controllato,
sperimentato…
M.T.: si, certo…
M.D.: tu hai avuto esperienze interne all’accademia, come docente… che diferenza c’è tra fare
l’antropologo al museo e farlo all’università?
M.T.: sostanziale. Mi sono trovato di fronte a molti studenti che hanno apprezzato tanto i miei
corsi di etnografa perché ne hanno percepito la concretezza. Io mi sono sempre sentito un
diretore, un etnografo museale, un antropologo museale prestato all’università. Le mie lezioni
teoriche, perché io ho insegnato Antropologia museale, Antropologia culturale e Etnografa
della cultura materiale, le ho sempre impostate portandomi dietro tuto il bagaglio di chi in
qualche maniera trata questi argomenti sapendo di dover rispondere alla colletvità. Quindi
sono costreto a non essere teorico. Sicuramente il mio bagaglio teorico non è completo, è
lacunoso, perché io ho dedicato molto tempo al lavoro applicativo, quindi il mio lavoro di
antropologo docente è stato molto condizionato dall’antropologia applicata. Questo ha dato
molta concretezza al mio insegnamento, e la cosa è stata apprezzata. Ho voluto mantenere
questa peculiarità per una scelta politica; nella mia maturazione professionale la scelta
politica, che ho imparato da Pietro, è stata sempre più caraterizzante.
M.D.: perché quella del diretore è in realtà una atvità con una forte impronta di politica
culturale
[XLIII]
M.T.: certo, è un gestore di un patrimonio colletvo e quindi, diciamo, il suo sguardo deve
essere sempre sul politico e sul sociale. Il suo lavoro è quello di gestire un patrimonio che è di
altri
M.D.: soto tut i punti di vista
M.T.: tut. E io penso che il lavoro di diretore sia tra quei lavori che comportano la capacità di
esser preoccupato, giusto per volgarizzare, dal fato che nei bagni ci sia la carta igienica e che
gli standard dei bagni siano di qualità, fno a saper gestire un gruppo di ricercatori. Io devo dar
delle risposte sul restauro, per esempio. Ma non sono un restauratore. Devo sapere come si
restaura, come ci si comporta… Il lavoro del diretore ha uno spetro amplissimo di intervento.
Deve sapere tanto. La mia atvità didatca, se vogliamo ritornare all’accademia, mi è piaciuta
molto; adesso la continuo a Perugia, mi sarebbe piaciuto continuarla a Parma però con i miei
corsi sono fniti soto i tagli dei contrat. Mi dispiace molto, perché per me insegnare era un
modo per rifetere sulle cose che stavo facendo; mi era estremamente utile, spero che lo
fosse anche per gli studenti, e mi manca. Secondo me l’ideale è quello di un diretore che
potesse portare all’accademia, all’università, il suo modo di fare, il suo sguardo sull’etnografa
in quanto diretore, quindi portare una professionalità precisa
M.D.: quanto deto fnora ci porta ad un’altra questione: perché è importante che un museo
antropologico sia direto da un antropologo? Cosa può dare un antropologo in più rispeto ad
altri specialisti?
M.T.: il diretore antropologo sa, conosce lo statuto del patrimonio che è chiamato a gestire. E
conosce la sostanza dello statuto del patrimonio etnografco. Le sue scelte politiche, le sue
valutazioni sono stretamente legate a quella missione che è propria della valorizzazione dello
statuto dell’oggeto, se vogliamo. Lo stesso penso che si potrebbe dire a proposito di un
naturalista in relazione al patrimonio naturale. Diverso è il discorso per quel che riguarda il
manager, perché se tu devi valorizzare una latna di birra o una zappa non lo puoi fare allo
stesso modo; valorizzare vuol dire entrare nella sostanza delle cose, utilizzare i paradigmi di
approccio a quel patrimonio. In una grossa strutura ci può essere un manager che non
conosce nulla del patrimonio ma che si occupa della parte della gestione, che fa funzionare
bene il personale, che sa come si fanno i contrat; però solo le grandi struture possono
[XLIV]
permetersi i diretori scientifci e dei diretori, chiamiamoli, “amministrativi”. Mentre nelle
realtà più piccole il diretore è scientifco e amministrativo insieme.
M.D.: quale particolare torsione imprime il fato che sei un antropologo alla funzione che
svolgi? Cosa aggiunge (o quali limiti comporta) il tuo essere antropologo al ruolo di diretore?
Questa particolare formazione che abbiamo rende il lavoro del diretore diverso, in qualche
modo? Una atenzione in più nei confronti degli altri…
M.T.: mi verrebbe da dirti di si ma non te lo dico, nel senso che un antropologo o un sociologo
o uno storico o un botanico che in ogni caso ha a cuore il patrimonio che si trova a gestire è
comunque chiamato ad avere uno sguardo politico su quell’oggeto. È chiaro che
l’antropologo, l’etnografo, quando guarda l’oggeto vede le umanità che stanno dietro
quell’oggeto, se vogliamo può essere più preparato, atento, alla dimensione umana, e quindi
della relazione, sa cosa è una relazione, sa quale è il valore di una relazione, no? Però penso
che se l’antropologo è più capace di… lo è ma, diciamo, limitatamente. Per me è di ogni
disciplina; ogni disciplina deve vedere, ogni disciplina applicata al museo, deve saper vedere
l’umano che sta dietro. Questo è quel che penso.
M.D.: e passando dal diretore alla strutura, quale è la specifcità di un museo etnografco in
relazione alla sua missione, alla sua gestione...
M.T.: mi sembra così ovvio che non riesco a capire il quesito che mi poni; un museo di
antropologia, un museo etnografco è un museo che non si interessa di ogget, ma si interessa
degli ogget in quanto orme dell’umano, delle relazioni, delle umanità che stanno dietro; non
dico dell’uomo, eh!, dico delle umanità. E questo è il caratere del museo etnografco. Il museo
etnografco è un museo che dovrebbe essere non tanto interessato alla storia degli ogget, a
come gli ogget sono la prova testimoniale di un fato avvenuto; dovrebbe piutosto essere
interessato agli ogget quali testimoni, al fato che quegli ogget hanno partecipato a delle
biografe, a delle umanità.
M.D.: dovendo pensare a un proflo scientifco e professionale per un diretore di un museo
antropologico, come lo articoleresti?
M.T.: a prescindere dalle “nostre” università, spero che tu indenta… Per esempio tantissimi
ragazzi che si dicono laureati in antropologia, faccio il caso più vicino al nostro, a Bologna, ne
escono non avendo fato neppure una ora di ricerca sul campo. Come è possibile che esca
[XLV]
dall’università un laureato in antropologia che non abbia fato un’esperienza di ricerca sul
campo? E la ricerca sul campo è struturale per un etnografo. A prescindete da questo, il
percorso è quello, ovviamente, di essere in ogni caso capace di sviluppare una professione di
antropologo. Allora, prima sei antropologo, prima conosci l’antropologia e poi devi seguire un
percorso di formazione tecnica che oggi puoi avere tramite dei master, dei corsi post laurea,
sulle forme della gestione. A un certo punto conoscere il patrimonio e saperlo gestire ti fa
diventare… l’ideale sarebbe poter seguire questi percorsi in contemporanea, con la capacità
poi di approfondire il percorso da etnografo e nello stesso tempo vedere quali possono essere
i riscontri applicativi in un museo, però questo almeno la nostra università non lo permete.
Tutavia la dove è possibile dovrebbero correre insieme. Adesso tu cosa fai: ti laurei in
antropologia e poi ti guardi atorno a cerchi quelle oferte formative che ti arrivano tramite i
master. Questa è la strada per diventare diretore, non andare avanti e avanti approfondendo
un solo aspeto; tu devi diventare un tecnico del museo, un professionista del museo e un
etnografo capace di svolgere una ricerca, di conoscere anche la storia dell’antropologia.
L’ideale sarebbe trovare degli istituti universitari che ti formano dandoti questo taglio,
formandoti sull’uno e l’altro aspeto; esistono, però devi migrare, forse andare anche oltre
oceano. Io direi a un giovane che vuole fare questo lavoro di guardarsi intorno, girare molto,
fare molte esperienze, di scegliere la strada del mestiere. Per me ha signifcato molto andare
in Francia, vedere, entusiasmarmi, ma quelli erano i tempi in cui si poteva fare gaveta, erano i
primi tempi. Anche quella è formazione, così come gli scorni che tu vivi quotidianamente, ti
ritorneranno, saranno utili anche quelli.
M.D.: quale è il bello di dirigere un museo etnografco?
M.T.: è bello dirigere un museo, è bello sapere che il tuo lavoro, se ben fato, ha un valore
sociale e politico; sapere di lavorare per la gente, per i dirit, per i dirit delle persone, ecco,
lavorare per gli altri. Questa è la soddisfazione, che ti fa anche tener duro quando ti trovi di
fronte a persone o amministratori che invece la vedono in altra maniera. Il mandato per un
diretore di museo non è un mandato amministrativo, è un mandato sociale. Io lavoro non per
il mio sindaco, io lavoro per la gente di Santarcangelo. Questo è quello che ti da forza e
soddisfazione.
M.D.: hai citato la gente di Santarcangelo: che tipo rapporto c’è con la popolazione? Vi
incontrate, discutete…
[XLVI]
M.T.: il rapporto è buono, collaborativo, su fronti diversi. Per esempio quest’anno dedicherò
molto tempo all’incontro con tut gli insegnanti delle scuole. Portiamo avanti dei proget
assieme, ci deviamo il pomeriggio, lo faccio come antropologo, con gruppi di insegnanti
organizzo dei piccoli corsi di didatca dell’antropologia, faccio formazione, poi alla fne
formazione partono i proget annuali, il loro lavoro coi ragazzini, la verifca, questo con le
scuole, ma anche con le altre agenzie, con il confronto col diretore delle biblioteche, con chi
lavora nel teatro, con le associazioni di categoria c’è una grandissima apertura.
M.D.: come cerchi di coinvolgere il non pubblico, quelli che non vengono? C’è un modo per…
Questa è una domanda interessata.
M.T.: non c’è un modo, il non pubblico non esiste, esistono dei non pubblici in territori, quindi
il mio non pubblico è diverso dal tuo, e allora cerchi di capire quale è il non pubblico, cerchi…
tenti, esplori, dei richiami, degli stimoli, però non è un lavoro struturato, hai una sfda che vivi
navigando un po’ a vista.
M.D.: l’importanza delle associazioni, delle comunità quali potrebbero essere ICOM, SIMBDEA:
cosa fanno per i diretori e cosa possono fare i professionisti per queste associazioni?
M.T.: per il diretore queste associazioni rappresentano una preziosa occasione per uscire dal
museo e guardarsi un po’ atorno, per incontrare professionisti coi quali si condividono gli
stessi problemi… E rappresentano anche una occasione per uscire dall’autoreferenzialità. È
importante partecipare alle comunità, perché lì poi valuti il tuo lavoro, ofri le tue conoscenze,
raccogli esperienze altrui. Le associazioni ofrono occasioni formative, di verifca del proprio
lavoro e di costruzione di politiche. Non tut però percepiscono questa potenzialità. Certi
diretori non partecipando agli incontri pensano di rispondere a dei loro punti di vista, mentre
per loro dovrebbe essere un dovere essere presenti a queste riunioni. Se io fossi un
amministratore obbligherei il diretore di un museo a partecipare, perché è un suo dovere
confrontarsi con quella comunità, è un suo dovere stare lì a formarsi e a capire, mentre
ognuno pensa che il museo sia proprio e che sia lui il guidatore. È dovere per un diretore
tirare fuori il naso dal suo buco.
M.D.: questo dell’autoreferenzialità è un problema grande…
M.T.: è uno dei pericoli più grandi perché ce lo portiamo dietro da una storia di direzioni
[XLVII]
autoreferenziali, perché è più facile essere autoreferenziali, comporta meno fatica, non devi
rispondere agli altri, non sei messo soto critica, mentre l’autoreferenzialità è la morte
M.D.: quello che poteva accadere quando, anche in altri contesti disciplinari, a dirigere i musei
erano i docenti dell’università, che si comportavano al museo come si comportavano in
accademia
M.T.: si. Ci possono essere otmi antropologi che sono dei cani a fare i diretori, come ci sono
degli otmi diretori che sono dei cani quando tentano di fare… come ci sono degli otmi
antropologi che sono dei cani a fare i docenti, perché insegnare è un mestiere, e magari sono
dei teorici, dei ricercatori meravigliosi, mentre sembra che se tu sei un buon antropologo sei
anche un buon docente o un buon diretore. Non è vero niente.
M.D.: tu hai esperienza anche di progetsta. Come convivo le due cose? Che diferenza c’è tra
progetarli e dirigerli i musei? Quali forse diverse entrano in campo?
M.T.: mah, assolutamente sono atvità diverse. A parte che bisogna chiarire cosa vuol dire
progetare… Nel senso che c’è una progetazione dell’allestimento e c’è la progetazione della
gestione. Gestire un museo signifca seguire tuto quello che fnora ti ho deto; quando io
progeto un museo meto insieme la mia natura di etnografo e la mia natura di architeto e
quindi scrivo. La progetazione è una forma di… progetare il museo è una forma di…
cerchiamo di essere corret: progetare la parte espositiva di un museo, perché un museo è
molto di più della sola esposizione, signifca metere a fruto le conoscenze tecniche per
realizzare una scritura che è una conseguenza del tuo sguardo di etnografo. E quando
progeto l’allestimento io meto da parte il mio essere diretore, però è chiaro che conosco
cosa è un museo e posso avere delle accortezze che qualcun altro non ha; tutavia queste non
sono signifcative nella qualità complessiva della progetazione. Poi c’è qualcuno che mi dice
anche di progetare la gestione di quell’allestimento, perché quell’allestimento sta al centro di
una macchina (e il museo è una macchina), anche se noi siamo abituati al museo come al
luogo dell’esposizione. L’esposizione è una parte del servizio, è quel luogo di una
valorizzazione del patrimonio tramite esposizione e scritura, ma il museo è archivio, è tuto il
resto, è didatca…
M.D.: un istituto a tut gli efet…
[XLVIII]
M.T.: noi vediamo una stanza allestita e diciamo: è un museo. E’ più facile, ma se vogliamo
esser corret…
M.D.: quale è il futuro che vedi per i musei e per i diretori?
M.T.: alla luce della situazione atuale, che è fortemente condizionata, nel senso che se i
diretori si formano sul campo in una realtà che vede i diretori in carica invecchiare, e più
invecchi e più sei rigido, e ai giovani che dovrebbero in ogni caso avvicendarli, “imparare da”,
non gli si dà la possibilità di imparare perché non gli si da lavoro, io penso che presto ci
troveremo di fronte a un vuoto generazionale dove ci saranno diretori che andranno in
pensione e giovani che non hanno avuto la possibilità di formarsi e che dovranno ripartire da
zero. Questo nella prospetva che ci sia posto e le cose possano andare avanti. Io vedo un
buco, un vuoto generazionale, che ci porterà a dissipare saperi pratici, perché i saperi di un
diretore, in molta parte, sono saperi pratici che tu puoi trasmetere solo tramite lavoro
comune da fare assieme. Il futuro dei musei di etnografa dipende dalla capacità che questi
avranno di resistere alla tempesta, e penso che molti riusciranno a resistere se troveranno un
puntello nel volontariato. Molti musei oggi rimangono aperti perché subentrano volontari, i
volontari che si organizzano. Però ci sarà una moria, sicuramente. Questo è il dato. Vedo un
futuro con un vuoto, mancherà un anello. Quando io andrò in pensione… ho qui Federica
Foschi che sta con me da dieci anni e che continuerà… lei si sarà formata, ma se io non avessi
Federica… sarà fato un concorso, oppure incaricata una persona che arriverà qui per ripartire
da zero, e quindi io sono un po’ triste.
M.D.: quanto è forte l’impronta che un diretore dà alla strutura che dirige?
M.T.: è fortissima, perché un diretore deve scegliere e decidere, quindi molto è legato al suo
modo di vedere le cose, alla sua pazienza, non pazienza, capacità di atendere o meno, il fato
che sia disposto al dialogo o meno. Il museo ha una fortissima impronta dal suo diretore, sia
in positivo che in negativo. Perché il diretore decide, e decide secondo il suo punto di vista e il
suo modo di vedere le cose. Quindi ci possono essere dei diretori che avviliscono i
collaboratori, che promuovono i collaboratori, e da come sono formati o avviliti i collaboratori
dipenderà il futuro del museo dopo di lui.
M.D.: dovendo defnire, in sintesi, il lavoro del diretore, questo in che cosa consiste?
[XLIX]
M.T.: consiste nel prendersi a carico patrimonio colletvo e saperlo gestire atraverso la sua
capacità di scegliere e decidere nel senso di esporsi. Però sostanzialmente è questo, se uno in
due parole dice «che cosa fai tu» io rispondo: «investo le mie capacità per gestire un
patrimonio che non è mio». Questa è la politica. E questo è il lavoro del diretore.
M.D.: torniamo così all’inizio
M.T.: e così si chiude il cerchio.
[L]
Intervista con Antonio Riccio
Direttore del Museo della pietra di Ausonia
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino – Largo Angelicum
Roma, 24 11 2011
Marco D’Aureli: La prima cosa che mi piacerebbe capire è come sei arrivato al museo,
atraverso quale percorso professionale e formativo. A che punto della tua formazione hai
incontrato l’antropologia museale, come mai…
Antonio Riccio: penso che siano cose che in parte già sai, perché la nostra comunità è
talmente piccola che ci conosciamo tut. Ci sono entrato con una Laurea in Sociologia e con
una tesi in antropologia tuta teorica, sul rituale, fata con Vincenzo Padiglione. Subito dopo la
laurea seguii il Corso di perfezionamento tenuto da Tentori sull’ Antropologia delle società
complesse. In quel momento Vincenzo Padiglione, che era stato incaricato di realizzare
l’Etnomuseo dei Monti Lepini, mi cooptò in questa piccola, all’inizio era piccola, equipe
formata da me e da Donatella Occhiuzzi, la quale invece aveva fato una tesi sulla museografa
etnografca. Ci trasferimmo a Roccagorga ed iniziammo a lavorare lì. Quindi diciamo che nel
mondo dei musei ci sono entrato in qualità di antropologo con una formazione sociologica. E ci
sono arrivato atraverso una direta esperienza sul campo di ricerca, fnalizzata a costituire la
base documentaria di questo museo. Questa ricerca è durata, non continuativamente, quasi
dieci anni. Capisci? Dieci anni in cui io ho lavorato a diverse forme di ricerca: sul campo,
d’archivio, in emeroteca, tute fnalizzate diretamente all’allestimento, ed ho avuto la
possibilità di condividere anche le prime esperienze di gestione museali messe in ato da
Vincenzo, che al tempo stesso era la prima volta che si cimentava in imprese simili. Questa è
stata la mia esperienza formativa, una esperienze privilegiata perché ho visto e ho partecipato
atvamente
alla
nascita
del
più
originale,
interessante
e
innovativo
museo
demoetnoantropologico del nostro paese.
M.D.: Forse il primo vero museo etnografco...
A.R.: etnografco, sopratuto. E questa già era una grande torsione che io dovevo fare rispeto
ai miei studi, perché in fn dei conti ero laureato in sociologia, con una limitata formazione in
[51]
antropologia e dell’etnografa ne sapevo poco e niente. Però ho fato molte ricerche in quel
periodo, proprio tante. Piccole e grandi, di media e lunga durata… Mi sono formato sul campo
con un preciso modello, che era Vincenzo Padiglione, un modello alto, difcile da seguire
anche sul piano delle elaborazioni teoriche, però in sintonia con la mia sensibilità per
l’antropologia simbolica che ha signifcato molto per la mia formazione da etnografo. Sul piano
delle tematiche di ricerca invece avevo anche preferenze o interessi diversi che hanno infuito
sull’allestimento museale. Per esempio se in quel museo, in una certa stanza c’è rappresentato
il dramma locale della Pasqua Rossa, è dovuto ad una mia particolare sensibilità sul tema
dell’Eccidio di Roccagorga, che io avvertivo come un tema afetvo privilegiato per la
comunità, almeno allora. Il mio è stato un contributo di antropologia storica, basato in parte
sull’esperienza etnografca e su materiale storiografco d’archivio e di stampa dell’epoca, un
impegno legato molto al modello di riferimento che avevo (l’antropologia simbolica) ed alle
aspetative che si erano venute a creare nella comunità, credo. Un impegno notevole dal quale
sono uscito con una mia formazione etnografca, comunque non da diretore, però
“propedeutica a”. Se dovessi dire come si potrebbe formare un diretore… se riuscisse a fare
un po’ di tirocinio seguendo atvamente la……
M.D.: nascita del museo
A.R.: anche, oppure semplicemente la sua gestione, perché dopo che il museo è stato
inaugurato ho continuato a sostenerlo per molti anni con diverse iniziative: per esempio una
mostra su un tema del quale mi ero interessato
M.D.: quale era?
A.R.: appunto l’Eccidio di Roccagorga; una mostra basata sulla ricerca condota in emeroteca a
Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale, su giornali dell’epoca, quindi articolata in un
percorso molto povero – le solite cose a costo zero – che, mi ricordo, fu tutavia impegnativa
da organizzare. Poteva essere anche interessante da sviluppare, mantenerne traccia, invece è
andata perduta. Poi ho fato altre cose: collaborazioni a iniziative successive, l’ultima la ricerca
di etnoarcheologia che facemmo sulle capanne lepine, alla quale partecipò la professoressa
Cancellieri, Federica, Giulia, Emilio, insieme ad alcune giovani archeologhe. La pubblicazione la
stanno ultimando adesso, con altri contributi di ricerca, successivi, ma del primo rapporto di
[52]
ricerca me ne occupai io, lo feci impaginare e rilegare, era gigantesco, ed anche la ricerca la
seguii io, Vincenzo mi incaricò del coordinamento; c’era bisogno di ricercatori locali,
naturalmente. Anche quella fu un’esperienza importante per me. Mi è servita quando, nel
2006-2007, ho iniziato a coordinare la ricerca sulla memoria della guerra ad Ausonia, condota
da sei ricercatrici locali. Fu fata anche una bella mostra su Sant’Erasmo, il Patrono locale,
molto carina, curata, alla quale collaborammo Donatella ed io, poi altre atvità che non
ricordo.
M.D.: Ricerche la cui restituzione avveniva non tramite monografe, ma tramite allestimento
A.R.: Si diretamente tramite allestimento. Ho scrito qualche cosa, ma molto poco di organico
e compiuto
M.D.: questa forma di restituzione atraverso allestimento museale la trovi soddisfacente, ti da
soddisfazione? La trovi in grado di comunicare tut gli aspet della ricerca…
A.R.: no, questo no. Non da soddisfazione pienamente perché il tuo diventa un contributo ad
un’opera colletva che comprende come minimo tre o quatro persone tra cui il diretore, il
grafco, l’architeto… il tuo lavoro si perde un po’ nella più ampia cornice costruita sopratuto
secondo il disegno museografco. Quello che tu hai raccolto, elaborato, viene usato
seletvamente; frantumato, rimaneggiato secondo gli usi e le rappresentazioni scelte… Non è
che riesci ad avere una percezione…
M.D.: un controllo
A.R.: no, una percezione o se vuoi una visibilità completa del tuo lavoro, direi. Per cui da
questo punto di vista la soddisfazione è limitata, ma tutavia vedi realizzata la tua fatica in
un’opera colletva in forma tridimensionale, esperienziale, tatle, museale, che fa piacere a
vedersi…
M.D.: Ad Ausonia come ci sei arrivato?
A.R.: come sono arrivato a Ausonia pure è interessante. Perché…
M.D.: con la ricerca?
A.R: no
M.D.: già c’era il museo?
[53]
A.R.: quando sono arrivato a Ausonia il museo era già realizzato, quasi per metà credo, se non
tuto, comunque era progetato ed in allestimento. Ad Ausonia ci sono arrivato con un
percorso strano. Il Comune istituì questo museo demoetnoantropologico; cercarono di farlo
dirigere a Sonia Giusti, la quale aveva steso il primo progeto e gli aveva dato un taglio tuto
storico, un museo di storia della pietra. Dopodiché Sonia Giusti ebbe un contenzioso con
l’amministrazione, li abbandonò, li citò persino in giudizio credo, e subentrò un team di
architet romani supportati da una collega antropologa di Formia, credo, e da un antropologo
toscano di cui ora non ricordo il nome. Ma il Museo, essenzialmente, è stato fato da un team
di architet. Io ci sono arrivato per due motivi. Il primo fu che la Regione richiamò all’ordine il
Comune per il rispeto della legge regionale 42, in virtù della quale la direzione scientifca
doveva essere afdata a un antropologo; loro l’avevano atribuita ad una storica locale. Si
posero allora il problema della direzione antropologica, e chiesero alla Regione Lazio. Ed
arriviamo al secondo motivo, perché la Regione li indirizzò a Vincenzo Padiglione, che è il
principale referente per il Lazio, e Vincenzo a sua volta mi chiese se volevo occuparmene.
All’inizio non fui entusiasta, anche perché andai lì e trovai questo architeto locale, che sentiva
il Museo come suo, che mi fece quasi un piccolo esame del tipo «vediamo chi sei, cosa hai
fato..», come ti presenti, insomma. Sembrava piutosto critico all’inizio, anche perché un
antropologo “rompeva” la situazione fno ad allora creatasi con il team di ricerca ed
allestimento, introduceva uno “straniero” come “padrone di casa”. Ci furono non pochi
problemi, infat, con l’architeto che si era interessato dell’allestimento e si sentiva
antropologo quanto e più di me. Io a queste condizioni, con un museo tuto sommato deciso e
realizzato, un percorso museale tracciato atraverso pannelli, molto didascalico, senza ogget,
non è che me la sentissi molto di proseguire. Poi trovai, o meglio incontrai, la comunità; che
era interessata e curiosa anche ad un rapporto, forse per lei nuovo, con un antropologo. Dato
che era venuto fnalmente fuori che il Museo era un museo antropologico, volevano capire
cosa fosse l’antropologia. Il mio impegno nacque quando cominciai a percepire che c’era una
comunità che in qualche modo voleva far suo questo museo e che avevo la missione di far
capire cosa signifcasse un museo antropologico.
M.D: Come glielo spiegasti?
[54]
A.R.: all’inizio in maniera accademica, quindi anche fumosa, probabilmente. La prima loro
domanda fu “che cos’è l’antropologia?”. Me lo ricordo ancora, durante una riunione in
biblioteca. E cercai di dirgli, di spiegare questa cosa, con scarso successo; sai quanto è difcile,
per non dire impossibile, dare una risposta chiara, illuminante o almeno soddisfacente, a
persone del tuto estranee alla materia…. Poi mi accorsi che oltre a questa curiosità, il
principale interesse di questo gruppo per il museo era quello di trovare una “sistemazione” nel
museo stesso. Erano una quindicina, sopratuto ragazze, e avevano formato un’ associazione.
Mi tornò utile l’esperienza di Roccagorga, gli feci istituire un’associazione sull’esempio di
quella nata a Roccagorga. E comunque fno a quel momento non mi ero manifestato
minimamente come antropologo. Mi sentivo in questo museo come uno straniero. Un museo
che non ho amato subito, anche se devo dire ha una sua estetica; gli architet, i grafci restano
e si confermano professionisti, con qualche limite di “leggibilità” dell’allestimento che però ha
una sua bellezza, ben curato per sobrietà, eleganza, molto ordinato, ed all’epoca, anche
innovativo. I pannelli (il museo è fato di pannelli, anzituto) non coprono, non nascondono,
queste grandi pareti di pietra, e quindi il castello e la sua strutura in pietra domina
l’esposizione; c’è un senso di pulizia, di essenzialità, è una estetica da “museo da architeto”,
non è l’estetica contaminante di Roccagorga, non è l’estetica…
M.D.: un po’ international style
A.R.: è una cosa tra l’asetco e l’elegante; che non è poco. Un silenzio roto da questi rumori
evocativi della pietra, scalpelli, giochi di luci sulle pareti, realizzati con una spesa esorbitante,
delle slides che venivano proietate in una stanza. Questi pannelli, all’inaugurazione dovevi
“spiegarglieli”: non è che potevi dire «questo è il pannello, leggetelo»; pannelli scrit con un
taglio in parte naturalistico, in parte ecologista, in parte storico, in parte leterario; un
miscuglio un po’ enciclopedico, forse la loro idea dell’antropologia. Tuto sommato c’era tuto,
però capivo che in quel museo mancava un’anima. Per lo meno mi sembrava che ci fosse un
vuoto. Anche fsico, se vuoi, ma sopratuto emotivo; era “freddo”. Poi scopri qual’era questo
vuoto e questo “freddo”. Ne parlai per primo con Vincenzo, perché anche secondo Vincenzo
occorreva intervenire per dare un’anima “antropologica” al museo. La cosa dalla quale lui era
rimasto colpito, quando lo vedemmo la prima volta, fù un mucchieto di ossa ed un teschio
[55]
appoggiati in una nicchia delle mura interne della corte. Il castello, dove il museo ha sede,
usciva da un lavoro di restauro importante; lo avevano rifato in maniera bellissima, e avevano
trovato tra l’altro, durante i lavori, molte ossa umane. Ossa, frammenti, crani di persone che
nel tempo erano state sepolte in questo castello che, cadendo in rovina , era diventato il
cimitero del paese, la discarica, era diventato di tuto. Per non parlare di come lo aveva ridoto
la guerra. Quindi queste ossa erano persone della comunità che “abitavano quelle mura”. Per
Vincenzo poteva essere un tema da sviluppare, non so a cosa pensasse esatamente, ma un
tema forte, antropologico, del tipo “qui bate il cuore della comunità, il luogo dove si
seppellivano i trapassati della comunità”, secondo me. C’erano delle leggende di persone
sepolte lì, durante la peste, altre storie di comunità… Insomma, qualcosa di più che un
territorio antropizzato ed incastellato come veniva descrito nei pannelli
M.D.: qualcosa che si avvicinava alla nozione di luogo profetico?
A.R.: si… un luogo signifcativo, che presentasse scenari evocativi dell’immaginario
comunitario, dell’immateriale custodito e celato tra tanta pietra. Poi trovai la mia via
(inaspetata) a quest’immateriale che sentivo mancante. Una signora mi raccontò una storia:
«ma lo sai che qui ce so’ passati i marocchini?». Si riferiva alla seconda guerra mondiale,
naturalmente, ed alle vicende narrate da Moravia ne “La Ciociara”. Io ero passato
distratamente davanti ai monumenti di Ausonia, le sue “statue della memoria”, senza capire
cosa rappresentassero. Ma prima di me c’erano passati gli architet e gli antropologi che
avevano pure fato ricerca sul luogo, avevano raccolto interviste, e nessuno aveva visto,
capito, possibile?. Penso che su quel tema ci sia stata una velata “censura”, ma non posso
esserne sicuro. Di fato ci sono quatro statue ad Ausonia dedicate alla memoria della guerra;
ma cosa volevano dire queste donne rafgurate sulla pietra? Chi scappa, chi piange sul fglio
morto, chi protegge bambini terrorizzati: cosa rappresentavano queste donne? Insomma,
questa signora mi disse: «qui ci so’ passati i marocchini; una donna di Ausonia per nascondere
la fglia l’ha murata dentro una rèseca, una nicchia del muro…». Raccontai a Vincenzo questa
storia ed anche lui restò colpito, sorpreso, mi disse «Sì, è una bella storia». Era la “madre delle
storie di Ausonia” e da quella nacque l’idea di cominciare questa ricerca. Ma è nata ed è subito
morta, però, perché nel 2004, dopo aver inaugurato il Museo, il nuovo sindaco lo chiuse
perché era in confito con chi lo aveva aperto, anche essendo entrambi dello stesso partito
[56]
politico. Il nuovo sindaco era un acerrimo antagonista dei promotori del museo, credo per una
“questione di classe” oltre che di “campanile”: perché quelli erano gli intelletuali del paese, e
lui era il proletario di Selvacava, una piccola frazione che pur essendo parte integrante del
comune di Ausonia tutavia si percepisce come comunità autonoma e distinta, se non
antagonista di Ausonia. Chiuse il Museo; mi mandò un “commissario”, un avvocato eleto nella
nuova giunta che, con toni intimidatori, mi elencò le mille mancanze formali e legali del
museo, mi fecero trovare persino la scala d’accesso al mastio centrale chiusa con catene: «qui
non si può accedere perché le scale non sono in sicurezza», e mi rispedì a casa, praticamente.
L’esilio durò un anno. Però io procedevo su questa pista di ricerca, ed alla fne dell’anno, era
l’inverno del 2005, andai dal Sindaco gli dissi «senti, noi dobbiamo parlare, è inutile che mi
eviti, dobbiamo capire cosa fare, altrimenti non ci sto più così»; mi aveva fato perdere il
fnanziamento del 2005, nel 2006 dovevo assolutamente presentare un piano e per che cosa
potevo presentarlo?. Gli dissi «Questo è il mio progeto»; era la ricerca sulla memoria locale
della guerra e lui rimase con occhi spalancati, perché avevo colpito il suo cuore e credo quello
di una gran parte della comunità. Il nucleo, il “tarlo segreto” della cultura locale era questo
dramma che nessuno, fno ad allora, aveva voluto cogliere. Con quel progeto “me lo
comprai”; ma rivelai anche un aspeto per lui inedito dell’antropologia, ed una missione anche:
quella di dare voce a chi non l’aveva avuta. Ne restò fulminato, ma anche immedesimato nel
progeto: tant’è che lui adesso se ne è appropriato, dice «sono stato io quello che…, sarò
ricordato come il Sindaco che ha promosso questa ricerca» e va bene, glielo facciamo fare; ma
anche quello è stato un successo “faticato”. Il sindaco era, ed è, molto legato alla memoria
della guerra, in un modo molto tradizionale, intelletualmente semplice, racconta ancora che i
marocchini erano cannibali e che avevano mangiato parti umane, di ragazze. Però proprio
tramite questa ricerca…
M.D.: tramite la ricerca è passata al riapertura del museo
A.R.: si…
M.D.: Poi la ricerca ha trovato un esito all’interno del museo?
A.R.: l’ha trovata adesso, tu pensa. Il 28 maggio del 2010 ho inaugurato una sala riconvertita
da luogo dove si vedevano proietate slides di operai e artisti al lavoro a sala dedicata a “Storie
[57]
come pietre”. Ho deto: «cominciamo questo discorso, inauguriamo questo patrimonio»; con
una prima installazione povera, poverissima, un pannello caotico fato con la trascrizione di
frasi prese diretamente dalla ricerca, in dialeto, due icone “privilegiate”, il goumier e la
ragazza murata viva, e …
M.D.: …dei frammenti di voce
A.R.: sì, un circuito sonoro che difonde le voci della memoria, che non sono quelle dei
testimoni intervistati, ma le loro interpretazioni, recitate da atori locali. Nella realizzazione di
questo spazio ho avuto lo stesso problema che si presentò a Roccagorga: quando dovemmo
fare la stanza dell’eccidio non avevamo una intervista buona per esser riprodota in
allestimento. Dovemmo andare in uno studio dove fecero dei lavori di ripulitura e di
montaggio…
M.D.: problemi di qualità dell’audio?
A.R.: si, facevamo le interviste con i registratori a casseta… Ad Ausonia, invece, ci sono le
“interpretazioni artistiche” di queste testimonianze, prese dal Reading che abbiamo ricavato
da queste storie e quindi sono una letura artistica di passi di interviste e testimonianze. E
sopratuto, nella stanza, è riprodota la scena “madre” del goumier che entra in una casa di
paese e della ragazza murata viva dalla madre per sotrarla alla violenza. Forse è una
installazione che può lasciare un po’ scioccati […], è forte, però rompe un muro di silenzio,
ignoranza, tabù, mostra una memoria sepolta. Poi davanti alla nicchia-icona della ragazza
nascosta dietro un muro di pietre ho messo un pannello, un pannello avvolgibile, che si può
sollevare a abbassare, sul quale è riprodota una donna che scappa, ripresa da una delle statue
della memoria di Ausonia. Vela e al contempo svela la storia drammatica delle donne e della
violenza della guerra. Questa è stata la restituzione museale di quella ricerca, a distanza di
molti anni. Nel fratempo ho scrito un libro, ho realizzato il reading e un video, anzi: ho
inaugurato il nuovo allestimento proietando quel video. E questa è stata la prima restituzione
di quella ricerca e di quell’intuizione. Devo molto all’esperienza di Roccagorga. Vincenzo
diceva a proposito delle sculture aforanti, che trovi quando entri all’Etnomuseo, che si viene
accolti dall’idea che ci sono delle storie che vogliono emergere, venire alla luce. Io penso che il
museo di Ausonia proponga un po’ la stessa cosa. Quella signora che me l’ha raccontato la
[58]
storia è come se l’avesse voluta “tirare fuori”, farla ri-emergere. C’era una grande voglia di
dirla. Il grande timore delle sei ragazze che hanno svolto la ricerca era: «ma queste anziane
non parleranno con noi, non vorranno, perché sofriranno …», e io rispondevo loro: «se
pensate che andate a far loro del male, non ci andate proprio. Io penso invece che quando
andrete da loro scoprirete che vi aspetavano da tempo», ed è andata così. La nostra è l’
esperienza di gente che voleva essere ascoltata; gente che per la prima volta ha deto di
essere stata violentata davanti a persone della propria famiglia, capito? È stata una cosa anche
terapeutica. Da lì ho sviluppato un laboratorio di arti terapie, dedicato alla “didatca della
memoria” per adulti […]
M.D.: Questa esperienza di ricerca ha avvicinato la comunità al museo, gli abitanti di Ausonia
hanno iniziato a vederci anche delle proprie storie…
A.R.: Si, in efet è stata la carta vincente. Ti premeto che ad Ausonia del Museo non importa
molto. Ci vanno quando c’è la festa di San Michele, perché il Museo confna con la chiesa e al
Museo ci entrano sopratuto per una ricognizione del castello, non del Museo in quanto tale,
perché si devono re-impossessare di questo luogo che prima era un luogo comune e adesso è
diventato un luogo privato. Però il tema della memoria li ha avvicinati: ho fato questo reading
della memoria e la gente è venuta; la prima volta riempirono l’auditorium, perché era in
inverno; poi l’ho fato in estate nel cortile del castello; l’ho fato nelle comunità vicine; sempre
con molta gente. Quella è stata la carta vincente. Ma si trata di un avvicinamento episodico.
Sono riti di comunità. A Natale e in piena estate, è il rito della memoria locale e piano piano
credo che questo museo si stia caraterizzando per questo link tra la pietra e la memoria, la
pietra che porta memoria, che la conserva, la manifesta, e che in qualche modo consente di
elaborarla. Per lo spazio e la voce che ha dato alle comunità interpretanti, è importante. Come
nasce questo Reading? Dovevo fare un seminario sulla ricerca, e mi portai delle slides con frasi
in dialeto prese dalle interviste. Durante la proiezione del powerpoint avevo vicino a me la
presidentessa di una compagnia teatrale di San Giorgio al Liri, alla quale chiedevo di leggere il
testo in dialeto, che a me riusciva male, e lei leggeva con grande partecipazione; e vidi che
stava interpretando. Ma fece di più: andò a casa ed il giorno dopo mi portò l’MP3 dove non
solo c’era la frase leta ma anche un sotofondo musicale degli Ashram, un gruppo musicale
[59]
napoletano, che il fglio (che faceva il DAMS a Bologna) le aveva suggerito, musiche intense,
molto appropriate e capii che aveva trovato una rappresentazione nuova di quella memoria; la
rappresentazione della seconda generazione. Quando sento oggi questa performance non sai
più se l’ha fata lei, o l’ho costruita io anche atraverso lei. Penso che è un prodoto che viene
dalla comunità interpretante; non so se è un rito “loro”, o un ibrido, qualcosa d’altro.
Probabilmente, se non c’era la ricerca museale non sarebbe nato, non avrebbero raccolto e
trasmesso niente… un patrimonio perduto, chissà; questa è la cosa sulla quale rifetere. A
qualcuno potrebbe sembrare che gioco sui sentimenti forti, sulle emozioni forti, ma ti posso
assicurare che se senti il reading capisci che ha una sua armonia, anche costruita, ma perché
c’era, c’è, nel patrimonio narrativo, che non indulge né ai versanti drammatici, né pietistici, né
di denuncia ma piutosto riproduce una narrazione colletva e complessa, con un suo
equilibrio che è quello della memoria sociale locale; c’è il riso e il pianto, c’è il dolore e
sopratuto c’è la serenità, pure se ti raccontano queste cose. Questo me l’ ha confermato
anche Miriam Mafai, che mi ha fato l’onore di venire a presentare il mio libro da Quirino Galli,
al Museo delle tradizioni popolari di Canepina. Ha deto «dovevo fare i conti con quella storia,
non li ho fat allora, li ho voluti fare adesso». E’ rimasta meravigliata e colpita sopratuto dal
tono emotivo delle narrazioni (sopratuto nel video) : “Dicono cose straordinarie con una
grande serenità”. Se le testimonianze trasmetono questo signifca che questa memoria non
pesa sull’ascolto, non drammatizza esperienze, non cerca “emozioni forti” che poi era il grande
fantasma di questa ricerca.
M.D.: È stata una grande soddisfazione insomma
A.R.: questa si
M.D.: quando vedi che quello che fai tocca delle corde, entra in risonanza con…
A.R.: poteva essere anche la soddisfazione narcisistica di aver trovato la cosa ad efeto, no?
Un successo “emotivo”. Me lo sono posto questo problema, perché ho ricevuto critiche su
questa difusione della memoria. Un funzionario provinciale quando gli ho presentato un
ulteriore progeto per dare continuità alla ricerca ed al suo allestimento mi ha deto:
«Ancora?». In occasione di una visita al Museo di Pastena vidi dei reperti bellici ed ho deto: «
anche voi avete conservato ogget, ricordi della guerra…». Ma la diretrice, una cara amica,
[60]
rispose «si ma qui da noi non è così forte, l’abbiamo superata questa cosa». Mi sembrò un
prendere distanza sia da altre “comunità del ricordo” che dal mio lavoro, anche una implicita
critica di coltivare nostalgie, superate o da superare. Mentre per me, quella memoria è solo la
punta dell’iceberg di un più ampio patrimonio locale; soto l’iceberg c’è il grosso, quella che
chiamo la “nuova memoria contemporanea”. Quindi all’inizio la soddisfazione veniva dall’aver
trovato risposta nella comunità; adesso la mia soddisfazione è di tipo “più antropologico”, nel
senso che ho trovato un legame forte con la contemporaneità, sopratuto nel collegamento
con i collezionisti ed i cimiteri, atori e luoghi della memoria atuale della guerra. Se mi fossi
fermato alla sola memoria orale forse mi sentirei vicino al folklorismo, alla mera raccolta di
reperti narrativi, ma ho lavorato molto sul materiale narrativo cercando legami con la
contemporaneità e sto ancora lavorando.
M.D.: L’antropologia in quel museo un po’ c’è entrata in un secondo tempo, a quanto mi
dicevi... mi spiegavi che quella strutura nasce con una impostazione un po’ generica sul tema
della pietra
A.R.: diciamo con uno sguardo “dedicato” al territorio antropizzato, tra l’antropologico e
l’ecologista; c’erano degli elementi antropologici, ma di superfcie; del tipo credenze sui
follet, o aspet magici e soprannaturali legati alla pietra, non una antropologia rifessiva,
interpretativa.
M.D.: Ora dato che hai toccato il discorso te lo chiedo subito, come è rifessivo il diretore di
un museo?
A.R.: come è rifessivo? Beh, sono stato rifessivo ritornando su cose che avevo scartato. Per
esempio ho raccolto interviste, questo patrimonio, di cui sono orgoglioso e geloso: 500 pagine
di trascrizione che mi sembravano un tesoro inesauribile, prezioso. Lo è, però avevo “scartato”
tante altre cose: i cimiteri della zona, le statue, i collezionisti, che mi sembravano un fenomeno
di margine. Invece più passa il tempo, più rifeto su questo corpus narrativo, più capisco che
anche da lì vengono rimandi al territorio, un po’ quello che il museo mi invita a fare; guardare
al territorio. E sul territorio ci sono il turismo della memoria, il collezionismo di reperti bellici, il
reenactemet, ci sono i “pellegrinaggi laici” dei locali in montagna e dei turisti stranieri ai
cimiteri di guerra, vengono ogni anno, c’è una efervescenza di forme di memoria in
[61]
cambiamento. Mi invita a diventare più rifessivo e più atento: sono andato sul territorio per
fotografare luoghi e segni della guerra, visitare case di collezionisti, di studiosi locali, musei
privati, mostre permanenti, cose che all’inizio scartavo mentre ora vi scopro la memoria della
contemporaneità. Anche la memoria orale è nuova, perché è narrata nel qui ed ora
contemporaneo, però queste forme che stanno emergendo è qualcosa in progress. Ha una sua
ricchezza, vivacità critica e problematica che invita alla rifessività.
M.D.: Nella vita del museo, nella vita ordinaria, questa rifessività come si inscrive nelle
pratiche, nelle atvità? Atraverso un coinvolgimento della comunità…
A.R.: si, da questo punto di vista devo dire che mi è servito… una volta che tu entri nel
processo di dialogo con le comunità locali ci rimani; cerchi di capire come loro immaginavano il
museo, che vita avrebbe potuto- o dovuto - avere e mi è sembrato di capire questo: è come se
mi dicessero «sì va bene, questo è il tuo museo, però questo posto e questo spazio (di
rappresentazione) è anche il nostro; dove ritrovare le nostre cose, sentirlo come proprietà
locale». Infat usano gli spazi museali, la corte, il castello, senza darmene notizia per farci
convegni della comunità montana, chiedono piccoli fnanziamenti per iniziative folkloriche,
come “Ausonia etnica”, senza neanche porsi un problema di coinvolgermi. Ma la “loro”
“Ausonia Etnica” è un prodoto autoctono del quale mantenere una gelosa gestione. A volte
mi è stato chiesto di presentare il museo a gruppi di persone alle quali il sindaco tiene in modo
particolare, ma in genere la fa lui stesso la guida; ci tiene a mostrare una competenza da locale
ed al contempo da uomo di politica e di cultura. Mi invitano a presentare libri, oppure ad un
convegno sul lavoro e la crisi del setore estratvo; di recente a Coreno Ausonio per una
Mostra sul “perlato Coreno” il marmo locale, ma molto limitatamente. La loro idea è che
questo museo non ha, né può avere una vita giornaliera, ma più che alto episodica
M.D.: eventi
A.R.: oppure con le scuole…
M.D.: Per te questo museo rappresenta un osservatorio… sulla comunità?
A.R.: si, certo, ti dà un punto di vista sul “come” il museo viene usato dalla comunità.
Prendiamo il problema dell’apertura. Come l’hanno risolto? Non hanno mai afdato la
gestione a un ente, hanno risolto il problema atraverso i volontari civili, che atraverso la
[62]
Comunità montana vengono “prestati” al Comune. Ma sono una risorsa per l’amministrazione,
non per il museo. Dicono « lo metamo al museo, però intanto guida il pulmino, da una mano
in Comune, alla ragioniera…». Capisci che il volontario è un “bene comune” nel senso che è
proprio “del Comune”, in questo senso parlerei di un osservatorio sul modo locale di vedere “il
museo della comunità”. Quando ho proposto di cambiare l’allestimento l’architeto che mi
chiamò a dirigere il museo, mi ha assalito, accusandomi di «stravolgere tuto…» di una deriva
museale rispeto all’allestimento. Ho dovuto chiamarlo, parlargli, spiegargli quello che volevo
fare. Si sente il custode di questo museo e vuole che rimanga così: lo ritiene suo, una “sua
creatura”. Poi abbiamo trovato una mediazione.
M.D.: L’esperienza del museo arricchisce l’antropologo? come? lo arricchisce di esperienze, di
punti di vista?
A.R.: si, perché secondo me ti pone dei problemi sul modo di afrontare e comunicare la tua
professionalità, di far capire che cosa è un antropologo. Io ho questa ambizione; di cercare di
farlo capire, o meglio di dare una interpretazione comprensibile del mestiere dell’antropologo.
Forse non è un’immagine diversissima da quello dello storico, ma a suo modo, è defnita.
Dapprima era più vaga, di ricercatore sul territorio, vai a fargliela capire l’antropologia, no?
Poi, quando ho presentato la ricerca sulla memoria qualcosa ha preso forma. Su un problema
circoscrito (la memoria della guerra e la violenza) - che riguardano un territorio, ecco, questa
concretezza del tratare in forme nuove fenomeni vissuti, colletvi, l’hanno capita. Il legame
pietra-memoria mi è servito per mostrare il link tra il patrimonio materiale ed immateriale, e
per essere più concreto. Da allora, quando parlo di questi temi il mio riferimento privilegiato è
la platea di “gente normale”, a discapito della terminologia antropologica, della quale mi
interessa il giusto. Molte sovrastruture… modi di parlare, di pensare e di essere, devi
negoziarle con chi parli quando fai il diretore. Secondo me la scelta non accademica, ma
comunque alta, è una scelta coraggiosa. Decidi a chi e come vuoi parlare con linguaggi diversi,
secondo il tuo pubblico, e la difcoltà è di individuarlo di volta in volta… […]. Il diretore
museale deve scegliere un modello; non necessariamente accademico. C’è chi ha come
priorità i suoi pubblici, le sue comunità interpretanti. L’esperienza di un diretore museale è la
diversità dei pubblici, la sfda a parlare con loro.
[63]
M.D.: Questa cosa del pubblico, del sapere individuarlo, rimanda un po’ a questioni le
chiamerei di “tecnica professionale” del diretore. Un diretore deve tra le tante cose saper
individuare il pubblico al quale si rivolge. Allora ti chiedo: dove hai imparato a fare il diretore?
Quali pensi siano le carateristiche le prerogative del diretore? Il lavoro del diretore in cosa
consiste?
A.R.: Guarda, io credo di aver imparato sul campo. Il mio maestro ideale rimane Vincenzo
Padiglione; che lo accet o meno è stato il mio maestro. Anche come diretore benché per sua
stessa ammissione, pur essendo un vulcano di idee e di iniziative, lo sai meglio di me, dal
punto di vista della gestione pratica non ha fato il diretore del quotidiano. Lui presidiava il
Museo, sì, ma delegava anche a me atvità, proget elaborati da lui, ma sviluppati da me, da
altri collaboratori successivi, atuali. Diciamo che ho imparato diretamente sul campo con
l’incarico ad Ausonia ed i problemi di quel Comune. Per cui stare appresso all’operatore
museale sapendo che poteva far fallire il piano di fnanziamento per mancate scadenze e altre
formalità burocratiche, è stata una cosa che ho imparato dopo che sono saltati ben due
fnanziamenti, dopodiché ho capito che dovevo fare anche quel lavoro. Il sabato matna vado
a Ausonia, due ore la matna, per parlare con l’operatore, per risolvergli problemi; gli mando
proget, mail di accompagnamento, testi pronti per le delibere…
M.D.: Scrivi le delibere, le determine, anche io il sabato matna vado a Latera e faccio la stessa
cosa, perché ho visto che se non le faccio io queste cose, loro… Poi c’è da dire che i comuni
sono piccoli, per tuta una serie di motivi… il sabato gli porto le delibere già scrite
A.R.: Io faccio anche la contabilità, ma approfto di quelle ore per avere il polso della
comunità, che dicono,che fanno, scambiamo ‘petegolezzi’, a volte scoperte preziose su
iniziative da fare, interessi locali da curare, seguire.
M.D.: è la perduzione quella, no?
A.R.: che però mi risolvono… capito? Se durante i miei incontri con l’operatore compare il
sindaco può essere l’unica occasione per parlargli. L’ultima volta mi ha suggerito una ricerca
sulla Madonna di Santa Maria del piano, perché “ se no sta sempre in mano alla chiesa!”. Ed
ha ragione. Io ho fato a suo tempo un video, all’inizio del 2004, sul culto di Santa Maria del
Piano, però non ho mai approfondito quel tema. Allora vedersi il sabato, parlare, confrontarsi
[64]
con il “proprietario” legale del Museo diventa uno scambio, è utile questa cosa, ho imparato
atraverso gli errori, ho imparato atraverso confit con la Provincia. Con la Provincia ho avuto
un difcile rapporto; sono andato a parlare con l’assessore alla cultura, per fortuna una
bravissima persona, ha capito il valore del progeto che porto avanti. L’ho invitato a venire al
Museo e quando è venuto e ha visto la stanza col goumier, l’icona del marocchino, lui che
viene da appartenenze politiche di destra, puoi immaginare come è rimasto… Però gli ho
spiegato che quel manichino di goumier, in acciaio, legno e jellaba, era un potente e
coraggioso ato di denuncia, un fantasma che prendeva corpo, aspeto, dal quale cominciare a
parlare, a far problema di una memoria lacerata e confusa. Far emergere problemi nuovi e
antichi, mostrare i danni prodot dalla censura, dal tabù, dal silenzio, ed ha capito. E questa la
ritengo una grande soddisfazione. Ha mostrato di essere sensibile all’impegno culturale, alla
scelta educativa; cose non da poco.
M.D.: Cosa deve saper fare un diretore di museo. Quale è un bravo diretore di museo?
A.R.: eh, guarda, dovrebbe saper fare parecchie cose; dall’amministrativo alla ricerca, dalla
produzione di allestimenti al tener viva l’atenzione sull’istituto, curare i rapporti con le scuole,
con gli anziani, saper trovare nuovi pubblici, girare il territorio, lavorare a tempo pieno per
atrarre la gente, perché la gente non viene da sola. Io questo l’ho sempre fato male, tardi,
insufcientemente. Quest’anno per la prima volta sono andato a bussare a un istituto
comprensivo di Pontecorvo, dove ci sono 1000 studenti, per cercare pubblici scolastici, e ho
cominciato a stabilire un rapporto. Ho capito che avrei dovuto farlo sei anni fa, e quindi che
dovrei girare di più il territorio. Molte persone della comunità mi chiedono di produrre piccole
pubblicazioni, modeste, adate alla domanda locale: “Voglio sapere la storia della Madonna
del Piano”, “Voglio avere delle belle fotografe della festa”, “Voglio avere un documento che
spieghi la leggenda”; sono piccole cose, non il volume, quello serve per te, la comunità dei
diretori museali, o accademica. Il libro sulla memoria degli Aurunci loro lo tengono come
oggeto d’afezione, in casa, forse non l’hanno neanche leto. Però dicono: «io sto qui
dentro…», capito? Lo sto ri-editando più bello, aggiornato, perché abbia ancor più questa
dimensione di “restituzione” ed “afezione” per loro. Con un apparato fotografco, una cosa
[65]
che non ho potuto fare all’epoca, perché troppo in freta, troppo impegnato a far conoscere
ciò che credevo di aver scoperto
M.D.: un ulteriore step di restituzione…
A.R.: sì, mi sembra che vada incontro all’esigenza dei letori interessati, dargli un testo più
curato e più articolato, che evidenzi le problematiche, le complessità, le ambiguità, le
intuizioni, le interpretazioni....
M.D.: Può sembrare banale, ma perché è importante che un museo etnografco sia direto da
un antropologo?
A.R.: è importante direi, più che da un antropologo, da un antropologo che è anche etnografo.
Perché non tut gli antropologi sono etnograf, purtroppo. Così come non tut gli etnograf
sono antropologi. Per me è importantissimo: ti faccio questo esempio. Dov’è che mi sento più
forte nell’insegnamento? Non nella teoria; su quella, uno bravo che studia e si aggiorna fnisce
col saperla meglio di me. La mia forza sta nell’esperienza della ricerca. Quando parlo delle
ricerche l’uditorio cambia, da così a così. Ho fato percepire a un gruppo di turisti che venivano
da Gaeta la stanza che ho inaugurato, Storie come pietre, quando ancora non era allestita.
Perché avevo la forza immaginifca della ricerca che mi ha permesso di far loro immaginare
l’allestimento. Con l’aiuto di poche cose; immagini, disegni, frammenti di idee; ma sono rimasti
incantati, sorpresi, come se l’avessero vista. Era un gruppo di persone adulte, mature, alle
quali ho chiesto pareri, forse rassicurazioni sulla scena museale che volevo proporre e mi
hanno deto cose importantissime. Hanno deto «si è forte però fai bene, devi aver coraggio,
bisogna farlo», mi hanno incoraggiato dove avevo dubbi. Altra gente magari ti suggerisce
dubbi su questioni delicate, forse i loro dubbi, ma te li pone: «non starai seguendo qualche
morbosa curiosità, non meterai troppo in evidenza il trauma?». Io non credo che la memoria
locale della guerra sia solo trauma, e che quand’anche lo fosse, l’unico modo possibile per
rappresentarlo, quel trauma, è quello museale; per comprenderlo criticamente ed uscirne
anche; atraverso l’elaborazione scientifca, testuale, museale. L’etnografo può portare anima
in un museo. Un museo DEA può dire “qualcosa di antropologico“se viene dell’etnografa.
Perché se no… il locale (noi dirigiamo musei locali) dove sta? Nella fraseta in dialeto? Non
credo che basti.
[66]
M.D.: Questo riferimento che facevi mi porta a fare una domanda: che diferenza c’è tra fare
l’antropologo in museo e all’accademia. […]
A.R.: alla Sapienza ho fato esperienza d’insegnamento per 8 anni; all’Angelicum insegno dal
2000, sono 11 anni… Che diferenza c’è con il fare l’antropologo al Museo di Ausonia? Non
sono mai stato interno al mondo dell’università; sono stato docente a contrato, non ho mai
avuto fondi di ricerca; se non avessi avuto la mia esperienza personale e museale di ricerca,
mi sarei sentito un docente improvvisato, debole, un insegnante liceale che riportava il
manuale agli studenti. Ho cominciato a tenere lezioni con tre persone; alla fne avevo l’aula
piena; signifca che qualcosa davo. Il massimo che ho potuto fare per sentirmi antropologo
all’università, è stato realizzare lezioni con powerpoint ricchi di immagini ed interpretazioni
provenienti dalla mia esperienza di ricerca, e questo li prendeva. Al museo devi far capire alla
gente che tu hai un mestere nelle mani, non sei uno che chiacchiera solo. All’università devi
far capire che la tua teoria ha dietro di sé una esperienza vissuta, forte, ed una passione vera,
in cui “credi”. Questo principio l’ho costantemente presente. Se mi chiamano a presentare un
libro «perché sei un professore» replico che «posso far vedere come legge questo libro un
antropologo». Molti non vogliono sentire chiacchiere accademiche, ma quando vai ad
intervistarli parlano. Capisci che a volte gli da fastidio il tuo linguaggio. Perciò quando ti
invitano a qualche iniziativa cerchi di dire cose antropologiche con un linguaggio “spaesante”,
un mix tra il linguaggio comune ed etnografco, mediazioni possibili.
M.D.: Non è facile, è impegnativo
A.R.: sì, a volte sembra che stai tradendo te stesso, perché usi parole in maniera anche
scorreta; ho rispolverato le parole simbolo, evocazione, che già mi sembrano abbastanza…
M.D.: tu pensa solo il conceto di tradizione, quanto è difcile… ogni volta che uno dice
tradizione sente…
A.R.: infat… “la tradizione - dico - non è quello che voi pensate; non è la voce del passato, la
tradizione è quello che stiamo facendo ora; è questo reading che rappresentiamo qui, oggi;
questa è la nuova tradizione di Ausonia”, capito? Se il conceto lo leghi ad una cosa concreta,
[67]
una atvità così, lo capiscono. Lo capiscono persino coloro che non vengono mai al museo,
tanto che non si azzardano a non venire al reading perché quasi quasi….
M.D.: è tradizione!
A.R.: Il difcile è trovare gli agganci con l’esperienza per queste parole. Così come il conceto
di cultura…
M.D.: identità, cultura…
A.R.: alla cultura siamo abituati a dargli un signifcato troppo alto. Una persona di Ausonia mi
ha deto: «noi siamo fat così; in inverno andiamo a fare una gita sul monte Fammera dove
durante la guerra andavamo a rifugiarci». È un pellegrinaggio laico; è la cultura della memoria
locale. « Sapete che cosa è una cultura? E’ anche questo».
M.D.: Ce ne ho una di domanda che forse non è formulata in modo chiaro. Quale particolare
torsione imprime l’essere un antropologo di formazione alla tua funzione. Come il tuo essere
antropologo condiziona il tuo lavoro di diretore. Come il diretore antropologo è diverso da
un diretore altro… per una particolare sensibilità… Pensi che questo imprima una cifra
particolare al tuo essere diretore?
A.R.: si, questo si. Ti faccio un esempio: mi confronto con il diretore archeologo, che si
relaziona con un pubblico, diciamo, ideale o idealizzato, al quale lui trasferisce questo sapere
con i suoi termini, le sue modalità, con la sua autorevolezza, sicurezza, che gli viene anche da
uno statuto consolidato della materia. Il diretore antropologo deve fare i conti con gente che
quando entra chiede: «Che c’entra la memoria della guerra con il Museo della pietra?». E tu
devi dirglielo in due parole; io me lo sono posto questo problema, di essere direto nelle
risposte, di fargli capire che non ci sono mediazioni intelletualistiche. E di farglielo capire con
le loro parole, con una logica comprensibile senza bisogno di terminologia specialistica, ma
senza evitarla. Tradurla, magari. Ai visitatori della stanza “Storie come pietre” dico, se c’è
qualcuno che è sensibile non voglio che si senta turbato: «pensateci prima di entrare in questa
stanza, non è un trauma ma non è nemmeno una cosa che ti lascia indiferente», capisco che
quello che a me dà signifcato e problema a certi potrebbe dare fastidio. In questa stanza, l’ho
già deto, ho messo l’immagine della madonna per ricreare un angolino della cucina, con
l’icona della Madonna con la candela, e vedi la gente che entra e si fa il segno della croce, e
[68]
capisci che hai sforato due dimensioni. La memoria della memoria e la devozione mariana,
entrambe tra passato e presente. Quindi hai generato una rifessività che gira sempre,
naturalmente… Credo che difcilmente esista qualcuno come l’antropologo che rifete su se
stesso mentre fa il diretore; l’archeologo forse non rifete su sé stesso se non dal punto di
vista didatco: «come posso migliorare la didatca per i bambini?», però non si guarda mentre
fa quel lavoro e non tematizza questo suo lavoro come problema. La considera una
competenza legitma…
M.D.: Io sono l’archeologo e ti dico come stanno le cose
A.R.: si, lui spiega… Sostanzialmente lui spiega; io so di dare una interpretazione e cerco di
farla apparire autorevole, sentita, e al tempo stesso non esclusiva. Che non è facile.
M.D.: Il bello di dirigere un museo etnografco?
A.R.: si, perché c’è anche il bello, è vero…
M.D.: beh, mi fai capire che allora c’è anche il bruto…
A.R.: si, c’è il bruto. Il bello sono le soddisfazioni che ho ricevuto dalle comunità interpretanti,
per usare questo nostro linguaggio; e dai pubblici. Piccole soddisfazioni. Per esempio questo
piccolo gruppo che veniva da Gaeta e mi ha confortato in un momento di crisi… La più grande
soddisfazione: l’aver organizzato il reading senza un soldo, sul volontariato di tut. Addiritura
del fonico che viene a spese sue, con l’amplifcatore e lavora tuta la serata, sono riuscito a
fargli avere dei soldi solo anni dopo […]. Il bello di fare il diretore è legato anche a questa
buona pratica, si. Ed è la cosa per cui sono riconosciuto lì, sul territorio, ma che mi ha dato
anche credito, autorevolezza scientifca. Il bruto… ce ne sono tante di esperienze. Di essere
considerato qualcuno che non deve rompere troppo, che se gli fai perdere due o tre
fnanziamenti, «pazienza, succede», e se ti pagano tardi e male, succede. Ed è sopratuto una
comunità che non ti fa la grazia di venire a visitare il museo se non quando serve a loro; e
quando viene, pretende di entrare gratis… Non so se capita pure da te
M.D.: da noi i residenti entrano gratuitamente, la gestione è afdata alle Pro Loco, c’è accordo
con l’amministrazione… deto questo i celleresi o i lateresi vengono solo ed esclusivamente
per gli eventi: i poeti, il concerto, il teatro di fgura, le mostre…
[69]
A.R.: quando il museo diventa luogo animato… questo ci fa rifetere sul nostro dispendio di
energie, no?
M.D.: Per quanto riguarda i rapporti con l’amministrazione…
A.R.: diciamo che ho guadagnato un rapporto di stima: loro mi stimano, al tempo stesso
alcune cose se le fanno per conto loro perché un’autonomia sulla gestione culturale la
vogliono conservare. Vorrebbero che li facessi partecipi della gestione scientifca, li coinvolgesi
di più, andassi a spiegarglieli i proget, a negoziarli, forse. Io spesso invio il progeto scrito
all’operatore che lo fa partire, quindi… manco di buone maniere
M.D.: tanto se glieli dai non li leggono...
A.R.: si, infat, dovresti andare a parlargliene; farlo leggere è anche quello un ato ostile o
quasi….
M.D.: poi però c’è il rischio che se gli chiedi un parere ti bloccano
A.R.: si…
M.D.: giochiamo veramente sul non deto
A.R.: a volte ti penti di averle dete certe cose, a volte di non averle dete… non sai come e
quando farli partecipi.
M.D.: Oggi il museo lo considerati una atvità qualifcante la tua professione di antropologo o
un qualcosa di secondario?
A.R.: no la considero una atvità qualifcante, per me è importante per la mia identità di
antropologo. Mi hanno chiamato a fare catalogazione, nel caso della festa di Santa Rosa per
l’Unesco; ho altre ricerche in corso, sono interessato alla difusione ed interpretazioni locali del
il Tai Chi Chuan, patrimoni immateriali dell’umanità, ho diversi temi miei, però quello che mi
qualifca è questo, perché ha un riscontro per un pubblico, per delle comunità. Tocca la vita di
certe persone. Per esempio la comunità dei collezionisti che è un fenomeno incredibile,
internazionale, complesso. Per me è molto importante.
M.D.: Che ruolo hanno le associazioni come SIMBDEA, ICOM nella tua vita: dare una identità
forte ai diretori, ofrire loro strumenti
[70]
A.R.: io dico che dovrebbero e potrebbero fare di più, tut e due. Per carità SIMBDEA… anzi,
meno male che SIMBDEA c’è, nel senso che se non altro ci aggiorna. Mi piacerebbe che ci fosse
una maggior dialogo, maggiori occasioni di contato, anche a livello regionale, una regione che
si riunisce chiamando a parlare dei problemi… di tute quelle cose che siamo costret a dirci
fuori della porta, nei corridoi. SIMBDEA che può dire? SIMBDEA non ha potere, però io credo
che dare citadinanza ai nostri problemi sia già importante, un modo per avere un luogo di
confronto se non altro, di espressione… può servire. Magari serve solo per sfogarsi, ma è
qualcosa. ICOM secondo me dovrebbero intervenire di più, con la sua autorità, perché ne ha di
più di SIMBDEA, dovrebbe e potrebbe fare molto di più, dovrebbe trovare dei modi di
dedicarsi anche ai piccoli musei. Fare dei proget in sinergia, porsi come referente, coordinare
trasversalmente proget… ma a questo ci devono pensare, perché se non ci sono più i fondi
regionali o ci inventiamo qualche altra cosa o è fnito tuto. Il loro ruolo deve crescere,
tantissimo.
M.D.: Per quanto riguarda il discorso della formazione, quale percorso immagini per un
aspirante diretore. Tu che insegnamento avresti voluto, cosa ti è mancato…
A.R.: intanto una formazione tecnico-burocratica, qualcuno che mi spiegasse come funzionano
le leggi, quali e quante leggi ci sono, altrimenti uno fnisce con l'essere in balia del funzionario,
il quale avendo capito che di questo non sai nulla ti raggira in tut i modi possibili. Leggi,
scadenze: si, su questo aspeto devi essere informatissimo. Secondo, una maggiore capacità di
formarti sul piano dei modi, delle possibilità; qualcuno che ti dica come fare per organizzare un
convegno, trovare fondi per un evento, presentare libri, video: a chi chiedere fondi, come,
dove, perché….. Nel mio caso hanno supplito le conoscenze individuali: Quirino Galli mi dice
«io faccio così…», però se non te lo dice nessuno non ti viene in mente, specialmente a me che
sono una persona poco pratica. Di queste cose perché non ne facciamo tesoro? Il modello
Canepina funziona così, il modello Ausonia funziona così…, il modello Cellere, o Latera, allora
capito? Una esperienza condensata in pillole, una bella dose, una cura di questo tipo ci
farebbe bene. […]
[71]
M.D.: È vero che questa chiacchierata a me serviva per fare il mio lavoro, ma in realtà ho preso
tuta una serie di idee, t’ho rubato un po’ di mestiere, anche se di furto non si è tratato dato
che non ti ho sotrato nulla…
A.R.: ben venga se uno… ma anche tu mi stai dicendo cosa che a me…
M.D.: ma tut siamo diventati diretori scopiazzando, rubando con gli occhi, prendendo
cantonate pazzesche, schiaf…
A.R.: frustrazioni dolori, dei veri e propri dolori, te lo posso assicurare, ho soferto tantissimo…
quando mi hanno deto che mi avevano fato perdere 45.000 euro di fnanziamenti mi sarei
messo a piangere, a me è costata una fatica terribile fare quei proget in tempo utile, seguirli,
sostenerli, stare atento alle scadenze….
M.D.: Quale futuro vedi per i musei e loro diretori, come la vedi?
A.R.: Pietro Clemente ci ha illuminato con la letera di de Varine sul futuro dei musei… io c’ho
pensato… è una bella domanda, a qualcosa è servito leggere quello che dice de Varine.
«Quale futuro vedi per i musei?»; io direi per «i piccoli musei», perché i grandi avranno altro
respiro. La prima risposta che ti darei è che la vedo nera che più nera non si può. A Pastena mi
dice Simona che non le hanno rinnovato il contrato; ad Emilio di Fazio a Riofreddo non
l’hanno rinnovato ed hanno inserito un diretore archeologo. In provincia di Frosinone c’è solo
un museo DEA ancora atvo, il mio. Vedo un futuro di feroce “selezione naturale”: dipenderà
dalla tgna (come dicono a Viterbo) dei diretori. Ad Ausonia dico: « non te lo faccio questo
favore…», questo museo lo tengo in vita fno a quando ce la faccio. Come? Inventando tuto e
di più, sopravvivendo, anche contro l’andazzo generale. Al limite faccio a meno della legge 42,
atraverso il volontariato, atraverso altre risorse, forse private. Forse, se levano la 42 ci
spronano veramente a fare il nostro mestiere?
M.D.: E se non basta?
A.R.: che crolli tuto a volte penso sia anche utile. Se non succede niente vorrà pure dire che
questo museo contava poco per quella comunità… Non vorrei sentirmi come quegli impiegati
inutili della Grecia che hanno afossato il loro paese pur di mantenere lo stipendio, nel mio
caso una istituzione sostenuta dallo Stato, alla fne. Se invece c’è solo la tua tgna, vuoi vedere
che da qualche parte si sprigionano forze ed energie? Io non ci ho mai provato, ma credi che
[72]
non troveremmo degli sponsor sulla piazza? Quando vado a pranzo nei ristoranti della zona,
che conosco, gli porto il paccheto dei depliant da distribuire ai clienti, loro sono contenti…
Danno vita culturale al locale, mostrano l’oferta locale di cultura. È un modo che mi fa capire
come delle sinergie sarebbero possibili. Ho tratato poco gli imprenditori della pietra. Uno mi
aveva chiesto se ero disponibile ad andare con lui perché gli sarei servito come consulente
durante un viaggio in Egito…
M.D.: una expertse
A.R.: hai capito? A questo punto non sarebbe male pensare ad organizzare dei corsi nei
musei… «Voi [imprenditori] qui con chi avete rapporto? Con paesi dell’Africa, della Cina? Vi
organizzo corsi, anche di base, sulle culture di queste società». Questo secondo me è un altro
spreco. Noi facciamo gli antropologi limitati…: tu solo il brigantaggio, io solo culti mariani o
della memoria, forse bisognerebbe trovare ramifcazioni… Proprio per questo ho lanciato la
proposta, di fare un corso per insegnanti sulle mutilazioni genitali femminili. “E che c’entra?”
potrebbe dire qualcuno. Ma se non ne parlo io, di MGF sul territorio, chi altri? E se non adesso,
che divampa una feroce campagna anti-circoncisione, quando?
Il futuro lo vedo in mano nostra. Non nel senso di padroneggiarlo, ma di esserne responsabili.
Non siamo impotenti, secondo me, se non perdiamo di vista la realtà, se ci impegniamo con la
passione che ci abbiamo messo fnora, e se la comunità lo percepisce. Non credo che siamo
destinati ad essere esclusi, o almeno lo spero. Nel fratempo, prepariamoci a combatere
l’inverno che si annuncia.
[73]
Intervista con Pietro Tamburini
Direttore del Museo territoriale del lago di Bolsena
Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena
Bolsena, 2 12 2011
Pietro Tamburini: credo che chiunque si occupi di musei in Italia sofra di questo paradosso:
più esperienza ha e più aumenta il suo livello di angoscia, proprio perché meglio conosce
questo ambito e i problemi che gli sono connessi. Quando senti parlare gli organi di stampa di
musei, delle not dei musei, dei giorni dei musei, degli anniversari dei musei, della festa dei
musei, anzi, della festa dei musei no, lasciamola da parte perché ha origini a livello regionale,
ma quando senti parlare di musei in Italia non si dice, ma si da per scontato, lo capisci dopo
quando approfondisci il problema, che si parla solo dei musei statali. Non si parla mai dei
musei civici, che sono la stragrande maggioranza e che costituiscono una realtà assolutamente
alternativa a quella rappresentata dai musei statali. Una realtà, la prima, molto più sacrifcata,
anche a livello di patrimonio ovviamente, ma molto più atva; direi forse l’unica veramente
atva dal punto di vista museale. Quelli statali sono i musei più straordinari che esistono, ma
sono quelli meno valorizzati, quelli meno messi a regime, quelli meno fruiti sia a livello di
quello che producono sia a livello del pubblico a cui si rivolgono. Tranne alcune eccezioni,
come ho sentito in questi giorni: è il caso del Museo Pigorini, un museo nazionale, che nasce
come museo etnografco, e che opera un po’ con le metodologie atraverso cui operano anche
i musei civici. Il Pigorini queste metodologie le ha mutuate dall’atvità dei musei civici, non le
ha insegnate lui ai musei civici, però avendo delle dimensioni sovra-civiche, di caratere
nazionale, ecco che quello che si fa al suo interno assume quasi il caratere di azione guida nei
confronti della museologia civica. Però è il contrario, i grandi musei hanno imparato dalla
museologia civica e quello che hanno imparato l'hanno portato a dimensioni quali un museo
civico non potrebbe mai aspirare. Infne i musei statali godono anche di fnanziamenti
straordinari rispeto a quelli di cui godono i musei civici...
Marco D'Aureli: va bene, ma fnanziamenti a parte, quali sono gli strumenti che questi grandi
musei hanno appreso dai musei civici?
P.T.: essenzialmente uno, quello di uscire dall’interno di sé stessi. Il museo nazionale è sempre
stato concepito sulla base di quello che si considerava una volta fosse l’obietvo principale del
[LXXIV]
museo, cioè conservare, e non quello di metere a disposizione. I musei nazionali hanno
sempre avuto come obietvo quello di conservare il patrimonio, di non farlo deperire, ma mai
di valorizzarlo, mai. Oltretuto sotoponendosi a costi, relativi in special modo al pagamento di
personale destinato alla custodia, assolutamente fallimentari quando si va a stilare un bilancio
tra quello che una strutura museale produce e quello che la medesima costa. Se il museo ha
come funzione prioritaria quella della conservazione, devi puntare sul personale di custodia,
non sul personale scientifco, didatco. Faccio sempre un esempio a questo proposito
paragonando due musei simili e vicini nello spazio. Il Museo Archeologico Nazionale di Vulci e
il Museo territoriale del lago di Bolsena. Sono musei che come superfci si assomigliano, tut e
due sono istituiti all’interno di un edifcio medievale, grosso modo, almeno alcuni anni fa
avevano un numerto paragonabile di visitatori, intorno ai 20.000... però anni fa, eh, non oggi…
prima che succedesse tuto questo; 20.00 visitatori il Museo di Bolsena e tra i 20 e i 30.000 il
Museo di Vulci. La diferenza sostanziale però risiede in questo: il Museo di Vulci, prima che
venisse istituito il Parco archeologico-ambientale, svolgeva solo la funzione di conservazione
del materiale esposto, peraltro in maniera assolutamente inadeguata: mi ricordo didascalie
scrite in modo incomprensibile per i non archeologi, dove comparivano termini tipo bilobato,
trilobato, a scossa, a ciambella, forma Isings 21 e via dicendo, e realizzate con una macchina di
vecchio tipo, quelle nere, in cui i carateri non sempre capitavano sulla stessa linea e le letere
fnivano col comparire sfalzate in alto e in basso. Immaginati che livello di comunicazione
poteva avere… Questo museo, isolato nella campagna, non all’interno di un contesto urbano,
ha nell’organico tra i 17 e i 20 custodi. Immagina quanto possa costare un custode all’anno,
moltiplica per venti e vedi questo museo quanto viene a costare alla colletvità. Il Museo di
Boslena, inaugurato nel 1991, dalla sua istituzione ha due custodi in pianta organica. Una cosa
di cui non si è accorto lo Stato è che lo sviluppo tecnologico ci ha dotato oggi di sistemi di
sicurezza estremamente economici e con potezialità altissime: telecamere a circuito chiuso,
sistemi d’allarme atvi, passivi, a raggi, infrarossi e via dicendo. Quindi immagina quanto costa
alla colletvità il Museo di Bolsena e il suo analogo Museo di Vulci. Questo cosa signifca,
anche? Che le risorse che produce il Museo di Bolsena con i bigliet di ingresso possono essere
investite nelle atvità del museo stesso, cosa che il museo come quello di Vulci non potrebbe
mai fare. In secondo luogo il museo di Vulci, essendo museo archeologico nazionale, sofre del
problema di cui sofrono quasi tut i musei archeologici nazionali. Un problema da cui si sono
[LXXV]
sgravati oggi i musei più grandi, la Galleria di Brera, il MAXXI, il MACRO, perché sono stati
fnalmente afdati alle cure di personale in grado di farli rendere, di gestirli opportunamente.
Io sono archeologo, li ho sempre frequentati i musei archeologici nazionali; il museo
archeologico nazionale è afdato alle cure dell’Ispetore di zona, che cambia periodicamente,
e che non è stato certamente assunto per questo compito ma come archeologo specializzato.
Un ispetore a cui viene afdato un territorio, per esempio quello di Tarquinia, si trova non
solo a dover controllare l’intero territorio, ricchissimo di cose da tutelare, ma si dovrebbe
occupare anche della direzione e della gestione del funzionamento del Museo Archeologico
Nazionale di Palazzo Vitelleschi, che è una strutura straordinaria come contentinore e come
contenuto, e che meriterebbe di avere uno staf fsso e specializzato in museologia e in
museografa: non solo il diretore, ma anche gli operatori, quell che si occupano della didatca,
della conservazione, della divulgazione, dell’editoria, della ricerca. Un museo del genere
dovrebbe avere questo personale in pianta organica e un diretore che non fosse l’ispetore di
zona, il quale eventualmente dovrebbe afancare il diretore. Questo riguarda tut i musei
archeologici nazionali, che poi sono tantissimi e espongono la parte più signifcativa del nostro
patrimonio storico.
M.D.: andiamo subito al centro del discorso, cioè… tu hai parlato di un museologo alla
direzione, allora…
P.T.: questo è un problema che riguarda di più… hai fato bene… ho lasciato il discorso in
sospeso: ho parlato degli intralci gestionali che subiscono i musei nazionali sia per le
dimensioni dell’organico, assolutamente inopportune, perché non servono e consumato tute
quante le energie che un museo può produrre, sia per il fato che non godono di una direzione
opportuna per far funzionare il museo. Ma questo della inadeguatezza dei musei riguarda
anche i musei civici, i quali non sono alieni da questo problema. Diciamo che nell’ambito dei
musei civici possiamo trovare situazioni soddisfacenti, da questo punto di vista, perché il
museo civico è direto da un diretore, mi si perdoni il bisticcio, assunto in mille modi diversi,
dai più adeguati ai meno adeguati, ma comunque per assolvere a questo compito; una
persona che viene assunta proprio per dirigere un museo e non per fare una cosa e poi anche
assumere su di sé questa responsabilità. Solo che c’è un problema: io non conosco
esatamente quali siano i palet che a livello nazionale ogni regione, ogni provincia, pone per
regolare l’assunzione, per regolare il reclutamento di questo personale, però conosco bene
[LXXVI]
quello che avviene nella nostra regione. Sono anni che lo vado dicendo... l’ho anche scrito,
due articoli su questo tema sono stati pubblicati, uno sugli at usciti ora nel secondo convegno
della Dalai Emiliani alla Sapienza, in cui mi permetevo, dopo tanti anni alla direzione di un
museo, dopo tanti anni di collaborazione con la Regione Lazio, di suggerire a questo punto
quali erano i punti deboli e i punti forti della normativa che regola la nascita, la vita, il
funzionamento dei musei civici del Lazio. Il problema nasce dal fato che i palet che la
Regione Lazio mete ai Comuni per l’assunzione dei diretori sono troppo deboli. Sono stati
rinforzati, ultimamente, ma piutosto per sanare un buco che si era improvvisamente aperto,
quello delle lauree triennali. Adesso non è più possibile assumere la direzione di un museo
civico con una laurea triennale ma ci vuole una laurea specialistica; ma questo è un problema
dato dalla distruzione dell’ordinamento universitario, prima non ci sarebbe stato questo
problema: le lauree erano di un tipo solo, erano tute specialistiche… Il problema è che,
appunto, non basta essere laureati in una disciplina per poter svolgere una adeguatamente la
funzione di diretore all’interno di un museo, anche se è un museo di quella stessa disciplina in
cui si è laureati. Prima cosa i laureati sono di due tipi: ci sono quelli bravi e quelli inet. Un
laureato bravo è una persona capace di fare molte cose oltre quello per cui ha studiato, la
fgura del diretore di museo è una fgura polimorfca, poliedrica, non può appiatrsi solo su un
ambito, su un aspeto della disciplina, il suo mestiere è anche altro, in qualche modo deve
sapersi destreggiare in molti ambiti diversi. Il diretore dovrebbe avere le carateristiche di un
manager; non necessariamente un diretore deve avere una specializzazione in una
determinata disciplina, ma deve sapere coordinare gli specialisti delle singole discipline e tuto
il personale che serve per il miglior funzionamento di qualunque tipo di museo. Il lavoro del
museologo in Italia è un po’ come quello del genitore. Il lavoro del genitore è un lavoro
difcilissimo, da svolgere nel migliore dei modi. Viene praticato da quanto è nato l’uomo ma
con gli esiti più diversi. Lo vediamo sopratuto oggi, che le notizie circolano rapidamente. Il
genitore... chi ti insegna a farlo? Il genitore dovrebbe essere uno psicologo, uno psicologo
infantile, poi dovrebbe essere una persona esperta di tante cose di caratere pratico, perché la
vita è anche atvità pratica, e io lo so abbastanza bene, dato che ho sacrifcato molta della mia
atvità intelletuale in favore di quella pratica: ho dovuto fare l’eletricista, l’idraulico, ho
dovuto riparare la moto, fare giardinaggio e tante altre cose, la fotografa… tute cose,
oltretuto, funzionali alla mia atvità di archeologo, perché quando facevo le schede RA per il
[LXXVII]
Ministero, le schede CA o le MA, le foto le facevo da solo e in questo modo riuscivo ad
otenere quelle economie di scala che mi consentivano di andare avanti. Quei disgraziati, che
non sapevano come fare, che non sapevano disegnare… io ho imparato anche a disegnare i
materiali archeologici… chiaramente questi che non sapevano farlo dovevano appoggiarsi al
disegnatore, al fotografo e così dimezzavano le loro capacità fnanziarie avendo poi grosse
difcoltà nella vita quotidiana. Il laureato bravo è quello potenzialmente in grado di fare tante
cose diverse oltre quelle per cui ha studiato
M.D.: fessibile…
P.T.: fessibile, aperto, non geloso delle proprie conoscenze o dei materiali, nel caso di un
museo afdato alla sua responsabilità. Come il genitore non ha preventivamente un corso che
gli insegni a farlo, il diretore di museo non ha un corso che gli insegni a farlo. Non l’ha mai
avuto. Non esiste una facoltà di museologia e di museografa in Italia, esistono solo degli
insegnamenti, che normalmente quando uno va a vedere da vicino si rende conto che non
sono quello che dichiara il titolo. Ricordo che a Viterbo insegnava Maria Cecilia Mazzi, ex
funzionario del Setore musei della Regione Lazio: teneva l'insegnamento di museografa e
museologia, ma era una storica dell’arte, aveva anche scrito qualcosa di storia dell’arte. Vado
a vedere e cosa era il corso di museologia e museografa che lei insegnava? Era un corso di
storia del collezionismo, che è una piccola parte, una branca della museologia e della
museografa e che oltretuto non riguarda neanche più la realtà atuale e i metodi atraverso i
quali i musei dovrebbero funzionare e i modi, le fnalità e gli obietvi a cui i musei oggi
dovrebbero tendere. La museologia e la museografa che insegnava la Mazzi erano materie
avulse da tuto questo. Quello che manca fondamentalmente è una preparazione preliminare
allo svolgimento di questo tipo di atvità. Uno si laurea e viene butato allo sbaraglio alla
direzione di un museo. Un altro esempio oltre il genitore volevo fare di professionalità a
rischio non per chi la esercita ma per chi la deve subire… quella dell’insegnante. Si trata di una
situazione molto molto simile a quella del genitore e a quella del museologo. Ti viene afdato
un lavoro complicatissimo, delicatissimo, dico oh! il genitore ha a che fare con il cervello in
corso di formazione di un bambino; l’insegnante peggio ancora, ha il compito gravosissimo di
dare un indirizzo, un ordine, di insegnare quelle materie che ti fanno crescere; il museologo ha
la funzione di far vivere il museo. Queste sono tre professioni per cui non è previsto un corso
di studi approfondito con tute le conseguenze che ciò comporta. Nel caso dei musei il fato è
[LXXVIII]
aggravato da quest’altra considerazione: che la Regione ha messo questi labili palet, la laurea
deve essere compatibile, semplicemente, con il tema prevalente del museo, così recitano i
paini setoriali della legge 42/1997, ma il problema nasce nel momento in cui ci rendiamo
conto che la Regione, una volta fnanziato il museo dalla A alla Z, lo passa al cento per cento
nelle mani del Comune che comunque è proprietario della strutura. È lì che si aggrava il
problema che dicevamo poco fa, nel senso che il Comune è libero di nominare chi vuole, a sua
discrezione, alla direzione del museo. I piccoli Comuni sofrono in genere di una certa
mancanza… il fato è che più il Comune è piccolo più è costreto a occuparsi di cose pratiche,
più il Comune è piccolo più deve sacrifcare il museo o la biblioteca alla fogna. Ci troviamo a
che fare con Comuni piccoli proprietari di musei e amministrati da persone che non sono
assolutamente in grado né di amministrare né tanto meno di capire quale sia la funzione e
l’importanza del museo che a loro appartiene. Questi comuni, con quale logica individuano la
fgura professionale a cui afdare il museo civico? Quelli più virtuosi, diciamo così, accogliendo
le prescrizioni regionali e individuando nell’ambito del comune, o se non c’è in altri ambiti, una
fgura professionale che risponda ai requisiti previsti dalla normativa regionale e che
comunque, ripeto, sono insufcienti. Il comune non virtuoso può addiritura nominare
diretore del museo un dipendente comunale, come è successo a Montefascone, un
ingegnere edile in pianta organica…
M.D.: è il caso del Museo dell’architetura...
P.T.: si, perché a volte anche comune medio non è in grado di distinguere la diferenza che c’è
tra un architeto e un ingegnere e tra la storia dell’architetura e la costruzione delle case. Nel
momento in cui questo avviene, la sorte del museo è segnata. Il Comune può anche scegliere
di tenerlo chiuso questo museo, no? Perché non interessa, perché considera che sia un costo,
addiritura, invece che una risorsa… Pensa che ci sono amministrazioni comunali che ci hanno
deto che pensavano di ricavare del denaro dal loro museo, museo che poteva avere nella
migliore delle ipotesi 2000 visitatori l’anno! Che pensavano di darlo in gestione a titolo
oneroso invece che contribuire loro alla gestione della strutura! Comuni, sopratuto, che
possono nominare diretore una persona, parente del sindaco, cugino dell’assessore, fglio di
questo o quell’altro. Ovviamente siamo in Italia, paese in cui tuto ciò ha raggiunto dimensioni
paradossali, fregandosene completamente del fato che in questo modo contravvengono alle
prescrizioni regionali e quindi non possono entrare nell’OMR perdendo tut i benefci
[LXXIX]
fnanziari che questo comporta. Perché se ne possono fregare? Perché, comunque, un comune
ha avuto già dalla Regione quello che voleva, ha avuto il museo, un museo perfetamente
completato…
M.D.: una amministrazione ha tenuto a batesimo il museo, l’importante è quello…
P.T.: si, si certo… il museo c’è, è lì, chiuso a aperto… chiuso forse si deteriora meno che
tenendolo aperto. Non percepisce i fnanziamenti dalla Regione Lazio? E chi se ne importa,
tanto viene aperto quando gli serve il museo, come facevano a Montefascone, che lo aprivano
per la fera del vino o per le mostre di antiquariato all’interno… Oltretuto adesso purtroppo
che succede? I fnanziamenti non li prenderà più nessuno, né quelli in OMR né quelli fuori, e
quindi certamente non ci troviamo di fronte alle condizioni giuste per poter risolvere questo
tipo di problema. La Regione ha una responsabilità che non dovrebbe fnire nel momento in
cui si inaugura un museo, ma dovrebbe continuare anche dopo. La Regione deve capire che
deve trovare gli strumenti legislativi necessari per fare in modo che i comuni non possano più
massacrare il lavoro fato in collaborazione e con i fnanziamenti della Regione Lazio, che i
comuni non possono deprimere i musei che la Regione gli ha consentito di aprire. Però per
questo deva cambiare la normativa.
M.D.: in atesa che questo accada… raccontami quale è stato il tuo percorso: come sei arrivato
a fare il diretore del Museo di Bolsena?
P.T.: io ci sono arrivato atraverso il percorso più scientifco possibile, partendo dal ruolo di
collaboratore alla realizzazione dell’allestimento. Il Museo di Bolsena è stato voluto
strenuamente dall’ingegner Alessandro Fioravanti, una persona che si è messa in testa di dare
corso a quello che cento anni fa, nel 1890, centoventi anni fa, aveva auspicato un certo
Antonio Sacco, l’unico fnora che ad aver rilevato a pubblicato la strutura del castello, della
rocca Monaldeschi. Sacco, nella sua nota alla Società storica volsiniese, scrisse, essendo in quel
tempo il castello in rovina completa, che, non dico l’unico, ma un otmo sistema per salvare la
strutura sarebbe stato quello di farci all’interno un museo. Nel 1991, esatamente cento anni
dopo, perché la mostra inaugurale del museo si tenne nel Novanta, fu inaugurato il museo.
Fioravanti, essendo una persona intelligente, anche se con tantissimi difet, pensò che il
Museo non poteva certo realizzarlo lui da solo e si circondò di una schiera di specialisti anche
di fama internazionale. Per l’etruscologia chiamò a sovraintendere i lavori Giovanni Colonna,
l’erede spirituale e istituzionale di Massimo Pallotno, accademico dei Lincei, accademico di
[LXXX]
Svezia e tante altre cose. La realizzazione di questa parte fu afdata a me, in quanto ero
archeologo e ero di Bolsena, dunque anche comodo perché stavo qui, costavo sicuramente
meno di uno che abitava lontano. Siamo nel 1991, e io ero archeologo come? Feci l’Università
a Perugia, mi laureai in letere classiche, poi vinsi il concorso di ammissione alla Scuola
nazionale di specializzazione in archeologia. Iniziai la scuola, det qualche esame… una Scuola
che trovai molto più facile dell’Università, perché ci sono Scuole di specializzazione che danno
riconoscimenti cartacei ma senza migliorare il bagaglio culturale di chi le frequenta.Nel 1983 fu
bandito il primo Dotorato di ricerca. Partecipai al concorso, ebbi la fortuna di vincerlo, a quel
punto però bisognava scegliere… nel fratempo insegnavo anche, det contemporaneamente
anche l’abilitazione all’insegnamento, superai lo scrito e avrei avuto l’orale un mese dopo, ma
contestualmente iniziava il Dotorato. A quel punto feci una scelta, tra l’insegnamento e la
carriera accademica... una scelta sciocca, ma non pensavo di stare in Italia… scelsi di fare il
Dotorato e abbandonai l’insegnamento. Cominciai il Dotorato che iniziò nel 1983 e fnì nel
1987, e dovet abbandonare la Scuola di specializzazione perché per questioni amministrative
serviva l’originale del diploma che però avevano dall’altra parte… dovet abbandonare dopo
due esami, epigrafa greca e topografa antica. Nel 1987 conseguii il titolo di Dotore di ricerca
in archeologia con una specializzazione in etruscologia. Subito dopo iniziai il post-dotorato,
altri due anni con una borsa di studio per la realizzazione di una carta archeologica del
territorio volsiniese. Quindi venni incaricato di occuparmi dell’allestimento della sezione
protostorica e etrusca proprio sapendo quale era la mia formazione; avevo i titoli per
potermene occupare. Oltretuto stavo qua, tanto meglio. Siamo in un’epoca in cui la fgura del
comunicatore, dell’esperto in comunicazione non esisteva ancora e quindi chiaramente questo
museo nasce, dal punto di vista dell’informazione che veniva fornita, in maniera un po’
casuale, perché afdato non a museograf ma a specialisti della disciplina che avevano, sì,
prodoto dei testi col pensiero fsso al visitatore che non conosce la materia, ma che non
avevano nozioni specifche riguardo il come comunicare all'ampio pubblico. Il primo problema
che un museologo si dovrebbe porre è: a chi mi rivolgo? E io lo feci. Capii che dovevo trovare il
registro grafco e contenutistico adato per il pubblico a cui mi volevo rivolgere. E siccome il
pubblico dei musei dovrebbe sempre tendere al globale, cercai di produrre un testo che fosse
utilizzabile sia dall’analfabeta culturale sia dallo studente universitario. Ognuno di questi
poteva cogliere delle informazioni, nessuno di questi usciva dal museo senza aver assorbito
[LXXXI]
nulla. Ma questo che cosa ha comportato? Ha comportato l’inserimento nei pannelli didatci
di testi abbastanza lunghi, in contrasto con quelli che oggi sono ritenute le regole
fondamentali della museografa: perché un testo venga leto, non spaventi nella sua
lunghezza, anzi invogli alla conoscenza… si sa che in un museo si leggono non più di cento
parole, allora il testo dovrebbe essere al massimo cento parole e scrite in carateri chiari e
grandi e lasciare il resto dell’informazione all’immagine e alla multimedialità sonora e visiva…
M.D.: quindi ci sei entrato da ricercatore
P.T.: sono entrato nello staf scientifco del Museo e quindi che cosa è successo? Quando il
museo è stato aperto, e quindi tut gli staf specialistici sono stati sciolti, io sono stato
nominato dall’amministrazione comunale di allora come diretore perché ero l’unico che aveva
i titoli per assumere quella carica ed ero qui. Perché non c’era un’altra persona che avesse
conoscenza di quel museo quanta ne avevo io, e quindi fu un motivo di caratere scientifco e
di opportunità ovviamente del momento. Ero l’unico archeologo a Bolsena, si… non c’erano
altri, e la parte archeologica… ti ricordo che nel Novanta fu aperto il Museo per la prima volta,
fu inaugurato il Museo con una mostra permanente sull’abitato villanoviano del gran carro,
che era quello su cui io avevo fato la tesi di Dotorato, per cui era quasi una nomina obbligata
la mia, la più opportuna possibile, perché la prima parte del museo fu aperta con il contesto
archeologico su cui io avevo conseguito il titolo di Dotore di ricerca… lo avevo studiato io, lo
avevo pubblicato io…
M.D.: eri la massima autorità su quel tema...
P.T.: anche se non ero stato istruito per essere museologo, perché non c’era una scuola di
museologia e mi sono dovuto inventare museologo a mie spese.
M.D.: qui si aprono… cosa è successo nel passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di
diretore? Come ti è cambiato… come l’hai vissuta questa cosa; l’assenza di un percorso ben
delineato che porta al ruolo di diretore, ieri come oggi, causa improvvisazione: quali rischi
comporta l’improvvisazione? Altra domanda: hai avuto qualche modello a cui ispirarti… Io ho
copiato, diciamo così, lo sto facendo tut’ora, molte buone pratiche… anche qualche errore ho
assorbito guardando come operano gli altri...
P.T.: cominciamo dalla fne… mi hai ricordato che questo metodo che hai usato tu mi è capitato
di usarlo anche a me in cose diverse. Io ho imparato a sciare guardando gli altri. Perché il
[LXXXII]
primo maestro che ho avuto di sci era un professore di educazione fsica del liceo classico di
Viterbo che ci portava all’Amiata, ci faceva metere a scaleta sulla pista, e lui - come facevano
i maestri di sci - partiva… noi fermi, ci mostrava quale era il movimento che dovevamo fare. Lui
partiva, faceva la diagonale, arrivava il momento di fare la curva e cadeva: noi lì imbarazzati…
Oggi so sciare abbastanza bene, ma non ho mai avuto altri maestri di sci se non i miei occhi,
guardando quello che facevano gli altri e cercando di imitarli. Non è buon sistema,
assolutamente… avrei potuto imparare in un anno, cosi c’ho messo vent’anni a imparare a
sciare. E poi ho assunto dei difet che non mi sono più tolto…
M.D.: la sotle metafora la ribaltiamo totalmente nel campo museale…
P.T.: direi di sì, inevitabilmente. Per ora è così, ma credo sia così per tut. Per tut no, non
pretendo di conoscere tute le situazioni, ma la stragrande maggioranza… per quanto riguarda
i musei civici credo che fno a cinque anni fa è stato tuto determinato dalla casualità formata
da due elementi: dall’improvvisazione, inevitabile, e da quella capacità che dicevo prima che la
persona ha in sé, direi quasi indipendentemente dalla formazione che ha avuto
M.D.: il suo spirito di iniziativa…
P.T.: si, si, di adatarsi alle situazioni, di capire, adoperarsi; anche la capacità manuale di fare le
cose
M.D.: ma anche avere una visione di progeto
P.T.: certo, sapere sempre quale è l’obietvo da raggiungere, inevitabilmente, no? Questa era
l’ultima cosa che mi chiedevi…
M.D.: i rischi a cui si va incontro nella gestione del museo a causa dell'assenza di formazione
specifca.
P.T.: gli esiti li vediamo tut i giorni, basta andare in un museo; ti guardi intorno, chiedi, fai due
o tre domande e capisci quali sono le conseguenze di questa situazione. Il Sistema museale del
lago di Bolsena è una fucina eccezionale per capire quali sono i pregi e i difet della
museologia locale oggi in Italia, perché nel Sistema abbiamo tredici struture museali quasi
nessuna delle quali nata in funzione sistemica e che noi ci stiamo adoperando perché tute
assumano una precisa funzione sistemica, la migliore possibile, la più vicina alla perfezione che
si possa otenere. Stiamo seguendo un percorso, da anni, e abbiamo visto tute quante le
situazioni che si possono creare a causa o grazie a quello che ha fato la Regione e a quello che
[LXXXIII]
hanno fato e continuando a fare i Comuni e anche la Provincia, se ce la vogliamo metere.
Tredici musei, abbiamo visto che sono molto diversi uno dall’altro poi vediamo quali sono le
conseguenze date da questa situazione: abbiamo dei musei che funzionano bene, dei musei
che funzionano, dei musei che non funzionano afato. Addiritura abbiamo dei musei che non
esistono ancora, come il Museo di Bagnoregio pur essendo tra gli istituti fondatori. Perché? Il
problema è che i comuni hanno carta bianca sulle sorti dei musei civici che però
paradossalmente non hanno fato loro ma li ha fat la Regione. Tut i nodi discendono da
quello. Io vado dal chiropratico perché? Perché mi si è spostata la prima vertebra, l'atlante, da
lì passano tut i fasci nervosi che collegano il cervello al resto del nostro corpo. Se c’è un
disassamento di una vertebra rispeto all’altra c’è una soferenza del canale midollare quindi le
informazioni non passano nel modo dovuto. Vado dal chiropratico da qualche anno e
ultimamente mi sta facendo una terapia per cui sta cercando e ci sta riuscendo gradualmente
di rimetere in ordine in asse le vertebre cerebrali, proprio per otenere di nuovo questo
passaggio fuido di queste informazioni che partono dal cervello e che possono in caso di
passaggio non fuido creare una serie di patologie, che uno non penserà mai di ricollegare a
una cosa del genere, le più disparate, dalle più stupide alle più gravi. Che cosa succede, tuto
discende da questo difeto iniziale… l’atlante è la normativa regionale; se la normativa
regionale non cambia nel senso che io ho già proposto almeno due volte pubblicamente,
questi problemi rimarranno sempre gli stessi; se cambiasse la normativa da un lato la regione
impedirebbe ai comuni di deprimere i loro musei e in secondo luogo i comuni si gioverebbero
del fato di essere sgravati, a loro volta, dagli oneri economici di gestione che a volte anche
non riescono a sostenere.
M.D.: in cosa dovrebbe consistere questa riforma?
P.T.: la Regione dovrebbe, una volta fnanziato il museo... facciamo fnta che la crisi atuale non
esista, se no questi discorsi diventano peregrini del tuto… nel caso ci trovassimo nelle
condizioni fnanziarie di venti anni fa, quando la Regione fnanziava un corso di formazione e
aggiornamento per diretori ad Albano Laziale della durata di una setmana, con
pernotamento, vito e alloggio in hotel a quatro stelle, questo era il momento… se fossimo in
quel momento lì la Regione dovrebbe metere dei palet più consistenti, semplicemente, e
sopratuto dotarsi di quegli strumenti sanzionatori eventualmente da metere in campo nel
caso di comportamento canagliesco da parte delle amministrazioni comunali. La Regione
[LXXXIV]
oltretuto dovrebbe imporre palet non solo di caratere amministrativo, ma anche di
caratere scientifco: dovrebbe imporre che l'aspirante diretore oltre alla sua normale
formazione abbia conseguito anche un diploma in museologia, museografa o semplicemente
che abbia esperienze di questo tipo, perché anche l’esperienza può, tuto sommato, essere
paragonata al conseguimento di un titolo… Noi di corsi di aggiornamento quanti ne abbiamo
fat? Tantissimi, ma ti dovessi dire nessuno di questi è stato un corso di museologia e
museografa. No n sono corsi che ci hanno insegnato la materia, la disciplina, no? Per anni
abbiamo fato i corsi di catalogazione, sulla numismatica, sui reperti medievali: ma quelli sono
corsi di aggiornamento per diretori? Quelli sono corsi di aggiornamento per archeologi, non
per diretori di museo. Non erano certo corsi di aggiornamento, non ci insegnavano certo la
museologia e la museografa. Così lontani nel tempo uno dall’altro, così diversi per contenuti,
così diversi per tipo di docenti, una volta professori universitari e una volta dipendenti di una
società che formava i quadri della FIAT, quindi anche inadeguati… Questo fa capire quanto
tut i problemi nascano all’origine. La normativa dovrebbe cambiare in questi due sensi, una
più restritva in senso istituzionale e più esigente in senso scientifco.
M.D.: nel tuo passaggio dal ruolo di ricercatore allestitore a quello di diretore cosa è
cambiato, come è cambiata la visione delle cose?
P.T.: prima ero otmista, poi sono diventato pessimista. Questo è stato il cambiamento
sostanziale. Anche io sono stato butato allo sbaraglio in qualche modo, no? Come il genitore e
come l’insegnante, però ho fato di necessità virtù. Trovandomi in questo nuovo ruolo mi sono
dovuto occupare non solo di gestire e far funzionare la sezione che io avevo allestito, ma
anche le altre che in parte erano compatibili con la mia esperienza professionale, perché
anche la parte allestita dalla Scuola francese di Roma era archeologica, anche se di archeologia
romana, e anche la parte allestita da altre professionalità era una parte sempre archeologica
anche se di epoca medievale e rinascimentale. Poi c’era la parte fnale connessa alla pesca,
quindi la parte antropologica, il dialeto, l’illustrazione sintetica del dialeto locale, e di tuto
quello strumentario che forse aveva connotato per millenni il mondo dei pescatori che
gravitava atorno al lago di Bolsena
M.D.: la cultura materiale della pesca
P.T.: e c’era anche…e forse verrà riallestita nei nuovi spazi di Palazzo Monaldeschi, la parte
sulle feste religiose e le tradizioni popolari, i Misteri di santa Cristina, l’Inforata e via dicendo.
[LXXXV]
Quindi che cosa ho fato? Mi sono reso conto, a un certo punto, di avere a che fare con
tematiche di cui fno a quel momento non mi ero mai occupato diretamente, però appunto,
ho capito che non era un problema che mi potevo porre. Intuii che era inutile che io mi facessi
una cultura su tuta quella serie di discipline di cui non sapevo nulla perché capii che
esistevano già degli specialisti di queste discipline e che all’occorrenza potevano essere
interpellati. Mi resi conto che io dovevo fare altro, dovevo far funzionare quella strutura,
dovevo portare scuole, dovevo formare anche il personale interno e dovevo individuare
sopratuto le professionalità, possibilmente nell’ambito territoriale relativo al museo, e poi al
Sistema che sarebbe sorto, per poter assolvere ai compiti a cui in non potevo e non dovevo
assolvere, perché la fgura del diretore del museo, ripeto, deve essere una fgura specifca
formata come tale in discipline assolutamente avulse da quelle che poi… non deve essere
formata in maniera specialistica nelle discipline su cui si fondano i musei, deve essere un
manager in grado di individuare le professionalità che servono per poter far funzionare al
meglio, valorizzare le discipline…
M.D.: qui torniamo a una questione importante: il diretore, in quanto a competenze, deve
essere un mix tra specialista e manager, ma come lo doseresti questo mix?
P.T.: deve essere sbilanciato a favore dell’aspeto manageriale, perché le disciplina
rappresentate nei nostri musei sono tantissime, ma c’è un aspeto che è comune a tut che è
quello della gestione. Se al Museo di Cellere il diretore fosse un manager, del tuto privo di
conoscenze antropologiche, che avesse te come collaboratore, avremmo risolto nel migliore
dei modi…
M.D.: dato che però abbiamo capito che nei nostri comuni grasso che cola se c’è un diretore,
che poi è diretore scientifco, che scrive i documenti, che cambia le lampadine…
P.T.: le capacità... ma scusa, il trasferimento di tut i libri da qui a Palazzo Monaldeschi, chi lo
sta facendo? Io, fsicamente…
M.D.: che ci sia una formazione, diciamo, del 30 % specialistica è importante perché soltanto
lo specialista sa come valorizzare nel migliore dei modi quel patrimonio, perché ogni
patrimonio ha una sua cifra carateristica, una sua anima, identità, e va valorizzato in modo
diverso. Perché valorizzare una zappa o una latna di birra, un manager potrebbe fare tute e
due le cose, però ognuna di queste richiede una azione diversa. Un manager da solo non può
farlo...
[LXXXVI]
P.T.: possiamo fare una scala gerarchica che va dal meglio al peggio. Il meglio è quello che ho
deto prima, cioè un museo direto da un manager che può avvalersi di tute le professionalità
necessarie
M.D.: diciamo un diretore e tanti conservatori
P.T.: bravo, come al Louvre… c’è il conservatore en chef e i vari conservsateur delle varie sezioni
museali. Il subordine successivo è che ci sia un manager che potrebbe anche essere una fgura
già esistente all'interno di un comune, un manager che fosse in grado anche di gestire un
museo sapendo anche di chi avvalersi...
M.D.: un super-segretario comunale, un super ufcio tecnico, che ne so…
P.T.: poi ancora in subordine si potrebbe considerare una soluzione accetabile quella che
dicevi tu prima. Allora, il museo antropologico con il diretore che ha capacità manageriali e
che se non gli vengono insegnate deve averle insite in sé
M.D.: e che al momento, secondo quanto dicevi prima, non ti da nessuno
P.T.: quelle capacità che dicevo prima di saper fare, avendo sempre però in mente quale è
l’obietvo da raggiungere, e che può avvalersi di altre professionalità che fossero necessarie
allao scopo. Un antropologo non può far tuto lui, sopratuto nel campo dei beni immateriali e
della multimedialità l’antropologo o impara a far tuto da sé oppure si avvale di altri tipi di
collaboratori che esulano anche dall’ambito antropologico che però diventano indispensabili:
l’operatore, il regista… E va bene. Poi ci sono livelli soto a questi, dati sempre dalla casualità.
Quello che ho scrito sull’ultimo articolo che ho dato a Fulvio Ricci per gli at di Gradoli è
proprio questo fato che non si può accetare che il successo della museologia laziale sia
afdato alla casualità. Perché fnora è stato così. Se un diretore funziona è un fato
assolutamente casuale, non è determinato quasi da niente, perché i palet sono talmente
bassi che se un diretore funziona non dipende dai vincoli che sono stati messi, non è un
merito di chi ha messo i palet, è un merito di sé stesso o di chi l’ha nominato a quell’ufcio,
che anche in quel caso è una persona che casualmente può essere lungimirante, perché è un
sindaco, un assessore alla cultura, e sappiano quale range possano coprire, cioè dal docente
universitario al contadino, senza nulla togliere al contadino, ma quando il contadino fa
l’assessore alla cultura crolla il sistema, così come quando al professore universitario gli fai
fare il contadino, crolla comunque il sistema. Ognuno deve operare nel proprio ambito e non
[LXXXVII]
invadere gli ambiti altri ma avvalersi delle professionalità che questi ambiti conoscono. Quindi
noi siamo afdati alla casualità. E questo riguarda sopratuto che cosa? Tut gli organismi che
vengono costruiti sopra questa base di casualità sono ancor di più casuali. Massimo Pallotno
diceva, a proposito dell’ipotesi... sai l’archeologia era una scienza umanistica poi è diventata
una scienza sperimentale, dove non si può afermare nulla se non provato più o meno da
prove oggetvamente inconfutabili; Pallotno diceva che una ipotesi può essere giusta o
sbagliata, ma una ipotesi costruita su una ipotesi è sicuramente sbagliata. Se lo status che
regola la museologia civica è la casualità, capisci che i sistemi museali, sia tematici che
territoriali che vengono costruiti sopra questa base di casualità, rischiano ancora di più di
essere afdati alla casualità. E noi ne siamo due testimoni di questo fato. Il fato che il
SIMULABO dal 2001 al 2011 sia l’unico sistema museale a livello regionale a funzionare, e non
ho tema di dichiararlo, è dato dal fato che casualmente è stato coordinato da una serie di
persone che hanno avuto come obietvo efetvamente quello di far vivere al meglio, di far
operare al meglio questo sistema e ci stanno riuscendo nonostante tute le difcoltà sia locali
che nazionali che continuiamo a incontrare. Gli altri sistemi territoriali della Regione... molti
non esistono più altri continuano ad esistere solo scrit…
M.D.: il VA.TE., il Sistema di Priverno…
P.T.: il VA.TE. mi hanno deto che è dissolto… il primo sistema museale della Regione Lazio,
fondato oltretuto su una fgura giuridica estremamente resistente che era il Sistema museale
dell’Agro Foronovano, della Sabina, era fondato su un consorzio di comuni, quindi una fgura
giuridica, con personalità giuridica: quello è stato il primo a dissolversi, dopodiché si sono
dissolti tut gli altri. Il nostro continua non solo a esistere ma anche a prosperare. Ma quale
sistema può vantare una sede stabile che la regione ha fnanziato per un 1.800.000 euro, che
ormai sta lì e lì rimane, non è che potrà più scomparire. Che futuro può avere un sistema di
musei fondato su musei inesistenti? Non stiamo a prenderci in giro... Sapendo della precarietà
generale dei nostri musei, chiesi quale potesse essere il futuro che aspeta un sistema museale
tematico fondato su una precarietà assoluta. Una volta avevano addiritura pensato, in
maniera non capisco se folle o completamente inadeguata, di afdare i sistemi tematici al
coordinamento dei singoli musei che stavano in carica un anno. Il museo di Valentano ha
direto il sistema PROUST per un anno. E poi l’anno dopo doveva passare a un altro. Ma siete
fuori? Nel momento in cui uno meteva a regime… passava a un altro, ma siete mat? E infat
[LXXXVIII]
cosa ha fato la Regione? L’ha avocato a sé… il Sistema PROUST è gestito ora diretamente
dall’Ufcio Musei. Così ha un senso, ma la direzione deve essere centralizzata e deve essere
stabile! Il nostro problema più grosso è la mancanza di stabilità. Finché la fgura del diretore è
afdata ai pruriti delle amministrazioni comunali, quella non sarà mai una fgura stabile, potrà
cambiare in qualunque momento a discrezione solo ed esclusiva del comune. Questo è folle, la
Regione deve impedire che ciò accada. Anche per un motivo scientifco, anche per dare
continuità alla gestione della strutura, no? Una continuità specie se garantita da una fgura
professionalmente valida, che può essere sostituita domani da una fgura assolutamente
inadeguata ma parente di Tizio o Caio. Questo la Regione dovrebbe impedirlo, e avrebbe
strumenti quanti ne vuole per farlo. La Regione, a livello dei sistemi museali, dovrebbe creare
un organismo diretvo stabile, come dissi nel convegno della Dalai nel 2008, facendo
l’esempio delle riserve naturali regionali. Facciamo astrazione dal momento critico che sul
piano fnanziario stiamo atraversando… Le riserve naturali regionali sono gestite diretamente
dalla Regione Lazio, ma perché non facciamo così anche con i sistemi museali? Gli date una
strutura stabile, fate i concorsi, assumete le persone giuste al posto giusto, ma fate in modo
che lo staf lavori fno alla pensione per un sistema museale, che è più complesso di una
riserva naturale, è molto più complesso di una riserva naturale, la riserva naturale è
monotematica direi…
M.D.: un sistema coordina poli e organismi molto articolati
P.T.: è una cosa difcile farla funzionare. Se poi vai a vedere come certe riserve naturali sono
gestite dici «allora lasciamo perdere», perché siamo sempre alla presa dello stipendio. Come
anche il personale del MIBAC, il suo scopo è prendere lo stipendio, non è operare atvamente
a favore di questo o quell’altro problema, è prendere lo stipendio. Guarda come sono tenuti i
siti archeologici. Veramente verrebbe voglia di andare all’estero dove tute queste cose sono
tenute in considerazione molto molto più ampia. [...]
Pessimismo, dunque... L’otmismo siamo noi, noi rappresentiamo anche il motivo per cui la
Regione può avere del personale che si occupa dei musei del Lazio, grazie a noi che gli diamo
un motivo per esistere e per operare, ma siamo noi che operiamo, non sono loro… non sono
loro.
M.D.: cosa deve saper fare un diretore di Museo? un buon diretore quale è?
[LXXXIX]
P.T.: eh, non si può rispondere a questa domanda, perché ogni risposta sarebbe estremamente
soggetva; dipende fondamentalmente dall’obietvo cui un diretore pensa a debba tendere il
proprio museo. Rispondere credo sia anche banale, facile… basta ripensare alle tematiche che
ci sono state trasmesse in questi tre giorni di formazione, basterebbe metere in campo quelle
e sarebbe già più che sufciente, ma sarebbe anche falso, perché il museo ha oggi tanti
obietvi da raggiungere. Una volta, all’inizio... forse bisognerebbe tornare all’obietvo più
nobile del museo, che fu il primo, poi ne sono nati altri meno nobili, quello di insegnare, di far
crescere la gente, far crescere l’ambito sociale di una zona. Ecco, far crescere la
consapevolezza della propria storia, della propria esistenza, e anche del presente, ovviamente,
in funzione di quello che potrebbe essere il futuro. Il futuro che cosa è? È un qualcosa che se
visto positivamente rende piacevole il presente; vivere in funzione di un pensiero felice, come
Peter Pan. Gli obietvi che possono darsi per un museo possono essere pensieri felici, che ti
fanno godere anche il presente, che ti fanno realizzare. Un diretore di museo forse dovrebbe
realizzarsi nel perseguimento degli obietvi, senza pensare all’obbligatorietà di raggiungerli,
mai. Altrimenti uno cade in depressione se considera la sua atvità nel contesto sociale,
politico economico che viviamo in questo momento. Tendere a questi obietvi atraverso delle
azioni. Atraverso azioni che per essere positive, cioè per dare senso della positività, devono
essere azioni non complesse, in scala rispeto al contesto all’interno di cui uno si trova a
lavorare, adeguate in qualche modo, e che possono essere assolte, nella peggiore delle ipotesi,
anche dal solo intervento di chi le ha progetate. Cioè, che nella peggiore delle ipotesi,
mancando ogni altra risorsa, possono essere perseguiti comunque con le proprie energie
soltanto. Nella migliore delle ipotesi, con le migliori energie sommate a quelle di un contesto
scientifco più ampio possibile. Avere un obietvo è fondamentale… in qualunque aspeto della
vita e sopratuto nell’ambito della formazione. Il grande pedagogo Mario Alighiero
Manacorda, ancora vivente, qui a Bolsena, mentre insegnava a Magistero a Roma, durante un
corso di aggiornamento per insegnanti che organizzò il Museo di Bolsena ci parlò del pensiero
di Platone circa l’educazione permanente. Ne parlò ai professori, cioè a personale scolastico,
per fargli capire un fondamento essenziale della museologia di oggi, che è quello per l’appunto
della formazione, dell’integrazione della didatca, che si fa a scuola, l’integrazione della
didatca con l’educazione al patrimonio, la cui somma diventa la formazione permanente,
l’educazione permanente dell’individuo. Non dovrebbe fnire mai l’educazione, no? Il museo è
[XC]
l’elemento indispensabile insieme alla scuola in questa formazione permanente. Parlando
della formazione dei giovani ateniesi, Platone nella Politca teorizzava per i giovani ateniesi
l’educazione dappertuto, ogni luogo del mondo può essere, deve essere, un luogo di
apprendimento, e il museo va da sé insomma… non c’è da spiegare quale forza possa avere
quale luogo dell’educazione permanente. Uno degli obietvi secondo me è questo. In che
modo deve interagire il museo con la scuola? Integrando tute quelle conoscenze che la scuola
non ti darebbe mai e che sono le conoscenze che fanno parte del tuo bagaglio, dovrebbero far
parte del tuo bagaglio, cioè la conoscenza di te stesso e del tuo contesto, prima di uscire
all’esterno e sulla base di questo conoscere tuto quello che è fuori, quello che è il resto,
questa è la formazione che dovrebbe dare un museo. Poi cosa altro dovrebbe dare un museo?
Fondamentalmente la ricerca, di cui dovrebbe divulgare in tempi rapidi i risultati a due livelli, a
livello specialistico e a livello divulgativo. Il museo può operare anche senza esistere, non è
necessario che sia una istituzione fsica, però nel momento in cui lo diventa lo deve rimanere;
un museo può anche operare senza esistere ancora fsicamente perché nel momento in cui
esso diventa occasione formazione permanente può operare sempre…
M.D.: perché il museo in fn dei conti è una tecnologia della conoscenza...
P.T.: bravo, esato
M.D.: l’importante è il patrimonio
P.T.: certo
M.D.: e il museo serve per conoscere il patrimonio…
P.T.: certo, un patrimonio da trasmetere, ma un patrimonio da trasmetere è anche quello che
atraversiamo quotidianamente camminando per le strade...
M.D.: forse non bisogna essere troppo… il museo serve a conoscere, valorizzare, difondere il
patrimonio, non è un bene di per sé… non è tanto la strutura che è importante, è l’azione che
svolge… A volte mi sembra che il museo venga trasformato in un feticcio, non ti pare?
P.T.: quello dell’aspeto feticistico è un limite, è un difeto in cui molti museologi cadono; e ci
cadono sopratuto quei diretori dei musei nazionali che non nascono come diretore di
museo ma nascono come archeologo…
M.D.: non so se ti è capitato di leggere quello che ha scrito anche Jean Clair sulla crisi dei
musei, c'è questa visione apocalitca, fnale...
[XCI]
P.T.: generalizzare nell’ambito dei musei mi sembra sbagliato proprio perché non esistono due
struture uguali; è come nella ceramica antica, no? Si è visto che non possono esistere due vasi
identici nemmeno in quella fata al tornio, fguriamoci se possono esistere due musei identici,
due universi... Fare previsioni generalizzanti nell’ambito della museografa non credo sia
possibile. Comunque scivolare nel feticismo del reperto o dell’oggeto è forse il guaio
maggiore che può correre un museo nella sua missione divulgativa...
M.D.: ma non esiste anche un feticismo dell’istituto museo? Ripeto, essendo quello veramente
importante il patrimonio, non ti pare che a volte siamo troppo ataccati a questo strumento di
valorizzazione e conoscenza?
P.T.: ma questo non dipende dalla museologia atuale, dipende un retaggio antico... addiritura
in inglese il termine museal è un termine negativo, “roba da museo” ha un valore negativo!
Per carità, bisogna cambiare questo valore in positivo, far diventare il museo cioè un luogo
positivo della nostra convivenza, anche se è un obietvo che non è giusto raggiungere in
maniera dissennata, come si sta facendo oggi facendo di tuto dentro un museo pur di portarci
le persone. Questo non mi sembra correto, mi sembra troppo facile come strategia, tu non
devi portare… non è obbligatorio che il museo venga riempito a tut i costi, il museo è bello
che sia riempito, ma è bello che sia riempito ma non come luogo in cui si mangia, si beve, in
cui si gioca, si balla o si vede il teatro. Per quello ci sono altri ambienti, e poi è un escamotage
falso, tu non vai lì per vedere il museo, tu vai lì perché in quel luogo si fa il teatro. Qualcuno ha
usato questi sistemi, e ho sentito già delle voci di critica nei confronti di questo ateggiamento.
Tu dovresti essere in grado di portare le persone nel museo per vedere il museo, e non è
difcile farlo questo…
M.D.: però se la metamo sul piano della conoscenza del patrimonio, che è qualcosa che sta
anche a cavallo tra interno e esterno del museo, portare al museo atvità che intorno a un
dato patrimonio ruotano, lo incrociano non mi sembra scorreto...
P.T.: però ruotano intorno a quel patrimonio! Beh, insomma… quello che ho visto fare al
Museo di Anzio, coprire e svelare l’opera d’arte... lì per lì sono rimasto perprelsso, poi ho
capito il senso dell'operazione, la scoperta dell’opera d’arte, la meraviglia che è fondamentale
nello stimolare il ricordo, e il ricordo è fondamentale per poter continuare a svolgere una
azione conoscitiva. Ma quello è funzionale al museo, non è qualcosa di diverso, è una novità,
[XCII]
una intuizione, una genialità che in qualche modo ti atra all’interno del museo ed è
funzionale alla scoperta del museo.
M.D.: per esempio, anche quello che abbiamo fato all’intero del Museo di Cellere, una
rassegna di teatro di fgura, buratni, lo scorso anno...
P.T.: ma che temi illustrava? c'entravano i briganti?
M.D.: no, non c'entravano i briganti, però il teatro di fgura tocca da vicino il sapere
dell'antropologia e i suoi classici oggeti di studio: da una parte il discorso sui beni immateriali e
le performance, dall'altra i grandi repertori della narrativa di tradizione orale. Per dire, il primo
spetacolo è stato La bella dalla stella d'oro, che trovo in Pitrè e trovo in altri repertori... Che
c’entra tuto questo col brigantaggio? C’entra con l’antropologia!
P.T.: va bene, però se tu avessi potuto esprimere un teatro di fgura sui temi del brigantaggio
sarebbe stata la morte sua… Comunque, tu hai parlato di ambito antropologico, il museo è
antropologico, per cui era funzionale comunque, ma non hai invitato la gente a pranzo dentro
al museo e subdolamente ogni tanto... non gli portavi il piato se prima non ascoltavano!
M.D.: anche nel caso della rassegna teatrale Culture parallele, ho scelto il griot che veniva a
parlare di immigrazione… e beh, in un museo di antropologia parlare di questo tema è
pertinente, per quanto non c’entra nulla con le zappe che sono esposte…
P.T.: le cose estranee al museo ci stanno comunque, ma stanno al di fuori, sono quelle che
vengono fate per far capire a tut che il museo esiste e vive a vantaggio della colletvità; non
c’è bisogno che entri all’interno del museo, il museo ti dà comunque. Questo è un messaggio
straordinario. La visibilità si è visto vale il 50% del successo delle nostre struture, troppo, ma è
così. La visibilità si può otenre in modi diversi. Volevo però tornare su quell’asepto feticistico
del reperto, perché ci ho già iniziato a scrivere una cosa, sul valore antropologico che
qualunque reperto al mondo in un museo può avere. Sto scrivendo un articolo che si intitola
Tra le righe dei repert, cioè caper leggere tra le righe dei reperti come fossero degli scrit, che
però hanno varie stratifcazioni di messaggio, no? L’oggeto esposto in un museo, può essere,
appunto, rifacendomi alla cultura della complessità e a quello che ci diceva Elisabeta Falchet,
non può in nessun modo esprimere un solo valore ma può essere leto in tante chiavi di
letura, e questo lo si può dimostrare facilmente. Io partirò da alcune cose esposte nel Museo
di Bolsena, dalla vetrina in cui sono esposti i materiali archeologici che vengono dal lago, che
[XCIII]
possono esprimere anche frontalmente, anche a prescindere da quelle che sono le richieste
formative del pubblico, possono comunque già di per sé esprimere vari messaggi
completamente diversi l’uno dall’altro addiritura. Questo è quello che bisogna fare per fare
formazione
M.D.: questa cosa mi ricorda un piccolo esperimento raccontato in uno dei libri che abbiamo
comprato per la nostra bibliotechina, Culture in mostra; in uno dei saggi si racconta di
medesimi ogget museografati in maniera diversa (secondo lo stile della museografa
naturalistica, di quella scientifca, di quella antropologica di fne Otocento, di quella artistica)
in modo tale da far capire che un unico oggeto, facciamo l’esempio delle zappe, può
legitmamente trovarsi tanto in un museo di storia dell’agricoltura, tanto in un museo di
ergologia quanto in uno etnografco, e che quello che veramente fa la diferenza è lo sguardo
tramite il quale l’oggeto viene indagato. È tuta una questione di sguardi. lo stesso vale per
quella cosa che chiamiamo oggeto etnografco, ma che non esiste come tale, esiste un
oggeto (qualsiasi) che può essere oggeto di uno sguardo etnografco, e tuto può diventarlo.
P.T.: è il museologo che deve identifcare i messaggio e il museografo che deve rappresentarlo.
Questo in un museo immaginario, vale sempre il discorso che magari ci fossero i museologi e i
museograf! Non tut gli architet museograf possono esporre tuto, perché un museografo
può esporre bene un certo tipo di ogget ma non un altro tipo, perché uno li sa
contestualizzare e altri no… Fare didatca sulla base della cultura della complessità nei nostri
musei è impossibile, cioè interpretare le esigenze formative dei singoli nel corso di una
educazione al patrimonio museale è impossibile, ha dei costi e dei tempi proibitivi. Perciò,
come ho deto nell’intervento di lunedì a Roma, l’importante è avere da questi discorsi uno
stimolo e uno spunto per seguire un percorso. Come i santi. I santi chi sono? Sono quelli che
sono andati più avanti di noi nel percorso verso la santità, ma sanno già che non ci arriveranno
mai. Ma l’importante è tendere. Anche il buon cristiano, chi è? Non è quello che ha la pretesa
di diventare santo, ma quello he ha capito la strada da percorrere per essere migliore. Questo
è il problema. Io ho voluto… sarebbe stato facile dire, per l’ennesima volta, «ma che ci venite a
raccontare»? Noi siamo un museo in un paese di 4000 abitanti, ma perché mi vieni a parlare
del Luovre? Possono trovare una utilità nel momento in cui prendo uno spunto da quello che si
fa al Louvre applicandolo poi in scala microscopica…
[XCIV]
M.D.: è chiaro, lunedì eravamo tut del mestiere, abbiamo piacere a conoscere quello che si fa
in altri contesti, ma se la met nell’otca di un corso di formazione rivolto a un pubblico
specifco, quello dei diretori dei musei locali del Lazio, allora mi sembra un po' mal impostato
il tuto. O organizzi un convengo, ma se destini quegli incontri a un pubblico specifco per
avere una utilità immediata, allora devi calibrarlo meglio…
P.T.: la calibrazione ci sarà adesso con questi incontri che abbiamo deciso di fare in futuro a
cadenza mensile. Lì si parlerà di noi. Se noi potessimo parlare tra di noi dei problemi… sai
quanti vantaggi avremmo, quante soluzioni troveremmo, quanti spunti avremmo per… è che
non ci conosciamo! I problemi che io incontro nel mio museo magari là l’hanno risolto
brillantemente in un modo a cui io non avrei mai pensato. Questo ci serve a noi! Non la
museologia dei massimi sistemi… quelle realizzazioni che si fanno nei musei delle nostre
dimensioni… mi interessa sapere quello che hai fato tu a Cellere, perché posso farlo anche io
qui. [...]
P.T.: l’operatività del diretore è soggeta a pesantissimi condizionamenti, parlo sempre dei
musei civici del Lazio. La fgura del diretore, già di per sé aleatoria, perché afdata alla
casualità, diventa ancor più aleatoria nel momento in cui si deve confrontare con il resto del
personale che gravita atorno al museo e la cui qualità e livello di preparazione sono parametri
del tuto afdati alla casualità. [...] Ho cercato di costruire un gruppo di lavoro, ovviamente
selezionando io le fgure professionali idonee a svolgere atvità di educazione al patrimonio, le
ho messe insieme, le ho messe al corrente di quali erano le mansioni che dovevano assolvere,
gli ho dato gli strumenti per farlo e posso dire che, a distanza di tre anni dalla costituzione di
questo gruppo, il fato stesso che ancora esiste vuol dire che ha prodoto qualcosa di utile.
Questo gruppo di lavoro svolge laboratori didatci indipendentemente dalla società che
gestisce la strutura museale, c’è un contato interno con questa strutura per motivi di
caratere fnanziario, oggi non si può dare in afdamento nessun lavoro se non passando
atraverso, ad esempio, una cooperativa, anche se questo tipo di rapporto ha dei costi
esagerati perché in questo modo si fatura due volte un lavoro, ma non solo perché la
cooperativa come società di servizi esige anche un utile di impresa che toglie risorse. Mi sono
riproposto quest’anno di svolgere lo stesso tipo di atvità prescindendo del tuto dalla
ulteriore decurtazione di fondi che avremmo subìto perché non sarebbe rimasto nulla per
svolgere l’atvità, consentimi di chiamarla, didatca… si esagera anche in questo, nella
[XCV]
terminologia si tende a esagerare, come quella di non chiamare sordi i sordi o ciechi i ciechi, i
quali non avrebbero nessuna difcoltà a sentirsi chiamare in questo modo perché non sono
termini ofensivi… ce li abbiamo fat diventare noi ofensivi non si sa per quel motivo, per un
motivo di ambito salotero, perché fa tanto fno
M.D.: politicamente correto
P.T.: cose che mi danno abbastanza fastidio, perché sono solo forma senza alcun contenuto
dietro. Gli operatori ecologici, i collaboratori domestici… sono tute stupidaggini, purtroppo
non cambiano la realtà di questa gente, non la migliorano la loro condizione. Parliamo di
didatca nel senso di educazione al patrimonio, ecco, anzi, ritorneremo a parlare di didatca
dando per scontato che signifchi educazione al patrimonio. La didatca è quello che tu fai,
quello che tu fai non cambia se la chiami didatca, invece sembra quasi che chiamandola
didatca del patrimonio cambi l’azione che tu fai, ma non è così. Quindi, stavo dicendo,
quest’anno pensavo di afdarla diretamente… si può fare nel momento in cui dichiari il
motivo per cui fai un afdamento direto per cifre ovviamente che sono piccole, già la
continuità nell’atvità potrebbe essere una otma ragione per afdare un compito con delle
risorse maggiori rispeto al passaggio atraverso la cooperativa. Mi sono cercato io le persone
idonee per fare questo. Il mio cruccio è di non poter fare nell’ambito di diretore del museo,
tuto quello che vorrei fare perché non ho tempo sufciente e non ho personale che mi possa
sostituire in questo. Io vorrei, dopo aver sistemato il dovere che il museo deve svolgere nei
confronti dell’ambito scolastico, sistemare anche i doveri che il museo dovrebbe svolgere nei
confronti dei non pubblici, altro termine abbastanza abusato, e in particolare verso gli anziani.
Gli anziani del piccolo centro non sono paragonabili agli anziani della grande metropoli, eh!
Vivono in un contesto totalmente diverso; nel piccolo centro l’atvità del circolo anziani è
ridutva e direi quasi nociva per far godere a queste persona una vecchia serena e atva dal
punto di vista intelletuale che poi diventa anche un punto di vista fsico. Questo è un cruccio
che rimane perché dovendo… essendo io un part time, io sono un fortunato in pianta organica
dopo venti anni
M.D.: un fortunato part-time
P.T.: venti anni di precariato in ambito museale e quaranta anni di precariato in ambito
archeologico, perché… mi vorrei ricollegare a quello che dicevo prima sulla formazione...
[XCVI]
M.D.: avevi iniziato con un discorso sull’accademia poi caduto…
P.T.: mi ci ricollego, ma dimmi...
M.D.: il tuo lavorare in un museo è qualcosa di cercato o è un riparo… era un tuo desiderio
oppure ti è capitato? Aspiravo a questo?
P.T.: c’è una sola parola, già usata prima, casualità. Casualità assoluta. Una casualità che
riguarda il fato che sia archeologo, non solo museologo. Questa passione per la ricerca
nell’ambito dell’antichità l’ho sempre avuta; quando facevo il liceo ce l’avevo, perché ricordo
che prendevo la moto e andavo a visitare i centri archeologici sparsi nel circondario, quindi
una ragione c’era evidentemente. Quando arrivai all’università, al momento delle scelta
importante, mi iscrissi a Scienze politiche, perché pensare di intraprendere una carriera di
caratere diplomatico che mi avrebbe portato anche all’estero non mi dispiaceva. Mi sarebbe
piaciuto girare il mondo. Mi iscrissi a Scienze politiche anche perché pensavo, avendo avuto
alle scuole medie dei docenti che mi hanno fato odiare la matematica, che in quella facoltà di
matematica non ce ne fosse. Invece, quando andai alla prima lezione di economia politica
decisi che era opportuno che cambiassi corso prima possibile. Decisi di passare alla facoltà
dove sicuramente la matematica non c’era, ma a quel punto quali letere? Quelle della mia
passione giovanile, quelle classiche, che mi avrebbero consentito di occuparmi di archeologia e
quindi di dare corso a quella passione che avevo ma che non era così forte e determinante da
avermi fato iscrivere subito a letere classiche. Diventai archeologo, ci misi sei anni invece di
quatro, perché nel fratempo feci tante altre cose, compresa la pubblicazione di alcuni studi
scientifci, fare scavi, insomma, mi formai. Poi ho fato il Dotorato, il postdotorato, sono
tornato a Bolsena perché per me è difcile separarmi da Bolsena, l’ho capito pian piano che
per me è difcile separarmi da questo luogo, e il fato che io sia stato nominato dipende da
una casualità forzata in qualche modo. In vita mia non ho mai chiesto niente a nessuno, ho
sempre agito in maniera tale da essere in qualche modo richiesto. È un fato di personalità,
non sono uno disposto ad andare in giro a pietire qualcosa, però non sono nemmeno uno che
si nasconde per non farsi trovare. Lancio dei segnali, chi li vuole raccogliere, se vengono
raccolti bene, però li lancio. Non vado chiedere un posto di lavoro, però faccio sapere che
potrei essere io quello giusto per quella particolare situazione. Quello che feci in quel
momento nel Novanta. Una volta allestito il museo io mi proposi mostrando con la mia atvità
che ero in quel momento la persona più idonea ad assumere quel ruolo. Questo fu percepito
[XCVII]
dagli amministratori dell’epoca, che erano diversi in ogni senso da quelli atuali, e sono
rimasto in quel ruolo tanto a lungo prima come precario poi stabilizzato anche se part time
forse perché… non voglio dirlo io… fato sta che sono cambiate tante amministrazioni e io sono
rimasto. Forse perché ero l’unico? O forse perché, come dicevi nel tuo caso, l’indolenza può
produrre efet di questo genere? Non so. A proposito dell’accademia una cosa volevo dire,
circa il Dotorato. Siamo in uno Stato in cui, noi, più che dei benemeriti, io e te e gli altri che
facciamo queste cose, siamo dei defcienti; ci ostiniamo a non voler capire. Finalmente
vengono banditi i dotorati di ricerca, che sostituiscono di fato la libera docenza, che all’estero
costituiscono il titolo indispensabile per iniziare la carriera accademica e senza il cui possesso
non si diventa niente. In Italia non esisteva questo titolo. Nel momento in cui viene stabilito
uno si aspeta fosse considerato analogo allo stesso titolo conseguito all’estero. Nel 1897 si
diplomano i primi dotori di ricerca tra cui il sotoscrito, e il ministro della Pubblica istruzione
invia una circolare a tute le commissioni di concorso, ce ne ho una copia a casa…
comunicando che il titolo di dotore di ricerca non doveva essere tenuto in considerazione in
nessun modo. Questa è l’Italia. Perché? Perché se fosse stato dato il ruolo che il dotorato
aveva all’estero, i baroni non potevano più sistemare all’università marito, fglia, nipote,
sorella… Oppure dovevano fargli fare prima il dotorato, ma nemmeno all'obbligo di quel
passaggio volevano sotostare! Quindi è un miracolo che io sia ancora qui dopo trent’anni da
quel concorso, e che tu gestisca addiritura due musei e non uno solo; signifca che siamo
miracolati, che abbiamo fato anche in modo di poter esser considerati tali.
M.D.: questa lunga esperienza di direzione, ti ha arricchito… in che modo l’esperienza del
museo arricchisce l’archeologo?
P.T.: assolutamente si, semplicemente per il fato che il museo si occupa di tuto e tu devi
occuparti di tuto, devi frequentare gli ambienti più diversi tra di loro, colti e incolti, aferenti
tut i campi del sapere, ti consente di muoverti, ti costringe a muoverti in qualche modo, a
conoscere situazioni, contesti, nuovi modi di comunicare… pubblici diversi e sopratuto ti
consente di sentirti ascoltato, che è una sensazione magnifca. Sopratuto per quelli che in
famiglia non riescono a considerarsi tali e che invece come diretori di fronte ad altre
persone… ascoltato dal mondo. A me veramente mi ha dato una identità, ha arricchito la mia
identità, mi ha fato sentire più me stesso, mi ha fato sentire più importante, anche se capisci
[XCVIII]
che il diretore di un museo civico di queste dimensioni, in uno Stato in cui si considera
importante solo chi ha e non chi è, è già un riconoscimento, uno stipendio...
M.D.: ascoltato dai visitatori, ma non dagli amministratori
P.T.: se ho potuto fare quello che ho fato è perché ho potuto interloquire con gli
amministratori in maniera paritaria e non subordinata. L’esempio ultimo è quello
dell’acquario. Io non mi sono opposto come diretore alla realizzazione dell’acquario, anche se
la presenza di un acquario in un museo archeologico non è il massimo che si possa otenere,
però ho capito qualche vantaggio la sua presenza può comportare, oltretuto in una sezione
che già era dedicata all’ecologia lacustre, per cui non c’è stato un cambiamento del percorso,
ma un potenziamento perché ciò che prima era statico è diventato dinamico. Non mi sono
opposto perché ho capito che vantaggio di conoscenze e di visibilità avrebbe dato questa
nuova strutura al museo e al suo territorio; un acquario di acqua dolce è un unicum in tuta
l’Italia centrale e potrebbe andare a vantaggio di un contesto anche perché siamo nel centro
visite del sistema museale, siamo nel capofla che ha tra le varie atvità quella di ridistribuire,
anche non volendolo, i visitatori sul territorio. I nostri amministratori campanilisticamente
potrebbero dirsi non interessati, come gli altri del resto, ognuno preoccupato della propria
stalla, però inevitabilmente, perché chi viene a visitare l’acquario che sta a 50 metri dal centro
visite, più gente viene all’acquario, più gente viene al sistema museale.
M.D.: il potere che ha un diretore… che potere ha? Ha un potere di indirizzo, impone le
proprie decisioni, le contrata…
P.T.: non si può generalizzare proprio per il motivo che come ho deto tuto è afdato alla
casualità. In un museo civico può esserci un diretore che impone le proprie scelte
all’amministrazione, e il contrario
M.D.: dipende dalla capacità delle amministrazioni di recepire…
P.T.: e dalla capacità del diretore di farsi capire, di farsi intendere, dei tentativi di dialogo che
uno fa. È chiaro che il dialogo avviene dal museo all’amministrazione, quando il dialogo parte
dall’amministrazione verso il museo può anche essere molto pericoloso, perché può essere il
segno di imposizioni avulse dall’ambito culturale, un ambito sempre a rischio, specie laddove
l’ambito culturale è soggeto a quello turistico, dove molto si investe in cultura perché la
cultura viene considerata essere funzionale al turismo. In una situazione in cui tuto è afdato
[XCIX]
alla casualità, essendo la sua formazione afdata alla casualità, essendo la natura
dell'amministrazione afdata alla casualità, essendo il museo afdato alla casualità della
gestione, alla casualità della sua dislocazione (si è fato il museo in un luogo dove era giusto
farlo o in un lugo dove non era giusto farlo), capisci che anche il potere che ha il diretore è un
potere assolutamente variabile dipendente da infnite variabili, quindi non si può
assolutamente dire… Mentre possiamo dire quale è il potere di un diretore di museo
nazionale, perché quella è una fgura nel ruolo dello stato le cui prerogative sono identiche in
tute le regioni e in tute le soprintendenze, la fgura del diretore di museo è quanto di più
indefnito possa esistere…
M.D.: quanto è forte l’impronta che un diretore da a un museo? è giuso che un diretore dia
una impronta forte? È inevitabile?
P.T.: domanda difcilissima a cui rispondere, perché è una domanda di una complessità
assoluta. Perché anche qui ovviamente tuto dipende dalla casualità. Se un diretore vuole può
dare una impronta forte al suo museo, che può essere una impronta di tipo molto diverso, può
essere visibile o invisibile, una impronta sul percorso museografco o sull’atvità che il museo
svolge, sulla gestione generale, una impronta immateriale che però poi da i suoi frut nella
colletvità, però il diretore… chi è il diretore? Che forza contratuale ha? Che preparazione
ha il diretore? E chi lo sa? Mi hai chiesto anche se era giusto o non giusto lasciarla una
impronta: direi che è obbligatorio che un diretore dia una impronta, se no a che serve? Per far
esistere un museo basta un custode, tuto quello che il museo fa al di fuori della sua apertura
dipende dall’impronta che gli da il diretore. Il museo può anche non fare nulla. Il mio museo
ha fato due cose ultimamente, anzi tre: è stato aperto, il museo può essere aperto tuto
l’anno, quasi tut i giorni, per il fato che ha un fusso di visitatori che glielo consente; ha fato
educazione al patrimonio, anche se in maniera discontinua perché tuto è legato ai
fnanziamenti, tanto più se la gestione è afdata a un gruppo di lavoro esterno, privato, in
qualche modo, di specialisti, che non possono lavorare gratuitamente; infne l’altra atvità che
ha svolto il museo è stata quella della divulgazione a mezzo stampa, quindi un qualcosa che
dentro il museo non la vedi esposta dentro le vetrine, ma se vai in biblioteca a Milano o a
Firenze trovi che questi prodot esistono e c’è scrito Museo territoriale del lago di Bolsena...
M.D.: una parola che a noi antropologi piace tanto è rifessività. È una parola molto complessa,
con varie stratifcazioni di signifcato. Può indicare, per esempio, nel momento della
[C]
restituzione dei risultati di una ricerca, mostrare le modalità atraverso le quali il dato è stato
costruito, il ruolo assunto dal ricercatore sul campo, il contesto all’interno di cui si è svolta
l’interazione tra il ricercatore e il suo interlocutore. Ti chiedo, quanto è rifessivo un diretore
di museo archeologico? Tradoto: quanto è evidente la funzione autoriale del diretore quale
mediatore tra patrimonio e pubblico...
P.T.: il mediatore non dovrebbe essere lui...
M.D.: si, ma date le condizioni che ci siamo det, dato che il diretore deve far tuto, è lui:
siamo noi che facciamo le mostre, noi che curiamo la comunicazione…
P.T.: come capita per i circhi di provincia, dove trovi il biglietaio che poi fa pure il clown, il
trapezista e il domatore di leoni
M.D.: comunque, quanto questa dimensione questa dimensione autoriale emerge nel museo
archeologico? È chiara questa mediazione?
P.T.: è ricercata questa mediazione, richiesta
M.D.: richiesta dal pubblico?
P.T.: e anche da me stesso…
M.D.: io dico un dichiarare esatamente quale è la tua visione e il tuo posizionamento, in virtù
di quali scelte racconti quel patrimonio in quel modo
P.T.: si ma vedi, come ho già scrito, in museologia e in museografa, come in politica, ma in
politica a torto e in museologia a ragione, si può dire tuto o il contrario di tuto, non esiste un
manuale di riferimento, non esiste ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, esistono solo opinioni
che possono far preferire un aspeto o un altro, dire una cosa è fata bene o una cosa è fata
male, ma sono comunque soltanto opinioni. Che è una cosa meravigliosa, perché ti
consentono di non arrivare mai da nessuna parte, di non concludere mai un discorso
M.D.: beh, si, nel nostro caso alimenta il dibatto…
P.T.: però anche nel nostro caso, come insegna l’ICOM, ci sono i luminari, i papi, la cui opinione
vale molto più della tua… o i grandi musei, i grandi musei detano legge…
M.D.: mi dici che questa dimensione autoriale, rifessiva c’è, trova espressione… è visibile…
P.T.: almeno per mia esperienza…
M.D.: ma è un punto di forza o di debolezza?
[CI]
P.T.: di forza, perché mi da la possibilità di cercare sempre qualcosa oltre, non considerare mai
di aver raggiunto l’obietvo, ma di cercare sempre una soluzione nuova e diversa dalla
precedente, ci gioco anche tanto, mi ci diverto tanto; interloquendo con l’interlocutore del
momento, che ormai riesco a inquadrare in una casella, questo mi agevola, mi agevola
moltissimo questo aspeto comunicativo, perché riesco sempre a calarmi in quel modo dove
l’ascoltatore trovare le parole e gli argomenti giusti per esprimere questo caratere di
rifessività e questo da grande soddisfazione quando vedo che c’è una risposta.
M.D.: poi ti volevo chiedere dell'autoreferenzialità a cui rischiano di andare incontro i diretori,
ma tuto sommato mi viene da dire che l’autoreferenzialità è l'altra faccia della rifessività, nel
senso che il fato di essere rifessivi chiude la strada all’autoreferenzialità
P.T.: se lo si è completamente, si
M.D.: contesti come quelli rappresentati dal Sistema museale del Lago di Bolsena o dalle
associazioni di categoria quali luoghi dove i diretori, oltre a formarsi reciprocamente
atraverso lo scambio di esperienze, metono anche a confronto le loro pratiche, consentono
di uscire dall’autoreferenzialità o comunque di limitarla? Per tornare a quanto ci siamo det
prima: c’è il rischio che il diretore diventi autoreferenziale?
P.T.: diciamo che lo sono quasi sempre, difcilissimo che non lo siano; il bello è riuscire a dare
all’autoreferenzialità l’aspeto della rifessività. Mi hai dato in questo momento l’opportunità
di rifeterci su questa cosa, forse così chiaramente non l’avevo mai inquadrtata questa
problematica, però in efet questo spiega un sacco di cose, ma questa situazione potrebbe
verifcarsi, anche se un fato del genere non si può insegnare, è istintivo, è una dote…
Contaminando l’autoreferenzialità con la rifessività si può otenere un risultato molto positivo
che ti consente di accontentare in qualche modo il tuo orgoglio, di metere a fruto quello che
tu sai andando incontro alle esigenze degli altri, cioè sposando le tue esigenze con quelle degli
altri, rendendole complementari, anche se questo non signifca voler per forza fare il discorso
complesso di adatare, cioè di non pretendere di trasmetere delle informazioni ma invece di
capire quai sono i tipi e i modi dell’informazione. È un compromesso che mi sembra utile per
l’operatore e per il pubblico, riuscire a raggiungere questo risultato… io ne ho fate tante di
visite, ho avuto interlocutori di tut i tipi, in venti anni… ho fato lezioni dalla scuola materna
all’università non mi sono mai trovato a disagio perché veramente sono riuscito ogni volta a
[CII]
calarmi nelle esigenze di quelle persone a rispondere alle loro esigenze, non imporre le mie. Io
ci metevo… la mia autoreferenzialità si risolve in un solo modo, nei contenuti: lì sono
autoreferenziale inevitabilmente, ma nei modi di trasmetere divento l’opposto, mi
trasformo… cerco di interpretare le esigenze di chi mi ascolta e come trasmetere quel dato,
che comunque è ogget, in maniera che sia non solo comprensibile ma richiesto dalla persona
che mi ascolta, necessario. E lo vedo dall’atenzione. Se non oteni questo risultato è fnito.
M.D.: fniamo con questa rifessione: quale è il tuo ruolo nella comunità, come vieni visto, cosa
fai...
P.T.: svolgo un ruolo di rappresentanza, mi sento di rappresentare i valori di questo territorio al
di fuori di questo territorio, in molti modi: dai passaggi televisivi alle lezioni, dalle visite guidate
fate portando persone a spasso di qua e di là alle lezioni di etruscologia fate per conto del
museo a persone che vogliono avere lezioni di questa materia. E come diretore del museo ha
assunto questo ruolo... poi l'insegnamento della museologia all’università a Roma, Siena,
Viterbo, anche recentemente, anche se tute cose precarie, saltuarie… Il mio ruolo è di
rappresentanza, poi c'è quello di studioso dell'antichità. Il mio ruolo è anche quello di
occuparmi di altre cose, cose spicciole che esulano dall’ambito culturale. Il ruolo del diretore
dovrebbe essere lo stesso: quello della rappresentanza, deve rappresentare qualcosa agli altri
M.D.: nel senso di rendere presente
P.T.: presentare, presentare le cose più disparate
M.D.: incorniciarle, dare loro una cornici e di letura
P.T.: ofrirle, regalarle, però fare presenti le cose, rappresentare. Ruolo che dovrebbero avere
in molti e che molti non assolvono… anche la rappresentanza è una speto pretamente
manageriale, rappresentanza si impara, si studia, è fondata sui modi in cui trasmetere,
rappresentare… [...]
P.T.: una chiacchierata come questa così approfondita, così libera non l’avevo mai fata, mi hai
dato l’opportunità di fare infniti voli pindarici, perché parlando di musei si vanno a toccare
tut gli aspet della vita, inevitabilmente, si può parlare di qualunque altra cosa, proprio
perché il museo può illustrare tut gli aspet della vita, non quello soltanto… passato,
presente… si è parlato dell’università, delle istituzioni, si è parlato delle persone, dei concorsi,
delle baronie universitarie… Il bello dei musei è che si può dire tuto e il contrario di tuto.
[CIII]
M.D.: forse uno dei pochi ambiti in cui fare questo è positivo, non causa danni...
P.T.: beh, la cultura può darsi che non serva, ma danni non ne ha mai causati.
[CIV]
Intervista con Giovanni Kezich
Direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
on line, 13 12 20011
Marco D'Aureli: quale percorso scientifco e professionale l’ha portata a ricoprire il suo
incarico atuale?
Giovanni Kezich: ho studiato antropologia a Siena, per una Laurea in flosofa, e poi a Londra
(UCL), per un Post-Graduate Diploma in Material Culture (che non esiste più) e poi per un Ph.
D. in Social Anthropology. Molto prima di laurearmi, avevo già accumulato una certa
esperienza sul campo, soto l'ombrello del folk revival sessantotesco nella sua versione
militante, esperienza sulla quale avrei basato i miei lavori di tesi prima, e di dotorato poi. Finiti
gli studi, non trovando subito una collocazione plausibile in ambito universitario, mi sono
occupato a lungo di editoria locale, e ho insegnato a scuola. Al Museo sono arrivato vincendo
un concorso, peraltro subito impugnato da una parte terza, e che è quindi passato atraverso
tut i gradi del giudizio amministrativo, in una bataglia durata circa sete anni (1986-1993),
che si è risolta alla fne a mio favore.
M.D.: lavorare in un museo è un obietvo che ha seguito intenzionalmente oppure ci è
arrivato per motivi contingenti?
G.K.: si e no. Da un lato, non ho mai perseguito strategicamente un obietvo del genere, che si
è manifestato, direi, un po' per caso. Dall'altro, ho sempre frequentato musei, in modo anche
un po' ossessivo - il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, da bambino, poi il Museo
Africano a Roma e il British Museum negli anni del dotorato - per cui non ho avuto difcoltà a
individuare subito il museo come un luogo "giusto" dove andare a lavorare: questo, a partire
dal mio Diploma in Material Culture londinese, che dava proprio il "museum work", come uno
dei suoi possibili sbocchi professionali.
M.D.: cosa signifca, per lei, lavorare in un museo?
G.K.: per me c'è la doppia atratva del guadagnare uno stipendio tenendo costantemente
d'occhio, e cioè non abiurando le discipline scientifche che desideravo perseguire da ragazzo:
di cui forse non ho mai capito molto, ma nelle quali, grazie anche al Museo, qualche progresso
[CV]
mi è riuscito di fare. Il che, a partire da una vocazione decisamente poco accademica, come la
mia, certamente non è poco.
M.D.: dove e come ha imparato a fare il diretore, quali modelli ha avuto, quale percorso
formativo pensa sarebbe necessario metere a punto per gli aspiranti diretori di museo (con
specifco riferimento ai musei locali, come sono la maggior parte dei musei DEA)?
G.K.: ho avuto stimoli molto eterogenei, a cominciare dalla lunga frequentazione dei musei
nell'infanzia, di cui ho già parlato, e se vogliamo anche dalla raccolta dei francobolli e qualche
anno di atvità nei gruppi archeologici. Poi il lavoro in casa editrice, importantissimo (il
computer, la grafca...), ma sopratuto per il fato che il manager museale, di fato, è a tut gli
efet un editore, anche se non necessariamente di libri. E, con l'editore, deve condividere una
certa ecletcità di fondo e una certa versatilità nel tratare fornitori e utenti di ogni genere. Poi
mi è servita l’esperienza a scuola e un po' paradossalmente, anche molto l’aver fato il servizio
militare, l’artiglieria da montagna: una scuola impareggiabile di relazioni gerarchiche, da
gestirsi quotidianamente con una certa dose di humor. E poi, il museo è certamente anche una
caserma: una disciplina diuturna, fata di turnazioni e di qualche ritualità, che va afrontata
anche un po' con lo spirito del corpo di guardia. Un po’ paradossalmente, invece, di musei
all’università non ho mai sentito parlare: allora non usava, e forse è stato meglio così. Non
sono particolarmente convinto che vi possa essere un percorso formativo struturato per
questa particolare professione, che invece ha tuto da guadagnare dalle specifche ecletcità
dei sogget che vi si afacciano: semmai, è giusto esigere che le amministrazioni dichiarino con
trasparenza quello che cercano, e che la formazione antropologica, per i musei etnografci, si
afermi comunque come un valore imprescindibile di riferimento. Questo sarebbe un obietvo
minimale, che è però ancora piutosto lontano.
M.D.: cosa deve saper fare un diretore di museo?
G.K.: deve credere all'importanza delle collezioni che conserva, e avere il senso che intorno ad
esse si possa eventualmente articolare un discorso culturale signifcativo e di qualche pregio. Il
che non è poco. Poi deve non farsi incantare dai venditori di cravate, che sono sulla porta dei
musei praticamente ogni giorno, e deve saper tratare con fornitori di tut i generi. E poi deve
sempre saper fare gli onori di casa, il che certamente non è il mio forte.
M.D.: come l'esperienza del museo arricchisce (se lo arricchisce) l'antropologo?
[CVI]
G.K.: il museografo è da un lato etnografo, cioè descritore, raccoglitore, e dall'altro
antropologo: nel senso che il museo - l'essere museo, non ha in sé niente di normale: è un
luogo totalizzante, strampalato, una vera eterotopia nel senso preciso di Foucault, ed è il fglio
cadeto di una cultura che chiede a gran voce, atraverso di esso, di essere decodifcata. Quindi
stare in un museo, particolarmente se etnografco, è certamente sempre anche un po'
feldwork, anche se forse in modo un po' mistifcato e blando.
M.D.: quale particolare torsione imprime la sua formazione al ruolo che svolge? in che misura,
per fare un esempio, il diretore di museo antropologico è diverso dal diretore di museo
naturalistico o archeologico o storico artistico? per questioni pretamente disciplinari o anche
per altro? in altre parole: esiste una anthropological way alla direzione del museo?
G.K.: per me è diverso nel senso che la competenza antropologica spinge naturalmente
all'analisi del sistema di relazioni che si articola intorno al museo stesso, secondo prospetve
che gli altri specialisti probabilmente non hanno. Se confrontato con il museo naturalistico o
quello storico-artistico o archeologico, fondati su delle epistemologie di riferimento un po’ più
solide, nel museo etnografco la natura pretamente ideologica degli exhibits e dei valori
rappresentati si staglia in modo lampante, il che rende praticamente indispensabile la
posizione dell'antropologo quale decodifcatore, mediatore ed interprete.
M.D.: è importante, e quanto, che un museo sia direto da uno specialista della disciplina di cui
il museo è espressione? quanto un diretore deve essere specialista di una certa disciplina e
quanto manager culturale?
G.K.: per me un museo lo si giudica dalla quantità di pensiero che si può intuire alle spalle dei
suoi allestimenti: che di per sé, sono sempre inadeguati. E' ovvio che a produrre questo
pensiero, deve esserci qualcuno che se intende. Su questo non ho dubbi, lo diceva anche
Šebesta: «Guai alla mancanza di profonde conoscenze programmatiche, verrebbe fuori un
pasticcio informe, di cui si accorgerebbe anche il profano…!». Se poi lo specialista è anche un
buon comunicatore e un buon manager, tanto meglio.
M.D.: quanto è forte l'impronta che un diretore lascia, imprime, sulla strutura che dirige? è
necessario che la lasci? è giusto che la lasci?
G.K.: come sopra. Il diretore è il depositario principale del pensiero che anima il museo: che di
per sé, è muto. E’ certamente inevitabile, ed è anche un bene che imprima un segno e che lasci
[CVII]
un segno, senza peraltro cancellare il segno di chi lo ha preceduto. Un museo che viene rifato
a ogni generazione, o a ogni cambio di diretore, non è - io credo - un buon museo.
M.D.: quale è il bello di dirigere un museo?
G.K.: chi ha scelto di lavorare in un museo ha certamente qualche difcoltà con il presente e
con le sue urgenze, e ha preferito rifugiarsi in un mondo un po' a sé stante: e i musei sono
ancora – o dovrebbero essere - almeno tendenzialmente luoghi sereni, tranquilli e ordinati,
aperti alla quieta contemplazione di ogget interessanti, dietro i quali si percepisce un
pensiero, un ordine. Questo si vede e si sente subito, e infat tra chi lavora nei musei c’è
subito una solidarietà di qualche tipo, un po’ a pelle. Al loro meglio, quindi, i musei pullulano di
geniacci, che sono riusciti a sotrarsi al meccanismo un po’ infernale della didatca
universitaria quale macchina che si perpetua da sola quale unico momento possibile di
realizzazione di una vocazione scientifca. In questo, il museo può invece divenire un’arena
perfetamente adeguata per il perseguimento di una certa disciplina anche a livelli di assoluta
eccellenza. Citerò a questo proposito la grande Margaret Mead che ha lavorato tuta la vita in
un museo, l’American Museum of Natural History, non a caso il più bel museo al mondo. Il
museo, dopotuto, è la casa delle Muse, che sono al servizio di Apollo, il quale Apollo è il dio
che rende accessibile all’uomo il sapere degli dei, proprio atraverso le discipline incarnate
delle Muse stesse... E qualcosa di questo, nei musei veri, ancora oggi si sente.
M.D.: quale futuro immagina per i musei? e per i loro diretori?
G.K.: il futuro in questo momento non lascia presagire niente di buono, per le troppe e
continue ingerenze della politica locale, che sui musei è veramente scatenata. I musei vanno
lasciati stare, sopratuto: altrimenti la loro funzione, che è direta sopratuto al futuro, viene
bruciata subito. Stesso pessimismo per quanto riguarda i diretori, che fniranno nelle teche,
come i dinosauri, soppiantati da una nuova generazione di manager bocconiani, che è già alle
porte. Ma quello che non è chiaro a questi signori è che la natura specialissima dei prodot
culturali, per il come vengono selezionati, individuati e riconosciuti nel corso delle epoche, e la
capricciosità della loro resa nel tempo, non soggiacciono a nessuna razionalità evidente, e
sfuggono a qualsiasi previsione. Quello che piace oggi, domani non piacerà più, non
interesserà più. Eppure, le scelte della cultura non sono mai prive di senso, anche se è un
senso che sfugge agli econometristi dei fussi turistici e agli amministratori politici. Come la
[CVIII]
rocca di Gibilterra, il museo, una volta formato, deve avere la forza di contrastare l’erosione
del tempo, e di riuscire a sopravvivere anche – ipoteticamente – a zero visitatori. Questo sarà
un buon Museo, e le generazioni future ce ne saranno grate. Forse.
M.D.: buone pratiche (e dunque necessariamente buone teorie) della direzione: condivisione
con gli amministratori delle linee guida dell'azione culturale del museo che dirige, rapporti con
la popolazione, coi pubblici, con gli stakeholders...
G.K.: nel nostro comparto specifco, la condivisione con gli amministratori è d’obbligo, nel
senso che è il Consiglio d’Amministrazione del Museo, che è direta emanazione della Giunta
provinciale, ad assumere gli at deliberativi. In questo senso, la discrezionalità del Diretore,
almeno formalmente, è ridota al minimo. I rapporti con la popolazione sono mediati dalle
Associazioni, che sono piccole istituzioni politiche per la gestione capillare del consenso. I
cosiddet “pubblici”, tranne quello specialissimo della didatca, sono per noi res incognita,
visti i costi stratosferici dei monitoraggi di marketing ben fat, e non volendo comunque
tediare i visitatori con questionari o altro. Altri stakeholders con cui ci confrontiamo
periodicamente sono l’Associazione degli amici del Museo, il comune di residenza, la comunità
locale ristreta (il nostro museo è in un paese), qualche museo locale, qualche consorzio di
promozione turistica: ma sono tut processi lentissimi, è tuto in via di miglioramento, si
vedrà.
M.D.: quale è il suo ruolo nella comunità che ospita il museo? cosa pensa di ofrirle, come
viene visto il suo lavoro?
G.K.: nella comunità dove lavoro, che è una comunità organicamente molto compata, sono e
resto un foraneo, anche dopo 21 anni suonati di servizio: il che, peraltro, per un antropologo,
non è un male: è stessa la condizione che andava a cercarsi chissà dove oltremare, riportata
più vicino a casa, come in un laboratorio. Non a caso, infat, quando partecipo al presepe
vivente, in un paese non lontano da quello dove lavoro, mi viene sempre assegnato, come
ruolo, quello del “rabbino capo”, cioè dell’ebreo: il che veramente la dice lunga.
Personalmente, tutavia, non credo afato che il museografo debba andare alla rincorsa delle
comunità e del loro favore: non siamo né costrutori di consenso, né assistenti sociali. E
sopratuto, non credo che il museo debba anticipare ovvero competere con le comunità sul
terreno che a loro è più congeniale, che è la manipolazione della memoria e la costruzione e
[CIX]
negoziazione diuturna del senso di identità. Il rapporto con le comunità, a mio avviso, deve
articolarsi come un vero e proprio scambio: loro ti consegnano feticci, certezze, radici, e tu gli
devi dare in cambio gli elementi di un sapere reperito altrove, completamente diverso, ma di
qualità
uguale,
e
quindi
scambiabile.
Meraviglia
contro
meraviglia,
a
gara.
M.D.: museo e ricerca: quale è la cifra carateristica della ricerca fata dal museo e per il
museo?
G.K.: il museo senza ricerca è una vetrina della Rinascente. Io sono molto orgoglioso del fato
che al Museo abbiamo promosso ricerche in modo autonomo in campi che spaziano dalla
dialetologia alla narratologia, dall’etnoarcheologia alla dendrocronologia, e fnalmente, con la
nostra ricerca in corso sul carnevale, abbiamo aperto un nuovo capitolo del comparativismo
etnografco, cento anni dopo Frazer. Di tute queste ricerche, il Museo è autore in proprio,
quanto a ideazione, metodologia, fnanziamento ed esiti concreti, che sono il più delle volte
dei prodot multimediali innovativi e altamente originali. Queste ricerche arricchiscono
l’esposizione di supporti multimediali e anche di ogget, e comunque animano dall’interno il
percorso museale, incrementano le conoscenze e la motivazione del personale. E, in questo
modo, il Museo ha smesso di fnanziare ricerche di terzi o, o peggio, di fungere da salvadanaio
per
ricerche
direte
dall’università,
come
purtroppo
a
volte
è
accaduto.
M.D.: può farmi una mappa delle sue mansioni?
G.K.: formalmente, il mio primo compito è quello di dare esecutività alle delibere del Consiglio
di Amministrazione con degli at di determinazione, ovvero di tradurre sul piano gestionale le
linee di indirizzo stabilite dal Consiglio. In pratica, speta però a me tuta l’ideazione della
programmazione annuale, che comporta decine di iniziative diverse, la ripartizione dei compiti
tra i collaboratori, e la supervisione continua di tute le iniziative in corso. Poi c’è una quantità
inusitata di adempimenti amministrativi, nel senso che tut gli at fanno capo alla mia fgura.
In pratica, si lavora dalla matna alla sera, tut i giorni dell’anno incluso qualche festivo. Il
posto è equiparato a quello di un dirigente della provincia autonoma, ed è quindi
ragionevolmente ben retribuito, anche se l’impato con una cultura dell’amministrazione
pubblica già sedimentata in modo molto solido, lascia davvero pochi spazi alla creatività
individuale nell’interpretarsi del ruolo assegnato. In questo, un po’ di libertà in più, per il
diretore, e qualche incentivo al muoversi, al perseguimento di contat, alla visita di altri
[CX]
musei, ovvero una sua restituzione allo status di libero citadino, oltre che di organigramma,
non guasterebbe afato.
.D.: cosa fanno, o cosa potrebbero fare, le associazioni di categoria (ICOM, SIMBDEA) per i
diretori e per i musei?
G.K.: ICOM e SIMBDEA, insieme, hanno redato qualche anno fa la Carta delle Professioni
Museali, che è stata ed è ancora un utile strumento di lavoro per il dialogo con le
amministrazioni: questo va riconosciuto. Ma è fnito tuto lì. Come associazioni di categoria,
sono sigle complessivamente deboli, poco rappresentative, elitiste ovvero un po’ setarie.
SIMBDEA in particolare risente molto di una forte componente accademica, che ha del nostro
lavoro una percezione sopratuto ideologica. In questo, SIMBDEA più che un’associazione di
setore è un po’ una lobby micropolitica, e un po’ un piccolo movimento culturale, che si fa
interprete dei valori di una sorta di nouvelle vague museografca, che può piacere o non
piacere (a me per esempio non piace), ma che comunque la posiziona su un versante molto
diverso di quello di associazione di setore che dovrebbe aprirsi, compatare, unire, invece di
discetare e distinguere. Un esempio migliore di associazione di setore è quello dell’ANMS,
dove i convegni a caratere contenutistico che si tengono regolarmente si accompagnano a un
lento progresso della capacità di lobbying del setore tuto, senza tante arzigogolature, ma è
anch’essa, nel quadro istituzionale generale, complessivamente piutosto debole.
M.D.: quanto è importante per un diretore il ruolo che la comunità scientifca (formata dai
colleghi antropologi, dai colleghi diretori) può svolgere? luogo di confronto, formazione,
dibatto…
G.K.: questo sarebbe importantissimo ma, fate salve le iniziative dell’ANMS, che però sono
per il setore etnografco quasi sempre inaferenti, in Italia non esiste quasi niente di
struturato. Quindi i confronti, la formazione, l’aggiornamento e il dibatto uno se li deve
andare a cercare da sé, un po’ a casaccio, negli interstizi dei tempi del servizio. Si è parlato
tanto, in questi anni, di reti nazionali, ecc., ma sostanzialmente siamo, mi pare, al punto di
partenza.
M.D.: come si inscrive la rifessività nel lavoro del diretore di museo? come è rifessivo il
diretore di museo?
G.K.: per quanto rifeta, non riesco a rispondere a questa domanda. La risposta, credo, non
[CXI]
speta a me, ma speta a chi guarda dall’esterno le modalità e i contenuti del mio lavoro.
[CXII]