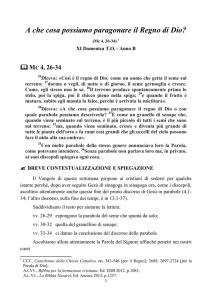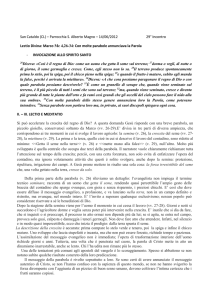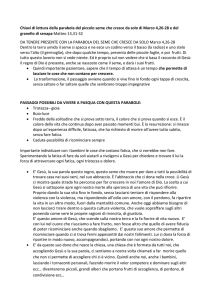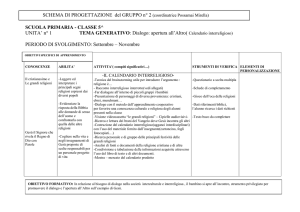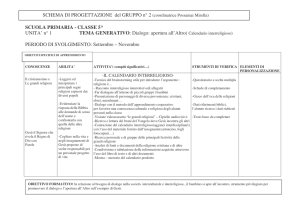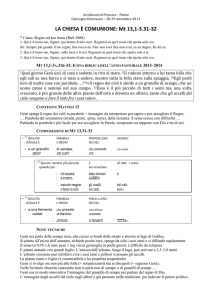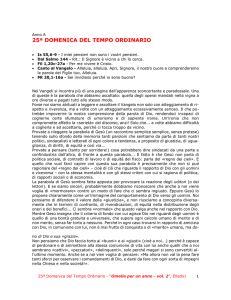XI domenica del TO B
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
Prima Lettura Ez 17, 22-24
Io innalzo l'albero basso.
Dal libro del profeta Ezechiele
Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io
prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei
suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un
monte alto, imponente; lo pianterò sul monte
alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e
diventerà un cedro magnifico.
Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà.
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo
l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e
lo farò».
Seconda Lettura 2Cor 5, 6-10
Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere graditi al Signore.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché
abitiamo nel corpo - camminiamo infatti nella fede e non nella visione - siamo pieni di fiducia
e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore.
Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti
infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa
delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.
Vangelo Mc 4,26-34
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell'orto.
Dal vangelo secondo Marco.
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli
stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco
pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è
il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa
più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono
fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere.
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
1
La prima lettura (Ez 17,22-24) riprende il maš
mašal «parabola» dell'aquila ideato da yüHezqë´l «Ezechiele»,
«Dio dà forza» (nato verso il 620 a.C.), per descrivere i rapporti di potere a livello internazionale (nim
nimš
nimšal
«morale della parabola») al suo tempo.
Ez 17,22: Così dice il Signore Dio: Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle
punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; (Kò ´ämar
´ádönäy yhwh(´élöhîm) wüläqaºHTî ´äºnî miccammeºret hä´eºrez härämâ wünätäºTTî mërö´š yö|nqôtäyw rak
´eq†öp wüšätaºlTî ´äºnî `al har-Gäböªh wütälûl, lett. «Così disse Signore Adonay: E prenderò io da cima il cedro alto e
porrò dalla testa dei rami di esso morbido coglierò e pianterò io su un monte elevato e alto»);
- Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro (wüläq
wüläqaº
wüläqaºHTî ´äºnî miccammeºret hä´eºrez härämâ).
härämâ Il ramoscello è il
ceppo davidico messianico, da cui sorgerà il re di Giuda (cf 2Sam 7,13).
I personaggi della parabola sono i seguenti: hanneºšer haGGädôl l'«aquila grande» è Nabucodònosor, re di
Babilonia (v. 3); il lübänôn «Libano» è immagine di Israele e di Gerusalemme. La cammeºret hä´äºrez «cima del
cedro» (v. 3) è il re Ioiachìn. L'´eº
´eºrec Künaº`an «paese di mercanti» (v. 4) è Babilonia, e il mizzeºra` hä´äºrec
«germoglio del paese» (v. 5) è il re Sedecìa. Questi fu una geºpen «vite» (17,6) simile a un capcäpâ «salice» (17,5),
perché crebbe in modo rapido e rigoglioso. La seconda «aquila grande» (v. 7) è Psammetico II d'Egitto (629
a.C. - 588 a.C.), con il quale Sedecìa aveva concluso un trattato di alleanza per contrastare l'assalto babilonese
contro Gerusalemme nel 588 a.C. (Ger 37,4-11). Infine, il rûªH haqqädîm «vento d'oriente» (v. 10) è lo scirocco
del deserto che soffia in certi periodi dell'anno, facendo inaridire tutto con il suo calore bruciante e
costituendo in tal modo una metafora della collera di Dio (Es 10,13; 14,21; Sal 78,26).
In sintesi: L'aquila compare in diverse metafore all'interno della Bibbia. Nei testi dell'Antico Testamento ci si
riferisce spesso alla rapidità e alla potenza del volo delle aquile. L'aquila era considerata l'immagine della
regalità e per questo in Ez 17 è usata per designare il re di Babilonia e il re d'Egitto. In Mesopotamia, come
presso altri popoli antichi, l'aquila veniva associata a diverse divinità di cui era simbolo. Un'aquila con il
ruolo di messaggero divino compare anche nell'Apocalisse di Giovanni (8,13). L'aquila grande è
Nabucodònosor che nel 597 a.C. da Gerusalemme («Libano») deporta a Babilonia il re davidico («cedro»)
Ioiachìn (v. 3) sostituendolo con il vassallo Sedecìa (vv. 5.13), il quale a sua volta cerca l'amicizia del faraone
egiziano (l'altra aquila grande del v. 7). Questo infelice tentativo scatena la repressione finale babilonese
(«vento d'oriente»: v. 10).
Notizie storiche sugli ultimi re di Giuda.
nübû|kadne´ccar «Nabu protegga l'erede», gr. Ναβουχοδονόσορ, lat. Nabuchodonŏsor, it. Nabucodonosor
II (634-562 a.C.), sovrano babilonese che regnò per 43 anni, dal 605 a.C. fino alla morte. Salì al trono alla
morte del padre Nabopolassar e sottomise il regno di Giuda, deportando gli ebrei in Babilonia e
distruggendo il tempio di Salomone (597 a.C.). Si dedicò alla ristrutturazione di Babilonia, pavimentando
strade, ricostruendo templi, scavando canali e costruendo giardini pensili, una delle sette meraviglie del
mondo antico.
yühôyäqîm Yehoyaqim, Ioiakìm: (632-597 a.C.), diciottesimo re di Giuda, figlio di Giosia, dispotico,
crudele e poco diplomatico. Quando divenne re, Ioiakìm aveva venticinque anni; regnò undici anni a
Gerusalemme. Sua madre era di Ruma e si chiamava Zebidà, figlia di Pedaià. 37Fece ciò che è male agli occhi
del Signore, come avevano fatto i suoi padri (2Re 23,36-37). Morì per cause naturali (597 a.C.) durante il
primo assedio di Nabucodònosor. Regnò su Giuda per 11 anni.
yühôyäkîn, Yehoyakhin, Ioiachìn (612 - 550 a.C.). Quando divenne re, Ioiachìn aveva diciotto anni; regnò tre
mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatàn. 9Fece ciò che è
male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre (2Re 24,8-9). Il re Nabucodònosor lo deportò a
Babilonia nel 597 a.C. e lo sostituì con lo zio Sedecìa. Figlio di Ioiakim morì esule a Babilonia, ospite più che
prigioniero (2Re 24,8-15)
cidqiyyäºhû Tzidqiyahu, Sedecìa (619 - 585 a.C.). Il suo nome significa «la mia giustizia è il Signore».
Quando divenne re, Sedecìa aveva ventun anni; regnò undici anni a Gerusalemme. Sua madre era di Libna e si
chiamava Camutàl, figlia di Geremia. 19Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Ioiakìm
(2Re 24,18-19). Il suo nome era Mattania, ma quando il re Nabucodònosor lo mise sul trono al posto di
Ioiachìn, suo nipote, gli cambiò il nome in Sedecìa (cf 2Re 24,17). Aveva 21 anni quando divenne re e
2
regnò 11 anni a Gerusalemme dal 597 al 586 a.C. I figli di Sedecìa furono ammazzati davanti ai suoi occhi;
Nabucodònosor fece cavare gli occhi a Sedecìa, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia (2Re 25,7).
Terzo figlio di Giosia, fu l'ultimo re di Giuda.
17,23: lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro
magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami
riposerà (Bühar mürôm yiSrä´ël ´ešTóleºnnû wünäSä´ `änäp wü`äºSâ peºrî wühäyâ lü´eºrez ´aDDîr wüšäknû
taHTäyw Köl ciPPôr Kol-Känäp Bücël Däliyyôtäyw TišKöºnnâ, lett. «In monte altezza di Israele pianterò esso. E
solleverà ramo e farà frutto e sarà come cedro magnifico. E dimoreranno sotto esso ogni uccello, ogni ala in ombra delle fronde
di essa dimoreranno»).
- un cedro magnifico (lü´eº
lü´eºrez ´aDDîr).
´aDDîr Dall'immagine della geºpen «vite» (vv. 6-7: re di Giuda imposti da
Nabucodònosor) si passa a quella del eºrez «cedro» (re di Giuda scelto da Dio). Se agli inizi questo oracolo
alimentò la speranza di un ritorno in patria, con una dinastia legittima rinnovata, più tardi esso fu letto come
profezia messianica.
- tutti gli uccelli (Köl
Köl ciPPôr).
ciPPôr Usata per la prima volta nel racconto del diluvio per descrivere tutte le specie
accolte nell'arca, questa immagine degli ciPPôr «uccelli» che trovano riparo sotto il cedro è usata di nuovo in
Ez 31,6 per descrivere il Faraone come un grande re.
17,24: Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto
e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il
Signore, ho parlato e lo farò» (wü|yäd`û Kol-`ácê haSSädè Kî ´ánî yhwh(´ädönäy) hišPaºlTî `ëc Gäböªh
higBaºhTî `ëc šäpäl hôbaºšTî `ëc läH wühipraºHTî `ëc yäbëš ´ánî yhwh(´ädönäy) DiBBaºrTî wü`äSîºtî, lett. «E
conosceranno tutti gli alberi del campo che io (sono) Adonay, abbassai albero alto, alzai albero basso, asciugai albero verde e
feci germogliare albero secco. Io Adonay parlai e farò»).
- gli alberi della foresta (`ácê
`ácê haSSädè).
haSSädè Se il cedro è il re di Giuda, tutti gli alberi della foresta sono i re delle
nazioni circostanti. Essi sapranno che Dio umilia il potente e suscita una nuova potenza dal nulla. Questo
insegnamento è ripetuto nel c. 31, in cui il Faraone è umiliato. Qui Dio promette un nuovo e glorioso re
d'Israele. Nel vangelo Cristo riprende questo detto profetico e ne fa uno dei suoi messaggi più qualificanti:
«Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato» (Lc 14,11).
L'anno 609 il faraone Necao, dopo aver sconfitto Giosìa, nomina Ioiachìm re di Giuda, che
morì nel 597, durante il primo assedio di Gerusalemme da parte di Nabucodònosor. Quattro anni più tardi,
Nabucodònosor sconfigge l'Egitto e nel 597 si porta via il re Ioiachìn come prigioniero, lasciando Sedecìa
come re vassallo. Sedecìa, fratello di Ioiachìm, presta giuramento di fedeltà al re di Babilonia, facendo di
Giuda l'avamposto in occidente e prima difesa contro le pretese egiziane. Ma nel 588 Sedecìa rompe il
giuramento di fedeltà, cercando aiuto nel faraone Ofra. Nabucodònosor reagisce rapidamente e sottomette
Giuda con la forza, conquistando Gerusalemme nel 586. Di questi avvenimenti ne parlano 2Re e il profeta
Geremia. Le notizie giunsero con rapidità agli esiliati in Babilonia: la possibile alleanza con l'Egitto dovette
rianimare le speranze. Ezechiele contrasta queste speranze umane con il presente oracolo (v. 16),
pronunciato probabilmente nel 588, appena ebbe notizia della ribellione di Sedecìa: questi non è il re
legittimo, né si può porre la speranza in un re umano. Non è dall'Egitto che viene la salvezza. Ioiachìm e
Sedecìa muoiono in esilio e la stirpe di Davide sembra aver fine. A questo punto cosa pensare della
promessa di Dio fatta alla dinastia di Davide? Ezechiele risponde appellandosi alla sovranità del Signore,
che sa e può compiere le sue promesse al di sopra di tutti i ricorsi umani.
3
La seconda lettura (2Cor 5,6-10) riconosce il desiderio di Cristo che abita nel cuore di ogni credente,
che aspira ad abitare presso il Signore.
2Cor 5,6-7: [Fratelli], sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal
Signore finché abitiamo nel corpo – 7camminiamo infatti nella fede e non nella visione –,
(Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου• 7διὰ
πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους, lett. «Avendo coraggio dunque sempre e sapendo che dimorando nel corpo
siamo lontani dal Signore; 7 per fede infatti camminiamo, non per visione»).
I verbi di questi due versetti sono: pres. part. di θαρρέω «ho coraggio, sono pieno di fiducia, confido», da cui il
sostantivo θάρσος, ους, τό «coraggio, fiducia»; perf. part. di οἶδα, oĩda «so, conosco»; pres. part. di ἐνδημέω
«abito, vivo, sto» (2x); pres. ind. di περιπατέω «cammino, mi comporto».
- siamo in esilio lontano dal Signore (ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου). Il verbo è pres. part. di ἐνδημέω «abito,
vivo, sto». La CEI traduce: «siamo in esilio lontano». Paolo introduce qui il motivo della condizione esilica dei
credenti che aspirano ad abitare con il Signore. Dal punto di vista sintattico, il v. 6 si presenta come un
anacoluto, poiché manca la conseguenza di ciò che deriva dal coraggio e dalla conoscenza dei credenti,
dovuto all'accumulo di pensieri che Paolo vuol fare confluire nel proprio dettato. Se consideriamo il v. 7
come una parentesi di spiegazione, il v. 6 potrebbe trovare una continuazione di pensiero nel v. 8: «preferiamo
andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore». Come si concilia lo stato di lontananza dal Signore con la
fondamentale convinzione di Paolo di essere ἐν Χριστῷ «in Cristo»? Di fatto Paolo si propone di
sottolineare la dimensione escatologica dell'esistenza cristiana, senza ignorare quella apocalittica dell'essere in Cristo (cf 1Cor 6,13b-14; 7,29-31). In definitiva, per quanto Gesù possa vivere in noi, ci troviamo
sempre nel versante della fede e non possiamo ancora contemplare il suo volto πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον «faccia a faccia» (1Cor 13,12). A riguardo, commenta bene l'Ambrosiaster: «Quando non lo
vediamo, sebbene sia presente, siamo assenti da lui».
- camminiamo infatti nella fede e non nella visione (διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους). Questo
versetto interrompe la proposizione precedente per spiegare il modo con cui i credenti "camminano" in
esilio, lontani dal Signore: διὰ πίστεως … οὐ διὰ εἴδους lett. «per fede non per visione». L'attenzione è
rivolta alla contemplazione della gloria di Cristo, percepita tramite la fede e non in modo visibile.
5,8: siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il
Signore (θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν
κύριον, lett. «abbiamo coraggio poi e preferiamo di più essere lontani dal corpo e di dimorare presso il Signore»).
- preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore (εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ
σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον). I verbi sono: pres. ind. di θαρρέω «ho coraggio, sono pieno di
fiducia, confido»; pres. ind. di εὐδοκέω «mi compiaccio, ritengo buono»; aor. inf. di ἐκδημέω «sono lontano,
assente»; inf. aor. di ἐνδημέω «abito, vivo, sto». Il versetto riprende l'anacoluto del v. 6 e si sofferma sui motivi
dell'abitare e dell'essere in esilio. Di fatto, tale situazione crea il desiderio di non abitare più nel corpo ma
presso il Signore: tale desiderio è particolarmente intenso poiché la trasformazione del corpo è già in atto
nell'esistenza di quanti hanno aderito a Cristo. Forse l'affermazione del v. 8 riflette la situazione di pericolo
di morte che Paolo sperimenta. Il parallelo più vicino è quello di Fil 1,21-23: Per me infatti il vivere è Cristo e il
morire un guadagno... da una parte il desiderio di essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, dall'altra è più
necessario per voi che io rimanga nella carne.
5,9: Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi
(διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι, lett. «Perciò anche ci
sforziamo sia dimorando (nel corpo) che essendo lontani, graditi a lui di essere»).
- ci sforziamo di essere a lui graditi (φιλοτιμούμεθα … εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι). I verbi sono: pres. ind. med.
di φιλοτιμέομαι «ho ambizione, considero onorato di»; pres. part. di ἐνδημέω «abito, vivo, sto»; pres. part. di
ἐκδημέω «sono lontano, assente». L'aggettivo εὐάρεστος, ον significa «piacevole, gradito». Nella nostra
condizione esilica Paolo preferisce essere definitivamente con Cristo, ma riconosce che ciò che conta è
essergli graditi, che in positivo significa: fissare lo sguardo sulle cose che non si vedono (cf 2Cor 4,18).
Paolo si esprime anche così: «Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore (Rm 14,8).
4
5,10: Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno
la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male (τοὺς
γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ
τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον, lett. «Infatti tutti noi comparire bisogna davanti al
tribunale di Cristo, affinché riceva ciascuno le cose per mezzo del corpo per ciò che ha operato, sia in bene che in male»).
- Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo (τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ
ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ). Il verbo è aor. inf. pass. di φανερόω «rendo noto, vengo
manifestato». Il sostantivo βῆμα, ατος, τό significa «lett. ciò che si calpesta, su cui si cammina. Passo, gradino,
tribunale, podio, tribuna». Paolo, in prospettiva escatologica, fa riferimento al tribunale di Cristo. Il tribunale
presso il quale tutti i credenti dovranno comparire non è soltanto quello di Dio (Rm 14,10) ma anche quello
di Cristo. Per questo, il πάντας ἡμᾶς «tutti noi» non si riferisce all'umanità, bensì a tutti i credenti. Paolo
sostiene che Dio giudicherà tutti, alla fine della storia, per mezzo di Gesù Cristo (Rm 2,16). L'espressione
φανερωθῆναι δεῖ «siano manifesti bisogna» va intesa come un passivo divino: appartiene al disegno divino
che tutti compaiano davanti al suo tribunale. Questo linguaggio risente dell'escatologia giudaica: il giudizio
finale è inteso come evento collettivo più che individuale.
- per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male (ἵνα
κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον). I verbi sono: aor.
cong. med. di κομίζω «mi prendo cura, conseguo, ottengo, ricevo, riscuoto»; aor. ind. di πράσσω «faccio, eseguo,
compio». L'aggettivo φαῦλος, η, ον significa «malvagio, vile, cattivo». L'essere giustificati e salvati in Cristo
rappresenta la grande novità del vangelo paolino. La condizione autentica per essere giustificati è πίστις
δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη «la fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) e non la scelta tra il
bene e il male. La prospettiva finale del giudizio non è qui segnata dalla paura o dal terrore ma dall'essere
graditi al Signore.
Il quadro escatologico di 2Cor 5,1-10 non è nitido ma sfocato; e non poteva essere
altrimenti, poiché noi camminiamo nella fede e non nella visione (v. 7). Il processo di trasformazione del corpo e
il possesso dell'abitazione celeste è già iniziato con la relazione dinamica tra l'uomo esteriore e quello
interiore, tra il vestirsi e il sopravvestirsi dei credenti (v. 4), e non inizia con l'evento della morte! Paolo non
asserisce, in modo esplicito, che tra la morte individuale dei credenti e la Parusia esista un periodo
intermedio che corrisponda, più o meno, all'Ade o ai Campi Elisi, ma sottolinea la condizione esilica dei
credenti: un esilio, iniziato con l'essere di Cristo in noi e che culmina nel nostro essere con lui.
A causa del movimento che procede da noi a Cristo, l'attenzione di Paolo si sposta in particolare
sull'escatologia che culmina con il giudizio finale davanti al tribunale di Cristo, mentre l'orizzonte
apocalittico dell'essere con Cristo è lasciato sullo sfondo. Per Paolo la dimensione etica dell'esistenza
cristiana si fonda più sull'essere ἐν Χριστῷ Ἱησοῦ «in Cristo Gesù» che sull'essere σὺν Χριστῷ «con Cristo»
(Fil 1,23). Se una novità bisogna riconoscere in 2Cor 5,1-10 rispetto a 1Cor 15 o a 1Ts 4 è l'indifferenza del
morire e del vivere: ciò che conta è essere graditi al Signore.
5
Il vangelo (Mc 4,26-34) di Marco ci riporta due parabole di Gesù, le uniche che espressamente
parlano del βασιλεία τοῦ θεοῦ «regno di Dio»: "il seme che cresce spontaneamente" e "il granello di senape".
Nella prima parabola (contenuta soltanto nel vangelo di Marco) il significato centrale è costituito dal contrasto
tra la crescita del piccolo seme nella terra e l'attesa «inerte» da parte dell'uomo. La seconda parabola
(presente anche in Matteo e Luca) fa perno su un altro contrasto: il divario tra il minuscolo granello di senape e
la crescita enorme dello stesso, al punto da offrire nutrimento e ombra a molti uccelli.
Mc 4,26-27: [In quel tempo, Gesù] diceva: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta
il seme sul terreno; 27dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa (Καὶ ἔλεγεν• οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν
σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός, lett. «E diceva: Così è il regno di Dio come un uomo che getti il seme sulla terra 27 e dorma e si alzi
di notte e di giorno e il seme germoglia e si allunga come non ha conosciuto egli»).
- e diceva (καὶ ἔλεγεν). Il verbo è impf. ind. di λέγω «dico, parlo». Nel primo discorso del Vangelo di Marco,
cioè quello delle parabole (4,1-34), la formula καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς «e diceva loro» introduce la parabola madre
del σπείρων «seminatore» (4,2). Tale formula viene ripresa ad ogni passaggio del suo insegnamento: Quando
poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. 11 καὶ ἔλεγεν
αὐτοῖς «Ed egli diceva loro»: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio» (4,10-11); la spiegazione della
parabola avviene in privato e si introduce ancora con Καὶ λέγει αὐτοῖς «E disse loro» (4,13). La seconda
parabola, quella della lampada da mettere sul candelabro, riprende la formula: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς «e diceva
loro» (4,21); la terza parabola, quella dell'uomo che getta il seme, si introduce con καὶ ἔλεγεν «e diceva» (4,26);
anche la quarta parabola, quella del granello di senape viene introdotta con καὶ ἔλεγεν «e diceva» (4,30).
Queste due ultime parabole sono incentrate sull'immagine del seme e sono le uniche (nel vangelo di Marco)
che pongono a tema il regno di Dio. Quindi, dopo aver richiamato i discepoli e la folla alla responsabilità
nei confronti della Parola/seme gettato generosamente e indistintamente in ogni tipo di terreno, il discorso si
focalizza nuovamente sullo σπόρος, ου, ὁ «seme». Notiamo però che la formula di apertura è quella più
breve: καὶ ἔλεγεν «e diceva»: (vv. 26.30), cioè priva del pronome αὐτοῖς «loro». Per alcuni studiosi questa
differenza non è a caso, ma segnala che ci sono due gruppi di destinatari diversi: la folla e i discepoli.
- Così è il regno di Dio (οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ). Sebbene quasi tutti gli studiosi del NT
sostengono che Gesù proclamava il regno di Dio per mezzo delle parabole, nel Vangelo di Marco questa e
la seguente sono le uniche due parabole dichiaratamente «del regno». Con οὕτως «così» ha inizio una
singolare introduzione di una parabola. Il regno di Dio è il tema del paragone, seguito dal racconto che
introduce in maniera molto generica una persona che lavora la terra.
- come un uomo che getta il seme sul terreno (ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς). Il verbo è aor.
cong. di βάλλω «lancio, getto». I principali soggetti presenti all'interno della prima parabola sono:
ἄνθρωπος «un uomo», ὁ σπόρος «il seme», ἡ γῆ «la terra». Essi vanno colti nel loro intreccio. Dell'uomo
viene evidenziata l'azione in tre tempi (vv. 26-27.29): 1) la semina che dà il via all'intero processo trattato
dalla parabola; 2) un periodo prolungato di inattività: «dorma o vegli, di notte o di giorno»; 3) la prontezza della
mietitura una volta che il seme è pronto. Il suo ruolo è essenziale. Del seme viene enfatizzata la forza
interna che si esprime in sei tappe: germoglia, si allunga, presenta lo stelo, quindi la spiga, poi il chicco
pieno e solo alla fine il frutto (vv. 27-29). Queste sei tappe, però, ne prevedono una settima (i numeri, ancora
una volta, non sembrano casuali): la mietitura. La terra infine è lo spazio in cui l'energia vitale presente nel
seme si manifesta in maniera sorprendente (v. 28).
La metafora dello σπόρος, ου, ὁ «seme» è ben attestata nell'AT. Is 61,11 ricorda che «la terra fa germogliare i
suoi semi». Sal 126,5s. contrappone lo spargere la semente fra le lacrime al giubilo della mietitura. Il lavoro
assiduo ha bisogno della benedizione di Dio: «Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell'anno il
centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto» (Gen 26,12; cf Qo 11,5s.). Il divieto di seminare e di mietere
nell'anno sabbatico presuppone un'abbondante mietitura nel sesto anno in seguito alla benedizione di Dio
(Lv 25,20-22). L'immagine è trasposta a esseri umani che «sono seminati e piantati» (Is 40,24) o agli Israeliti che
Dio ha seminato tra i popoli (Zc 10,9), o alla vita morale: «seminare la giustizia» (cf Os 10,12; Gb 4,8; Pr
22,8»). Il campo metaforico "seme-seminare" è particolarmente sviluppato nel NT. Il sostantivo σπόρος,
ου, ὁ «seme» ricorre tuttavia solo sei volte, di cui due nel Vangelo di Marco (4,26.27); altre due volte in Luca
(8,5.11) e due volte in Paolo (2Cor 9,10). Invece il verbo σπείρω «semino» ricorre 52 volte: si tratta del
6
discorso sapienziale e profetico della semina e della mietitura. Paolo adopera la parabola del chicco che
cresce per spiegare la risurrezione: «Come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?». 36Stolto! Ciò che tu
semini non prende vita, se prima non muore. 37Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un
semplice chicco di grano o di altro genere. 38E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo»
(1Cor 15,35-38). Il campo metaforico "seme-seminare-mietere" è particolarmente adatto a simboleggiare
l'avvento del regno di Dio in Gesù e in ogni credente, nonché il suo successivo sicuro compimento.
- dorma o vegli (καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται). I verbi sono: pres. cong. di καθεύδω «dormo, son morto, sono
inerte»; pres. cong. pass. di ἐγείρω «sveglio, desto». L'azione del seminatore è descritta con uno schema
ritmico, tenuto assieme da quattro καὶ «e»: καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος.
- di notte o di giorno (νύκτα καὶ ἡμέραν). I tempi della giornata corrispondono al costume ebraico di
considerare la notte come l'inizio del giorno seguente.
- il seme germoglia e cresce (ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται). Due sono i verbi della crescita: pres. cong. di
βλαστάνω «germoglio, fiorisco, produco» e pres. cong. pass. di μηκύνω «cresco, m'allungo» (nel NT solo al
passivo: μηκύνομαι). La ripetizione dei verbi serve a descrivere il lento processo della crescita in natura.
- come, egli stesso non lo sa (ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός). Il verbo è perf. ind. di οἶδα «so, conosco». Alla luce della
parabola del seminatore (cf Mc 4,1-20) in cui si afferma che «il seminatore semina la Parola», si comprende
che Gesù qui sta parlando dell'efficacia della Parola di Dio. Il seme seminato germoglia e completa la sua
crescita senza intervento del seminatore (cf Mc 4,27-28). L'efficacia della Parola (cf Is 55,10-11; Eb 4,12) non
va intesa in senso mondano e pensata come misurabile in termini quantitativi: la Parola di Dio è sempre Ὁ
λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ «la parola della croce» (1Cor 1,18), potenza di vita celata nell'impotenza di un
crocifisso. Il seme è anche segno di Cristo e della sua Pasqua: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore produce molto frutto» (Gv 12,24). La Parola di Dio interiorizzata funge da antidoto
alle parole meschine e volgari di un linguaggio ormai fuori controllo.
Il rabbino capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni, nel presentare l’opera Chafètz Chayìm «Le leggi della
maldicenza» (Morashà 2015), scrive: «La nostra parola, il linguaggio complesso che ci distingue dagli
animali, è uno strumento essenziale di relazione, è una forza immensa di cui dispone ogni essere umano.
Una forza che può essere usata per costruire ma il più delle volte serve a distruggere: una reputazione, un
lavoro, una famiglia, una vita. Nell’esperienza comune non ci dedichiamo a capire quali e quanti possano
essere i danni che un uso improprio della nostra parola possa produrre anche se con le migliori intenzioni
o inavvertitamente. Le regole sull’uso corretto della parola compaiono nella Torà sotto forma di precetti e in
fatti narrati ... esse sono una guida alla costruzione e al mantenimento di una società basata sul rispetto
reciproco».
4,28-29: Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno
nella spiga; 29e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la
mietitura» (αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον εἶτα στάχυν εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός, lett. «Di proprio
impulso la terra porta frutto, prima stelo poi spiga poi pieno grano nella spiga. 29 Quando poi permette il frutto, subito invia la
falce, perché è giunta la mietitura»).
- La terra produce (ἡ γῆ καρποφορεῖ). Il verbo è pres. ind. di καρποφορέω «fruttifico». L'uso di questo
verbo richiama 4,20: quelli seminati sul terreno buono: sono coloro che ascoltano la Parola, l’accolgono e
καρποφοροῦσιν «portano frutto»: il trenta, il sessanta, il cento per uno.
«Portare frutto» fa parte sia del campo metaforico della mietitura escatologica e sia della metafora della vita
secondo la fede, come nell'allegoria della parabola del seminatore (Mc 4,20), nel discorso della montagna (Mt
7,16-20) e in Paolo (Rm 1,13; 6,21.22; 15,28; 1Cor 9,7).
- spontaneamente (αὐτομάτη). L'aggettivo αὐτόματος, η, ον «spontaneo, automatico» è usato anche in senso
avverbiale «spontaneamente» per indicare qualcosa che si verifica senza una causa visibile. Il seme contiene
un'energia vitale che lo abita e fa pressione al suo interno. Nella descrizione della piaga delle tenebre in
Egitto è detto «Nessun fuoco, per quanto intenso, riusciva a far luce, neppure le luci αὐτομάτη «spontanee» degli
astri» (Sap 17,5). L'aggettivo è usato anche nella versione della LXX di Lv 25,5.11 per descrivere la crescita
spontanea dei frutti della terra negli anni sabbatici e giubilari. L'uso del termine in questo senso
suggerisce che è Dio che si cela dietro la crescita.
- prima lo stelo, poi la spiga, (πρῶτον χόρτον εἶτα στάχυν). I termini usati sono: χόρτος, ου, ὁ «vegetazione,
erba, fieno, recinto, orto, pascolo, foraggio»; στάχυς, υος, ὁ «spiga». Le quattro fasi della crescita: «prima lo stelo,
29
7
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 29e … il frutto maturo» sono un altro esempio in questa breve parabola
della ripetizione di parole per creare un senso del tranquillo e compassato trascorrere del tempo. Inoltre
queste quattro fasi «si sostituiscono ai quattro tipi di terreno della parabola del seminatore per sottolineare
non la bontà dell'ascolto, ma il potere sconosciuto per cui la parola del regno ottiene risultati positivi nella
gente che ascolta nel modo appropriato» (Gundry).
- poi il chicco pieno nella spiga (εἶτα πλήρη / πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ). L'agg. πλήρης, ες significa
«colmo, pieno, completo, integro, perfetto»; σῖτος, ου, ὁ «grano, frumento». Alla lettera, «il grano pieno nella
spiga». Nel greco antico πλήρης era a volte usato come aggettivo indeclinabile. La frase con tale forma deve
pertanto essere quella più antica, poi corretta con la forma maschile πλήρη più classica che ricorre in
numerosi manoscritti.
- quando il frutto è maturo (29ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, lett. «quando (lo) permette il frutto»). Il verbo è aor.
cong. di παραδίδωμι «do, trasmetto, consegno» può avere una triplice sfumatura: «consegnare» il frutto al
seminatore, «consegnarsi» alla mietitura, «permettere» quest'ultima. Gli studiosi concordano nel cogliere in
esso il senso di «permettere», individuando nella frase una costruzione aramaizzante. Notiamo che la
conclusione della crescita è descritta con il verbo all'aoristo. «Il frutto» diventa il soggetto dell'azione; esso
determina il momento della mietitura.
- subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura (εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ
θερισμός). I verbi sono: pres. ind. di ἀποστέλλω «invio, mando»; perf. ind. di παρίστημι «metto, dimostro,
provo»; i sostantivi sono: δρέπανον, ου, τό «falce»; θερισμός, οῦ, ὁ «mietitura, messe, raccolto». Il padrone
reagisce εὐθὺς «subito» e pone fine al ritmo sempre uguale del dormire e del vegliare. L'immagine della falce
e della mietitura richiama Gl 4,13: «date mano alla falce, perché la messe è matura», che rappresenta un grido di
giubilo per il futuro giudizio salvifico di Dio. Il verbo ἀποστέλλω «invio» (131x nel NT; 20x Mc) è
importante nel Vangelo di Marco. Nell'AT e nell'apocalittica la mietitura è una metafora consolidata degli
eventi finali. L'essere umano collabora con Dio all'instaurazione del suo regno ed esorta indirettamente
l'ascoltatore e l'ascoltatrice a fare altrettanto. In questa parabola l'«uomo» rappresenta i predicatori, il seme
il messaggio, la terra gli ascoltatori. A ciò si aggiungono, come aiutanti dei contadini, i lavoratori dediti alla
mietitura. La collaborazione di tutte queste persone permette di riconoscere il regno di Dio nei suoi inizi e
fa addirittura già partecipare alla mietitura.
Il messaggio della parabola è questo: l'annuncio del Vangelo ha una forza vitale intrinseca che però non
può schiudersi da sola. Il seme ha bisogno di qualcuno che lo semina e di una terra che lo accoglie e che
permette alla sua forza vitale di esprimersi. Chi semina viene caratterizzato dalla pazienza dell'attesa e
dalla sapienza di mettere mano alla falce solo quando «il frutto lo permette» (v. 29). Pur apparendo inattivo, il
seminatore vigila sulla crescita del seme. Alcuni autori individuano nel v. 29 un richiamo a Gl 4,13: «Date
mano alla falce, perché la messe è matura; venite, pigiate, perché il torchio è pieno e i tini traboccano, poiché grande è la
loro malvagità!» optando per una rilettura escatologica dell'intera parabola. Tuttavia, l'obiettivo di Gesù e
dell'evangelista è quello di delineare l'identità e la responsabilità dei discepoli nel "qui e ora", il che non
esclude un richiamo agli ultimi tempi.
Il δρέπανον «falce» svolge un ruolo solo in Ap 14,14-19 (sette volte). Qui però è simbolo dell'ira e del
giudizio del Figlio dell'uomo. A portare la falce sono gli angeli, non i contadini con i loro aiutanti. Mentre Ap
14,15s. descrive come Gl 4,13 in maniera generica solo l'evento della mietitura escatologica senza parlare di
una distruzione, Ap 14,17-19 parla della mietitura o della raccolta dell'uva come predizione di un
annientamento. L'immagine della falce in Mc 4,29 non include una distruzione escatologica. Anche Gv
4,35-38 parla di escatologia tramite il lavoro di mietitura per mano dei discepoli. Nel dialogo con la
Samaritana Gesù passa dal cibo alla mietitura. Quindi: «Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato;
altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica» (v. 38). I discepoli sono evidentemente paragonati ai
mietitori. Paolo invece usa la successione del piantare e dell'irrigare in relazione a se stesso e al suo discepolo
Apollo: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere» (1Cor 3,6).
La parabola del seme che cresce spontaneamente rimanda alla capacità spontanea della terra di fare
germogliare e crescere. Attraverso di essa opera la potenza creatrice di Dio (Filone di Alessandria, De
opificio mundi, 167). Senza la fusione con la terra il granello del seme non può produrre lo stelo, la spiga e il
frutto. La fede nella creazione costituiva per la società contadina palestinese la spiegazione scientifica
naturale dei processi della crescita che si verificano nella natura e rimanda nello stesso tempo al regno di Dio
che sta per cominciare. Sorprendente è invece l'indiretta allusione a Gl 4,13. I termini ἀποστέλλω «invio»,
εὐθύς «subito», δρέπανον, ου, τό «falce» e θερισμός, οῦ, ὁ «mietitura», sono carichi di significati teologici e
8
sono posti a conclusione. A cosa allude questa mietitura? Ricordiamo che le tre feste di pellegrinaggio al
tempio, šälöš rügälîm
rügälîm,
lîm, «tre piedi» dalla parola reºgel «piede», perché i pellegrinaggi si facevano a piedi (Es
23,14), erano feste della mietitura: mietitura dell'orzo = PeºsaH «Pasqua», mietitura del grano = šäbù`ôt
«Pentecoste», raccolta dell'uva = suKKöt «Capanne».
4,30: Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? (Καὶ ἔλεγεν• πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἢ ἐν τίνι αὐτὴν
παραβολῇ θῶμεν; lett. «E diceva: Come paragoniamo il regno di Dio o con quale esso parabola poniamo?»)
- A che cosa possiamo paragonare (πῶς ὁμοιώσωμεν). Il verbo è aor. cong. di ὁμοιόω «rendo simile, assimilo,
paragono». Per un'analoga doppia introduzione cf Is 40,18: «A chi potreste paragonare Dio, e quale immagine
mettergli a confronto?». Questo linguaggio è tipico anche delle parabole rabbiniche più tardive.
- con quale parabola (ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ). Il termine παραβολή «parabola» è usato nel senso ebraico di
maš
mašal. Gesù utilizza un linguaggio parabolico, sapienziale, concreto, non astratto, dogmatico o teologico. Il
linguaggio di Gesù è narrativo, aderente al reale, profondamente umano, semplice, comprensibile, che
attua una comunicazione aperta, inglobante e non escludente. Il Vangelo chiede di essere annunciato come
benedizione che riconosce la bellezza della vita e che a sua volta stabilisce relazioni personali autentiche
e profonde. Se così non fosse, si rischia di soffocare la buona notizia con una cattiva comunicazione, frutto
di pregiudizi e ignoranza che oscurano la dimensione di perdono e di misericordia rivelata da Dio.
- possiamo descriverlo (θῶμεν). Il verbo è aor. cong. di τίθημι «metto, offro, do, depongo, stabilisco, decido,
custodisco». Alcuni codici sostituiscono θῶμεν con παραβαλῶμεν «possiamo raccontare» tentando di rendere
l'espressione più chiara. L'uso della prima persona plurale ha l'effetto di coinvolgere gli uditori nella ricerca
di una similitudine adeguata e quindi di una comprensione più profonda del mistero stesso del Regno.
4,31-32: È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; 32ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo
possono fare il nido alla sua ombra» (ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον
ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων
τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ κατασκηνοῦν, lett. «Come a un grano di senape, che quando è seminato sulla terra, più piccolo essente di tutti
i semi che (sono) sulla terra, 32 e quando è seminato, sale e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami grandi, così da
potere sotto l'ombra di lui gli uccelli del cielo porre la tenda»).
- È come un granello di senape (ὡς κόκκῳ σινάπεως). I termini sono: κόκκος, ου, ὁ «chicco della melagrana, di
grano, seme, granello»; σίναπι, εως, ἡ «sènape». La frase si apre in modo insolito con un dativo, dando per
scontata una premessa. Il senso è il seguente: «Per quanto concerne il regno di Dio, si verifica quanto succede
per un granello di senape». Il seme della pianta della senape era proverbiale per la sua piccolezza (cf Mt
17,20: fede esigua quanto un seme di senape). La pianta della senape, i cui semi sono usati per il loro aroma,
lungo le sponde del mare di Galilea può raggiungere l'altezza di circa tre metri. Plinio il Vecchio (23 – 79
d.C., Naturalis historia 19,170-171) dice che è una pianta resistente che cresce rapidamente e tende a invadere
il giardino. Il punto è che il regno è un qualcosa sia di resistente che invadente. L'antichità conosce diverse
specie di senape e di piante simili alla senape. Oggi la σίναπι della nostra parabola è abitualmente
identificata con la Brassica nigra, la senape nera della moderna botanica. Diversamente dagli autori greci e
latini, i rabbini catalogano la senape tra le piante del campo e non tra le piante da giardino e ne vietano la
coltivazione negli orti (Mishnà, Kil'ajim 3,2; Tosefta, Kil'ajìm 2,8). Nella Mishnà e nei Talmudim il granello di
senape è più volte menzionato come l'unità più piccola (Mishnà, Nasir 1,5; Niddà 5,2; Berakhòt 5,8d,36; 31a).
Secondo il trattato Pe'a del Talmud di Gerusalemme un arbusto di senape sviluppato raggiunge la
grandezza di un albero di fico (7,20b,17-19); tale affermazione è esagerata, così come la notizia che con tre
rami di un arbusto di senape si sarebbe potuta coprire una capanna (7,20b,15-17).
- quando viene seminato (ὅταν σπαρῇ). Il verbo è aor. cong. pass. di σπείρω «semino, spargo, diffondo», da cui
ὁ σπείρων «il seminatore» (Mt 13,3); ὁ σπείρας «il seminatore» (Mt 10,39); σπέρμα, ατος, τό «seme, sperma,
germe, sopravvivenza, discendenza»; σπερμολόγος, ου, ὁ «che raccoglie semi, nel NT ciarlatano» (At 17,18).
Notiamo il doppione poco elegante dal punto di vista letterario «quando viene seminato» (vv. 31.32). Nel
racconto manca la figura umana e al termine non si parla di mietitura, ma di uccelli che fanno il nido
all'ombra della pianta di senape.
9
- cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi (ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον
πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους). I verbi sono: pres. ind. di ἀναβαίνω «cresco»; pres.
ind. med. di γίνομαι «vengo, divento»; pres. ind. di ποιέω «faccio, produco». I sostantivi sono: λάχανον, ου,
τό «verdura, legume, ortaggio» (dal verbo λαχαίνω «zappo, scavo»); κλάδος, ου, ὁ «ramo» (dal verbo κλάω
«spezzo, rompo»).
- che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra (ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν, lett. «così da potere sotto l'ombra di lui gli uccelli del cielo porre la tenda»). I verbi
sono: pres. inf. med. di δύναμαι «posso»; pres. inf. di κατασκηνόω «pianto la tenda, abito, dimoro». I
sostantivi sono: σκιά, ᾶς, ἡ «ombra, proiezione del corpo»; πετεινόν, οῦ, τό «uccello»; οὐρανός, οῦ, ὁ «cielo,
firmamento, Dio». Nell'AT i grandi alberi qualche volta sono presi a simbolo del potere nazionale. In Daniele
il grande albero sotto il quale «dimoravano le bestie della terra e sui cui rami abitavano gli uccelli del cielo» è un
simbolo della persona e del potere di Nabucodònosor (Dn 4,19). In Ez 17,22-23 Dio prenderà un ramoscello
da un grande cedro e lo pianterà affinché possa portare frutto e diventare un nobile cedro. Poi, «sotto di lui
tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà». La corrispondenza verbale tra Mc 4,32
ed Ez 17,23, dove gli uccelli si riposano ὑπὸ τὴν σκιὰν «all'ombra», attesta che per Marco questa è la
principale allusione all'AT. Pertanto il regno di Dio proclamato da Gesù è il luogo dove tutte le creature
viventi troveranno rifugio. C'è anche una sottile ironia nel presentare il regno non come un maestoso
cedro ma come un cespuglio di senape. Questo campo metaforico è ripreso anche nel manoscritto delle
Hodajòth «ringraziamento», scoperto a Qumran nella prima grotta nel 1947, ove si parla di alberi e cespugli
che crescono nascostamente, dai quali spunterà un pollone destinato a diventare una piantagione eterna
(1QH 16,5-6.10s.) e «...i cui rami [servirono] a tutti i volatili» (16,9). Qui si allude al destino escatologico
della comunità. Di un raduno escatologico dei popoli presentati come animali e uccelli parla 1Enoc 90,30.33.
L'attenzione della seconda parabola (il granello di senape) sembra focalizzarsi su un gioco di contrasti. Pur
avendo un parallelo in Lc 13,18-19 la versione marciana enfatizza maggiormente il divario tra l'iniziale
piccolezza del seme e la grandezza dell'arbusto che ne esce, al punto tale che i suoi rami possono diventare
uno spazio di riparo per gli uccelli del cielo. Evidentemente, la parabola gioca sul potere evocativo delle
immagini: l'albero che offre riparo nella tradizione biblica è spesso simbolo di un regno che garantisce
protezione a chi vi prende parte (Gdc 9,8-15; Ez 17,22-24; 31,1-9; Dn 4,10-12.17-23); altrettanto evocativa è la
piccolezza del granello di senape, proverbiale in diversi testi della tradizione rabbinica. La γῆ «terra» gioca
ancora un ruolo importante nella parabola: menzionata due volte nel v. 31 continua a essere il luogo dove si
realizza il passaggio dalla piccolezza del seme alla grandezza dell'arbusto. Obiettivo dell'immagine
sembra essere quello di sostenere la fiducia di quanti sono coinvolti negli umili inizi del Regno, tenendo
vivo il senso di responsabilità verso coloro che sono stati chiamati a trovare dimora e riparo al suo interno.
4,33: Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano
intendere (Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν, lett.
«E con tali parabole molte parlava a loro la parola come potevano ascoltare»).
- Con molte parabole (παραβολαῖς πολλαῖς). Il termine italiano «parabola» traduce l’ebraico maš
mašal. La radice
verbale mshl ricorre nell'AT con due significati diversi: 1) essere simile, assomigliare, raccontare una
parabola, cantare un canto beffardo; 2) dominare, regnare (K.-M. Beyse-H. Gross, in GLAT V, Paideia 2005,
coll. 424-433). Il sostantivo maschile maš
mašal può significare: «detto, proverbio, massima sapienziale,
metafora, parabola, allegoria». Propriamente il maš
mašal rappresenta il «racconto» (sostantivo o verbo in forma
qal «attivo»), mentre il nimš
nimšal indica la «morale della parabola» (sostantivo o verbo al nifal «passivo»). Pertanto
il maš
mašal si presenta come un espediente didattico o esegetico del midraš
midraš,
raš, metodo tradizionale dell’esegesi
biblica. Il sostantivo midraš
midraš «spiegazione» deriva dal verbo däraš «cercare, richiedere, esigere». La tradizione
ebraica usa questo verbo per l’interpretazione della Scrittura.
Ci sono due tipi di midraš
midraš:
raš il midraš haggadàh, di carattere illustrativo-narrativo, e il midraš halakàh, di carattere
normativo-giuridico. Un celebre esempio di midraš
midraš è il Cantico dei Cantici, i cui protagonisti sono intesi come
allegoria del rapporto tra Dio e il credente. Il plurale mešalim o mišlê è il titolo del libro dei «Proverbi».
La parabola è un tratto di assoluto rilievo nella tradizione delle parole di Gesù, che l'ha scelta come
strumento-chiave per l’annuncio della sua teo-logia. Grazie al linguaggio delle immagini, facilmente
comprensibile, Gesù ha mostrato una grande attenzione nei confronti degli incolti, dei poveri. Tuttavia la
vena anti-intellettualistica della comunicazione in parabole, riconosciuta nel passato, oggi convince di meno
perché si nota opportunamente un tratto di enigmatica ambivalenza in tante parabole di Gesù.
10
Etimologicamente il vocabolo contiene l'idea generica di accostamento e comparazione: παραβάλλω «getto
innanzi, accosto» (hapax nel NT: At 20,15). Da qui il significato figurato di «parabola, paragone, similitudine,
immagine». Il termine παραβολή, ῆς, ἡ appare 50 volte nel NT, impiegato esclusivamente dai sinottici, se
si eccettuano le uniche due ricorrenze della Lettera agli Ebrei (9,9; 11,19). Il quarto vangelo preferisce il
termine παροιμία «similitudine» (Gv 10,6), benché contenga a sua volta due "parabole" esclusive della sua
tradizione, ossia quella del buon pastore (Gv 10) e quella della vite e i tralci (Gv 15) (cf P. Sequeri). Il därš
däršan
(dal verbo däraš «cercare») è colui che compila il midraš
midraš,
raš è il predicatore professionista. yühôšùª` viene
considerato il därš
däršan,
an il compilatore di mešalim e di midraš
midrašim
rašim più grande di tutti i tempi.
- annunciava (ἐλάλει). Il verbo è impf. ind. di λαλέω «parlo, annuncio» e denota un'azione abituale.
- la Parola (τὸν λόγον). Qui la parola è usata in senso assoluto come una sintesi virtuale dell'insegnamento
di Gesù (cf 4,14).
- come potevano intendere (καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν). I verbi sono: impf. ind. di δύναμαι «posso, ho potere»;
pres. inf. di ἀκούω «odo, ascolto». Qui non si vuole affermare che Gesù scelga le parabole perché, senza di
esse, il popolo non avrebbe compreso nulla, né si vuole esprimere una restrizione operata da Gesù stesso.
L'espressione riprende piuttosto l'immagine di 4,24-25: «Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con
la misura con la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. 25Perché a chi ha, sarà dato; ma a chi non
ha, sarà tolto anche quello che ha».
4,34: Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa
(χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα, lett. «Senza ma
parabola non parlava a loro, in disparte però ai propri discepoli spiegava tutte le cose»).
- Senza parabole non parlava loro (χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς). Il verbo è impf. ind. di λαλέω
«parlo, annuncio». Marco ribadisce quanto già detto in 4,33a, secondo l'abituale tecnica delle espressioni
duplicate. Spesso le parabole che Gesù narra sono seguite dall'incomprensione degli uditori e dalle
spiegazioni che Gesù fornisce ai suoi discepoli (Mc 4,34). In effetti, il linguaggio semplice delle parabole
rivela mentre cela, e richiede un'intelligenza umile e non arrogante, una sapienza, una capacità di cogliere
in unità la terra di cui narrano e il cielo a cui alludono. L'intelligenza del mistero non va confusa con la
conoscenza e ancor meno con l'informazione, ma si situa sul piano della Hokmâ - σοφία «sapienza», che
abbraccia in sé il sapere e il sapore, la mente e il palato, lo spirito e il corpo. Un'intelligenza capace di
gratitudine è aperta al dono perché il mistero del Regno non è conquista degli intellettuali, ma dono
accolto dai semplici e dai piccoli (cf Mt 11,25).
- ai suoi discepoli (τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς). Questo versetto sovente è considerato una ripetizione di 4,11: «A
voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole», ma qui il
concetto è diverso. Nei versetti precedenti non si parla di spiegazione e i destinatari sono οἱ περὶ αὐτὸν σὺν
τοῖς δώδεκα «quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici» (4,10), mentre qui sono οἱ μαθηταί «i discepoli»
che ricevono le spiegazioni. Questo è il primo caso in cui Gesù interpreta insegnamenti enigmatici per i
suoi discepoli. Tali spiegazioni verranno date anche a riguardo di altri argomenti importanti per la
comunità: il concetto di puro e impuro (7,17-21), il divorzio (10,10-12) e il pericolo della ricchezza (10,2330).
- spiegava ogni cosa (ἐπέλυεν πάντα). Il verbo è impf. ind. di ἐπι-λύω «sciolgo, slego, libero; nel NT: spiego,
risolvo». Con il verbo ἐπιλύω si indica l'interpretazione, la spiegazione allegorica, l'iniziazione al mistero
del Regno. Il sostantivo ἐπίλυσις, εως, ἡ «liberazione, nel NT spiegazione, opinione, interpretazione, soluzione»
(hapax nel NT: 2Pt 1,20) e il verbo ἐπιλύω «spiego» (2x nel NT: Mc 4,34; At 19,39) a volte sono usati per la
spiegazione di affermazioni religiose o di oracoli.
La conclusione (vv. 33-34) è segnata da due tensioni narrative: quella tra il parlare e l'ascoltare e quella tra
l'accoglienza delle parabole e l'accesso alla loro spiegazione. Il «parlare», qui espresso dalla formula
ἐλάλει τὸν λόγον «annunciava la Parola» ha per soggetto Gesù e rimanda a quel λόγος «parola» che ha
giocato un ruolo dominante nella spiegazione della parabola del seminatore (vv. 13-20). L'«ascoltare» ha
per soggetto la folla e richiama sia un atteggiamento positivo di accoglienza, sia il limite con cui la Parola di
Gesù si trova a dover fare i conti: quello di un ascolto limitato, ben illustrato dalle tipologie di terreno
descritte nei vv. 13-20. Se nell'insegnamento di Gesù le parabole restano il codice comunicativo per
eccellenza, a cui tutti possono accedere, l'agiografo precisa che l'atteggiamento positivo dell'ascolto non
basta: esso deve essere seguito dal discepolato; in caso contrario il significato più profondo delle cose
11
(ἐπιλύω «illustrare, spiegare») resta inaccessibile. Questo è il significato delle espressioni ἐκεῖνοι οἱ ἔξω
«quelli di fuori» e οἱ περὶ αὐτὸν «quelli intorno a lui» (Mc 4,10-11).
Preso nel suo insieme, Marco 4,1-34 sviluppa i principali temi teologici di questo
vangelo. Ne emerge una cristologia che non solo ribadisce il motivo di Gesù come colui che insegna con
autorità (1,27; cf 4,1-2) ma anche che identifica la morte e la risurrezione di Gesù con il mistero del regno.
In Marco 4 Gesù è l'uomo forte il cui potere alla fine sarà reso manifesto anche se per adesso è nascosto
come il processo di crescita del seme.
Le parabole del seme acquistano una connotazione cristologica e la funzione di parabole della
speranza per la comunità. Come il seme ha un suo potere e dinamismo che a suo tempo si concretizza nella
messe, così è anche il mistero del regno di Dio. Il contrasto tra il potere di Gesù, che è nascosto e assente
sulla croce, e la sua gloria al momento del suo ritorno (13,26-27; 14,62) non è da meno del contrasto tra il
più piccolo di tutti i semi e la più grande di tutte le piante dell'orto. Le parabole di Mc 4,1-34 sono
metafore della cristologia del vangelo.
Ugualmente importante sia nel contenuto che nel contesto è il tema dell'essere discepoli, che in
Marco è correlato alla cristologia. Il concetto dell'essere discepoli permea il cap. 4 ed è messo in risalto dai
ripetuti inviti ad «ascoltare» (4,3.9.23.24.33). Nel pensiero biblico l'ascolto è strettamente legato
all'obbedienza; gli inviti di Dio in tal senso sono espressi nella preghiera quotidiana ebraica che comincia
con šüma` yiSrä´ël «Ascolta, o Israele» (Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41; cf Mc 12,29).
La parabola, dal sapore semitico, può essere inquadrata nel contesto del messaggio escatologico di
Gesù. Questa interpretazione esprime bene il contrasto fra il piccolo chicco del seme e l'abbondante frutto.
Il regno di Dio è già arrivato adesso con Gesù. La nostra parabola si spinge però al di là della tensione
escatologica e si collega con la teologia della creazione. Essa parla anche di una gioia che contrasta con la
fatica del seminatore. I predicatori possono lasciare spazio con tranquillità alla predicazione: è la Parola
che si impone, non il predicatore.
La parabola del granello di senape è caratterizzata dalla contrapposizione fra piccolo e grande, fra
semina e crescita. Il regno di Dio arriverà in maniera imprevedibile e sovrana e trasformerà il mondo. Il
granello di senape contrapposto al cedro, che nella Bibbia è immagine dei governanti, porta in sé un senso
di ironia, pone i sogni di grandezza imperiale in una luce comica. In tal modo, la speranza nel
compimento del regno di Dio viene presentata come speranza in una sovranità opposta a quella terrena.
La nostra parabola è tramandata, oltre che in Mc 4,30-32, anche in Mt 13,31s., Lc 13,18s. e VangTom
20: «I discepoli di Gesù dissero: «Dicci a che cosa assomiglia il regno dei cieli!». Egli rispose loro: «È simile a
un granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma se cade su un terreno coltivato produce un
grande ramo (e) diventa rifugio per gli uccelli del cielo». Molto istruttivo è il cambiamento di soggetto, che fa
produrre al terreno il ramo, nonché l'aggiunta che il terreno è coltivato. Questo sposta l'attenzione dalla
crescita della pianta alla ricettività e all'attività del terreno (dell'essere umano).
Un'allusione alla nostra parabola ricorre nello scritto Dialogo del Redentore (Codice di Nag-Hammadi
III, 5, 144,5-8), che risale al II secolo. Qui Maria (Maddalena) domanda se il granello di senape è di specie
celeste o terrena; tuttavia la menzione è troppo succinta per permettere delle conclusioni.
Nella storia dell'interpretazione la parabola fu volentieri spiegata nel senso della diffusione della
fede e della Chiesa. Un'esegesi collegata con il protestantesimo liberale del XIX e XX secolo vide in essa
metaforicamente espresso l'ottimismo di Gesù per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo del regno di
Dio nella storia.
12