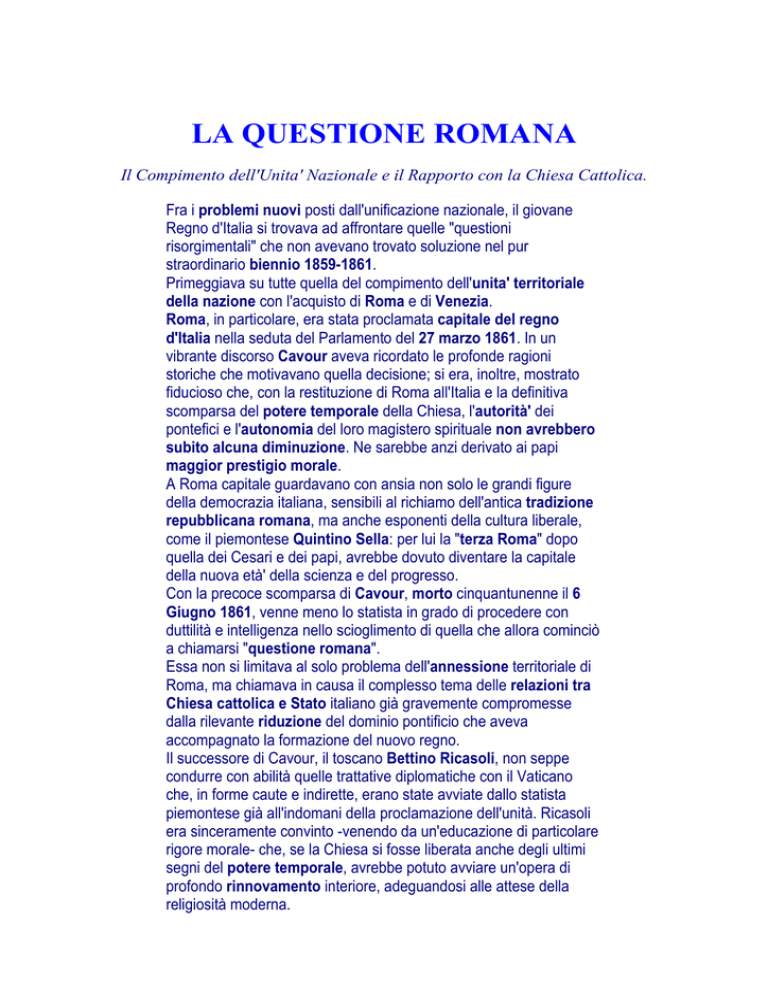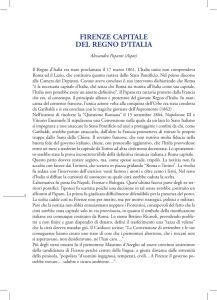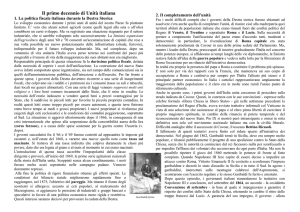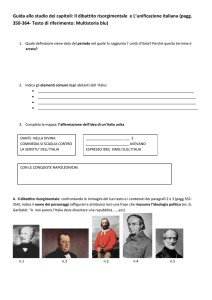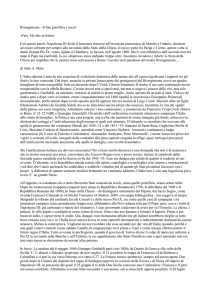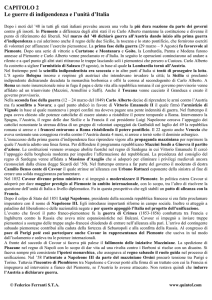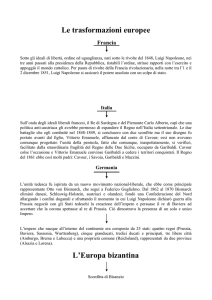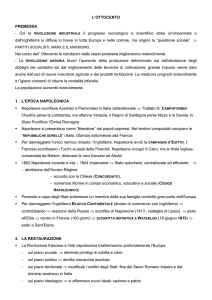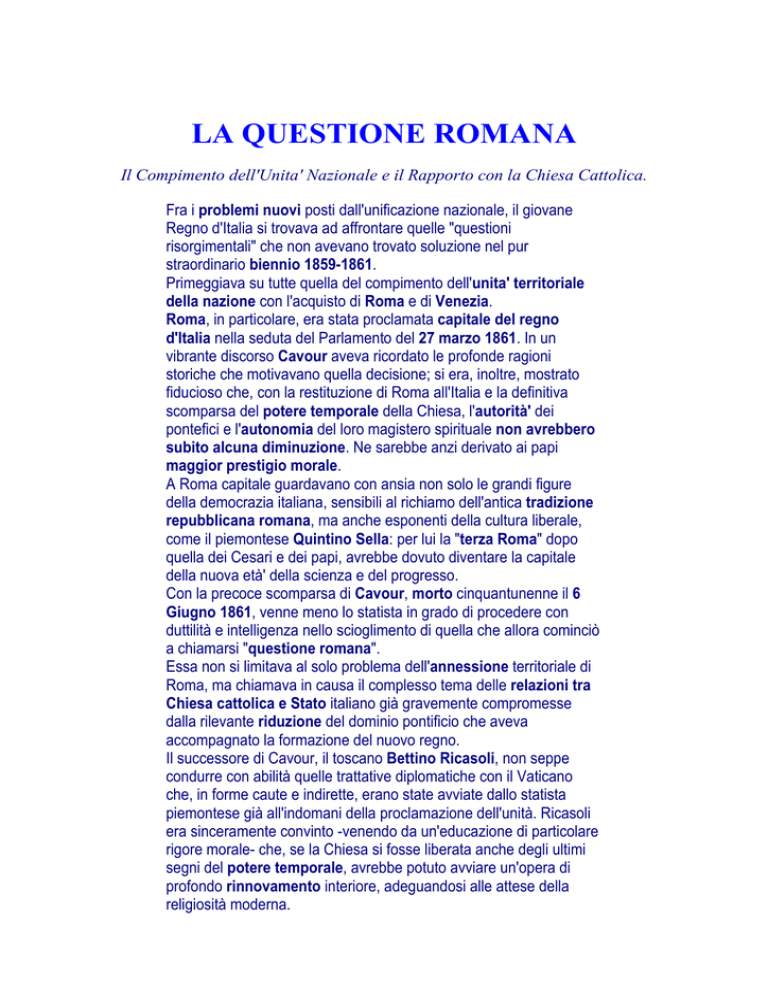
LA QUESTIONE ROMANA
Il Compimento dell'Unita' Nazionale e il Rapporto con la Chiesa Cattolica.
Fra i problemi nuovi posti dall'unificazione nazionale, il giovane
Regno d'Italia si trovava ad affrontare quelle "questioni
risorgimentali" che non avevano trovato soluzione nel pur
straordinario biennio 1859-1861.
Primeggiava su tutte quella del compimento dell'unita' territoriale
della nazione con l'acquisto di Roma e di Venezia.
Roma, in particolare, era stata proclamata capitale del regno
d'Italia nella seduta del Parlamento del 27 marzo 1861. In un
vibrante discorso Cavour aveva ricordato le profonde ragioni
storiche che motivavano quella decisione; si era, inoltre, mostrato
fiducioso che, con la restituzione di Roma all'Italia e la definitiva
scomparsa del potere temporale della Chiesa, l'autorità' dei
pontefici e l'autonomia del loro magistero spirituale non avrebbero
subito alcuna diminuzione. Ne sarebbe anzi derivato ai papi
maggior prestigio morale.
A Roma capitale guardavano con ansia non solo le grandi figure
della democrazia italiana, sensibili al richiamo dell'antica tradizione
repubblicana romana, ma anche esponenti della cultura liberale,
come il piemontese Quintino Sella: per lui la "terza Roma" dopo
quella dei Cesari e dei papi, avrebbe dovuto diventare la capitale
della nuova età' della scienza e del progresso.
Con la precoce scomparsa di Cavour, morto cinquantunenne il 6
Giugno 1861, venne meno lo statista in grado di procedere con
duttilità e intelligenza nello scioglimento di quella che allora cominciò
a chiamarsi "questione romana".
Essa non si limitava al solo problema dell'annessione territoriale di
Roma, ma chiamava in causa il complesso tema delle relazioni tra
Chiesa cattolica e Stato italiano già gravemente compromesse
dalla rilevante riduzione del dominio pontificio che aveva
accompagnato la formazione del nuovo regno.
Il successore di Cavour, il toscano Bettino Ricasoli, non seppe
condurre con abilità quelle trattative diplomatiche con il Vaticano
che, in forme caute e indirette, erano state avviate dallo statista
piemontese già all'indomani della proclamazione dell'unità. Ricasoli
era sinceramente convinto -venendo da un'educazione di particolare
rigore morale- che, se la Chiesa si fosse liberata anche degli ultimi
segni del potere temporale, avrebbe potuto avviare un'opera di
profondo rinnovamento interiore, adeguandosi alle attese della
religiosità moderna.
Questa convinzione si traduceva, però, in un ostacolo a tentativi di
conciliazione che avevano come interlocutore un pontefice, Pio IX,
convinto della necessità del dominio temporale quale garanzia di
libero esercizio dell'azione spirituale e sospettoso verso ogni
esperimento di riforma del Cattolicesimo.
Abbandonato da Vittorio Emanuele II, sempre oscillante in materie
religiosa, Ricasoli si dimise dalla presidenza del Consiglio (1862)
lasciando il posto a Urbano Rattazzi, l'antico leader della Sinistra
piemontese.
A lui andava la fiducia del sovrano, il quale sembrava convinto di
poter ripetere, utilizzando abilmente l'alleanza con i democratici, il
successo ottenuto da Cavour con l'impresa garibaldina.
La situazione internazionale si presentava, tuttavia,
profondamente mutata rispetto a due anni prima.
Né l'Inghilterra, né l'Austria, né, soprattutto, la Francia,
intendevano assistere senza reagire alla fine del dominio pontificio.
Del resto, Rattazzi non possedeva certo quella sapienza diplomatica
che Cavour aveva così brillantemente utilizzato per uscir vittorioso
nella difficile crisi politica apertasi con l'impresa dei Mille. Egli
agevolò copertamente le iniziative del partito garibaldino, tendenti
all'arruolamento di volontari per marciare su Roma e su Venezia, ma
già nel maggio 1862, di fronte all'ipotesi di una probabile guerra con
l'Austria, fu costretto a far disperdere, a Sarnico, le truppe di
volontari pronti a varcare il confine del Trentino.
Lo stesso comportamento equivoco si rivelò, in maniera assai più
clamorosa, due dopo quando Garibaldi tornò in Sicilia per farne il
punto di partenza di un'iniziativa contro lo Stato pontificio.
Per rassicurare Napoleone III, che minacciava l'invio di truppe a
difesa del papa, Rattazzi proclamò lo stato d'assedio nell'isola e, in
seguito, mandò l'esercito a fermare Garibaldi che intanto era
sbarcato in Calabria con i suoi volontari.
Il 29 agosto 1862 forze dell' esercito regolare aprirono in
Aspromonte il fuoco contro i garibaldini. Garibaldi, ferito, fu
imprigionato per alcuni mesi nella fortezza di Varignano presso La
Spezia. L'episodio di Aspromonte destò enorme impressione
nell'opinione pubblica italiana.
Esso riportava alla luce quel contrasto tra iniziativa popolare e
iniziativa regia, tra democrazia e moderatismo, nella formazione
dell'unità nazionale, che la conclusione dell'impresa garibaldina del
1860 aveva occultato ma non certo superato. La crisi di
Aspromonte provava, da un lato, come trovassero espressione nelle
iniziative del movimento democratico sentimenti ben presenti nella
collettività nazionale e come se fosse autenticamente popolare la
spinta verso Roma e verso Venezia.
Dall'altro lato essa confermava quanto questa spinta potesse
realizzarsi solo con un'adeguata copertura politico-diplomatica.
Caduto Rattazzi, vittima dell'ambiguità della propria condotta, si
giunse così, a opera del nuovo presidente del Consiglio, il moderato
bolognese Marco Minghetti, alla firma (15 settembre 1864) della
cosiddetta "Convenzione di settembre" con Napoleone III.
In virtù di questo accordo la Francia ritirava le truppe poste a difesa
dell'integrità dello Stato pontificio, e di questa integrità si faceva ora
garante il Regno d'Italia che, quasi a simboleggiare una definitiva
rinuncia a Roma, si impegnava a trasferire la propria capitale da
Torino a Firenze.
La notizia della Convenzione determinò gravi tumulti nella città
sabauda, la separazione dalla maggioranza di un gruppo di deputati
piemontesi - chiamato "la Permanente" - intransigenti difensori delle
prerogative dell'antico regno sabaudo, e infine le dimissioni dello
stesso Minghetti, sostituito dal generale piemontese Alfonso
Lamarmora. Il governo italiano , in realtà, vedeva nella Convenzione
solo un espediente diplomatico. Con esso, senza pregiudicare le
aspirazioni su Roma, si otteneva l'importante risultato di eliminare
dalla penisola ogni presenza militare francese.
Nonostante il nuovo passo fatto verso il completamento dell'unità
nazionale nella terza guerra d'indipendenza, ripresero, così, forza le
correnti democratiche. Esse rimproveravano alla diplomazia regia ora come all'epoca della prima e della seconda guerra
d'indipendenza- di non riuscire a perseguire fino in fondo l'obiettivo
dell'unità nazionale.
Tornato al potere Rattazzi nell'aprile 1867, si intensificò
l'organizzazione del volontariato garibaldino per una nuova
spedizione verso Roma. La condotta nuovamente ondeggiante di
Rattazzi, intimorito dalle proteste di Napoleone III, portò a un nuovo
arresto di Garibaldi nel settembre 1867.
Non si fermò, tuttavia, l'organizzazione dell'impresa. I volontari
entrarono ai primi di ottobre nello Stato pontificio, raggiunti da
Garibaldi, che era fuggito da Caprera.
Contro di essi, però, Napoleone III aveva provveduto a inviare un
corpo di spedizione militare comandato dal generale Oudinot ed
equipaggiato da moderni fucili -gli chassepots- a retrocarica e
rigatura a spirale.
Dopo un primo successo dei garibaldini a Monterotondo, falliva
l'insurrezione di Roma, dove i volontari che erano riusciti a entrare in
città venivano sconfitti dai pontifici a Villa Glori. Il 3 novembre 1867
anche gli uomini di Garibaldi erano definitivamente battuti a
Mentana dalle bene armate truppe francesi.
Ancora una volta Rattazzi non aveva saputo assicurare all'iniziativa
quella copertura politico-diplomatica che, grazie a Cavour, aveva
grandemente favorito l'impresa del 1860.
L'insuccesso del moto popolare a Roma, al quale i garibaldini
avevano attribuito importanza decisiva per la riuscita del loro
disegno, denunciava, d'altro canto, i limiti organizzativi dei
democratici.
Il pendolo sempre oscillante nella storia del Risorgimento tra
iniziativa popolare e iniziativa diplomatica tornava, così, a volgersi
verso quest'ultima. Le difficoltà dell'Impero napoleonico e le sempre
più manifeste ambizioni della Prussia lasciavano, infatti, intravedere
prossimo un nuovo sconvolgimento dell'orizzonte internazionale.
La sconfitta di Napoleone III a Sedan e la proclamazione in Francia
della repubblica offrirono al governo italiano, guidato ora dal
piemontese Giovanni Lanza, l'occasione per assumere un' iniziativa
autonoma. Il 20 settembre 1870 un corpo di bersaglieri al comando
del generale Raffaele Cadorna entrava a Roma attraverso una
breccia aperta nelle mura della città all'altezza di porta Pia.
Pio IX, dopo una resistenza poco più che formale, si ritirava nei
palazzi vaticani. Con un successivo plebiscito del 2 ottobre veniva
proclamata l'annessione della città e del restante territorio
pontificio all'Italia. La "legge delle guarentigie" (delle garanzie) del
13 maggio 1871, regolò i rapporti con la Santa Sede.
ANCORA SULLA "QUESTIONE ROMANA"
Alla questione sociale, costituita dalla rivolta meridionale, si affiancava, senza
tuttavia intrecciarsi, la questione del completamento dell'unità, a cominciare dalla
questione romana, resa incandescente dalla decisione del primo Parlamento
italiano di dichiarare, nella seduta del 27 marzo 1861, Roma capitale d'Italia mentre
ancora la città era saldamente in mano al papa, garantito dall'appoggio delle
principale potenze europee.
A favore di una sua rapida conquista si erano mobilitati in particolare il Partito
d'azione e più in generale i democratici. Dopo che i moderati erano riusciti a
dirigere e controllare pienamente il processo di unificazione, per la corrente
democratica risorgimentale la questione romana era rimasta praticamente l'unico
cavallo di battaglia, l'unico tema qualificante per conservare e recuperare
un'identità e una presenza politica significativa. In effetti essa si prestava
particolarmente allo scopo: in primo luogo la rilevanza internazionale della
questione romana la poneva al centro di difficili equilibri della complessa rete di
alleanze tessuta dai moderati nel contesto europeo. Far precipitare la situazione
accelerando e forzando il processo di unificazione -ponendo, cioè la questione in
termini rivoluzionari- avrebbe significato mettere in gravissima difficoltà la destra,
farne emergere le contraddizioni e porne in crisi l'intera politica estera. Tanto più
che l'ondata di generale simpatia di cui aveva goduto tra le potenze liberali la
rivoluzione italiana era andata rapidamente spegnendosi e l'Italia, costituitasi più
grande del previsto, era ora guardata con generale diffidenza.
In secondo luogo, l'inseparabilità della questione romana dalla più generale
problematica politico-religiosa esasperava la contrapposizione tra l'intransigente
anticlericalismo (e per certi aspetti anticattolicesimo) dei democratici e la logica più
mediatrice e compromissoria di parte della destra. La formula separatista
cavouriana "libera chiesa in libero stato" si basava infatti sull'idea di un
compromesso stabile tra Stato liberale e Chiesa cattolica, fondato sulla rinuncia da
parte della seconda al proprio potere temporale in cambio del dominio spirituale, e
sull'impegno del primo a garantire non solo la piena libertà religiosa ma il "primato
etico-civile del cattolicesimo come base della vita nazionale". In questo senso si
erano orientate le trattative avviate da Cavour con la Santa Sede. E nella stessa
direzione si era mosso Bettino Ricasoli, che il 12 giugno 1861 gli successe alla
giuda del Governo. Cattolico praticante, il barone Ricasoli aveva tentato sia di
convincere Pio IX a una soluzione negoziata, sia di ammorbidire la posizione
francese sulla questione. Ma aveva ricevuto un doppio rifiuto: Pio IX difese il
proprio potere temporale con intransigenza, opponendo un netto "non possumus"
alle ipotesi diplomatiche italiane; Napoleone III protrasse ulteriormente la
permanenza delle truppe francesi nello Stato Pontificio, avvertendo nel contempo
che un'iniziativa italiana su quel territorio sarebbe stata considerata come
un'aggressione diretta. Contestato sia dalla destra, che avrebbe preferito maggiore
cautela, sia dalla sinistra, che caldeggiava una politica estera più aggressiva
minacciando il ricorso all'azione diretta di tipo garibaldino, dopo appena nove mesi
di governo, il 3 marzo del 1862, Ricasoli dovette rassegnare le dimissioni.
Lo sostituì Urbano Rattazzi, più vicino alle posizioni della sinistra e comunque
convinto dell'opportunità di ripetere la mossa cavouriana del 1860 attraverso uno
spregiudicato uso dell'azione extra-governativa garibaldina. Così Garibaldi si diede
ad organizzare gruppi di volontari nel Veneto, incoraggiato dal tacito assenso del
governo italiano che, secondo una tecnica sperimentata, sperava di poter trarre
vantaggio dall'azione dal basso senza compromettersi. Ma il clima internazionale
era cambiato. L'appoggio dell'Inghilterra non era più incondizionato come un
tempo. E l'atteggiamento della Francia, fattasi ben più guardinga nei confronti della
potenza cresciutale ai confini meridionali, rimaneva intransigente. Perciò, quando
Napoleone III dichiarò la sua aperta ostilità a ogni iniziativa, Rattazzi e il re
intervennero sciogliendo con la forza le organizzazioni dei volontari.
Ancora più energicamente il governo intervenne quando Garibaldi, pochi mesi più
tardi, tentò l'avventura dal sud, concentrando i propri volontari in Sicilia e puntando
su Roma, nel tentativo di ripetere la gloriosa impresa di due anni prima, portandola
questa volta al suo estremo compimento (liberazione di Roma: «O Roma o
morte!»). Il governo italiano, pressato dalla Francia, proclamò lo stato di assedio,
ordinando alle truppe regolari di fermare i volontari garibaldini con la forza. Lo
scontro avvenne il 29 agosto sulle pendici dell'Aspromonte, in Calabria, dove
l'esercito italiano, intercettate le colonne in marcia, non esitò ad aprire il fuoco.
Garibaldi fu ferito (come recita il canto popolare dedicato all'episodio: «Garibaldi fu
ferito, fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda i suoi soldà»),
arrestato e rinchiuso nel forte Varignano. Ma il governo Rattazzi non sopravvisse
alla crisi che ne nacque e pochi mesi più tardi, l'8 dicembre 1862, fu costretto a
dimettersi.
Dal fallimento dell'avventura romana erano usciti sconfitti tanto i moderati (i cui
tentennamenti avevano inferto una ferita profonda all'orgoglio nazionale), quanto i
democratici (i cui metodi rivoluzionari si erano rilevati inefficaci). Soprattutto era
risultato impraticabile, nella nuova situazione nazionale, quell'intreccio tra
diplomazia moderata e azione diretta democratica che aveva invece dominato la
fase precedente. Da quel momento in avanti i governi dovettero adottare una tattica
del tutto diversa, fatta di tante trattative diplomatiche e attenta a sfruttare gli spiragli
aperti nel quadro europeo dalle contraddizioni tra le potenze dominanti.
Questa via seguì il ministero presieduto dal moderato bolognese Marco Minghetti,
succeduto nel marzo 1863 al governo di transizione di Luigi Carlo Farini. Convinto
della necessità di una soluzione consensuale della questione romana, Minghetti si
mosse sul piano diplomatico con l'obbiettivo prioritario di rassicurare le grandi
potenze e in particolare la Francia. Il 15 settembre del 1863 questa politica diede
un primo significativo risultato, con la firma di un accordo (la Convenzione di
Settembre) con Napoleone III, in base al quale il governo italiano si impegnava a
difendere i confini dello stato pontificio e a stabilire la propria capitale a Firenze (si
trattava di una implicita rinuncia a Roma capitale), in cambio del ritiro delle truppe
francesi entro due anni. In questo modo ci si garantiva la benevolenza di
Napoleone III (il cui presidio di Roma incominciava a costare eccessivamente) e
contemporaneamente si ponevano i democratici di fronte al fatto compiuto.
Ma l'ondata di impopolarità di tale soluzione travolse il governo. I democratici
denunciarono con forza il carattere di definitiva rinuncia a "Roma capitale" della
Convenzione e il rischio di un "Aspromonte permanente" implicito nell'impegno
italiano a tutelare i confini pontifici. Torino insorse il 21 settembre contro la
decisione di trasferire la capitale; ci fu una sanguinosa repressione che causò 30
morti. Minghetti fu così costretto alle dimissioni (23 settembre 1864) e venne
sostituito alla guida del governo dal generale La Marmora (28 settembre 1864).
Il Vaticano, allarmato dalle possibili conseguenze dell'accordo italo-francese,
accentuò ulteriormente il proprio atteggiamento di intransigente chiusura, ribadendo
duramente la condanna del liberismo e di ogni forma di modernizzazione. Nel
dicembre 1864 fu pubblicata l'enciclica papale Quarta Cura, insieme ad un Sillabo
di errori che comprendeva tutti i principi essenziali del liberismo. Tra le tante
proposizioni enunciate, la settantanovesima asseriva che la libertà di discussione
corrompe le anime e la trentaduesima che il clero ha un diritto naturale ad essere
esentato dal servizio militare. La tolleranza religiosa, la libertà di coscienza e di
stampa, la legislazione eversiva, furono tutte condannate, insieme con il
socialismo, il razionalismo e le associazioni per la diffusione della Bibbia, ed era
recisamente negato che il Papa dovesse o potesse scendere a compromessi "col
progresso, col liberismo, colla moderna civiltà".
Il Sillabo suscitò enorme indignazione, e per quanto la parte meno illiberale del
clero si affrettasse a mettere in dubbio sia il significato di esso che la sua autorità,
la maggior parte della gerarchia ecclesiastica lo accolse come un pronunciato
infallibile (in base al dogma dell'infallibilità del papa in materia di dottrina). In
seguito non mancarono alcuni suoi difensori che affermarono che esso non
impediva ad un cattolico di definirsi liberale in politica. In effetti, dato che le
proposizioni condannate si stavano diffondendo rapidamente, c'era da aspettarsi
che la chiesa cambiasse metro e venisse a patti con il liberismo e la civiltà moderna
in un futuro non troppo lontano. La sua pubblicazione originaria comunque,
apparve come un grave colpo inflitto alle tendenze favorevoli al compromesso e
provocò un'ondata di anticlericalismo.
Francesco Crispi annunciò al Parlamento che la cristianità doveva venir purgata
dai vizi della Chiesa romana o altrimenti perire. Successivi governi conservatori
proposero che i seminari fossero sottoposti a controllo governativo, che i prefetti
potessero, quando necessario, interferire perfino nella celebrazione dei riti religiosi
e che i sacerdoti potessero essere rinviati a giudizio qualora rifiutassero
l'assoluzione a quanti fossero stati scomunicati per motivi politici. La successiva
legge del 1866 soppresse quasi tutti gli ordini e le congregazioni religiose e
confiscò i loro beni. Circa 13.000 enti ecclesiastici erano stati soppressi e in base a
questa nuova legge altri 25.000 seguirono la stessa sorte. A parziale giustificazione
venne fatto osservare che era giusto che una parte dei beni della Chiesa passasse
allo Stato ora che questo intendeva assumersi la responsabilità dell'istruzione e
della pubblica beneficenza. I redditi delle parrocchie vennero lasciati intatti, ma i
capitoli delle chiese cattedrali ed i vescovi furono anch'essi costretti a cedere allo
Stato le loro proprietà ricevendo in cambio il 5% (dopo aver operata la deduzione di
tre decimi per scopi educativi e di pubblica beneficenza). I seminaristi furono tenuti
a compiere il servizio militare ed il nuovo codice civile non diede sanzione legale ai
matrimoni che non fossero stati celebrati secondo il rito civile.