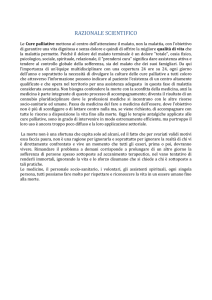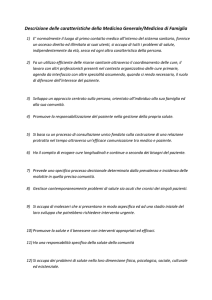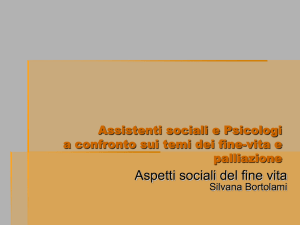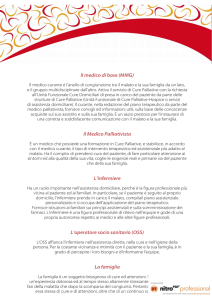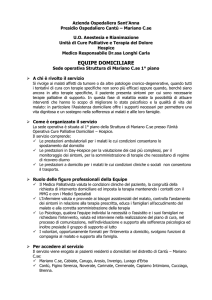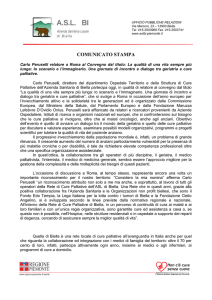Marina Sozzi Sia fatta la mia volontà. Ripensare la morte per cambiare la vita Chiarelettere, Milano, 2014. La nostra civiltà occidentale, in tutte le manifestazioni delle scienze umane, storia, psicologia, antropologia, sociologia, ha rappresentato una specie di congiura del silenzio nei confronti della morte. E il silenzio sulla morte è calato anche nella vita delle persone. La sofferenza, l’agonia e la morte appunto sono diventati un tabù, qualcosa da nascondere negli ospedali e da dimenticare in fretta. E la coscienza del singolo individuo lasciata a sé è facilmente preda di paure irrazionali. Aspirazione massima delle persone della nostra epoca è quella di morire “senza accorgersene”, di notte: la bella morte agognata è quella improvvisa, nascosta alla coscienza. Anche la medicina, fino all’avvento delle cure palliative, non è stata da meno: i medici prossimi al morente hanno sentito come loro dovere professionale, fino a qualche decennio fa, nascondere alla persona malata il suo stato. Si usano parole “leggere” povere di significato per riferirsi alla morte: decesso, dipartita, trapasso. Ancora oggi un medico che arriva al letto della persona morta redige una doverosa “constatazione del decesso”. Marina Sozzi, tanatologa e bioeticista, ha invece attraversato negli anni tutti gli aspetti culturali del morire nella vita sociale delle persone. E ora ha riversato in questo libro tutta la sua esperienza, costruita attraverso studi, letture, confronti, interviste e anche viaggi in diverse culture ( o in culture del diverso sentire sulla morte). Qui si parla di riti funebri, di tabù, di etica del fine vita, di eutanasia, di cordoglio, di lutto, di come sono organizzati i cimiteri nelle varie epoche e società. E’ un libro di esperienza: come vive una tanatologa le sue malattie, la sua mortalità, dovendo essere professionalmente legata in modo costante alla morte. Qui ci fa partecipi delle sue letture e dei suoi viaggi. Quello che colpisce nella lettura di queste pagine è il clima di serenità: “la capacità di affrontare le avversità della vita, e nello specifico la morte propria o di una persona amata, con maggiore calma”. Marina Sozzi finalmente usa la parola: SI PUÒ DIRE MORTE e www.sipuodiremorte.it è il blog che lei condivide coi naviganti su internet. Le poche pagine di introduzione sono da stampare e da fornire a un malato terminale, una volta entrati in confidenza con lui, con leggerezza, sincerità e rispetto. Quello che tocca da vicino noi medici e operatori sanitari tutti è il capitolo sulle cure palliative. Qui non ci possono essere sconti. Le nostre manchevolezze non ci sono perdonate: “troppo arduo dire a un uomo che morirà, troppo impreparati a farlo i dottori”. Si parte da una costatazione di inerzia: “In Italia fatica ad essere spazzato via il vecchio modello etico del paternalismo, secondo il quale il medico deve proteggere il paziente da notizie sulla sua salute che potrebbero addolorarlo” per arrivare all’unica vera definizione di chi mente, di chi si barcamena in “un’altalena tra accanimento e abbandono terapeutico” e “la famiglia è lasciata sola…”: vigliaccheria, pag.96. Chi lavora davvero a contatto coi morenti percepisce che “il malato sa, sente la morte che si avvicina” e non permettergli di condividere le sue emozioni, di parlarne, di urlare o di piangere, o di raccogliersi in un tenero e affettuoso commiato condiviso, non è un atto medico. La ricerca medica, quella scientifica, ha necessità di radunare le sindromi e i casi clinici sotto un ombrello che chiamiamo malattia: per misurare, per provare, confrontare metodiche e strumenti, per far emergere ciò che è efficace e consegnare il protocollo a un medico, che non è uno scienziato, ma un professionista che cerca di usare la scienza. Ed è il medico che si confronta con la persona malata, nella sua individualità, nella sua costante diversità rispetto al modello scientifico. Possibile diversità del malato dal gruppo studiato e del medico dal gruppo dei ricercatori. Se il medico calato nel territorio mantiene come interesse prevalente quello di combattere unicamente la malattia, e cioè combattere la morte, o meglio la sua, del medico, paura di morire, può anche fallire nella sua mission. Poiché la medicina è nata ed è orientata ad alleviare la sofferenza: questo è il punto di incontro tra persona-­‐medico e persona malata. Il morire rivela la fragilità dell’essere umano, essere di aiuto a chi soffre ne rivela la grandezza. E allora avanti con le cure palliative, con la nostra formazione per essere capaci di somministrarle, con la consapevolezza, non solo razionale ma anche emotiva, che anche noi medici siamo mortali e nel prenderci cura dell’altro non dobbiamo investirlo con le nostre paure. La morte non si può curare, ma i medici possono ancora influenzare le vite dei loro pazienti in modo positivo e significativo. I medici possono garantire che i pazienti vivano i loro ultimi giorni con il livello più alto possibile di confort e care, ciò è dato da riduzione delle preoccupazioni del paziente, dall’incoraggiamento a rimeditare gli affetti, dall’integrazione tra le cure spirituali e i trattamenti sanitari, dalla promozione dell’alleanza terapeutica medico paziente che dona dignità ai pazienti, dal prevenire ospedalizzazioni non necessarie e cure finalizzate al prolungamento della vita. Certo tutto questo non può essere assicurato dal medico solo, nelle cure palliative emerge sempre la necessità di un lavoro di equipe. Per curare la sofferenza. Grazie Marina Sozzi per averlo scritto. Giuliano Bono medico di famiglia [email protected]