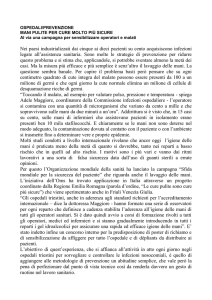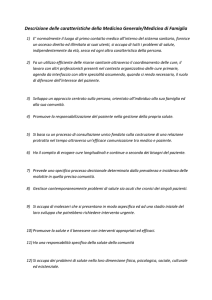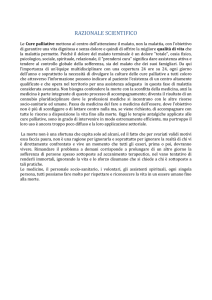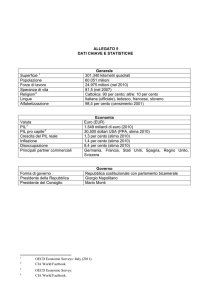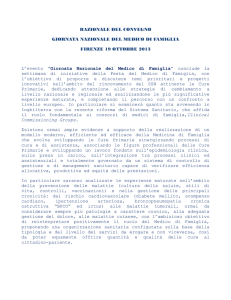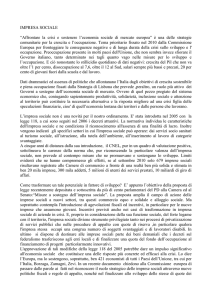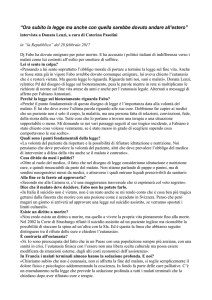TERAPIE
Interrompere le cure
Solo il paziente
può decidere
quando dire basta
Gli oncologi si interrogano su come
scegliere le cure nei momenti finali della
vita di una persona. Ancora non esiste
una risposta univoca, ma tutte
coinvolgono il paziente, che deve essere
protagonista della scelta
a cura di DANIELA OVADIA
i è un momento,
nella vita di alcuni pazienti malati
di cancro e dei
loro medici, in
cui la domanda sorge spontanea: le cure alle quali il malato è sottoposto sono davvero
utili per allungargli la vita? E,
soprattutto, il periodo di vita
in più che gli viene concesso
è di una qualità adeguata alle
aspettative del malato? Queste domande costituiscono
uno dei problemi principali
dell’oncologia clinica e riempiono intere sessioni nei congressi scientifici, anche se discuterne solo tra medici potrebbe non avere senso, perché non esiste una risposta
univoca alla domanda “quando una cura oncologica diventa inutile?”
V
“La risposta potrebbe essere: quando il rapporto tra benefici ed effetti collaterali non
è più a favore dei primi” dice
Maurizio D’Incalci, direttore
del Dipartimento di oncologia dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di
Milano. Per quanto scientifica
suoni questa affermazione,
tradurla in comportamenti
concreti è tutt’altro che semplice, perché i benefici sono
percepiti diversamente da ciascun paziente e, in sostanza,
ogni caso fa storia a sé.
PAESE CHE VAI, USANZA
CHE TROVI
In un editoriale pubblicato
nel 2011 su Annals of Oncology
e considerato una sorta di
linea guida in materia, Sofia
Braga, oncologa medica dell’Istituto portoghese di oncologia di Lisbona, faceva un quadro della situazione nei diversi Paesi europei, dimostrando
come le differenze di tratta-
mento tra un luogo e l’altro, a
parità di stadio della malattia
e di tipologia di tumore, potessero essere davvero molto
ampie.
Uno studio svedese, per
esempio, dimostrava che circa
il 25 per cento dei malati affetti da tumori solidi aveva ricevuto una chemioterapia nell’ultimo mese di vita, percentuale che corrisponde più o
meno alla media continentale, con però variazioni molto
grandi. In Portogallo è il 37
per cento dei terminali a essere ancora in cura con farmaci
che sono riservati a una diversa fase della malattia. Negli
Stati Uniti è solo il 15 per
cento. Due studi italiani, effettuati in due diversi centri oncologici, mostravano dati ancora differenti: in uno era in
cura il 23 per cento dei malati
terminali, nell’altro il 15. In
Corea uno su due viene trattato, mentre la percentuale più
bassa si registra in Gran Breta-
In questo articolo:
chemioterapia
cure palliative
decisioni di fine vita
gna: solo l’otto per cento dei
pazienti considerati terminali
ha ricevuto una terapia. Lo
studio britannico, pubblicato
nel 2006 sul British Journal of
Cancer, è anche l’unico ad
aver registrato le cause di
morte, scoprendo che, tra i pazienti curati con chemioterapici, il 7,5 per cento era deceduto per tossicità da farmaci e
il quattro per cento circa per
sepsi neutropenica (infezioni
non controllate per mancanza
di meccanismi immunitari di
difesa), due possibili effetti
della somministrazione di sostanze che hanno bisogno di
una buona conservazione dei
sistemi di metabolizzazione
dei farmaci e di eliminazione
delle sostanze tossiche: in pratica fegato e reni ben funzionanti.
L’IMPORTANZA DEI SISTEMI
SANITARI NAZIONALI
“Dietro queste cifre ci
sono certamente differenze
di tipo culturale su ciò che significa prendersi cura di chi
non ha più speranza di guarigione” spiega Livio Garattini,
direttore del Centro di economia sanitaria Angelo e Angela Valenti (CESAV) dell’Istituto Mario Negri. “Nei Paesi
mediterranei c’è una documentata tendenza a usare più
farmaci, a volte con un eccesso di cure, mentre nei Paesi
del Nord questa tendenza è
più limitata. I casi della Gran
Bretagna e degli Stati Uniti
fanno però storia a sé e dipendono molto dall’organizzazione sanitaria del luogo.
In Gran Bretagna, per esempio, la libertà di prescrizione
da parte del medico è molto
ridotta ed esistono linee
guida stringenti che dicono
fino a quando il Sistema sani-
tario pubblico copre economicamente un certo trattamento. Questo spiega perché
solo pochi ne hanno diritto
negli ultimi mesi”.
Negli Stati Uniti, invece,
dove non esiste un sistema sanitario pubblico, bisogna che
il malato abbia un’assicurazione che paghi e, in genere,
laddove il paziente o il
curante tendono a prolungare la terapia anche
per ragioni psicologiche e
umane, interviene un perito
esterno che si limita a studiare le carte e a decidere se vale
ancora la pena provarci oppure no.
Il medico gioca comunque un ruolo importante
nella scelta, in tutti gli scenari: non a caso i parametri che
determinano più facilmente
il profilo di chi viene curato
più a lungo sono la giovane
età (perché si fa di tutto per
salvare i più giovani), lo stato
di avanzamento delle metastasi (che sono il problema
clinico principale da affrontare), il tipo di tumore e la
sua sensibilità ai trattamenti:
se risponde bene, ovviamente si continua nella cura. La
forma di tumore trattata più
a lungo, almeno negli Stati
Uniti, è quella polmonare: il
43 per cento dei malati è curato nell’ultimo mese di vita
e il 20 per cento addirittura
nelle ultime due settimane.
SE IL TROPPO STROPPIA
Anche se queste cifre possono sembrare aride, sono in
realtà necessarie ai medici per
capire se stanno esagerando
nel prendersi cura di un malato, per quanto assurdo questo
possa suonare. “Non è vero
che è sempre utile curare: a
volte i farmaci fanno più male
che bene, danno effetti collaterali che rovinano anche le
ultime settimane di vita e
inoltre obbligano il paziente a
spostarsi continuamente per
visite, esami e terapie
invece di trascorrere il tempo
a casa propria, con la famiglia” continua D’ Incalci.
Provare troppe terapie, pur
sapendo che hanno scarse
possibilità di funzionare, può
anche precludere l’uso di una
terapia sperimentale, come
spiega ancora l’oncologo, che
ha seguito molte sperimentazioni di nuovi farmaci: “I test
di fase 1, quelli effettuati su
pochi pazienti per verificare
se una nuova sostanza è sicura per l’uomo, sono spesso
proposti alle persone per cui
le terapie tradizionali sono
state inefficaci perché hanno
molto da guadagnare se per
caso la molecola funziona meglio di
quelle vecchie. Il problema è che
non si possono fare sperimentazioni su
soggetti che hanno usato
troppe terapie diverse. In Italia, purtroppo, sono i medici
stessi a essere poco abituati a
questo tipo di studi – perché
se ne fanno pochi – e, quindi,
non riescono a cogliere appieno l’opportunità che rappresentano”.
sono alcune domande che il
medico deve porsi, la prima
delle quali è: quale sarà il beneficio per il paziente? Per rispondere, però, bisognerebbe
avere uno strumento efficace
in grado di stimare la prognosi: tutti gli studi effettuati in
materia dicono invece che i
medici non sono bravi estimatori della sopravvivenza del
loro paziente e che in genere
tendono a essere ottimisti, sia
perché sono emotivamente
coinvolti sia perché sottostimano le possibili complicanze. Per questa ragione sono
stati messi a punto degli algoritmi (come
l’indice di
Karnofsky o
quello dell’Organizzazione mondiale della sanità) che sono molto usati in
medicina palliativa e che tengono conto anche di sintomi
invalidanti come la mancanza di appetito, la perdita di
peso, i disturbi della deglutizione e del respiro. Vi sono
poi altri esami sul sangue che
possono dare un’idea dello
stato di salute generale della
Un terapia
sperimentale
può essere una
buona scelta
DOMANDE CRUCIALI
Secondo Sofia Braga, vi
OTTOBRE 2013 | FONDAMENTALE | 25
TERAPIE
Interrompere le cure
RIFIUTO TERAPEUTICO
SE IL PAZIENTE NON VUOLE
osa accade se è il paziente a voler sospendere le cure? La
legge attuale prevede che se una persona è capace di
intendere e di volere (e di esprimere il proprio parere), il
medico non può imporre alcun trattamento, nemmeno quello
salvavita come la rianimazione.
Se però lo stesso paziente diventa incosciente o non è più in
grado di dire a che cosa acconsente, il medico è tenuto a
intervenire con ogni mezzo salvavita, anche se il malato è in
una fase terminale della sua malattia. Se l’intervento salvavita
(per esempio il collegamento a una macchina per sostenere la
respirazione) è già in atto, interromperlo, anche su esplicita
richiesta del malato, può esporre il medico all’arresto e a un
procedimento d’indagine.
Da molti anni si discute delle cosiddette direttive anticipate,
cioè di quei documenti (tra i quali vi è anche il testamento
biologico) in cui la persona esprime la propria volontà in
merito alle cure (non solo quelle salvavita o terminali)
nell’eventualità in cui non sia più in grado di esprimersi. Tali
documenti possono essere presi in considerazione dal medico
(sempre che questo ne venga a conoscenza) ma non sono
vincolanti, come invece accade in altri Paesi. In sostanza la
scelta resta nelle mani del curante.
C
persona. Nessuno di questi
metodi si è però rivelato davvero efficace nel prevedere
con ragionevole certezza la
sopravvivenza e quindi l’utilità di continuare con le chemioterapie.
“La maggior parte delle
linee guida in materia ha
usato un sistema empirico”
spiega ancora Braga nel suo
lavoro. “Dopo che tre diverse
linee di terapia sono fallite, è
molto improbabile che la
quarta funzioni, a meno che
non si tratti di un farmaco del
tutto nuovo o sperimentale”.
Anche a questa regola, però, ci
sono eccezioni, come per
esempio nel caso dei tumori
del seno HER-2 positivi, che
possono rispondere anche a
diversi tipi di sostanze.
LA VOLONTÀ DEL SINGOLO
Esiste una domanda cardi-
26 | FONDAMENTALE | OTTOBRE 2013
ne, che dovrebbe stare al
centro della decisione,
come spiega Stein Kaasa,
esperto di cure palliative dell’Università di Trondheim, in
Norvegia, in uno speciale dedicato proprio al tema delle
cure inutili pubblicato su
Cancer News, la rivista della
European School of Oncology: cosa vuole il paziente?
Vi sono infatti importanti differenze culturali anche tra i
pazienti e desideri diametralmente opposti. C’è chi vuol
tentare sempre il tutto e per
tutto e chi preferisce lasciar
perdere e affidarsi alle sole
cure palliative. “Anche negli
hospice e nei centri di palliazione si usa la chemioterapia,
ma con combinazioni e dosaggi diversi da quelli della
fase di cura” spiega Kaasa. Alcuni chemioterapici, infatti,
possono essere utili anche
contro il dolore, come
per esempio
il 5-fluorouracile nei tumori solidi. “Bisogna però essere certi che il dolore non
possa essere controllato con
farmaci più semplici e più gestibili” continua Kaasa.
sono le diverse opzioni e
che cosa ci si può ragionevolmente attendere da ciascuna di esse. Non è vero
che i malati e i familiari non
sono in grado di affrontare
questo tipo di comunicazioni: spesso è il medico che
non sa come trasmetterle in
modo empatico ed efficace”.
E infatti uno studio britannico pubblicato nel 2008
sulla rivista JAMA afferma
che solo il 39 per cento dei
pazienti ha discusso la prognosi con il proprio medico,
mentre tra i ricoverati in un
grande hospice solo il 39
per cento dei malati e il 62
per cento dei familiari riferisce di aver
discusso
della gestione degli ultimi momenti
della vita
con un medico o uno psicologo. E proprio i familiari giocano un
ruolo importante, perché vi
possono essere conflitti tra
di loro o tra la loro visione e
quella del paziente, che
deve comunque sempre prevalere, anche se questo
complica la gestione del
caso.
Alla fine, secondo Stein
Kaasa, la soluzione per una
gestione ottimale degli ultimi momenti di vita non è
molto diversa da quella che
si usa per curare e guarire: si
deve puntare a una medicina personalizzata, perché
nessuna cura è inutile se il
paziente la sceglie e la desidera, mentre tutte sono inutili se il paziente preferisce
un approccio meno invasivo
che lo lasci tornare, finché
possibile, alle sue attività e
relazioni familiari.
La soluzione
è una gestione
condivisa
delle cure
IMPARARE A COMUNICARE
Quello che manca, in Italia, è una cultura della condivisione della decisione e
l’abitudine a parlare apertamente di quelle che vengono chiamate decisioni di
fine vita, come spiega Egidio
Moja, docente di psicologia
clinica all’Università degli
studi di Milano. “Esistono
delle linee guida, e delle tecniche precise, per la gestione di colloqui così delicati e
particolari” spiega. “Bisogna
che i medici abbiano tempo,
scelgano un luogo appartato
dove non verranno disturbati e siano pronti a spiegare,
per quanto possibile, quali