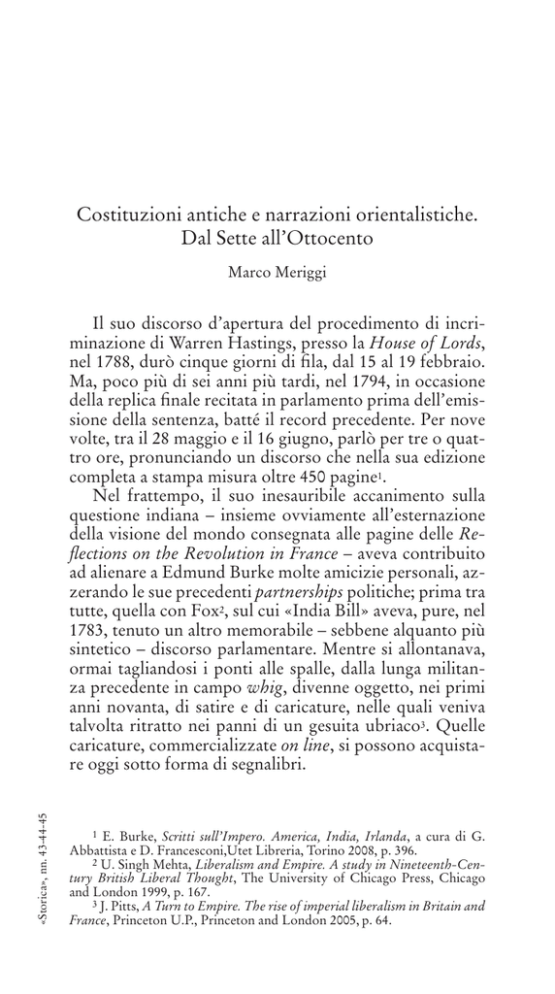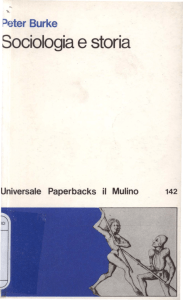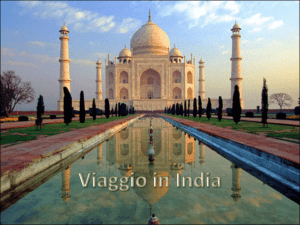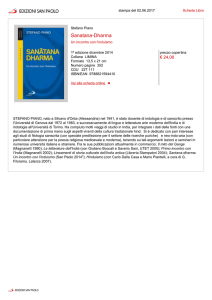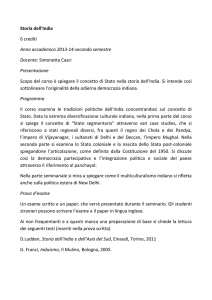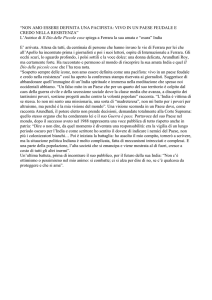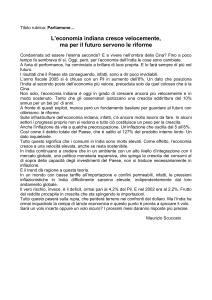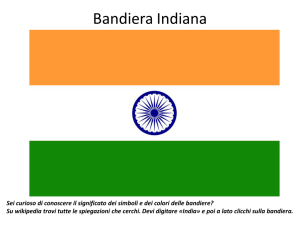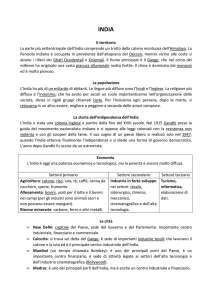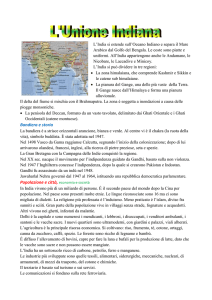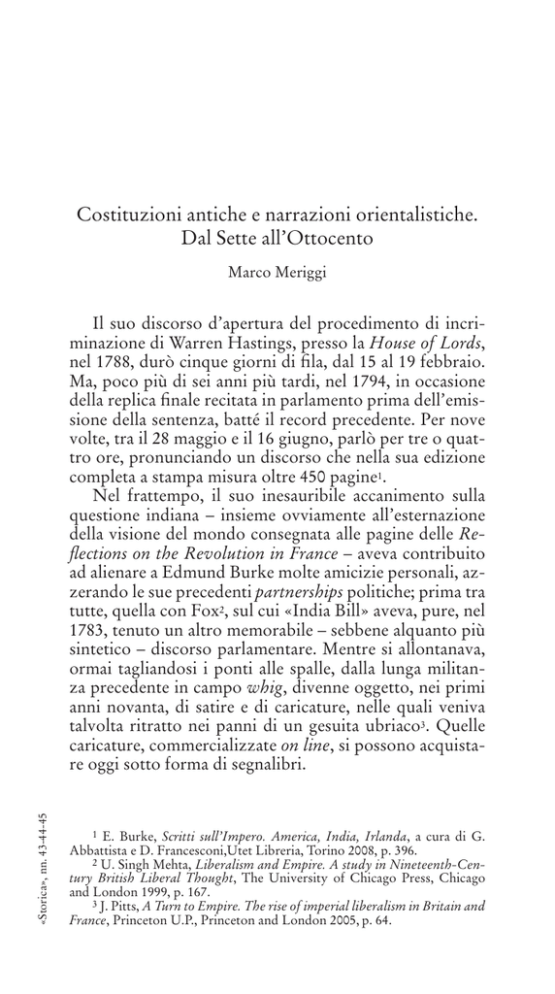
Costituzioni antiche e narrazioni orientalistiche.
Dal Sette all’Ottocento
Marco Meriggi
«Storica», nn. 43-44-45
Il suo discorso d’apertura del procedimento di incriminazione di Warren Hastings, presso la House of Lords,
nel 1788, durò cinque giorni di fila, dal 15 al 19 febbraio.
Ma, poco più di sei anni più tardi, nel 1794, in occasione
della replica finale recitata in parlamento prima dell’emissione della sentenza, batté il record precedente. Per nove
volte, tra il 28 maggio e il 16 giugno, parlò per tre o quattro ore, pronunciando un discorso che nella sua edizione
completa a stampa misura oltre 450 pagine1.
Nel frattempo, il suo inesauribile accanimento sulla
questione indiana – insieme ovviamente all’esternazione
della visione del mondo consegnata alle pagine delle Reflections on the Revolution in France – aveva contribuito
ad alienare a Edmund Burke molte amicizie personali, azzerando le sue precedenti partnerships politiche; prima tra
tutte, quella con Fox2, sul cui «India Bill» aveva, pure, nel
1783, tenuto un altro memorabile – sebbene alquanto più
sintetico – discorso parlamentare. Mentre si allontanava,
ormai tagliandosi i ponti alle spalle, dalla lunga militanza precedente in campo whig, divenne oggetto, nei primi
anni novanta, di satire e di caricature, nelle quali veniva
talvolta ritratto nei panni di un gesuita ubriaco3. Quelle
caricature, commercializzate on line, si possono acquistare oggi sotto forma di segnalibri.
1 E. Burke, Scritti sull’Impero. America, India, Irlanda, a cura di G.
Abbattista e D. Francesconi,Utet Libreria, Torino 2008, p. 396.
2 U. Singh Mehta, Liberalism and Empire. A study in Nineteenth-Century British Liberal Thought, The University of Chicago Press, Chicago
and London 1999, p. 167.
3 J. Pitts, A Turn to Empire. The rise of imperial liberalism in Britain and
France, Princeton U.P., Princeton and London 2005, p. 64.
210
Storica
Al disagio che veniva provando per il sarcasmo riservatogli in parlamento – dove, tra i Commons, sedeva da
quasi tre decenni, essendone entrato a far parte nel 1766
– si aggiunse nel 1794 l’amarezza per la sentenza che vanificò le aspettative che Burke aveva per tanti anni coltivato. Non solo Hastings risultò assolto dalle accuse per le
quali l’oratore irlandese ne aveva chiesto l’impeachment,
ma venne anche gratificato dalla Compagnia delle Indie
orientali di una robusta pensione per i servizi svolti nel
subcontinente tra il 1772 e il 1785. Burke si sarebbe spento pochi anni più tardi, nel 1797. In seguito, fin quasi ai
giorni nostri (ed in Italia, soprattutto) sarebbe stato ricordato prevalentemente come il più corrosivo tra i detrattori britannici della Rivoluzione francese, e come uno dei
padri fondatori del moderno pensiero conservatore. Ma,
come cercheremo di mostrare, le Reflections (e, con esse,
la sua interpretazione di una vicenda apparentemente tutta europea) avevano rappresentato nella parabola del suo
pensiero il punto d’approdo di un percorso molto più risalente e ricco di sfumature, che negli ultimi lustri – auspice soprattutto la crisi dell’eurocentrismo storiografico – è
tornato a suscitare un interesse tutt’altro che rapsodico.
Va ricordato che la maggior parte degli scritti politici di
Burke – e si tratta di migliaia di pagine – è dedicata all’India4; ed è sforzandosi di interpretare le vicende occorse
nella seconda metà del secolo in quel Paese lontano che
egli venne affinando alcune delle categorie di lettura che
avrebbe riproposto nel 1790 nelle Reflections.
Per quanto ridotta all’osso, una cronaca degli antefatti delle battaglie parlamentari sulle quali ci apprestiamo a
soffermarci pare indispensabile.
1. Il tramonto dei moghul e il nuovo impero inglese
In seguito alla morte dell’imperatore Aurangzeb, nel
1707, ma in misura drammatica a partire dai tardi anni
trenta del Settecento, dopo il saccheggio di Delhi effettuato dal sovrano persiano Nadir Shah, l’impero moghul,
che dal Cinquecento dominava il panorama politico del
subcontinente indiano, precipitò in una fase di rapido e ir4 Mehta,
Liberalism cit., p. 166.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
211
reversibile declino. Ne scaturì la formazione di un sistema
policentrico di stati territoriali virtualmente emancipati
dalla subordinazione al governo di Delhi (tra i principali:
la confederazione Maratta, i territori del nawab di Arcot e
di quello del Carnatico, i domini del nizam di Hyderabad,
il regno del Mysore), sui quali sia la Compagnia inglese
sia quella francese delle Indie orientali, presenti nell’area
dal Seicento, cercarono immediatamente di proiettare la
propria influenza. Il che le portò a entrare in acceso conflitto armato l’una contro l’altra. La guerra dei Sette Anni
(1756-63) ebbe in India uno dei suoi scenari più importanti, e la vinsero gli inglesi.
Dalla vittoria riportata sulla rivale francese la Compagnia inglese uscì profondamente trasformata nella sua
struttura. Era divenuta di fatto, negli anni precedenti, una
vera e propria potenza militare, assoldando al proprio servizio militi provenienti dalle caste guerriere del Paese, e
all’originario profilo mercantile venne ora affiancando una
sempre più pervasiva caratterizzazione politico-istituzionale. Nel 1764, con il trattato di Allahabad, l’imperatore
moghul, tenuto in pugno dai britannici che gli facevano
credito a singhiozzo, si risolse a concedere loro – dietro la
promessa di un compenso che ben presto non gli venne più
corrisposto – il diwani del Bengala, di Bihar e di Orissa:
ovvero l’amministrazione civile, inclusa la titolarità delle
funzioni di prelievo fiscale, di una popolazione di alcune
decine di milioni di persone5. La Compagnia si trasformò così in un «vero e proprio agente di governo, dotato
di enormi poteri di carattere politico e amministrativo»6.
Quella che era stata sin lì soprattutto una corporation di
grandi operatori commerciali divenne di fatto la titolare di
una funzione compiutamente pubblica. Ma di quale stato? E in base a quale forma di ordinamento?
Lo statuto della Compagnia ne sanciva la dipendenza – ancorché assai mediata – dalla corona britannica.
Ma a consegnare ad essa le chiavi del governo territoriale
dell’India nord-orientale, per quanto obtorto collo, era stato l’imperatore moghul. All’ambiguità di questa situazione il governo britannico cercò di rimediare nel 1777 con
5 Per queste notizie cfr. sia M. Torri, Storia dell’India, Laterza, RomaBari 2000, pp. 317-54, che N. Ferguson, Impero. Come la Gran Bretagna ha
fatto il mondo moderno, Mondadori, Milano 2007, pp. 38-47.
6 Cfr. Scritti sull’Impero cit., p. 235.
212
Storica
il Regulating Act. Vi si formalizzava la funzione marcatamente pubblicistica inerente alla carica di governatore del
Bengala (pur sempre designato dagli azionisti della Compagnia), affiancando però a questa figura un Consiglio di
quattro membri di designazione governativa, dei quali in
teoria il governatore avrebbe dovuto essere il semplice
braccio operativo. Consiglio e governatore erano pensati
come responsabili di fronte al parlamento di Londra7.
Si trattava della risposta istituzionale alla situazione
di fatto creatasi con la metamorfosi della Compagnia da
corporazione mercantile ad agenzia di potere territoriale. Essa era tesa a incorporare all’interno del sistema costituzionale britannico l’inedita trasformazione in senso
statuale della presenza inglese in India. Ma, nel corso del
proprio mandato, Hastings, che fu governatore del Bengala dal 1772 e governatore generale dei territori britannici nel subcontinente indiano dal 1774 al 1785, si emancipò
in modo sostanziale dal controllo del Consiglio delegato
dal governo a orientarne l’attività e, a partire dai primi
anni ottanta, il suo operato cominciò a suscitare la sempre
più indignata attenzione di alcune fazioni del parlamento.
Queste, forti delle testimonianze intorno alla deriva del
governatorato Hastings rilasciate in particolare da uno dei
membri del Consiglio che l’affiancava in India, ottennero l’istituzione, tra il 1781 e il 1782, di due commissioni
d’inchiesta, incaricate di vagliare la legittimità dei modi
dell’amministrazione del governatore in quei lontani Paesi che cominciavano ormai ad essere percepiti come parti a
pieno titolo del nuovo impero territoriale britannico.
Alla fine del 1783 il governo di coalizione Fox-North,
di cui Burke era sostenitore, presentò un «decreto di riforma del governo dell’India finalizzato a correggere gli abusi di potere compiuti dalla Compagnia delle Indie Orientali [...] e a ridimensionarne l’esercizio di poteri sovrani»8
attraverso il trasferimento a due commissioni di nomina
parlamentare dei poteri dei direttori e degli azionisti della
Compagnia. Approvato dai Commons, il decreto venne
tuttavia bocciato in sede di Camera dei Lords e il suo naufragio coincise con quello del breve governo Fox-North
7 R. Travers, Ideology and Empire in Eighteenth-Century India. The
British in Bengal, Cambridge U.P., Cambridge 2007, p. 36.
8 Scritti sull’impero cit., p. 285.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
213
(aprile-dicembre 1783), che l’aveva espresso. Un anno più
tardi, l’India Act di Pitt, titolare del nuovo governo, recepì però comunque in modo sostanziale le critiche sollevate negli anni precedenti nei confronti del governatorato
Hastings e stabilì un più stretto ed efficace vincolo di dipendenza gerarchica tra Londra e l’amministrazione esercitata in India dalla Compagnia. Rispetto alla proposta
formalizzata l’anno precedente da Fox, la differenza stava
essenzialmente nell’attribuzione al governo e alla corona
(e non al Parlamento) dei poteri di indirizzo e di controllo
del governatorato di Calcutta.
Il suo ingresso ufficiale in campo a proposito di temi
connessi alla nuova natura di quello che – mentre perdeva un’America di coloni e acquistava un India di sudditi
– veniva operando la propria metamorfosi in un impero
territoriale vero e proprio, Burke lo fece in occasione
dell’insediamento della commissione incaricata nel 1782
di effettuare un’inchiesta sull’amministrazione anglo-indiana, fornendo un contributo sostanziale all’elaborazione degli undici rapporti prodotti in quella sede; dell’India,
del resto, si interessava attivamente già da qualche anno.
Poi, nel dicembre 1783, tenne alla Camera un importante discorso sull’India Bill proposto da Fox (che egli aveva d’altro canto in gran parte materialmente redatto). Vi
espose con determinazione la propria convinzione che il
governo di un Paese tanto vasto e tanto ricco di popolazioni, di tradizioni e di culture istituzionali così diverse da
quelle inglesi non potesse rimanere ulteriormente consegnato nelle mani di quella che si configurava pur sempre
essenzialmente come una corporazione privata, traendone l’implicita legittimazione ad operare – malgrado la trasformazione in senso pubblicistico derivatale dall’assunzione del diwani – con assoluta discrezionalità ed arbitrio
nei territori di propria pertinenza.
Tre anni più tardi Burke, che nel frattempo si era talmente appassionato allo studio della questione indiana
da guadagnarsi la fama di uno dei maggiori esperti del
subcontinente residenti sul suolo britannico, dette avvio
a una campagna per l’impeachment di Hastings, che era
tornato l’anno prima dal Bengala. Dopo altri due anni,
esaurite le procedure formali preliminari, il procedimento
di incriminazione dell’ex-governatore venne ufficialmente aperto presso la Camera dei Lords. Sarebbe durato dal
214
Storica
febbraio 1788 all’aprile 1795, impegnando, in quegli oltre
sette anni, in tutto 149 giorni di sedute.
2. Hastings secondo Burke: un dispotismo occidentale
Vario e composito si presentava il quadro dei «gravi
crimini e misfatti» di cui Burke accusava Hastings, anche se in sostanza li si poteva condensare nella cifra della
spregiudicatezza con la quale si era rapportato alla selva delle giurisdizioni e dei potentati territoriali grandi e
piccoli che componevano il mondo poliedrico dell’India
tardo-moghul9. Ad ogni buon conto, nell’addentrarci nelle ragioni della sua battaglia, rinunceremo deliberatamente ad indugiare su molti dei dettagli che egli venne man
mano precisando nel corso della maratona parlamentare
di quegli anni; né, d’altro canto, ci interessa qui accordare un’attenzione più che rapsodica al tema degli interessi patrimoniali personali di Burke in India, i quali, pure,
giocarono certamente un ruolo importante se non altro
nella fase iniziale del suo impegno di riflessione polemica
sull’argomento. Piuttosto, ci piace, in sintonia con quanto
ha fatto una letteratura che in anni recenti ha man mano
aggiunto nuovi capitoli alla storia del Burke «indiano»10,
fissare l’attenzione su un tema che la percorre in lungo e
in largo: quello del dispotismo.
9 Per il dettaglio delle accuse si veda ivi, p. 353; ma anche Ferguson,
Impero cit., p. 55. In sintesi: comportamento sleale e mendace nei confronti
dell’imperatore moghul; uso spregiudicato della corruzione attiva e passiva
nel rapporto con il mondo dei «piccoli principi» indiani; indebito sostegno
militare accordato all’uno o all’altro dei contendenti locali, con conseguente
turbativa degli equilibri interstatali del subcontinente; esercizio dissennato
e predatorio della fiscalità nel Bengala, abbinato al sistematico misconoscimento dei diritti tradizionali fruiti dalle aristocrazie territoriali; rifiuto, infine di obbedire prontamente all’ordine di dimettersi che gli era stato inviato
da Londra.
10 Oltre alle già citate opere di Mehta, Pitts, Travers, Abbattista-Francesconi, penso, in particolare, a F.G. Whelan, Edmund Burke and India:
Political Morality and Empire, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh
1996 e, in ambito italiano, a D. Buonfiglio, La questione indiana nel pensiero
politico di Edmund Burke, Franco Angeli, Milano 2008. Agli scritti indiani
di Burke ha dedicato un capitolo anche il recentissimo studio di M. Curtis,
Orientalism and Islam. European Thinkers on Oriental Despotism in the
Middle East and India, Cambridge U.P., Cambridge-New York 2009, pp.
103-38, il quale, per altro, ignora la letteratura sopra citata. La ricostruzione di Curtis ripropone sostanzialmente il punto di vista di Hastings e pare
poco aggiornata anche sul piano dei riferimenti agli studi sul sistema istituzionale moghul.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
215
Come è stato a più riprese sottolineato da pressoché
tutti gli autori che abbiamo poc’anzi citato, nella critica
rivolta ad Hastings da parte di Burke si celava certamente
anche uno spiccato pregiudizio antimercantile, fondato
sul presupposto dell’incongruenza dell’esercizio della sovranità politica da parte di una corporazione privata. Nel
1764, assumendo il diwani del Bengala, la Compagnia si
era trasformata – qualcuno ha osservato – in una bizzarra
contaminazione tra «the merchant-sovereign and the sovereign-merchant»11. Era questo, del resto, il retropensiero che induceva Burke a condensare nell’immagine della
rapacità la sua interpretazione delle finalità del governatorato Hastings e dei modi del suo esercizio della funzione
di prelievo fiscale. Ma, se il soddisfacimento di uno spirito
di rapina (e la conseguente sconsiderata spoliazione delle ricchezze di un Paese affabulato come ricco e fiorente nel «buon tempo antico» e ora viceversa ridotto alla
fame e indotto a continue sommosse dalla cura tributaria
del governatore) rappresentava nei suoi ragionamenti la
stella polare dell’operato di Hastings, a destare l’indignato sconcerto del pensatore irlandese erano soprattutto le
modalità istituzionali attraverso le quali egli l’aveva perseguito. Per Burke, infatti, esse si collocavano nel solco del
dispotismo e risultavano dunque agli antipodi rispetto alle
tradizioni costituzionali inglesi, così come esse erano venute prendendo forma nel lungo tempo storico dischiuso
dall’emanazione della Magna Charta e rivitalizzato dai rivolgimenti seicenteschi. Per Burke, il quale aveva avviato
la sua carriera politica tra i whig di Rockingham e che si
attestava da tempo su una posizione molto critica nei confronti della prerogativa regia, il centro indiscusso del sistema costituzionale – l’emblema della cittadinanza e della
nazione e la garanzia contro ogni deriva autoritaria – era il
Parlamento. Perché, dunque, nei territori dell’India divenuti surrettiziamente inglesi dopo l’assunzione del diwani
da parte della Compagnia il pubblico potere veniva esercitato senza che Commons e Lords potessero sindacarne la
gestione e senza alcun riguardo né per le forme del diritto
11 Travers, Liberalism cit., p. 45. Anche Adam Smith nel suo saggio La
ricchezza delle nazioni segnalava l’implausibilità della condizione ancipite
derivante a una corporazione commerciale dall’esercizio di una funzione
pubblica. Cfr. Buonfiglio, La questione indiana cit., p. 35.
216
Storica
britannico né per quelle tradizionalmente vigenti in loco
prima del 1764?
Per giustificare le modalità di esercizio di un potere
che svolgeva i propri compiti amministrativi ricorrendo
a un protocollo di matrice sostanzialmente autocratica e
militare, Hastings aveva fatto ricorso per un verso all’evocazione dello stato di eccezione (la cui incombenza in un
Paese così lontano e problematico ne poteva giustificare
l’esenzione dai meccanismi di controllo costituzionale
previsti per lo spazio metropolitano), per l’altro a una legittimazione dotta e autorevole, ovvero a quella categoria
di dispotismo orientale che, a partire dalla formalizzazione teorica offertane da Montesquieu nell’Esprit des lois,
costituiva uno dei possibili – non l’esclusivo – modi di
lettura dell’alterità asiatica nella cultura europea del Settecento12. Il ragionamento era il seguente: dal momento che
le popolazioni dell’India non avevano conosciuto, nella
loro storia, altre forme di esercizio del potere che quelle
dispotiche, nel ricevere il testimone del comando da parte
del governo moghul i merchants della Compagnia trasformati in sovereigns non potevano fare altro che riproporle,
visto che esse irradiavano l’unico linguaggio comprensibile alle orecchie di un popolo per il quale era naturale
rapportarsi all’autorità dalla prospettiva della sudditanza
pura e semplice. Quel che valeva in Gran Bretagna, perdeva in altre parole di senso e di pregnanza in un Paese
sfibrato, superstizioso e corrotto, oltre che ignaro dello
spirito di libertà incarnato dalle istituzioni di cui gli inglesi andavano legittimamente fieri in patria; così che, in
un contesto tanto degradato e corrotto come quello del
Paese retto dai lontani eredi di Tamerlano, era gioco-forza che ci si adattasse a governare con le stesse modalità
tiranniche radicate nelle consuetudini locali e a tollerare
l’aporia di un dispotismo esercitato da liberi13, sulla base
di una «moralità geografica» che a Burke pareva viceversa
inaccettabile14, dal momento che induceva a «spogliarsi di
12 F. Venturi, Despotismo orientale, in «Rivista storica italiana», LXXII, 1, 1960, pp. 117-26; ma anche J. Osterhammel, Die Entzauberung
Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert, Beck,
München 1998.
13 Mehta, Liberalism cit., p. 14.
14 Pitts, A turn to Empire cit., pp. 60-2.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
217
tutto quello che si è imparato in Europa per inaugurare un
nuovo ordine e un nuovo sistema di vita»15.
Si trattava di una delle possibili modalità di percezione del rapporto tra il governo della madre-patria e quello
di un oltremare culturalmente contraddistinto dal segno
dell’alterità, che avrebbe a lungo tenuto banco nella costruzione ideologica del colonialismo britannico moderno.
Non sorprenderà, in tal senso, che argomentazioni molto
simili a quelle esternate da Hastings in relazione all’India del secondo Settecento tornino a riproporsi a distanza
di oltre un secolo in un famoso discorso parlamentare di
Lord Balfour tenuto nel 1911 a proposito dell’Egitto16.
Anche Burke, come Hastings, attribuiva per altro nella
costruzione delle proprie categorie concettuali un rilievo
nevralgico alle teorie politiche di Montesquieu. Ma il fatto
è che, mentre il governatore del Bengala ne valorizzava
soprattutto le considerazioni intorno alla radicale alterità
(in senso deteriore) dei sistemi di potere asiatici rispetto a
quelli europei, l’oratore irlandese ne apprezzava, viceversa – in linea con la sua sensibilità politica whig – l’enfasi
sul ruolo essenziale dei corpi territoriali intermedi nel garantire tanto la salute morale e l’ordine sociale di un Paese, quanto un solido argine nei confronti di una eventuale
deriva in direzione tirannica dell’istituto monarchico. Al
tempo stesso, però, quest’ultimo si rifiutava di accordare
credibilità alla lettura in chiave unilateralmente dispotica
dei modi tradizionali di esercizio del potere in Oriente
proposta dall’autore dell’Esprit, sostenendo che essa si basava su fonti inattendibili, o comunque male interpretate,
o, ancora, manipolate per mezzo di una selezione maliziosa17. Burke, invece, il quale, pure, nei suoi primi scritti
di tema indiano aveva mostrato anch’egli di credere alla
teoria del dispotismo orientale, riteneva di disporre ora di
fonti alternative e più affidabili.
15 E. Burke, Discorso di apertura del procedimento di incriminazione di
Warren Hastings (15-19 febbraio 1788), in Scritti sull’Impero cit., p. 382.
16 Ne riporta ampi stralci E. Said, Orientalismo. L’immagine europea
dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 2002, p. 39. Cfr. anche M. Meriggi, L’Europa dall’Otto al Novecento, Carocci, Roma 2006, p. 151.
17 Osterhammel, Die Entzauberung cit., pp. 275-84 sviluppa una pregevole analisi delle fonti delle quali si era servito Montesquieu e dei modi della
sua lettura delle stesse.
218
Storica
3. Alla ricerca della costituzione indiana
A sostanziare la narrazione del dispotismo orientale
proposta da Montesquieu – argomentava l’autore delle
Reflections – erano state due convinzioni erronee: quella relativa all’inesistenza di leggi codificate e di «check
and balances» costituzionali nei sistemi di potere asiatici
e quella della natura tutta patrimoniale delle monarchie
d’Oriente, con il relativo corollario in termini di assenza
dell’istituto della proprietà fondiaria privata e dunque di
impossibilità di trasmettere ereditariamente quest’ultima.
Come a dire: insignificanza tanto dei corpi quanto degli
individui, e dei diritti che nella coeva Europa risultavano
agli uni e agli altri variamente correlati, a fronte della supposta latitudinaria arbitrarietà di un potere in ostaggio alle
capricciose fantasie del despota di turno18. Era un equivoco il cui radicamento, specie nella cultura francese, risaliva
a un’opera tardo seicentesca di François Bernier19, medico
avventuriero la cui vita s’era spesa tra la corte moghul di
Aurangzeb e quella borbonica di Luigi XIV. Ma nel frattempo un autore come Anquetil-Duperron, uno dei primi orientalisti moderni in senso proprio20, aveva portato,
grazie alla sua Legislation orientale, vigorosi argomenti
e fresche conoscenze contro la lettura «despoteggiante»
dell’Oriente proposta da Bernier e ripresa da Montesquieu, oltre a scagliare acuminati strali polemici contro
l’«uso proditorio» delle generalizzazioni di quest’ultimo
da parte inglese al fine di giustificare l’operato della Compagnia delle Indie21. Burke, a quanto pare, non conobbe
l’opera di Anquetil-Duperron22; egli si servì però largamente dei materiali di studio e delle elaborazioni offerte
18 Sulla questione cfr. l’ampio studio di R. Minuti, Proprietà della terra
e despotismo orientale: aspetti di un dibattito sull’India nella seconda metà
del Settecento, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», VIII, 2,
1978, pp. 29-177.
19 F. Bernier, Histoire de la derniere revolution des estats du Grand Mogul, chez Claude Barbin, Paris 1671, tome I, pp. 166-200.
20 Su di lui cfr. l’Introduzione di G. Abbattista a A.H. Anquetil-Duperron, Considérations philosophiques historiques et géographiques sur les deux
mondes (1780-1804), a cura di G. Abbattista, Scuola Normale Superiore,
Pisa 1993.
21 Ivi, in particolare p. XXVI, dove vengono esposti i temi principali
della Legislation orientale.
22 La lessero, la conobbero, la apprezzarono, però, altri in Gran Bretagna, come documenta Venturi in Despotismo orientale cit., pp. 122-5.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
219
da Philip Francis, per qualche anno membro del Consiglio posto a fianco di Hastings in Bengala, che aveva fatto
ritorno in patria dopo aver cercato vanamente di arginare la deriva dispotica del governatorato e che durante gli
anni trascorsi nel subcontinente aveva messo a punto una
interpretazione tutta diversa dei modi del potere e della
società moghul. Secondo Francis non solo in Bengala si
dava la presenza di una proprietà fondiaria privata sostanzialmente paragonabile a quella esistente in Gran Bretagna, ma la regione, non diversamente dai Paesi europei
coevi, godeva, prima che avesse inizio l’esercizio del diwani da parte della Compagnia, dei benefici di una «venerabile antica costituzione»23, consegnata alla tutela di una
virtuale aristocrazia ereditaria di proprietari fondiari (gli
zamindar) che Bernier non era stato capace di riconoscere
in quanto tale, misconoscendone i diritti sostanziali, ed
offrendo così a Montesquieu argomenti per la sua teorizzazione dell’Oriente come dispotismo, di cui a sua volta
Hastings si serviva per schiacciare il Paese sotto il tallone
della tirannide.
Si trattava, certo, di una costituzione difficile da comprendere e forse ancora più da raccontare a un pubblico
come quello europeo, se non attraverso il gioco incrociato
delle metafore e delle analogie. Cediamo, a questo proposito, la parola a Burke, che nel suo discorso del 1783
sull’India Bill di Fox, dopo aver ricordato come negli immensi territori del subcontinente governati direttamente
dalla Compagnia vivessero oltre «trenta milioni di esseri
umani»24 (ovvero il quadruplo della popolazione britannica del tempo), ne raccomandava l’immediata sottrazione a
un dominio che da qualche lustro veniva esercitato in totale assenza di garanzie legali. Era invece urgente portare
in India un governo basato su «sicurezza e protezione»;
ed in tal senso il decreto Fox e «i suoi collegati» erano da
intendere come un tentativo di messa a punto di una sorta
di «Magna Charta dell’Indostan»; un equivalente di ciò
che la «Petizione del diritto e la Dichiarazione dei diritti»
23 Travers, Liberalism cit., p. 151. Ma cfr., per altre puntualizzazioni,
anche le pp. 167, 171 e 174.
24 E. Burke, Discorso sull’“India Bill” di Fox (1 dicembre 1783), in Scritti
sull’Impero cit., p. 281.
220
Storica
(rispettivamente del 1628 e del 1689) «hanno significato
per la Gran Bretagna»25.
La popolazione indiana, infatti, non era paragonabile,
come avrebbe voluto Hastings per giustificare il proprio
dispotismo, a una «plebe abietta e barbara», o a un’accozzaglia di selvaggi «come i Guarani o i Chiquito che vagano lungo i desolati confini del Rio delle Amazzoni o del
Rio de la Plata. Sono, invece, da molto tempo un popolo
civilizzato e raffinato, raffinato da tutte le arti della vita
civile già all’epoca in cui noi vivevamo nei boschi»26.
Ancora: «Lì è presente una nobiltà molto antica e rinomata». E, insieme ad essa, una costituzione le cui funzioni,
pur se a prezzo di uno spericolato esercizio di contestualizzazione, potevano venire secondo Burke avvicinate a
quelle che, in forme diverse, nel continente europeo garantivano istituzionalmente modalità negoziali e pattizie
di irrogazione dell’autorità politica:
Se dovessi prendere in considerazione l’intero aggregato
dei nostri possedimenti indiani, lo comparerei con l’impero di
Germania, cioè il termine di paragone più simile cui riesco a
pensare. I nostri possedimenti diretti invece li comparerei coi
domini austriaci, senza che questi possano risentire del paragone. Il Nababbo dell’Oude potrebbe far la parte del re di Prussia,
mentre il Nababbo di Arcot [...] lo paragonerei all’Elettore di
Sassonia. Il Rajah di Benares [...] potrebbe benissimo restare alla
pari almeno con il principe di Hesse, mentre il Rajah di Tanjore
è all’altezza dell’elettore di Baviera.
E, ancora, passando dal livello dei quasi-sovrani locali
ai quali l’impero moghul riconosceva una dignità federati-
25 Ivi p. 283. Per quello che riguarda, più in generale, la riflessione di
Burke sul tema della ancient Constitution all’interno dello stesso modello
britannico, cfr. naturalmente J.G.A. Pocock, Burke and the Ancient Constitution. A problem in the History of ideas, in «The Historical Journal», III,
2, 1960, pp. 125-43, ora anche in Id., Politics, Language, and Time: essays on
political Thought and History, University of Chicago Press, Chicago 1989,
pp. 202-31.
26 Ivi, p. 285. Sui precedenti del nesso civiltà/barbarie nell’immaginario
coloniale della prima età moderna e sui fondamenti aristotelici di questi, cfr.
A. Pagden, La caduta dell’uomo naturale. L’Indiano d’America e le origini
dell’etnologia comparata, Einaudi, Torino 1989. Sulla triade civiltà/barbarie/
stato selvaggio nella riflessione europea settecentesca cfr. invece Id., Lords
of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500-c.
1800, Yale U.P., New Haven and London 1995, pp. 162-6 (trad. it. Signori
del mondo. Ideologie dell’Impero in Spagna, Gran Bretagna, Francia 15001800, il Mulino, Bologna 2008) e Osterhammel, Die Entzauberung cit., pp.
235-46.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
221
vo-consociata a quello delle quasi-aristocrazie territoriali
tanto di religione indu quanto di fede musulmana:
I polyagar e gli zamindar del Nord, assieme ad altri grandi
capi, potrebbero benissimo equivalere al resto dei principi, duchi, conti, marchesi e vescovi dell’impero [...]. Si tratta di un impero di tale dimensione, di tale complicata natura e di tale dignità
e importanza che non a caso l’ho paragonato alla Germania e al
governo tedesco; non perché vi sia un’esatta rassomiglianza, ma
perché esso servisse da termine medio attraverso il quale avvicinare l’India alla nostra capacità di comprensione, e se possibile
ai nostri sentimenti, al fine di risvegliare una qualche simpatia
per gli sfortunati nativi, al cui destino temo che non saremo mai
sensibili finché continueremo a guardare questo oggetto così remoto attraverso un filtro fallace e nebuloso27.
Dunque, «avvicinare l’India alle nostre capacità di
comprensione». È soprattutto all’enucleazione delle strategie concettuali messe a punto da Burke per conseguire questo obiettivo che sono dedicati lo studio di Uday
Singh Mehta e quello di Jennifer Pitts, nei quali, per altro, la peculiarità della posizione dell’irlandese viene fatta
risaltare su uno sfondo più vasto, coincidente con la vicenda intera del pensiero imperiale britannico (Mehta) e
anche francese (Pitts) tra la metà del Settecento e la metà
dell’Ottocento28. Vi viene delineato un orizzonte dominato soprattutto da un problema: quello dell’assenza di
familiarità (unfamiliarity) dei pensatori liberali rispetto
ai modi di organizzazione politica delle civiltà precipitate nel campo di gravitazione del governo britannico in
seguito all’epifania di una sin lì inedita dimensione imperiale della presenza inglese in India. Ma si trattava al
tempo stesso, si può aggiungere, di un senso di disagio e di
smarrimento che una figura come Burke avvertiva anche
in relazione alla metamorfosi che l’esercizio del governo
che gli era familiare – la ancient Constitution britannica
– veniva conoscendo attraverso i processi di imperializzazione settecenteschi.
Confrontarsi con il diverso e imparare a riconoscerne i
tratti di affinità sostanziale rispetto al familiare, al di sotto del bagliore irradiato dal caleidoscopio pittoresco delle
differenze e delle peculiarità civili e religiose; sulla base
di questo presupposto, restituire dignità e considerazio-
27 Burke, Discorso sull’“India Bill” cit., pp. 285-6.
28 Mehta, Liberalism cit.; Pitts, A turn to Empire cit.
222
Storica
ne – oltre che, più prosaicamente, un governo mite – a
un «popolo civilizzato e raffinato» ricco di una tradizione
molto più antica e venerabile di quella britannica ed ora
colpevolmente bollato di barbarie dal merchant divenuto sovereign: la riflessione di Burke si sviluppò a partire
da questi punti fermi, nonché dall’assunzione preliminare
della nozione dell’universalità sostanziale del rule of law
sotto tutti i cieli del mondo.
Ai suoi occhi tutti i sistemi di ordinamento storicamente dati – in Europa come in Asia – possedevano in
realtà robusti anticorpi rispetto alla minaccia di un esercizio arbitrario del potere; e la legge di natura – «the law
of Humanity, Justice, Equity, the law of Nature and of
Nations»29 – non consisteva tanto in un «detailed set of
rules», ma piuttosto in un dispositivo consuetudinario
idoneo, in ragione di forme diverse a seconda delle civiltà
e delle culture, a favorire il rispetto da parte dei governanti di un corpo di obbligazioni morali nei confronti dei
sudditi30 e a indurre di conseguenza l’attivazione di modalità negoziali nel rapporto tra potere e comunità. Dunque,
non diversamente dalla Gran Bretagna, l’India moghul
una costituzione ce l’aveva: «In Asia as well as in Europe
the same Law of Nations prevails, the same principles are
continually resorted to. Asia is enlightened in that respect
as well as Europe»31. Si trattava, secondo Burke, di una
costituzione mista, nella quale elementi derivanti dal diritto islamico si intrecciavano con le forme di autorganizzazione gerarchica caratteristiche della società indu. Essa
faceva affidamento, in tal senso, tanto sulle leggi coraniche
(le quali statuivano il campo di obbligazioni dei regnanti
e le eventuali modalità di esercizio del diritto di resistenza a un potere ingiusto), quanto sui consolidamenti legali
formalizzati nel tempo da una genealogia di regnanti del
passato, fra i quali spiccavano i nomi di Gengis Khan, di
Tamerlano, di Akbar; tanto sul codice di Gentoo, la raccolta di consuetudini brahmaniche, di cui i progressi nella
conoscenza del sanscrito da poco avevano reso dispo-
29 Così Burke, nel suo discorso di replica tenuto nel 1794, cit. in Pitts,
A turn to Empire cit., p. 81.
30 Ivi, p. 82.
31 Ivi, p. 80.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
223
nibile una traduzione inglese32, quanto sulla «Common
Law or the Statute Law of this Kingdom»33; tanto sulle
funzioni negoziali e consultive esercitate dagli ‘ulama rispetto a un esercizio sovrano della giurisdizione confortato da una giusta interpretazione della lettera coranica34
quanto sul «buon governo» familiare e sull’attitudine a
proteggere i più deboli dispiegata dagli zamindar. Burke,
in particolare, intendeva questi ultimi, diversamente da
Hastings, non come semplici affittuari in balia ai capricci
dell’imperatore, bensì come figure accostabili a quelle dei
detentori ereditari di un potere signorile o semisignorile
in qualsiasi parte d’Europa; ovvero come un’aristocrazia
terriera, carica dello stesso carisma e del medesimo senso
di responsabilità nei confronti della comunità a essa subordinata di cui tradizionalmente l’aristocrazia europea
si faceva vanto, e, come questa, elemento indispensabile
per il buon ordine di una società organico-gerarchica, una
società, cioè, basata su un’autorità non «dispotica», ma
«affettiva»: «Men of great place, men of great rank [...]
cannot fall without an horrible crash upon all the others
that are about them. Such Towers cannot tumble without
the ruin of Cottages»35.
Torri e magioni: una società basata sui privilegi? Ma i
privilegi – per Burke come per Montesquieu – rappresentavano la garanzia di una costituzione, lo strumento idoneo «to chek the abuse of the subordinate Authority»36;
mentre i funzionari della Compagnia durante il dispotico
32 Quella di N. Halhed, Code of Gentoo Law, 1776. Cfr. Buonfiglio,
La questione indiana cit., p. 136. Anche Hastings, per la verità, la cui personalità è molto più complessa di quanto non risulti dal ritratto unilaterale
e sommario offertone da Burke, aveva mostrato di credere all’esistenza di
una antica costituzione brahmanica, preesistente al dominio moghul. Fu
lui, d’altro canto, a promuovere quell’attenzione alla cultura pre-persiana
nel subcontinente che si esplicitò non solo nella traduzione effettuata da
Halhed, ma anche, più in generale, nella promozione istituzionale dello studio del sanscrito, dal quale sarebbe scaturita l’«invenzione» della linguistica
indoeuropea da parte dell’orientalista William Jones, il quale lavorò per un
certo periodo a stretto contatto con Hastings. Per
����������������������������
una enucleazione più ampia di questo tema cfr. B.S. Cohn, Law and the Colonial State in India, in
Id., Colonialism and its forms of Knowledge: the British in India, Princeton
U.P., Princeton 1996, pp. 57-75.
33 Così Burke nel 1788, citato in Pitts, A turn to Empire cit., p. 81.
34 Per una descrizione generale del ruolo degli ‘ulam nei sistemi di potere di matrice musulmana cfr. G. Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, Torino 2002, pp. 239-45.
35 Burke (1794), citato in Pitts, A turn to Empire cit., p. 75.
36 Burke (1788), ivi, p. 66.
224
Storica
governatorato Hastings avevano dato vita alla mostruosità di «una nazione di impiegati. La Compagnia è una repubblica, una comunità politica, senza popolo; uno stato
di soli magistrati. La conseguenza è che manca un popolo
capace di controllare, di sorvegliare e di controbilanciare
il potere dei funzionari»37.
Ciò che, dunque, maggiormente sconcertava Burke
era l’autoreferenzialità del potere coloniale, non meno
che il livellamento, da quest’ultimo operato, delle gerarchie costituzionali e sociali storicamente consolidatesi su
un territorio la complessità delle cui caratteristiche civili
e culturali gli inglesi stavano appena cominciando a conoscere, man mano che l’impero mercantile «leggero» di
ieri si trasformava nell’impero di conquista e di dominio
del presente. Consisteva in questo, fondamentalmente, il
dispotismo di cui Burke accusava Hastings: l’assenza di
simpathy, ovvero di attenzione partecipata, rispetto ai valori di una costituzione antica, cancellata di colpo decapitandone le cuspidi naturali.
4. Costituzionalismo islamico e costituzionalismo indu
Sino a quel momento l’India istituzionale sulla quale
gli inglesi avevano ritenuto di documentarsi era stata soprattutto, se non esclusivamente, quella musulmana dei
sovrani moghul e dei livelli dell’amministrazione più vicini al potere centrale; la stessa India parlante persiano,
del resto, che anche Bernier aveva narrato e Montesquieu
a sua volta ripreso. La si considerava – così argomentava
Burke – dispotica; ma a torto. Infatti il diritto musulmano, non diversamente da quelli consuetudinari europei,
si basava anch’esso su modalità di esercizio intensamente
negoziali:
La maggior parte dell’Asia [...] è nelle mani di governi maomettani, e dire governi maomettani significa dire governi della
legge [...]. È una legge istituita da Dio, munita di una doppia
sanzione – giuridica e religiosa – rispetto alla quale nemmeno
il principe può derogare. Se qualcuno mi porterà il Corano e
mi mostrerà anche un solo passo che autorizzi un sia pur minimo potere arbitrario del governo, sarò pronto a riconoscere
37 Ibid. Ma qui utilizzo la traduzione italiana: Burke, Discorso di apertura (1788), in Scritti sull’Impero cit., p. 371.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
225
di aver letto invano quel libro e di aver invano studiato le vicende dell’Asia. In verità non si troverà lì nemmeno una sillaba
in questo senso; al contrario, gli oppressori conclamati sono
fulminati da ogni singola lettera di questa legge. Per spiegarla
ci sono interpreti, ossia il numeroso clero stabilito dappertutto
in Asia, che essi chiamano uomini di legge. Essi sono i custodi della legge: per consentirgli di tutelarla alla perfezione, essi
ricevono garanzie contro il risentimento dei sovrani, che non
possono toccarli.
E, spostandosi dal piano dell’enucleazione, all’interno
del Corano, di un diritto naturale del quale gli ‘ulama si
presentavano in tutto il mondo islamico come i virtuali
garanti costituzionali, a quello dell’evocazione di un caso
specifico ben più noto e familiare di quello moghul, anche se, come quest’ultimo, danneggiato presso l’opinione
pubblica europea da una «cattiva stampa» che a sua volta si
ispirava in modo preconcetto alle teorie di Montesquieu:
Il governo a noi vicino più simile a quelli di cui egli (Hastings) parla è il governo del Gran Signore, l’imperatore dei turchi. Dispone di un potere arbitrario? Ma se non ha nemmeno il
potere supremo del Paese! [...] Al Gran Signore manca la prima
caratteristica del potere sovrano, perché egli non può imporre
tasse al suo popolo. Un altro aspetto per il quale gli manca potere sovrano è che egli non può disporre della vita, della proprietà
o della libertà di alcun suo suddito se non tramite ciò che si
chiama fatwa, o sentenza giudiziaria: egli è tanto più rigorosamente sottomesso alla legge rispetto ai sovrani europei da non
poter decidere le guerre e le paci senza di essa. Dunque, non
potendo toccare la vita o la proprietà dei suoi sudditi, non potendo imporgli alcuna tassa, non potendo decidere le guerre e
le paci, lascio concludere alle loro signorie se questo, secondo i
principi di una simile costituzione, possa venir definito potere
arbitrario. (Il Gran Signore) è un sovrano maomettano, e non
esiste alcun maomettano che possa esercitare un potere arbitrario in alcun modo compatibile con la costituzione. Secondo la
costituzione di quel Paese, il magistrato che detiene il potere
esecutivo è anche la persona cui si applicano maggiormente le
catene della legge38.
38 Burke, Discorso di apertura (1788) in Scritti sull’Impero cit., pp.
388-90. Sull’istituto della fatwa e sulla figura del mufti, l’esperto in materia giuridica dotato della facoltà di emetterla, cfr. Vercellin, Istituzioni cit.,
pp. 305-7. Per una contestualizzazione delle modalità di lettura delle forme
istituzionali dell’Impero ottomano nel dibattito europeo del Settecento cfr.
A. Thomson, L’Europe des Lumières et le monde musulman: une altérité
ambiguë e R. Minuti, Tolleranza e Islam. Aspetti di un dibattito tra Seicento
e Settecento, entrambi in Le problème de l’altérité dans la culture européenne. Anthropologie, politique et religion aux XVIIIe et XIXe siècles, a cura
di G. Abbattista e R. Minuti, Bibliopolis, Napoli 2006, rispettivamente pp.
259-80 e pp. 195-217.
226
Storica
Anche in questo caso, l’operazione concettuale di
Burke passava per una tabula rasa preliminare delle fonti
occidentali canoniche sull’argomento; non solo Montesquieu, ma anche Robertson, la cui descrizione dell’impero ottomano era forse la più nota al pubblico britannico,
e dunque anche ai Lords che lo stavano ascoltando. Ma la
costituzione vigente in Bengala non si esauriva in un mero
ricalco di quella ottomana. E per smentire le tesi «dispotistiche» di Hastings, l’oratore irlandese iniziava a dipingere in tutta la gamma delle sue sfumature il ritratto di una
sorta di costituzione territoriale sociale brahmanica, preesistente al dominio moghul e a distanza di molti secoli dal
suo inizio pur sempre coesistente con esso. Burke:
Il Bengala e le province a esso unite sono più estesi del regno di Francia e un tempo contenevano, come anche la Francia
contiene, un interesse agrario vasto e indipendente, composto
da principi, grandi signori, una grande e piccola nobiltà molto
numerose, liberi proprietari, affittuari di rango inferiore, comunità religiose e fondazioni pubbliche39.
La questione che interessa, naturalmente, non è qui
se la lettura più veritiera delle forme del potere politico
nell’India moghul fosse quella in chiave dispotica di Hastings o quella di tipo costituzionale di Burke. Ciascuno
aveva attinto a un corpo di informazioni diverse. Hastings
si era procurato le proprie direttamente sul campo; Burke
dipendeva in gran parte da quelle di Philip Francis. Ma
va tenuto conto del fatto che a dare sostanza e parvenza di veridicità alle une e alle altre era stata la narrazione
certamente non priva di malizia offerta agli inglesi da attori sociali locali interessati a fornirne una consona con i
propri interessi. Cosa fossero, in realtà, gli zamindar (ad
essi si riferiva Burke quando, nel brano poc’anzi citato,
evocava l’«interesse agrario vasto e indipendente» presente in Bengala), con gli strumenti offerti dal lessico sociale
europeo non potevano dirlo del resto con precisione né
l’uno né l’altro. E sebbene, diversamente da Burke, non
lo dichiarasse, anche Hastings al momento di descriverne
la natura aveva fatto ricorso a un gioco di implicita comparazione attraverso l’approssimazione analogica, con
l’obiettivo di sottolineare la precarietà dei loro diritti di
proprietà e di legittimare così l’esproprio delle loro ter39 Burke,
Discorso sull’“India Bill” cit., p. 325.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
227
re, che andava effettuando dichiarandosi erede dei poteri patrimoniali assoluti attribuiti dalla sua narrazione del
mondo moghul all’imperatore di Delhi. Figure complesse
di «esattori, appaltatori, intermediari rispetto al potere
politico-amministrativo» e, tuttavia, figure patrimoniali a
loro volta, suggerisce di definirli Guido Abbattista40; non,
dunque, figure omologhe, per così dire, alla «nobility»,
alla «gentry», ai «freeholders», come a seconda dei contesti le traduceva Burke, ma tuttavia a un tempo dotate
di prerogative negoziali nei confronti del potere statale
e investite di un ruolo di responsabilità tutoria riguardo
ai sudditi residenti all’interno delle loro terre. E, d’altro
canto, sebbene la ricerca più recente si mostri per lo più
propensa ad accordare maggiore credibilità a un paradigma interpretativo vicino a quello suggerito da Burke, presentando la società moghul settecentesca come un «antico
regime» intensamente pattizio e plurale, e, dunque, come
un sistema a sovranità frammentata, partecipata e dispersa41, le alchimie istituzionali del subcontinente in epoca
precoloniale restano ora come allora drammaticamente unfamiliar per un lettore occidentale: le costituzioni
asiatiche antiche non sono, in altre parole, costituzioni
europee difettose, alle quali manca qualcosa; sono altro,
radicalmente altro.
Burke, come abbiamo visto, con il proposito di riscattarla dalla svalutazione operata da Hastings, aveva
paragonato la costituzione moghul ad un ventaglio articolato di figure concettuali familiari agli interlocutori
cui si rivolgeva. La si poteva, secondo lui, considerare
come una variante del modello costituzionale «gotico»
incarnato in Europa dal Sacro Romano Impero42; oppure
40 Ibid. Un ampio inquadramento del contesto di relazioni in cui si
muovevano gli zamindar in Torri, Storia dell’India cit., pp. 364-75.
41 Cfr. Travers, Ideology and Empire cit., p. 122. Ma
��������������������
va ovviamente osservato che la tendenza a ridimensionare gli aspetti monocratici del paradigma assolutista, del quale il tipo del dispotismo orientale rappresentava
nel Settecento la variante più carica di enfasi, è oggi largamente presente
anche all’interno della storiografia dedicata all’Europa. Cfr. Meriggi, La storiografia modernistica e lo Stato. Considerazioni sullo stato dell’arte, in Lo
stato dello Stato. Riflessioni sul potere politico nell’era globale, a cura di O.
Guaraldo e L. Tedoldi, Ombre corte, Verona 2005, pp. 21-33.
42 Sul tema cfr. ora P.P. Portinaro, Il labirinto delle istituzioni nella storia
europea, il Mulino, Bologna 2007, specialmente pp. 171-86 e le osservazioni
in proposito di M. Bellabarba, Stati e Imperi d’Europa, in «Storica», 39,
2007, pp. 119-228.
228
Storica
avvicinarsi al suo particolare «spirito delle istituzioni»
facendo ricorso ad un’accezione fortemente universalizzante e generica della nozione di diritto naturale; o, ancora, sottolinearne l’analogia con il disegno istituzionale
di un impero ottomano letto in chiave antitirannica; o,
infine, andare alla ricerca, nel tessuto sociale che ad essa
corrispondeva, di una aristocrazia fondiaria apparentabile con quella che nel modello di Montesquieu metteva
al riparo gli stati europei dalla minaccia del dispotismo.
Neppure lui, per la verità, mostrava di misconoscere il
ruolo giocato nel subcontinente dall’elemento della corruzione, che rappresentava uno dei punti principali della
narrazione autolegittimante di Hastings e al tempo stesso il luogo comune in ragione del quale si veniva rinforzando allora in Europa, su scala generale, il moderno
paradigma «orientalista», intonato alla svalutazione e al
declassamento morale delle società asiatiche. Ma, diversamente dal governatore del Bengala, che, lamentandone
la pervadenza quotidiana, la considerava al tempo stesso come una riprova della barbarie della società locale
e come una forma di temperamento informale del supposto dispotismo orientale, ricavandone un ulteriore argomento giustificativo per un esercizio imparzialmente
dispotico del potere – extrema ratio di riaffermazione di
un governo civile, per quanto autoritario, in un contesto
socialmente e culturalmente degradato –, Burke la valutava alla stregua di una deviazione occasionale e rapsodica da una normalità altrimenti caratterizzata. Vedeva
in essa, in altre parole, una deroga estemporanea rispetto
alla regolarità di una costituzione sui generis, non il ripugnante e obliquo strumento di contenimento di un dispotismo, che l’irlandese si rifiutava di riconoscere come
la normale condizione dei modelli statuali indiani.
5. Uccelli rapaci, tigri, ourang-outang:
il bestiario occidentale di Edmund Burke
Era pronto ad ammettere, infatti, che nel subcontinente esistessero singole figure di despoti (come ve ne
erano del resto state anche in Europa); non che vi prosperasse il dispotismo come sistema astratto e generalizzato. Sistematicamente dispotico e corrotto, al con-
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
229
trario, risultava nella sua analisi l’esercizio del mandato
governatoriale da parte di Hastings. Quel dispotismo era
animato dallo spirito di rapina, dal quale derivava «la nostra fetta di responsabilità nel saccheggio d’Oriente»43;
coincideva con l’indiscriminato imbavagliamento delle autorità tradizionali del territorio e con il sovvertimento delle sue consolidate gerarchie sociali, perpetrato attraverso il sequestro e la commercializzazione dei
beni fondiari detenuti dagli zamindar. Al loro posto si
affacciavano ora uomini nuovi, spinti dalla motivazione del guadagno e del profitto, e ignari del tradizionale
senso di responsabilità sociale inscritto nel patrimonio
genetico dell’aristocrazia. Intanto, le leve del potere amministrativo venivano assunte da un feroce e insaziabile
manipolo di «young boys», i quali costituivano i quadri
esecutivi della macchina burocratica diretta da Hastings,
ovvero gli strumenti operativi del suo rapace dispotismo,
che subentrava a una costituzione un tempo «mild and
orderly»44:
I nativi praticamente non sanno cosa voglia dire vedere i
capelli grigi di un inglese, perché a governare laggiù sono dei
giovani (quasi dei ragazzi) [...], animati dall’avidità tipica della
loro età e da impetuosità giovanile [...]; uccelli da preda e di passaggio, dotati di un appetito costantemente insaziabile per un
cibo costantemente scarso [...]. Se noi venissimo cacciati dall’India oggi stesso, non resterebbe nulla per indicare che, durante
l’inglorioso periodo del nostro dominio, essa è stata posseduta
da creature superiori agli ourang-outang o alle tigri45.
Si trattava di ragazzi educati in un Paese fiero della
propria libertà e delle proprie consolidate gerarchie sociali, ma ora trasformati da una perversa metamorfosi in despoti e in «distruttori della grande e piccola nobiltà di un
intero regno»46, che si accingevano a far ritorno in patria
carichi delle ricchezze ricavate dalle loro rapine e pronti a
farne uso per entrare sgomitando in Parlamento e per corrompere dall’interno gli istituti tradizionali della libertà
britannica. Ad essere drammaticamente in gioco a causa
del dispotismo della Compagnia non era dunque soltanto
43 Burke, Discorso di apertura (1788), in Scritti sull’Impero cit., p. 364.
44 Burke (1788), citato in Buonfiglio, La questione indiana cit., p. 139.
45 Burke, Discorso sull’“India Bill” cit., p. 298.
46 Ivi, p. 299.
230
Storica
la venerabile e antica, ma unfamiliar, costituzione indiana;
lo era la stessa costituzione inglese.
Da qualche tempo, del resto, un ulteriore stormo
di giovanotti spregiudicati e inclini a violentare dispoticamente le consolidate gerarchie di rango del proprio
Paese era in azione sotto un cielo molto vicino a quello
rispecchiato dal Tamigi. Per vederli all’opera, bastava attraversare il canale della Manica; erano, infatti, insediati
al timone del governo rivoluzionario di Parigi.
Gli scritti indiani di Burke coprono un arco temporale che impegna circa un ventennio, tra il 1774 e il 1794.
Le Reflections on the Revolution in France sono del 1790
e tra quella data e il 1794 l’irlandese scrisse e pubblicò
diversi altri interventi in proposito. Il critico inflessibile degli eccessi della Rivoluzione francese e il difensore
appassionato dell’antica costituzione indiana trassero,
dunque, argomentazioni e ragionamenti dalla medesima officina degli attrezzi. E non stupisce che qualcuna
delle immagini che Burke aveva costruito per dare pathos alla sua narrazione orientale finisse per slittare tra
le maglie del racconto da lui riservato agli sconvolgenti
eventi francesi. E viceversa. Quando pubblicò le Reflections, egli aveva infatti scritto già da qualche anno il suo
discorso di apertura per l’impeachment di Hastings; e
quando tenne, nel 1794, la sua replica finale, da anni andava scrivendo a proposito della rivoluzione in Francia.
Fu – come è noto – a causa dell’apologia che riservò
all’antico regime di quel Paese che Burke ruppe allora
definitivamente i ponti con i whigs, i quali, pur non identificandosi certo con i rivoluzionari di Parigi, consideravano in tutto e per tutto dispotico – e indifendibile dal
punto di vista di ciò che rappresentava per loro la libertà britannica – il sistema che essi avevano abbattuto47.
Ma le vignette che lo ritrassero beffardamente allora nei
panni di un gesuita ubriaco rappresentarono il riflesso
di un isolamento che l’uomo politico irlandese si stava
costruendo tanto con il suo anacronistico accanimento
nella questione indiana quanto con la sua virulenta reazione alle novità provenienti d’oltre Manica.
47 Pitts,
A Turn to Empire cit., p. 93.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
231
6. Contro la costituzione antica: dall’India alla Francia
Per Burke sia nell’India imperiale sia nella Francia della
rivoluzione quello che si stava perpetrando era un delitto
di lesa maestà nei confronti di una tradizione costituzionale in un certo senso universale, ispirata alla virtù della
prudenza, capace di irradiare – in forme diverse – modalità di esercizio del potere di natura contrattuale, e, grazie
ad esse, idonea a garantire l’ordinata riproduzione della
società; di qualunque società: sia quella solcata dal corso
del Gange, sia quelle rispecchiate dalle acque del Tamigi
o della Senna. Dunque, i voraci «young boys» manovrati
da Hastings e i sanguinari giacobini che terrorizzavano la
Francia appartenevano allo stesso ceppo.
Il loro scopo – e qui il suo racconto indiano cede il passo a quello francese – era di «distruggere ogni legame tra il
territorio e la notabilità sociale (dignity), e di abolire ogni
tipo di nobiltà, di gentry e di istituzioni ecclesiastiche»48.
Ad infiammarli era una «filantropia omicida». E come
avevano fatto i funzionari della Compagnia qualche anno
prima in India, i rivoluzionari d’oltre Manica stavano ora
trattando la Francia come un Paese di conquista [...]. La politica
di simili barbari vincitori, che condannano un popolo soggiogato e insultano i suoi sentimenti è sempre stata [...] quella di
distruggere tutte le vestigia del Paese antico, nella religione, nella politica, nelle leggi, nei costumi; di stravolgere ogni confine
territoriale [...] e mettere all’asta le sue proprietà; di abbattere i
suoi principi, nobili e autorità religiose; di sottomettere e abbassare tutto ciò che ha sollevato la propria testa al di sopra della
misura comune49.
Uccelli predatori in India, come abbiamo poc’anzi
ascoltato in riferimento agli
oscuri giovanotti i quali, avendo ottenuto in un modo per loro
incomprensibile un potere di cui non sapevano vedere né gli
scopi né i limiti, hanno rovesciato, sovvertito e ridotto in frantumi i diritti più consolidati e le più antiche e riverite istituzioni
di ogni epoca e nazione, come in un disgraziato e perverso, puerile gioco della capriola50
48 Burke, Thoughts on French Affairs, citato in Mehta, Liberalism cit.,
p. 138 (traduzione mia).
49 Reflections, citate ivi, p. 138 (traduzione mia).
50 Burke, Discorso sull’“India Bill” cit., p. 326.
232
Storica
e se ne erano tornati poi in patria determinati a riscattare le proprie dubbie origini sociali insinuando la loro
«mercenary logic into the historically sanctioned estates that anchor British Society» e ad acquistare con la
moneta sonante delle loro rapine «power and social
standing»51; «arpie della rivoluzione» in Francia, «emerse dalla notte e dall’inferno», «oscene arpie», pronte a
vantarsi di possedere «non so quali divini attributi», ma
in realtà paragonabili anch’esse a nient’altro che a «disgustosi e rapaci uccelli predatori»52. Uccelli predatori,
dunque, prima in India e dopo in Francia. Non diversamente dagli ourang-outang e dalle tigri in sembianze
umane che avevano imperversato senza freni nel Bengala
di Hastings, ora i giovinastri di Parigi stavano «distruggendo a proprio piacimento l’intera tessitura originaria
della loro società (fabric of society)» e mettendo a repentaglio «l’intera catena e continuità sociale della comunità
(commonwealth)»53. E il dispotismo esercitato dagli inglesi in India e quello irradiato dai rivoluzionari in Francia rappresentavano il riflesso di un medesimo sentimento «anaffettivo» nei confronti delle comunità territoriali
e dei valori all’interno di queste storicamente radicati54,
l’esito della «insolenza arrivista» di uomini nuovi55 incapaci – a differenza delle élites tradizionali, che ne possedevano innato il senso, tanto in India, quanto in Francia,
quanto in Gran Bretagna – di esercitare la funzione di
governo alla stregua di un atto fiduciario56, e per questo
scatenati contro l’«autorità dell’antichità»57.
Al tema dello spirito antitradizionalista del 1789, anche
se essenzialmente in relazione alla specifica fattispecie della sua di poco successiva proiezione napoleonico-imperiale, torneremo tra breve. Ora ci piace di prendere congedo
dalle fatiche indiane di Burke cercando di collocarne la vis
polemica sullo sfondo di quel processo generale di «disincantamento dell’Asia» da parte della cultura europea, al
quale Jürgen Osterhammel ha dedicato una decina di anni
51 Così Mehta, Liberalism cit., p. 173, parafrasando Burke.
52 Burke, Letter to a Noble Lord, cit. in Mehta, Liberalism
(traduzione mia).
53 Burke, Reflections cit., ivi, p. 140 (traduzione mia).
54 Pitts, A turn to Empire cit., p. 62.
55 Buonfiglio, La questione indiana cit., p. 75.
56 Ivi, p. 73.
57 Ivi, p. 124.
cit., p.173.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
233
fa uno studio di grande spessore, illustrandone la varietà
di declinazioni tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, dunque proprio in coincidenza con il dispiegarsi
del nuovo ciclo coloniale, del quale la conquista britannica dell’India rappresentò il grande episodio fondativo58.
7. Il disincantamento dell’Asia
Si trattò, naturalmente, in primo luogo, di un disincantamento operato attraverso il filtro della svalutazione
culturale, grosso modo secondo le medesime modalità
illustrate da Said nel suo studio fondativo della stagione
degli studi postcoloniali59. Non che quella svalutazione
rappresentasse qualcosa di radicalmente nuovo. Ma accanto al tradizionale motivo della presunzione di superiorità del Cristianesimo e quindi dell’Occidente rispetto
a qualsiasi altra religione o forma di culto, che pur avendo
costituito sin lì il canone prevalente di orientamento dello sguardo europeo sulle società non occidentali, si era,
specie nei contatti con le grandi civiltà asiatiche, talvolta
aperto alla possibilità di contaminazione o sincretismi60, in
essa cominciò ora a assumere un crescente rilievo un fattore inedito. Nell’elaborazione concettuale formalizzata
nel secondo Settecento dalla catena dei mediatori culturali
europei disseminati tra l’Asia e l’Europa (dai produttori
di fonti originali, come mercanti, religiosi, e – in misura
crescente – militari e amministratori, agli intellettuali che,
viceversa, senza mai muoversi dall’Europa ne traducevano in forma astratta le suggestioni), la presunta inferiorità dell’Oriente venne infatti sempre più motivata in base
all’identificazione illuministica tra idea di progresso ed
espansione territoriale europea. La seconda confortava,
58 Osterhammel, Die Entzauberung cit. Ma, per una illustrazione delle caratteristiche strutturali del «nuovo» colonialismo tardosettecentesco
e per un confronto con quello soprattutto spagnolo e portoghese dell’età
moderna, cfr. anche Id., Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, Beck,
München 2006 (quinta edizione attualizzata), in particolare p. 17 per una
definizione delle particolarità delle nuove colonie di dominio britanniche
e poi francesi.
59 Said, Orientalismo cit.
60 Penso, in tal senso, soprattutto alla vicenda gesuitica e ai riti cinesi o
brahminici. Per una recente messa a punto in proposito cfr. G. Imbruglia,
Un impero d’età moderna: la Compagnia di Gesù, in Le problème cit., pp.
159-78.
234
Storica
d’altro canto, sul piano materiale, attraverso il linguaggio
eloquente della conquista territoriale, le pretese universalizzanti della prima; e di quel linguaggio il caso dell’India
di Hastings e di Burke non rappresentò che un precoce
esempio di declinazione, al quale molti altri sarebbero seguiti nei decenni successivi.
Il processo non fu, per altro, lineare e univoco, dal momento che, all’interno della sensibilità tardo-settecentesca
europea, con quella, per così dire, escludente e gerarchizzante (la posizione di Hastings, nel nostro caso), coesisteva una vocazione includente e relativizzante (come quella
di Burke). E, a prescindere da questo, poteva accadere
che, nel selezionare i materiali di prima mano di cui avvalersi per le loro costruzioni idealtipiche sull’Oriente, gli
intellettuali che operavano in Europa facessero uso di informazioni o punti di vista del tutto contrastanti. È un fenomeno, del resto, che ci si è rivelato evidente accostando
gli antitetici «racconti» indiani di Hastings e di Francis,
così come essi vengono prendendo forma all’interno della
narrazione di sintesi fornita da Burke.
Sullo sfondo di una prospettiva, per esempio, che tendeva a attribuire alla categoria di dispotismo una valenza
tassonomica universale, piuttosto che considerarla come
strettamente ancorata a una geografia o a una forma di
civiltà, non era inusuale che, nel momento in cui se ne deprecava l’esistenza, singole figure di despoti à la Montesquieu61 finissero per vestire panni europei, piuttosto che
asiatici62; e che la categoria di dispotismo, anche se declinata con l’aggettivazione «orientale» venisse adoperata
essenzialmente come argomento polemico tutto interno
alle dinamiche europee (che era, del resto, quanto aveva
fatto a suo tempo lo stesso Montesquieu), da parte di chi
vigilava sulla conservazione delle forme di libertà vigenti.
61 Il dispotismo, in sintesi, per Montesquieu consisteva in: assenza di
leggi, arbitrio di chi comanda, assenza di proprietà privata, assenza di corpi
intermedi e di una aristocrazia corporata e ereditaria, esercizio del potere da parte di una gerarchia amministrativa completamente subordinata al
sovrano, percezione schiavile di se stessi da parte dei sudditi, ancoramento
al solo presente e alla quotidianità dell’orizzonte dell’esistenza. Così Osterhammel, Die Entzauberung cit., p. 277.
62 Per esempio, e a seconda dei punti di vista, quelli di Enrico VIII d’Inghilterra, di Filippo II di Spagna, di Ivan IV il terribile, di Luigi XIV. Cfr. ivi,
p. 270, ma anche Venturi, Despotismo cit., p. 119.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
235
Per converso, a condividere la convinzione di Burke
a proposito della costituzionalità dei sistemi di governo
asiatici, pur se in ragione di forme unfamiliar alla tradizione del diritto pubblico europeo, erano a loro volta in
molti. Gibbon, per esempio, era solito attirare l’attenzione sulla «democrazia» degli arabi, pur ammonendo che
essa aveva poco a che fare con l’esistenza di istituzioni individuabili in quanto tali e che tendeva piuttosto ad esprimersi in uno spirito di libertà individuale che costituiva
un prezioso contrappeso ai tentativi di induzione generalizzata dell’obbedienza63. E ancora: come Burke qualche
lustro più tardi a proposito dell’impero moghul, anche un
autore come James Porter in relazione all’impero ottomano individuava, nel 1768, negli ‘ulama un virtuale corpo
intermedio; il pilastro delle costituzioni islamiche64. Ancora; oltre all’autore delle Reflections, a suggerire l’analogia tra le forme indiane di impero e la costituzione cetuale del Sacro romano Impero tedesco erano stati quanti,
alle prese con il medesimo problema di inadeguatezza del
lessico politico europeo, s’erano sforzati di descrivere le
architetture istituzionali della confederazione maratta del
Deccan65 e i modi della sua virtuale eteronomia da Delhi.
Analogamente, come a respingere la tesi dell’inesistenza della proprietà fondiaria privata (per Montesquieu,
il primo e imprescindibile attributo della libertà) nelle
monarchie orientali e in particolare nell’impero moghul
c’era una schiera nutrita di studiosi, dall’orientalista francese Anquetil-Duperron al britannico Charles Boughton
Rouse, che nel 1791 dedicò anch’egli un’opera al tema,
animato com’era dal proposito di «�����������������������
vindicate the great empires of Turkey, Persia, and Indostan from the character
of barbarism that has been ascribed to them»66, così, trovandosi a descrivere le caratteristiche dell’organizzazione
castale indu67, c’era chi tendeva a tradurla nei termini di
una sorta di società cetuale al massimo livello di intensità;
63 Osterhammel, Die Entzauberung cit., p. 266.
64 Ivi, p. 307. Ma cfr. anche Thomson, L’Europe cit., pp. 270-3.
65 Osterhammel, Die Entzauberung cit., pp. 228 e 341.
66 Venturi, Despotismo cit., p. 125. L’opera si intitola Dissertation
concerning the Landed Property of Bengal, London 1791. Cfr. anche Osterhammel, Die Entzauberung cit., pp. 296-7.
67 Cfr. S. Bayly, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth
Century to the Modern Age, Cambridge U.P., Cambridge 1999, pp. 64-143
per un persuasivo inquadramento del problema.
236
Storica
il che significava, anche, percepirla e valorizzarla come un
saldo presidio antidispotico. Profilato già da Raynal nel
1770 nella sua Histoire des deux Indes, questo modo di
guardare agli equilibri della società brahmanica sarebbe
stato riproposto non solo da Burke nel 1788, in occasione dell’Opening dell’impeachment di Hastings, ma anche,
tre anni più tardi, da un autore senz’altro distante dalle
posizioni conservatrici che l’irlandese stava intanto maturando, come William Robertson. Quest’ultimo dichiarava
infatti di ritenere il sistema delle caste funzionale e proficuo per l’India, anche se basato su uno spirito gerarchico
ormai estraneo agli indirizzi della civiltà prevalente nella
moderna Europa. Ancora al di là della svolta di fine secolo, l’orientalistica primo-romantica – e soprattutto Friedrich Schlegel – si sarebbe appassionata a questa lettura
aristocratizzante, organicistica e spiritualizzante della costituzione materiale indu, impostando una modalità di approccio e di avvicinamento alla civiltà del subcontinente,
la cui eredità ideale è ancora visibilmente manifesta nelle
opere di Louis Dumont68.
Il cosmopolitismo di queste voci, capaci di andare alla
ricerca di una possibile elaborazione della differenza che
non ne implicasse necessariamente la subordinazione gerarchica all’alterità europea (la cui eventuale superiorità
veniva, in tal senso, discussa alla stregua di un’ipotesi, non
assunta preliminarmente come un assioma), si ripropone,
su un piano generale e non meramente circoscritto al caso
indiano, in quei filoni della cultura europea settecentesca
che espressero una critica al colonialismo e alla sua inclinazione a svalutare le varietà dei costumi del mondo non
occidentale disconoscendone preventivamente i modelli
alternativi di ragionevolezza e di legittimazione. A questi
filoni ci riferivamo quando, poc’anzi, abbiamo accennato
alla coesistenza, in ambito illuminista, di una vocazione
includente e relativizzante, accanto a quella escludente
68 Osterhammel, Die Entzauberung cit., pp. 334-42. Ma, prima di lui,
su questi temi: R. Schwab, La Renaissance orientale, Payot, Paris 1950; R.
Gérard, L’Orient et la pensée romantique allemande, Didier, Paris 1963;
W. Halbfass, Indien und Europa. Perspektiven ihrer geistigen Begegnung,
Schwabe Verlag, Basel-Stuttgart 1981. Di Dumont cfr. invece Homo hierarchicus. Il sistema delle caste e le sue implicazioni (1966), Adelphi, Milano
1991 e Homo aequalis 1. Genesi e trionfo dell’ideologia economica (1977),
Adelphi, Milano 1984. Su Dumont, da ultimo: S. Vibert, Louis Dumont.
Holisme et modernité, Michalon, Paris 2004.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
237
predominante. Seppure con gradazioni e intonazioni diverse, e in modo, comunque, discontinuo, quella vocazione si associò a nomi come quelli di Voltaire, Robertson,
Herder, Kant, Raynal, Diderot, infine Alexander von
Humboldt69, ai quali, nei limiti del contesto specifico del
quale ci stiamo occupando, anche quello di Burke – pur
tenendo conto delle ambivalenze sulle quali ci si è qui soffermati – può essere proficuamente accostato.
Ma, se ancora nei primi anni novanta la battaglia
dell’irlandese poteva apparire non del tutto anacronistica,
e inserirsi in un campo di tensione aperto, il cui esito non
sembrava ancora necessariamente prefigurato, nel corso
della svolta di fine secolo a prevalere nettamente, quanto
meno nei Paesi attivamente protagonisti della nuova ondata coloniale ed imperiale, come la Gran Bretagna e la
Francia, fu un orientamento agli antipodi con il suo.
Grosso modo negli stessi decenni, infatti, da un lato la
società europea smantellò le strutture dell’antico regime,
prendendo congedo dalle proprie costituzioni antiche a
caratterizzazione corporata, dall’altro i suoi avamposti
operativi oltremare avviarono concretamente per la prima
volta il processo di sottomissione materiale di vaste parti
dell’Asia. L’imperializzazione della presenza britannica in
India, in particolare, inaugurò l’epoca del dominio europeo su quelle società asiatiche ad alta configurazione civile
e culturale, con le quali durante l’età moderna – nella fase
degli imperi «leggeri» mercantili – si erano semmai venuti
costruendo dei rapporti di sinergia, intonati al rispetto se
non all’ammirazione. Viceversa, sulla base dei nuovi presupposti coloniali, delle civiltà asiatiche si tendeva ora a
enfatizzare in modo unilaterale uno stato di degenerazione che non solo esimeva gli europei da qualsiasi obbligo
di considerazione per i loro assetti istituzionali e sociali
pregressi, ma li autorizzava anche a prescindere, nei Paesi
conquistati, dall’osservanza dei codici morali che all’interno dell’Europa venivano non solo considerati irrinunciabili, ma anche presentati come una delle prove più
convincenti della presunta superiorità occidentale lungo
69 Su questo punto cfr. Pagden, Lords cit., pp. 162-90, e, più di recente,
con specifico riferimento a Kant e alle sue ambiguità in proposito, T. McCarthy, Race, Empire and the idea of human development, Cambridge U.P.,
Cambridge-New York 2009, pp. 42-68.
238
Storica
la scala del progresso umano. Era la regola della «morale
geografica», tanto deprecata da Burke.
Sottomettendola materialmente, l’Europa dimostrava
ora il proprio distanziamento da un’Asia, il cui presente veniva relegato nella dimensione avvilente del ristagno
e della riproposizione all’infinito del passato, dalla quale
si sosteneva che i nativi non sarebbero stati in grado di
emanciparsi, se non attraverso la salutare sottomissione
agli occidentali. Accadeva così che l’universalismo a vocazione relativizzante e comparativa, che ancora a fine
Settecento risulta animare nel profondo la filosofia della storia di un Herder – teorico delle civiltà, al plurale,
nonché della loro varietà/specificità e della loro possibile
dissonante sincronia70 – cedesse definitivamente il passo
a un diverso universalismo, a spiccata impronta monodimensionale, incentrato sul presupposto dell’unicità della
civiltà – al singolare –, di cui gli europei, in ragione del
rilievo assunto dalla costellazione scientista, sperimentale
e secolarizzata nella loro cultura durante il Settecento, si
caratterizzavano ora come gli esclusivi titolari.
8. Hegel e la scala del tempo
Si era agli inizi dell’addensamento di quella nozione
di «missione civilizzante europea»71 che avrebbe rappresentato la stella polare nella legittimazione dell’imperialismo ottocentesco. Essa presupponeva l’elaborazione di un modello stadiale della storia dell’umanità
(la scala della civiltà), al quale a fine Settecento, mentre
Burke combatteva instancabile la sua battaglia di retroguardia in Parlamento, avevano offerto contributi concettuali fondamentali autori come Turgot, Condorcet,
Volney72, e che avrebbe trovato, qualche decennio più
tardi, il suo più maturo inveramento nella filosofia della storia di Hegel. La civiltà aveva, sì, avuto inizio in
Oriente; e le recenti scoperte della linguistica indoeuropea ne venivano, del resto, offrendo implicitamente
70 E. Schulin, L’idea di Oriente in Hegel e Ranke (1958), Liguori, Napoli 1999, pp. 27-39.
71 J. Osterhammel, Europe, the «West» and the civilizing Mission, German Historical Institute, London 2006.
72 Id., Die Entzauberung cit., p. 286.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
239
una conferma, proponendo al tempo stesso nuovi sottili argomenti a favore della tesi della sua sostanziale
unicità73; ma il cammino dello spirito nel tempo storico
l’aveva portata altrove, precipitando i popoli asiatici
nella stagnazione rispetto alla quale il presente europeo aveva spiccato il volo, ricavandone la legittimazione a sottomettere il mondo del passato e a spingerlo
d’imperio lungo la strada del progresso74. La missione
britannica nel nuovo oltremare imperiale si configurava, dunque, per i suoi apologeti, nitida e luminosa.
Sostituendo il proprio «buon» dominio a quello «corrotto» sin lì esercitato dai Moghul su una popolazione
indu alla quale programmaticamente non si riconosceva – diversamente da quanto proposto da Burke – il
possesso di una autoctona costituzione antica, visto
che il cammino della civiltà aveva da tempo conosciuto
nel subcontinente una battuta d’arresto, gli alfieri della
modernità coloniale avrebbero risollevato un Paese degenerato, portandolo «from feudal tenures to security
of property; from barbarism to civility; from persecution to tolerance; from despotism to… well, to a different, more enlightened kind of despotism»75.
Orientamento eurocentrico della comparazione culturale e arrogazione della pretesa di esercitare in base
alla propria incommensurabile superiorità – una superiorità derivante, in ultima analisi, dall’eloquenza di un
diritto di conquista che in linea di principio esimeva
dal rispetto di quello localmente consolidato – un flusso beneficamente modernizzante in Paesi rimasti incagliati a livelli inferiori della scala di civiltà e per questo
da avviare al futuro attraverso l’eterodirezione del loro
presente: il «disincantamento» dell’Asia ne implicò la
reificazione, trasformandone le porzioni di volta in
volta conquistate in una tabula rasa affidata a militari
ben determinati ed agguerriti e ad amministratori auspicabilmente efficienti. Torniamo, per un istante, a
73 Sul tema cfr. T.R. Trautmann, Aryans and British India, University
of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1997 e Id., Languages
and nations. The Dravidian Proof in colonial Madras, University of California Press, Berkeley-Los Angeles- London 2006; ma anche S. Timpanaro,
Friedrich Schlegel e gli inizi della linguistica indoeuropea in Germania, in
«Critica Storica», IX, 1972, pp. 72-105.
74 Schulin, L’idea cit., pp. 83-211.
75 Così, causticamente, Travers, Ideology and Empire cit., p. 248.
240
Storica
quel Bengala ormai anglicizzato dal quale Hastings si
era allontanato nel 1785 e nel quale, mentre si consumava a Londra la lunga recita parlamentare organizzata da
Burke, si era insediato il nuovo governatore, ����������
Lord Cornwallis (in carica dal 1786 al 1793).
Si trattava, diversamente da Hastings, di un membro
dell’aristocrazia, e non di un merchant improvvidamente trasformato in sovereign dagli eventi e dagli azionisti
della Compagnia. Non a caso, del resto, in base alla riforma di Pitt approvata nel 1784, a designare il governatore dei domini britannici in India sarebbe stato da quel
momento in poi il governo; ed era costume di quest’ultimo attribuire responsabilità di così grande rilievo solo
ad esponenti di quel ceto aristocratico che – secondo
quanto sosteneva anche Burke – era il solo depositario
della virtù e della prudenza necessarie per governare con
saggezza i popoli. Anche nei decenni e nei secoli a venire, a reggere l’India britannica sarebbe stato sempre e
sistematicamente un aristocratico; ma questo non significava in alcun modo che, al di là di questo aspetto indubbiamente significativo, ma non nevralgico della questione, le tesi dell’irlandese fossero state recepite. Quello
che egli aveva posto non era, infatti, solo un problema di
blasoni e di opportuna considerazione dei ranghi sociali,
ma piuttosto, soprattutto, un problema di esercizio dei
modi del potere.
Ora, con il nuovo governatore, è vero, si avviò da
parte britannica lo smantellamento del dispotismo personale e quasi autocratico caratteristico dell’era �����
Hastings; ma ciò non comportò la riesumazione di alcuna
costituzione locale antica e neppure la proclamazione di
una sorta di «Magna Charta» dell’Indostan, suscettibile di offrire alle popolazioni del subcontinente qualche
elemento di libertà «all’inglese». L’idea, che era stata
propria di Burke, di un nuovo state-building coloniale,
da intendere come introduzione di un sistema costituzionale misto, costruito con materiali eterogenei attinti
tanto dalla tradizione locale quanto da quella britannica, cedeva il passo al pragmatismo amministrativo che
contraddistinse il Raj per gran parte dell’Ottocento76.
Esso muoveva dal presupposto della rimozione pura e
76 Ivi,
pp. 233-41, per una messa a punto articolata di questo nodo.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
241
semplice delle strutture di governo preesistenti a quello
inglese e dunque della totale trascuranza della tradizione istituzionale caratteristica dell’India islamica moghul.
Al posto di questa, dopo la «quasi-satrapia» di Hastings,
sarebbe subentrato un impersonale governo delle leggi
all’inglese, affidato qualche decennio più tardi a una burocrazia assai più caratterizzata in senso professionale
(per quanto ancora a lungo tutt’altro che impermeabile
agli influssi del patronage, come lo era stata al massimo
grado quella settecentesca) e affinata sotto il profilo amministrativo. Come si sarebbe espresso in proposito un
paio di decenni più tardi James Mill, quella che si aveva in mente era ora una «revolution masterminded by
skilfull administrators»77. Al di sotto del livello gestito
da questa intelligence dell’amministrazione, si sarebbe
provveduto inoltre a recepire qualche aspetto particolare
e circoscritto delle consuetudini legali di matrice brahmanica, senza per questo avvalorarne alcuna recezione
di ordine più sostanziale.
Sullo sfondo di un processo contraddistinto dall’eclissi della prevalente attenzione riservata all’India islamica
e persianeggiante in età moderna e dalla contestuale crescita dell’interesse degli europei per un induismo proprio da loro, del resto, allora formalizzato in quanto tale,
costringendone in un sistema forzosamente compatto e
coerente le tradizionali fluidità, si veniva così delineando
un modello di governo che, dal momento che trovava
il proprio baricentro nella definizione puramente burocratica degli assetti di potere, sottraeva ai sudditi indiani
della Corona tanto il conforto di una costituzione antica
«asiatica» quanto i benefici di una eventuale costituzione moderna «europea». Non interessava più se e secondo quali forme la prima si fosse data; essa apparteneva
comunque al passato, ad una tappa anacronistica nella
scala temporale della civiltà. Quanto alla seconda, per
essa i sudditi «degenerati» e irrazionali che popolavano
quei territori per il momento non erano maturi. Nel loro
presente, dopo un’era oscura di «barbarism and religion
under Muslim tiranny», non poteva che attenderli ora
77 Citato
in Osterhammel, Die Entzauberung cit., p. 299.
242
Storica
una tutta burocratica «���������������������������������
modern era of colonial enlightenment» sotto la guida inglese78.
9. Nell’Impero di Napoleone:
un orientalismo per l’Europa?
Profeta, in ragione della sua filosofia della storia,
dell’imminenza della supremazia sull’intero mondo orientale da parte di un’Europa nella quale egli individuava la
figura della maturità e del compimento della storia della
libertà, Georg W. Hegel indicava il tratto segnaletico più
forte della superiorità occidentale nella sua «matura statualità». Egli era, altresì, persuaso che all’affermazione del
moderno stato occidentale – e al suo definirsi come punto
d’approdo dello spirito nel suo cammino verso la libertà
– molto avesse contribuito Napoleone Bonaparte, con le
sue concezioni antitradizionaliste e con la sua sistematica
opera di smantellamento di quello che da qualche tempo
aveva cominciato ad essere chiamato antico regime79.
Come il britannico, che stava assumendo la propria
forma moderna attraverso la sottomissione dell’India,
quello francese sorto qualche lustro più tardi in seguito
all’ascesa di Napoleone, e in un batter d’occhio dilatatosi
in modo travolgente, era un impero di conquista, sebbene tendesse ad autorappresentarsi come il provvidenziale
strumento della liberazione dei popoli e il radioso vettore
del progresso della civiltà. Ma non si trattava, in fondo,
delle medesime modalità di autonarrazione caratteristiche, in quegli stessi anni, del «nuovo» colonialismo britannico nei lontani scenari del subcontinente?
La letteratura che ci accingiamo a prendere ora in considerazione non propone esplicitamente questo accostamento, nel senso che all’impero britannico accenna appena, e in modo del tutto rapsodico. Essa tematizza però
quello franco-napoleonico non solo rivendicando la congruenza dell’utilizzo di una nozione come quella di orientalismo – nella stessa accezione à la Said che può essere
adoperata per descrivere le modalità di legittimazione del
dominio europeo coloniale a partire da fine Settecento –
78 Travers, Ideology and Empire cit.,
79 Schulin, L’idea di Oriente cit., pp.
p. 244.
38, 73, 94, 186.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
243
per spiegarne le logiche di dispiegamento, ma anche riproponendo in modo quasi irriflesso schemi di ragionamento
e di argomentazione che presentano forti assonanze con
quelli coi quali abbiamo preso confidenza indugiando a
lungo tra le pagine indiane di Edmund Burke.
Nella ricostruzione di Michael Broers80, che è specificamente dedicata ad alcune delle aree della Penisola italiana
direttamente annesse all’Empire tra l’inizio dell’Ottocento e il 1809 e riorganizzate nella cornice dei dipartimenti
(ma, segnatamente, a venire tematizzate, sulla base di un
minuzioso scavo archivistico, sono la Liguria e il Piemonte), si coglie lo sviluppo di una linea di lettura che talvolta pare assomigliare a quella abitualmente suggerita dalla
letteratura ideologica di impronta antirivoluzionaria81, ma
che finisce poi per differenziarsene profondamente, sia
per la serietà del lavoro scientifico che vi è profuso, sia
per l’apprezzabile ampiezza degli orizzonti metodologici
di riferimento.
Non diversamente dal Bengala schiacciato a fine Settecento dal nuovo impero di conquista britannico, l’Italia
napoleonica delineata da Broers è un Paese nei confronti
del quale i rulers francesi intrattengono un rapporto economico di natura essenzialmente «colonial», che è del resto il non sorprendente riflesso del «predictable burden of
imperial domination»82. Ma non si tratta soltanto di una
questione di sfruttamento economico, esercitato da un
centro (straniero) sulle sue nuove periferie territoriali. A
suggerire di leggere attraverso la chiave coloniale la condizione dei dipartimenti italiani dell’impero di Bonaparte
è, ancora di più, l’atteggiamento di disprezzo ostentato
dai dominatori francesi nei confronti degli administrés
italiani e delle loro tradizionali forme di identificazione
culturale e di organizzazione sociale. Quella cui ci si trova
davanti, in Italia (ma anche in altre aree dell’Europa im80 Se ne seguono gli sviluppi attraverso: M. Broers, Cultural imperialism in a European Context? Political
������������������������������������������������
culture and cultural politics in Napoleonic Italy, in «Past & Present», 170, febr. 2001, rifuso in Id., The politics
of religion in Napoleonic Italy. The war against God, 1801-1814, Routledge,
London and New York 2002; Id. The Napoleonic Empire in Italy, 17961814. Cultural Imperialism in a European Context?, Palgrave MacMillan,
Basingstoke and New York 2005.
81 Sul tema, in chiave critica, cfr. Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell’Italia giacobina e napoleonica, a cura di A. Rao, Carocci,
Roma 1999.
82 Broers, Cultural cit., p. 152.
244
Storica
perializzata in varie forme da Napoleone, come l’Olanda
o la Spagna)83, è secondo Broers la violenza iconoclasta
di una «Great Nation» che agisce nei territori conquistati giocando simultaneamente le carte della «arrogance»
e dell’«enlightenment» e, una volta presentatasi come la
vessillifera del progresso e della civiltà, traendone l’autolegittimazione a sconquassare la «fabric of life»84 di società nei confronti delle quali ha emesso un inappellabile
verdetto di anacronismo. Come l’India, o come altre aree
extraeuropee in quello stesso torno di tempo reclutate a
forza nella macronarrazione orientalista, l’Italia dei prefetti transalpini è un Paese del passato, della superstizione,
dell’irrazionalità, della pigrizia, bisognoso dunque della
rigenerazione francese per sopravvivere degnamente nel
tempo presente: «As with western views of the ottoman
Middle East, in Said’s formulation, so the administrators
of Imperial Italy viewed urban and élite culture as old
centres of civilization in decline»85. A derivarne sarebbe
stata, in primo luogo, l’incapacità di intrecciare un proficuo dialogo con le élites locali: «The most perverse aspect
of French imperial rule in Italy was, arguably, the disdain
the French felt for the culture of the elites they meant to
appease and integrate». Ma
������������������������������
come sarebbe stato, del resto, possibile realizzare quell’integrazione, sulla base di
una svalutazione così cruda da tradursi in un processo di
«esotizzazione» tanto radicale da indurre l’autore a paragonarla a quella evocata da Tzvetan Todorov in Noi e
gli altri?: «Close contact between the imperial rulers and
the ruled may not have begun as an exercise in confronting the other by the intruding power, but it evolved into
exactly that»86.
Il gap di comunicazione e lo spossessamento esercitato ai danni dei titolari delle giurisdizioni tradizionali, sui
quali soprattutto Broers si sofferma nell’articolo pubblicato in «Past & Present», non rappresentarono, secondo
lui, che il presupposto per il dispiegamento di un impe83 Un colpo d’occhio in proposito in Id., Europe from Absolutism to
Revolution 1715-1815, Blackwell, London 2007.
84 Id., Politics cit., p. XI. Si noti l’assonanza con l’immagine della «fabric
of society», che abbiamo incontrato poc’anzi in Burke.
85 Id., Cultural cit., p.162.
86 Ivi, p. 153, con esplicito riferimento al Todorov di Noi e gli altri. La
riflessione francese sulla diversità umana, Einaudi, Torino 1991, per quello
che riguarda la formalizzazione del concetto di «altro».
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
245
rialismo culturale a tutto campo. Le proiezioni operative
«aggressive and elitist» di una idea di progresso di matrice
illuminista della quale Napoleone tendeva a rappresentarsi come una sorta di esecutore militante avrebbero infatti
indotto le dirigenze amministrative francesi operanti in
Italia a distruggere quella che Broers considera come l’ultima manifestazione di una «folk-religion» genuinamente
europea: la «piety» e la «�����������������������������������
Christianity of the late ancien régime����������������������������������������������������
», che nel «discourse» dei napoleonici, programmaticamente ostile, a causa del suo conclamato universalismo,
a qualsiasi forma di pluralismo o relativismo culturale,
rappresentava il principale bersaglio di una lotta contro
«barbarism, ignorance e superstition»87.
Dunque: barbarie, ignoranza, superstizione; gli stessi obiettivi polemici che abbiamo visto poc’anzi evocare all’interno delle narrazioni autocelebrative del nuovo
colonialismo britannico in India e che troviamo invece
qui ben esemplificate da quella folla di 4.000 flagellanti
che Broers, estraendone la vicenda dalle carte d’archivio, ci presenta intenti ad ascoltare clandestinamente una
predica pubblica dai toni molto accesi in un bosco vicino
a Sestri, nel 1808, sfidando così il divieto da qualche tempo imposto dalle autorità transalpine all’attività missoniaria88; o, ancora, dal mondo delle confraternite – sorta
di costituzione parallela religiosa e popolare, alternativa tanto a quella statuale, quanto, per più di un verso,
a quella di una Chiesa troppo addomesticata e troppo
remissiva nei confronti dell’«invasore coloniale» – la cui
trama l’autore si sforza di ricostruire in un capitolo successivo dello stesso libro89.
L’aggressività dello stato coloniale, o, meglio, dello
sguardo svalutante e disprezzante che esso irradia verso
una realtà locale intesa come complessivamente subalterna – a causa del suo tradizionalismo e della sua supposta
inerenza al passato –, è dunque, al tornante tra Sette e Ottocento, una modalità di esercizio del potere che semina
sconcerto non solo nell’Asia disincantata e oppressa, ma
anche nell’Europa del progresso? Appoggiandosi non
solo alla riflessione di Said, ma anche a quella di studio-
87 Broers, Politics cit., p. XII.
88 Ivi, p. 44.
89 Ivi, soprattutto pp. 66-77.
246
Storica
si dei processi ottocenteschi occidentali di omologazione
nazionale, come Eugene Weber o Linda Colley, Broers arriva effettivamente a teorizzare l’esistenza di un «���������
internalized, inter-European model of cultural imperialism»90. Ma
suggerisce, al tempo stesso, anche cautela:
Altough applying the model of orientalism to attitudes
within Napoleonic Europe should be hedged with qualifications, the examination of French hostility towards their Italian
administrés conceive to warn historians against assuming too
readily the historical reality of a single, unified European sense
of cultural superiority over the rest of the world91.
Dunque, anche nel primo Ottocento come già nel
Cinquecento, le «Indias» non si trovano soltanto in lontani continenti al di là del mare; ve ne sono di «otras»92,
generosamente disseminate nel cuore stesso dell’Europa.
Ma le avanguardie della civilizzazione europea hanno
nel frattempo smesso l’abito del religioso e indossano
ora quello dell’amministratore; parlano un linguaggio
secolarizzato e si preoccupano di sradicare costituzioni e
consuetudini anacronistiche, piuttosto che di diffondere
la luce della vera fede.
Le tesi di Broers sono state di recente contestate in
modo molto puntuale da Livio Antonielli, in un saggio
la cui prima parte è largamente dedicata alla loro disamina93. Si è fatto notare, in particolare, come la lettura
suggerita dallo studioso irlandese si concentri in modo
troppo riduttivo su alcune porzioni della Penisola (quelle, per l’appunto, direttamente annesse all’Empire) e,
così facendo, finisca per trascurare quel tema del consenso tributato al regime napoleonico da almeno alcuni
qualificati strati della società italiana, soprattutto – anche se non solo – nei grandi regni «indipendenti» di
quell’epoca, come il regno d’Italia e quello di Napoli.
Beauharnais, Giuseppe Bonaparte, Murat, nel momen-
90 Ivi, p. 11.
91 Id., Cultural cit., p. 179.
92 Il riferimento è naturalmente
al saggio di A. Prosperi, «Otras indias».
Missioni della Controriforma tra contadini e selvaggi, ora in Id., America e
Apocalisse e altri saggi, Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, RomaPisa 1999, pp. 64-87.
93 L. Antonielli, L’Italia di Napoleone: tra imposizione e assimilazione
di modelli istituzionali, in Gli imperi dopo l’Impero nell’Europa del XIX
secolo, a cura di M. Bellabarba, B. Mazohl, R. Stauber e M. Verga, il Mulino,
Bologna 2009, pp. 409-31.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
247
to in cui smantellarono le costituzioni antiche dei territori sui quali vennero mandati a regnare, mostrarono
sì – come gli uomini della Compagnia messi all’indice
da Burke – un difetto di simpathy nei riguardi di consuetudini molto radicate tra le popolazioni del tardo
antico regime italiano e molte delle innovazioni che introdussero (dai nuovi modi della fiscalità, all’anagrafe,
alla leva, alla dispersione della tradizionale rete religiosa
di assistenza) destarono effettivamente tra queste un ben
percepibile sconcerto. Analogamente, una parte delle
vecchie élites locali mostrò di considerare la rivoluzione
amministrativa dei napoleonidi come una sorta di «furto
di giurisdizione»94. Ma l’«astrattezza» illuminista di cui
l’amministrazione imperiale napoleonica rappresentò,
secondo Broers, una sorta di braccio armato, derivava da
un orientamento culturale al quale nella Penisola strati
significativi delle stesse élites tradizionali avevano aderito con convinzione nella seconda metà del Settecento,
e che già allora s’era tradotto nell’attività riformistica
propria delle monarchie più dinamiche. In una parola:
parallelo a un Settecento conservatore, di cui Broers dimostra la perdurante vitalità oltre la soglia del nuovo secolo, l’Italia degli antichi stati aveva conosciuto anche un
Settecento riformatore e una stagione illuministica; così
come, a cavaliere tra Sette e Ottocento, c’era stato anche un giacobinismo italiano; e così come, infine, nell’età
napoleonica – e soprattutto nelle capitali formalmente
autonome, Milano e Napoli – ad agire l’«imperialismo
culturale» di cui parla Broers erano stati non solo «invasori stranieri», ma anche robusti e significativi settori
della società locale, interessati in prima persona a una
trasformazione radicale dei rapporti tra comunità e potere. Pur in un rapporto di articolazione gerarchica, in
quell’epoca a Parigi, a Milano, a Napoli (se non anche a
Torino, a Genova, a Firenze, a Roma), si parlava la stessa
lingua progettuale e si operava nel solco di una cultura
condivisa (da alcuni) o respinta (da altri). Mentre, d’altro
canto, la «piety» e la «Christianity of the Old Regime»
avevano a loro volta i propri sconsolati sostenitori tanto
al di qua quanto al di là delle Alpi.
94 Meriggi, Società, istituzioni e ceti dirigenti, in Storia d’Italia, a cura di
G. Sabbatucci e V. Vidotto, Laterza, Roma-Bari, vol. I, 1994, pp. 119-228.
248
Storica
Situandosi all’interno di coordinate che, a ben vedere,
non sono inedite per la storiografia britannica, tradizionalmente incline a concentrarsi sui tratti imperialistici e
dispotici di un sistema – come quello napoleonico – percepito come concorrente al britannico, e, viceversa, meno
interessata a evidenziarne le sinergie con le aspettative di
riforma coltivate da parte delle stesse élites dei territori
conquistati dall’esercito francese95, Broers sembra tuttavia a tratti enfatizzarne alcune linee-guida, riproponendo immagini che abbiamo già visto affiorare nella prosa
di Burke, all’interno tanto dei poco noti discorsi «indiani» recentemente riscoperti dalla storiografia quanto di
quelli «francesi» ai quali soprattutto è collegata la fama
dell’autore delle Reflections: il difetto di simpathy dei
conquistatori/modernizzatori per le forme della cultura
tradizionale locale, l’attacco sconsiderato alla preesistente
«fabric of life»96 e al suo intreccio olistico/organicistico.
India britannica, Francia della rivoluzione, Europa napoleonica: il coro nostalgico che ascoltiamo sollevarsi dalle
pagine tardo-settecentesche dell’ex whig di Rockingham
e da quelle scritte ai giorni nostri dallo storico dell’imperialismo bonapartista è provocato da un fenomeno che va
considerato sostanzialmente unitario? Ed è proficuo adoperare le stesse categorie di lettura «post-coloniali» per
l’impero britannico in Asia e per quello franco-napoleonico in Europa?
Sì e no, direi. Da un lato, infatti, in considerazione di
quanto suggerito poc’anzi, in alcuni tratti nevralgici l’analogia risulta sfocata ed imprecisa. Per altri versi, però, essa
consente di tematizzare le modalità di una «grande trasformazione» delle strutture di esercizio del potere, che
nello scorcio tra Sette e Ottocento non ebbe luogo, evidentemente, solo negli scenari esotici delle colonie d’oltremare (Burke), ma anche nel cuore dell’Europa stessa; e,
all’interno di questa, non solo nei Paesi conquistati (Broers), ma anche in quelli che di questa conquista si stavano
rendendo protagonisti (di nuovo Burke). Mentre crollava
in India (o, poco più tardi, nell’Italia imperializzata), l’an95 Per un colpo d’occhio recente sul tema: D. Laven, L. Riall, Re������
storation Government and the Legacy of Napoleon, in Napoleon’s Legacy. Problems of Government in Restoration Europe, eds. D. Laven and L. Riall, Berg,
Oxford-New York 2000, pp. 1-26.
96 Broers, Politics cit., p. XI.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
249
tica costituzione pluralistica e corporata franava anche in
Francia, sotto la spinta di una generazione «eversiva» che
aveva per altro il suo pendant anche nell’India britannica,
e che Burke temeva potesse giungere a intaccare e corrompere la stessa venerabile tradizione della libertà inglese. A
determinare quel crollo erano, tanto in Asia quanto in
Europa, strumenti di impatto e di trasformazione molto
simili. Strumenti «coloniali»?
10. Civilization as an ideology
Illuminante, in proposito, per arricchire ulteriormente
la riflessione su questo punto, ci pare lo sguardo d’insieme
al problema offerto una ventina di anni fa da John Stuart
Woolf, in un articolo per molti versi propedeutico al suo
di poco successivo grande lavoro di sintesi sull’Europa
napoleonica97. Stuart Woolf vi introduce, programmaticamente, la nozione di «French cultural Imperialism» – una
formulazione che ha forti assonanze con quella che svolge
un ruolo tanto nevralgico nell’impostazione di Broers – e
ne declina le caratteristiche così:
The concept of civilization as an ideology had developed
long before the Revolution as an instrument of French power
and had acquired additional potency in the Enlightenment
through its association with the idea of progress. In the Napoleonic years it became unashamedly a form of cultural imperialism98.
Ma la «civilizing mission» che ne venne estrapolata e
affabulata – la legittimazione a travolgere in nome di un
progresso assunto come vettore universalizzante il tessuto tradizionale della società – non trovò applicazione solo
nei confronti delle «extra-European experiences» rispetto
alle quali «in its eurocentrism ‘civilization’ was opposed
and superior»99. Era stato elaborato, sì, in gran parte in
97 L’articolo cui ci si riferisce è: J. Stuart Woolf, French Civilization
and Ethnicity in the Napoleonic Empire, in «Past & Present», 124, 1989,
pp. 96-120. La successiva grande opera di sintesi: Id., Napoleone e la conquista dell’Europa, Laterza, Roma-Bari 1990. Ma è da vedere, nella stessa
ottica, anche un suo lavoro precedente a quattro mani: J.C. Perrot, J.�����
Stuart Woolf, State and Statistics in France, 1789-1815, Chur, London-ParisNew York 1984.
98 Stuart Woolf, French Civilization cit., p. 106.
99 Ivi, p. 119.
250
Storica
relazione all’altro dall’Europa. Ma prima i rivoluzionari, poi i napoleonici, lo «sguardo scientifico coloniale»
di derivazione illuminista dal quale ricavarono la nozione di «ethnicity», piegandola ad una caratterizzazione
sostanzialmente svalutante dell’oggetto sul quale esso
di volta in volta si posava, lo affinarono applicandolo a
frammenti di quella società corporativo-pluralista che
stavano trasformando in patria ed in Europa. Uno strumento drasticamente omologante come la statistica, che
di quello sguardo rappresentava la dirompente proiezione operativa, piegò alla proprie logiche classificatorie e
livellanti non solo i lontani spazi coloniali, ma anche le
varietà racchiuse all’interno della stessa dimensione metropolitana.
Torniamo allora a chiederci: si può proficuamente
parlare del colonialismo affermatosi alle origini del mondo contemporaneo come di un fenomeno ubiquitario, da
misurare anche nelle sue manifestazioni «interne», oltre
che in quelle extra-continentali alle quali in genere si
tende ad associarlo?
È una linea di riflessione che è stata proposta non
soltanto in relazione al caso giacobino-napoleonico, ma
anche in rapporto al farsi della Gran Bretagna moderna
attraverso la progressiva omologazione culturale del suo
«margine celtico» (Galles, Scozia, Irlanda)100; un problema, del resto, che anche il Burke del periodo «indiano»
aveva particolarmente a cuore: nella sua attività di polemista a sostegno del rispetto delle tradizioni territoriali,
i suoi discorsi contro Hastings e contro i rivoluzionari di
Francia si intercalano e si intrecciano con quelli in difesa
di una «libertà» irlandese (compresa quella dei cattolici d’Irlanda) anch’essa da lui percepita come eposta alla
minaccia di un emergente dispotismo101. Per chi lo considerava ormai come un inguaribile e patetico misoneista,
il passo fu breve, a questo punto, per ridurre l’austero
oratore parlamentare alla caricatura di gesuita ubriaco
100 Cfr. R.J. Hind, The Internal Colonial Concept, in «Comparative
Studies in Society and History», 26, 1984, pp. 543-68. ��������������������
Una suggestiva rivisitazione del tema dal punto di vista della sua affabulazione letteraria in F.
Moretti, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Einaudi, Torino 1997, in
particolare il cap. I, pp. 14-97.
101 Cfr. l’ultima parte dell’antologia curata da Abbattista e Francesconi,
Scritti sull’Impero cit., pp. 429-91.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
251
nella quale l’abbiamo sorpreso immortalato in apertura
di discorso.
Ora, avviandoci a tirare le fila del percorso che abbiamo proposto: per discutibile che sia102 – nel senso che
quella di un rapporto conflittuale tra centro e periferie nazionali è forse un’immagine più calzante per circoscrivere
il medesimo fenomeno che si vuol descrivere – a me pare
che il concetto di «colonialismo interno» qualcosa di importante da dire sui grandi processi di omologazione istituzionale che si situano alle origini del mondo moderno
in realtà ce l’abbia. «Orientalizza», forse, più che «provincializzare» l’Europa103; ma così combinandosi con una più
consueta nozione di colonialismo puro e semplice, esso
rende possibile il tentativo di formulare una macrolettura della transizione sette-ottocentesca dalle ambizioni
planetarie. Pur sempre eurocentrico nelle sue coordinate
di fondo (perché i soggetti ne sono essenzialmente Gran
Bretagna e Francia, mentre gli altri Paesi, fuori e dentro
l’Europa, ne rappresentano l’oggetto), lo sguardo straniante che ne deriva accosta in modo originale l’usuale
all’esotico, il familiare all’inconsueto, l’occidentale al non
occidentale. È lo sguardo che percorre intensamente una
delle più recenti opere di sintesi costruite in adesione ai
canoni della World History, quella che Christopher Bayly
ha dedicato qualche anno fa al tema della nascita del mondo moderno104.
11. Stato moderno come stato coloniale
Nel sollecitarla a dialogare con i temi che siamo venuti
man mano enucleando, effettueremo un’operazione necessariamente selettiva. Nel suo affresco a tutto campo Bayly
parla anche di molto altro, e lo fa in relazione a un arco
cronologico decisamente più lungo di quello che coincide
coi decenni sui quali abbiamo concentrato l’attenzione. E,
102 Cfr. Osterhammel, Kolonialismus cit., p. 22, che per una critica più
articolata rimanda a Internal Peripheries in European History, ed. H.H.
Nolte, Muster-Schmidt Verlag, Göttingen 1991, che non ho potuto vedere.
103 D. Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004 per
una enucleazione della proposta interpretativa sottesa a quest’ultima definizione.
104 C. Bayly, La nascita del mondo moderno, Einaudi, Torino 2007.
252
Storica
tuttavia, non solo egli attribuisce un rilievo strategico al
quarantennio tra il 1780 e il 1820, ma individua il nocciolo
duro di quella che reputa come la prima grande ondata di
globalizzazione della storia mondiale (1760-1830) proprio in quei fenomeni planetari di addensamento istituzionale e costruzione della statualità moderna sui quali
ci siamo soffermati anche noi nel percorso che ci ha portati dall’Asia all’Europa, dall’India alla Gran Bretagna,
da questa alla Francia e al continente.
Anche per lui, all’inizio di questo periodo, a rappresentare il fuoco della narrazione è un mondo transcontinentale di costituzioni antiche di impronta cetuale.
Nel mondo islamico, nell’India brahmanica, nella Cina
buddista
come nelle più vecchie tradizioni europee, grande peso era conferito a certi tipi di persone e a certe condizioni sociali [...]. Il
clero tra i musulmani, i sacerdoti brahmanici e i monaci tra gli
indù e i buddisti, la nobiltà in Cina, detenevano tutti un peso
consultivo di gran lunga superiore a quello dei comuni sudditi,
in quanto incorporavano le virtù delle antiche costituzioni105.
Il rilievo corale e ubiquo delle gerarchie sociali, in
quel vecchio mondo costituzionale, d’altro canto, faceva sì che vi fossero «ampie ‘somiglianze di famiglia’ tra
molti regimi dell’Eurasia e dell’Africa occidentale e settentrionale»; così che «l’idea di dispotismo orientale, un
artefatto della prima Europa moderna» in ragione della
odierna sensibilità storiografica non può che rivelarsi
come un’arma spuntata, che «incombe sulla comprensione vulgata dell’impero cinese dei Qing o di quello indiano
moghul»106. Ancora: «Nessun sovrano asiatico o africano
era realmente un despota, illuminato o meno»107, sebbene
ancora nel cuore dell’Ottocento gli osservatori europei,
perfino i liberali più avanzati
con in testa lo stesso John Stuart Mill, in linea di massima (negassero) a indiani, cinesi o africani la capacità di governarsi, con la
motivazione che i loro costumi erano difettosi e che secoli di dispotismo orientale li avevano avvezzati al regime autocratico108.
105 Ivi,
106 Ivi,
107 Ivi,
108 Ivi,
pp. 368-9.
p. 11.
p. 76.
p. 367.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
253
Ma intanto, dal tardo Settecento, in Europa come nelle sue proiezioni coloniali (nonché in almeno alcuni degli stati extraeuropei capaci di sottrarsi in quel periodo al
dominio occidentale) era scattata l’ora dei burocrati, gli
uomini della modernizzazione messi in campo dai governi con l’obiettivo di «intervenire in zone della società un
tempo autonome»109, di sottoporle alla pressione livellante
e autoritaria dispiegata dal «rullo compressore dello Stato
moderno»110, di smantellare la tradizionale indipendenza
fruita al tempo delle costituzioni antiche dalle cuspidi gerarchiche delle comunità territoriali. Lo stesso processo in
tutte le parti del mondo?
Solo in parte, naturalmente, in verità; perché in Europa alla nuova pervasività statuale, per quanto a passo incerto, faceva pendant l’affermazione del nuovo e speciale
contrattualismo individualista basato sui diritti dell’uomo
sacralizzati dalla rivoluzione e nutrito per altri versi delle
linfe risalenti del liberalismo; mentre altrove, essenzialmente in forza della dilatazione dei nuovi imperi occidentali, «la Dichiarazione dei diritti dell’uomo» tendeva
a risolversi tout court in una «dichiarazione dei diritti
dello Stato»111 e nello smantellamento del costituzionalismo tradizionale in assenza della contestuale sostituzione
di questo con un costituzionalismo moderno. Accadeva
soprattutto in quei territori nei quali si veniva realizzando quella che Bayly definisce la «convergenza coloniale»,
evocandone esemplificazioni come «l’invasione europea
dell’Egitto e l’accelerata espansione del potere europeo in
India, nel Sudest asiatico e in Africa meridionale»112: una
«invasione cristiana» e statale il cui esito fu quello di frantumare le «storie indigene del mondo».
Tra i protagonisti di quell’invasione, forti di una mentalità classificatoria di cui avrebbero fatto uso per ridisegnare in una trama unitaria e compatta le un tempo volatili
e fluide gerarchie del mondo, c’era, certo, anche Napoleone, condottiero non solo di soldati, ma anche di quegli
scienziati che nel 1798 inviò in Egitto «per cartografare
il paese e raccogliere i resti delle sue antiche civiltà»113;
109 Ivi,
110 Ivi,
111 Ivi,
112 Ivi,
113 Ivi,
p. XXVI.
p. 260.
p. 311.
p. 84.
p. 380.
254
Storica
un’operazione che, come abbiamo visto, secondo Broers
avrebbe presto replicato con modalità molto simili anche nelle periferie dell’Europa imperiale. Ma intanto, con
l’intento di «spartire e incamerare», secondo i medesimi
criteri, quella che era stata l’India moghul, s’era messa
con «impetuose azioni» all’opera una autentica folla di
«piccoli napoleoni [...] britannici»114.
Visto dalla prospettiva coloniale, nello studio di ����
Bayly lo stato amministrativo europeo tardo settecentesco e
primo ottocentesco tende, dunque, a assumere una connotazione unitaria. Lo scenario mondiale, per così dire,
contribuisce ad essenzializzarlo, ridimensionando drasticamente la pregnanza di quel contrasto tra l’«eccezionalità» britannica e i processi di accentramento burocratico
continentali di matrice rivoluzionario-napoleonica che a
lungo ha costituito poco meno di un luogo comune in
sede storiografica. È vero: «La Gran Bretagna, nella sua
politica coloniale ed estera, aveva cercato di sviluppare
un sistema più autoritario e centralizzato di quanto non
risultasse negli affari interni»115; quello che, come sappiamo, Burke aveva visto prender forma nel Bengala di Hastings e dei suoi young boys, e di cui aveva paventato la
possibile trasmigrazione in patria. E, dunque: «Il governo britannico si mostrava più moderno nel suo impero
coloniale in Oriente»116. Ma l’ora del burocrate – quella
che gli sguardi conservatori percepivano come la «mostruosità» di una repubblica formata solo da funzionari –
stava suonando anche nei territori metropolitani, dove, a
sua volta, si esplicitava nell’assottigliamento vertiginoso
delle distanze tra i centri e le periferie, nella falcidie delle
varietà, nell’inedita cogenza dei meccanismi dell’obbedienza al potere. Quella incarnata dallo stato intrusivo,
classificatore, «dispotico», non era, evidentemente, una
faccenda che riguardasse solo i territori sottomessi d’oltremare o che vedesse ad esclusivi protagonisti prima gli
smantellatori parigini della costituzione storica francese
e poi la loro discendenza disseminata qualche anno più
tardi dall’avventura napoleonica nei quattro angoli del
continente. Per alcuni versi, lo scenario coloniale rap-
114 Ivi,
115 Ivi,
116 Ivi,
p. 99.
p. 298.
p. 331.
Meriggi, Costituzioni antiche e orientalismo
255
presentava una anticipazione di quello interno; così che,
se il confronto critico con le narrazioni orientalistiche di
ieri e di oggi (nonché con quelle che a loro volta tematizzano quelli sorti in età contemporanea come imperi
in forma di stato, e per questo diversi da quelli caratteristici dell’età moderna)117 suggerisce di formalizzare su
scala planetaria il tema dello stato moderno come stato
coloniale, questa sfida va, credo, raccolta. È vero che non
è solo ad Eboli che si è fermato Cristo118; e che, di conseguenza, non diversamente dallo stato supposed assoluto
dell’età moderna, quello «dispoticamente» amministrativo sette e ottocentesco (e anche, naturalmente, a prescindere dal suo potente correttivo garantista) è stato a sua
volta più una tensione progettuale che una realtà. Ma per
approfondirne caratteristiche, natura, declinazioni, le
voci delle costituzioni antiche che veniva frantumando –
in alcune aree, a lungo, senza consentire che al loro posto
se ne insediassero di nuove – sono altrettanto preziose di
quelle che hanno fatto da coro alla sua affermazione.
117 Cfr. A.G. Hopkins, Back to the Future: from national History to
imperial History, in «Past & Present», 164, 1999, pp. 199-243. Per
�������������
una panoramica vasta in proposito: Gli Imperi dopo l’Impero cit. e, in particolare, in
questo volume R. Romanelli, Gli Imperi nell’età degli stati, pp. 35-72.
118 Così Bayly, La nascita cit., p. 338.