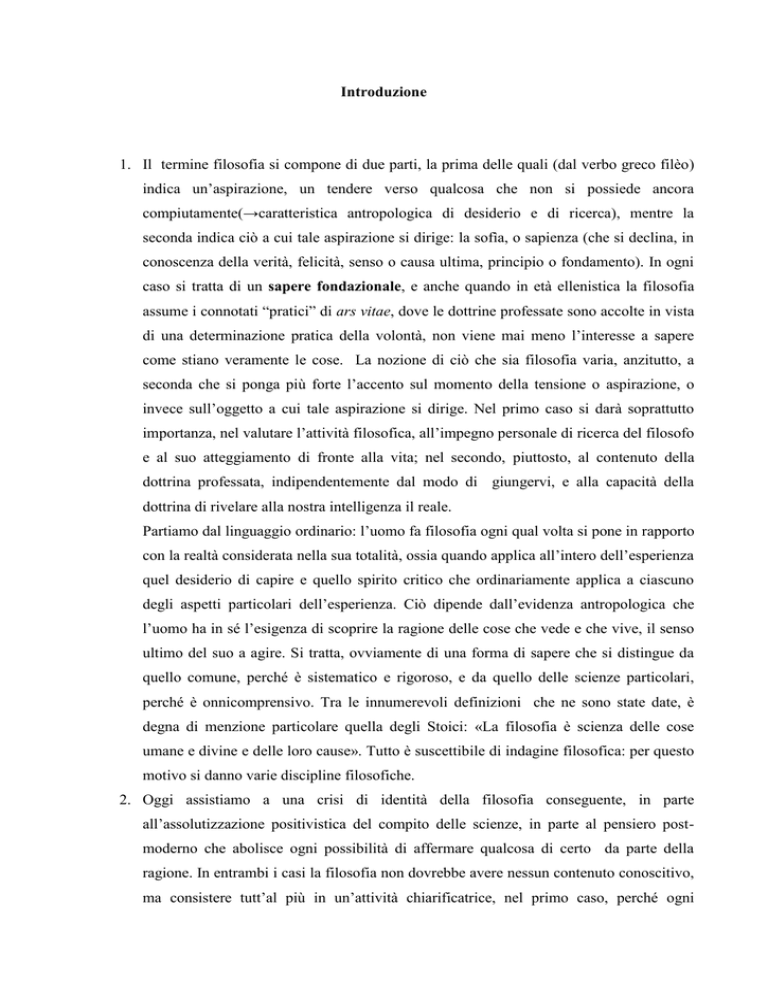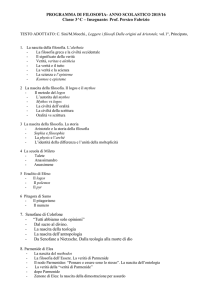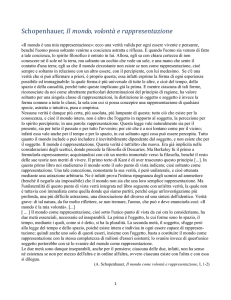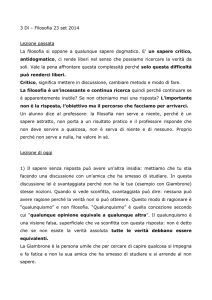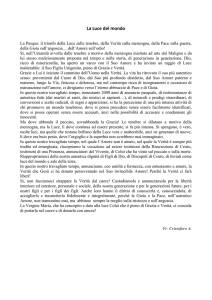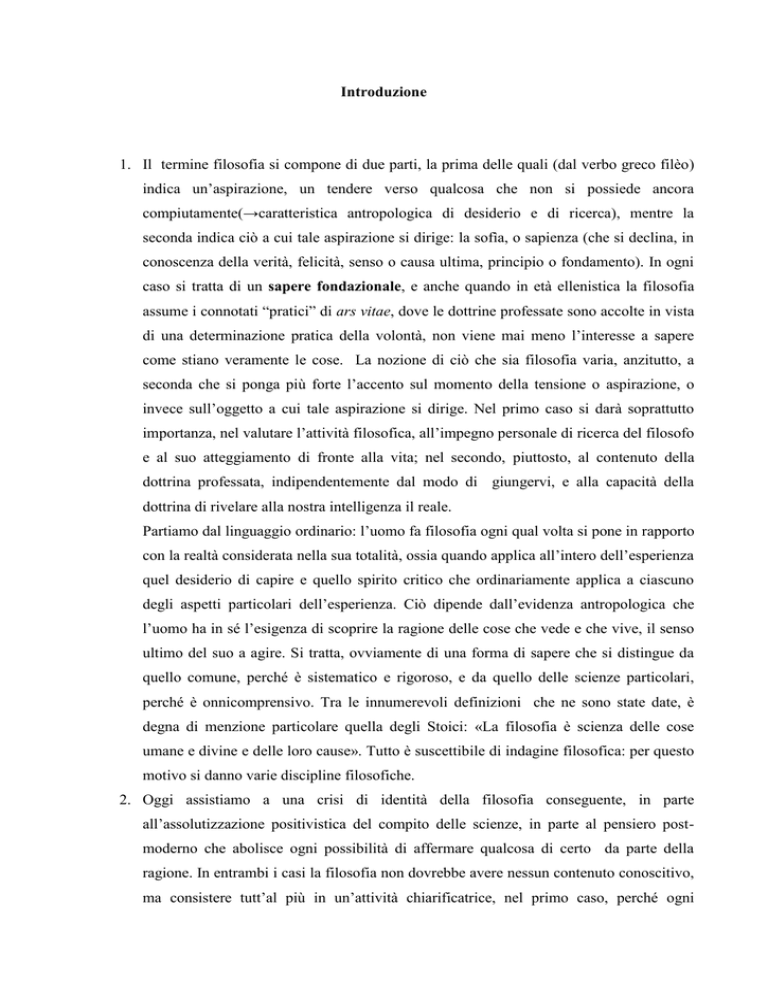
Introduzione
1. Il termine filosofia si compone di due parti, la prima delle quali (dal verbo greco filèo)
indica un’aspirazione, un tendere verso qualcosa che non si possiede ancora
compiutamente(→caratteristica antropologica di desiderio e di ricerca), mentre la
seconda indica ciò a cui tale aspirazione si dirige: la sofìa, o sapienza (che si declina, in
conoscenza della verità, felicità, senso o causa ultima, principio o fondamento). In ogni
caso si tratta di un sapere fondazionale, e anche quando in età ellenistica la filosofia
assume i connotati “pratici” di ars vitae, dove le dottrine professate sono accolte in vista
di una determinazione pratica della volontà, non viene mai meno l’interesse a sapere
come stiano veramente le cose. La nozione di ciò che sia filosofia varia, anzitutto, a
seconda che si ponga più forte l’accento sul momento della tensione o aspirazione, o
invece sull’oggetto a cui tale aspirazione si dirige. Nel primo caso si darà soprattutto
importanza, nel valutare l’attività filosofica, all’impegno personale di ricerca del filosofo
e al suo atteggiamento di fronte alla vita; nel secondo, piuttosto, al contenuto della
dottrina professata, indipendentemente dal modo di giungervi, e alla capacità della
dottrina di rivelare alla nostra intelligenza il reale.
Partiamo dal linguaggio ordinario: l’uomo fa filosofia ogni qual volta si pone in rapporto
con la realtà considerata nella sua totalità, ossia quando applica all’intero dell’esperienza
quel desiderio di capire e quello spirito critico che ordinariamente applica a ciascuno
degli aspetti particolari dell’esperienza. Ciò dipende dall’evidenza antropologica che
l’uomo ha in sé l’esigenza di scoprire la ragione delle cose che vede e che vive, il senso
ultimo del suo a agire. Si tratta, ovviamente di una forma di sapere che si distingue da
quello comune, perché è sistematico e rigoroso, e da quello delle scienze particolari,
perché è onnicomprensivo. Tra le innumerevoli definizioni che ne sono state date, è
degna di menzione particolare quella degli Stoici: «La filosofia è scienza delle cose
umane e divine e delle loro cause». Tutto è suscettibile di indagine filosofica: per questo
motivo si danno varie discipline filosofiche.
2. Oggi assistiamo a una crisi di identità della filosofia conseguente, in parte
all’assolutizzazione positivistica del compito delle scienze, in parte al pensiero postmoderno che abolisce ogni possibilità di affermare qualcosa di certo da parte della
ragione. In entrambi i casi la filosofia non dovrebbe avere nessun contenuto conoscitivo,
ma consistere tutt’al più in un’attività chiarificatrice, nel primo caso, perché ogni
contenuto conoscitivo viene esaurito dalle scienze, nel secondo perché viene dissolto il
potere della ragione di riconoscere e affermare qualsiasi certezza (dissoluzione del
sapere epistemico). Emblematica, a tale riguardo è la posizione decostruzionista di
Derrida che identifica il linguaggio come un evento a sé stante, privo di referenza,
sconnesso rispetto alla realtà che dovrebbe esprimere e significare o la prospettiva
inaugurata da Gianni Vattimo, in Italia, da lui stesso definita come “pensiero debole”.
(Svolta linguistica, ermeneutica o teoria generale dell’interpretazione)
Per Auguste Comte, fondatore del positivismo, compito della filosofia è quello di
«scoprire le relazioni e il concatenamento tra le scienze, riassumere, possibilmente, tutti
i loro principi propri nel minimo numero di principi comuni, conformandosi
incessantemente alle massime fondamentali del metodo positivo» (Cours de philosophie
positive, Paris, 1830-1842, vol.I). E’ da notare che permane, nel corso dei successivi
sviluppi della filosofia, l’identificazione della filosofia come scienza unificata o il
riconoscimento della sua insostituibile funzione unificante nei confronti degli altri
saperi. Per le scuole neocriticiste la filosofia deve valere come teoria del sapere e il suo
compito viene configurato in termini di fondazione del sapere in generale.
Enucleiamo le caratteristiche o note distintive del sapere filosofico:
1) Sapere dell’intero o approccio olistico alla conoscenza (Platone nella
Repubblica usa il termine synòpsis): l’essere umano non si accontenta di quel
sapere certo ma parziale e frammentario che si può raggiungere con le
scienze particolari ma aspira a un sapere totale, quello cioè che riguarda la
totalità delle cose dal punto di vista delle loro cause ultime. In tal senso si
può parlare della filosofia in termini di sapienza che cerca salvezza.
2) Rigore logico-scientifico: sono filosofici soltanto quei discorsi che
affrontano i problemi e le questioni ricavate dall’esperienza con metodo
rigoroso e sistematico, utilizzando un linguaggio appropriato (lessico
filosofico) e un robusto impianto logico.
3) Sapere aperto ad un’ incessante opera di ricerca e di approfondimento: il
sapere filosofico non si presenta mai come definitivo e irreformabile, bensì
sempre bisognoso di approfondimento, di ulteriore verifica, di migliore
formulazione, di nuovi confronti con realtà storiche diverse. In ciò consiste il
carattere “problematico” della filosofia. Nella prossima lezione vedremo
cosa può essere problematizzato e cosa no.
4) Vocazione pedagogico-educativa che impegna il filosofo nella trasmissione
della sapienza. Fin dalle origini questa forma di ricerca si presenta come
“associata”, coinvolgente più persone accomunate dallo stesso impegno e
interesse. La ricerca filosofica, nella sua vocazione originaria, non chiudeva
l’individuo in se stesso; esigeva anzi una concordanza di sforzi, una
comunicazione incessante tra gli uomini che ne facevano il tèlos
fondamentale della vita e determinava quindi una solidarietà salda e effettiva
tra coloro che vi si dedicavano. Sarebbe impensabile una filosofia senza
scuole.
5) Carattere di gratuità della filosofia, il suo essere un sapere disinteressato.
Afferma infatti Aristotele nella Metafisica: «Se è vero che gli uomini si
diedero a filosofare con lo scopo di sfuggire all’ignoranza, è evidente che
essi perseguivano la scienza col puro scopo di sapere e non per qualche
bisogno pratico».
Se consideriamo la questione sulla quale gravita successivamente la ricerca,
nella filosofia classica pagana, si possono distinguere cinque periodi:
a) Cosmologico (dominato dal problema di rintracciare l’unità che
garantisce l’ordine del mondo e la possibilità della conoscenza
umana)
b) Antropologico (dominato dal problema dell’uomo: Sofisti e Socrate)
c) Ontologico (dominato dal problema dell’essere o della realtà in
generale e dal rapporto dell’uomo con essa: Platone e Aristotele)
d) Etico (dominato dal problema della condotta di vita dell’uomo in
vista del conseguimento della felicità e della sapienza: stoicismo,
epicureismo, scetticismo, cinismo…)
e) Religioso (dominato dal problema soteriologico, cioè quello di
trovare per l’uomo la via del ricongiungimento con Dio, considerata
come l’unica via di salvezza: neoplatonismo, gnosticismo pagano)
I Greci sono stati i primi (VI sec. a.C) ad impegnarsi in quel tipo di indagine
critica e razionale in cui riconosciamo ancora oggi i tratti salienti della
filosofia. Sebbene esista una disputa tra gli occidentalisti e i cosiddetti
orientalisti, non si può non riconoscere che i Greci siano stati il primo popolo
occidentale a creare esplicitamente il modo di pensare filosofico(→si coglie
immediatamente una differenza di natura, non già nel contenuto). Mentre
infatti la sapienza orientale è di tipo religioso e tradizionalistico (privilegio e
appannaggio di una casta sacerdotale), la sapienza greca invece si presenta,
in quanto filosofia, come una ricerca razionale accessibile a tutti gli esseri
umani. Altra nota distintiva della scienza greca rispetto a quella egiziana e
mesopotamica, lo abbiamo già visto, è il suo carattere spiccatamente teorico
e “disinteressato”. Mentre infatti gli egiziani e i mesopotamici sviluppavano
le scienze in termini prevalentemente descrittivi e per scopi immediati e di
pratico interesse, i Greci tendevano a coltivare le scienze principalmente per
desiderio di conoscenza e di comprensione dei perché delle cose. I Greci
quindi, non si sono limitati a ricevere il materiale delle nozioni astronomiche,
matematiche, mediche ecc. dagli altri popoli, ma hanno dato ad esse una
forma di scientificità per lo più sconosciuta ai popoli precedenti.
A chi viene attribuito originariamente l’uso del termine filosofia?
Secondo una tradizione molto nota, Pitagora avrebbe usato per primo la
parola filosofia in un significato specifico. Egli paragonava la vita alle grandi
feste di Olimpia, dove alcuni convengono per affari, altri per partecipare alle
gare, altri per divertirsi ed infine alcuni soltanto per vedere ciò che avviene:
questi ultimi sono i filosofi. Fin dall’origine è sottolineato il distacco tra la
contemplazione disinteressata propria dei filosofi e l’affaccendamento degli
altri uomini. (→Da notare come nel mondo attuale la crisi di identità della
filosofia risulti legata alla subordinazione dei saperi al criterio di utilità
materiali: primato della tèchne sulla nòesis prefigurato già da Husserl nella
Crisi delle scienze europee). In seguito la filosofia assunse il carattere di una
ricerca radicale sui fondamenti dell’essere, del conoscere e dell’agire e venne
perciò considerata la “regina” del sapere.
Il libro I della Metafisica di Aristotele è dedicato per intero alla determinazione e
illustrazione del concetto di sofìa o filosofia (intesa qui nel senso forte di metafisica
come conoscenza delle cause e dei principi.
1) Distinzione tra conoscenza empirica (semplice constatazione del che) e scienza
(scoperta del perché). La sapienza si ottiene passando dal “che” al “perché” delle
cose. Altra caratteristica della sapienza deve essere la conoscenza di tutte le cose,
dell’intero, che coincide con la conoscenza dei principi di tutte le cose.
2) Il fine della sapienza è la contemplazione della verità in quanto tale, la quale più di
ogni altra cosa appaga quel naturale desiderio che differenzia l’uomo da tutti gli altri
esseri viventi, ossia il desiderio di conoscere.
3) Non tutte le cause sono oggetto della sapienza, ma solo certe cause e certi principi:
tutte le scienze infatti sono conoscenze di cause particolari; la sapienza invece, è
conoscenza di quelle prime o supreme.
4) L’ arché individuato dai filosofi pre-socratici, pur diversificandosi in una varietà di
elementi materiali si può configurare come il risultato di una comune intuizione
originaria dello spirito ellenico che è “una realtà che permane identica pur nel
trasmutarsi delle sue affezioni” (→distinzione aristotelica tra sostanza e accidenti).
Filosofia= sapere dell’intero (synòpsis) che considera le cose del mondo e gli avvenimenti della
storia sub specie aeternitatis. La filosofia cioè, indaga l’essere in quanto tale, dal punto di vista del
fondamento o della causa prima. Ciò presuppone il riconoscimento dell’intelligibilità del reale,
l’esistenza di un kòsmos (sistema ordinato di relazione tra gli enti) da investigare razionalmente e da
ricapitolare in una unità superiore di senso. Vale la pena ricordare a tale riguardo che funzione
primaria dell’intelletto è di cogliere nell’esperienza l’universale
Scienza= sapere settoriale (epistème) che studia gli accidenti e non l’essere in quanto essere; essa
indaga cioè uno specifico modo d’essere delle cose (sapere specialistico). Si tratta comunque di un
sapere definitivo che giunge a spiegare le cose dell’esperienza (interne ed esterna) attraverso le
leggi (fisiche, metafisiche, logiche, morali) che governano la realtà. Già il termine greco di epistème
implica l’idea di un fondamento (connotata dalla radice stènai), e per Aristotele questo fondamento
consiste in una prima e indispensabile fase del processo scientifico ossia il rilevamento dei dati che
Aristotele denomina “osservazione” (historìa), intendendo con questo termine la coscienza delle
evidenze primarie, tanto di quelle sensibili come di quelle intelligibili, formulate per mezzo del
giudizio, previa l’astrazione dei concetti. La scienza, nella gnoseologia aristotelica, si identifica
quindi con il “ritrovamento delle cause” di ciò che si è osservato, per spiegare le cose in rapporto
alla loro causa necessaria.
Nella gnoseologia tomista, ha particolare importanza il fondamento dell’epistème, che si identifica
con i giudizi primordiali, detti prima principia. Questi principi primi sono indemonstrabilia, proprio
in quanto premesse di ogni possibile demonstratio: sono dunque la base pre-critica di ogni possibile
critica.
L’esistenza di varie discipline filosofiche si giustifica come “discorsi metodologicamente diversi”
ossia come diversi approcci al medesimo oggetto – l’esperienza (problema cosmologico e
metafisico; problema teologico; problema antropologico ed etico) – per ottenere una comprensione
più profonda di alcuni aspetti che in astratto possono essere isolati e studiati a parte, anche se in
concreto costituiscono un’unità di senso. Occorre quindi conservare l’interesse per l’universale e
sottolineare che è la metafisica a dare consistenza a ogni singola disciplina filosofica.
Questione del “cominciamento” o punto di partenza della filo-sofia in rapporto
all’evidenza antropologica dell’uomo come essere animato dal desiderio di conoscere la
verità*.
Punto fermo deve restare la consapevolezza che i propri atti conoscitivi sono resi
possibili dalla presenza dell’essere delle cose.
L’esperienza non è filosofia, è solo il presupposto della filosofia, la quale è ricerca di
una verità superiore.
*La grande scoperta di Parmenide è che la verità si fonda sull’essere delle cose. Il
filosofo di Elea ha espresso per primo la struttura stessa della verità, la quale consiste in
una relazione tra l’essere (èinai) e l’intelletto (lògos). Parmenide ha dunque intuito che
la struttura della verità è di tipo relazionale; da qui poi è scaturita la concezione
filosofica della verità come conformità della mente con l’oggetto conosciuto. Questa
concezione della verità è stata poi rielaborata nella formulazione medievale di
adaequatio intellectus et rei che Tommaso riprende dal filosofo ebreo Israeli, tramite
l’arabo Avicenna.
L’aspetto più significativo da sottolineare è che la nozione di adaequatio presuppone che
l’essere delle cose sia di per sé intelligibile (cioè capace di essere colto dall’intelletto) e che
l’intelletto a sua volta sia capace di aprirsi (cioè sia intenzionalmente aperto all’essere stesso).
Nel corso di tutta la filosofia classica permane la convinzione che il pensiero abbia una natura
intenzionale, sia cioè relativo alle cose e orientato ad esse: non è mai un “pensiero vuoto”, né
può essere concepito come un’entità in sé, bensì come una corrispondenza tra soggetto e
oggetto tra intellectus e res. Il pensiero cioè si può definire come apprensione dell’essere
delle cose, la cui totalità è aperta fin dal principio, fin dal primum cognitum. È da notare che
la definizione di verità cui ci riferiamo parla di corrispondenza tra intelletto e realtà (res sunt)
non tra intelletto e oggetto (obiectum), come invece prese a dire Cartesio e, sulla sua scia,
molti autori moderni tra cui Kant, che in ultima analisi fanno della verità logica una sorta di
accordo del pensiero con se stesso. La res, nel realismo metafisico non si riduce all’obiectum
o “rappresentazione”, ma è ciò che ha l’essere in senso pieno e forte. In Agostino, ad esempio,
troviamo la consapevolezza che la verità logica – quella cioè che la mente può esprimere con i
suoi giudizi – dipende totalmente dalla verità ontologica, ossia l’intelligibilità delle cose
create dall’Intelligenza divina. L’uomo dunque non crea la verità ma la scopre e tenta di
esprimerla con la mente e con le parole, cercando sempre di conformarsi alla realtà delle cose.
La verità che la mente scopre ed esprime è dunque immutabile ed eterna, mentre le cose del
mondo sono mutevoli e contingenti.
Vale la pena sottolineare che il soggetto conoscente non si accontenta per natura della
conoscenza dell’immediatamente evidente ma va alla ricerca di una verità ulteriore. Il
pensiero umano presenta una duplice dimensione operativa:
1) Esso è costitutivamente legato all’immediatezza del percepibile o sperimentabile
2) Esso trascende l’immediatezza attraverso la mediazione dell’inferenza, che consente di
passare dal cosiddetto dato dell’esperienza, per poi concludere ben oltre lo sperimentabile.
Ciò è possibile perché siamo svincolati dalla materia, nella libertà dello spirito. La libertà si
configura quindi come condizione di possibilità del pensiero.
Nell’antichità greca e cristiana è impensabile problematizzare la certezza psicologica della
coscienza individuale. Il problema critico, che da Cartesio in poi coincide con la
trasformazione dell’evidenza immediata dell’esistenza del mondo e della propria soggettività
in una tesi da dimostrare, si configurava piuttosto con la ricerca e la conseguente acquisizione
– nel dialogo intersoggettivo – dei criteri della verità, quelli che permettono di distinguere tra
verità apparente (conoscenza ordinaria o dòxa) e verità certa (conoscenza riflessa, metodica,
critica o epistème): questo passaggio dalla conoscenza ordinaria alla conoscenza riflessa nel
processo di riconoscimento della verità si può definire dialettica (nel significato più generico
processo di conoscenza), che nei filosofi eleati e in Eraclito assume i connotati di una
dialettica dei contrari, in Platone diventa dialettica del progresso, in Aristotele viene
correttamente intesa come dialettica dei presupposti e di fondazione. Nel primo caso il
carattere di epistème viene attribuito solo all’intuizione intellettuale, dal momento che
l’esperienza sensibile viene considerata fonte di illusioni e di inganni. La dialettica per
Platone designa il passaggio dall’esperienza alla scienza ed è possibile proprio perché
l’esperienza non è del tutto priva di valore: in essa già c’è un elemento intrinseco che reclama
una delucidazione, una piena giustificazione, un rimando alle Idee che l’anima già possiede e
deve ricordare. L’esperienza in questo senso, con i suoi giudizi, viene assunta da Platone
come punto di partenza della filosofia; la doxa rimane inferiore all’epistème, ma allo stesso
tempo ne è la necessaria premessa. Aristotele invece, con la sua dialettica dei presupposti,
spinge fino a un limite mai prima raggiunto dal pensiero greco, l’apprezzamento della dòxa,
sebbene si impegni nella ricerca di un radicamento ontologico.
Il dubbio metodico universale formulato da Cartesio e da lui adottato come punto di partenza
della riflessione filosofica mette radicalmente in crisi la nozione relazionale classica di verità.
Infatti, il metodo cartesiano del dubbio iperbolico è indirizzato alla scelta del pensiero vuoto
(il cogito infatti è proprio il dubbio, ossia il pensiero senza oggetto diverso da sé. Per la prima
volta la filosofia esprime così un atto di libertà del pensiero che si affranca dalla reale
evidenza delle cose.
Conseguenza immediata di questa trasformazione dell’approccio alla conoscenza è
l’autoreferenzialità e assolutizzazione del pensiero. Con Cartesio la conoscenza non ha più
come oggetto l’essere delle cose ma le idee e la gnoseologia che poi fonda o esclude, a
seconda dei casi la metafisica, diventa l’essenza stessa della filo-sofia. L’equivocità del
metodo cartesiano consisteva nel fatto che, con la dichiarata intenzione di uscire fuori dallo
scetticismo per edificare una nuova scienza su basi certe, egli ne riconosceva le ragioni
adottando il dubbio come metodo per ritrovare il fondamento aletico del sapere. Da allora:
la filosofia moderna adotterà la rappresentazione o idea come unico oggetto certo del pensiero
il discorso sul mondo diventerà impossibile e la filo-sofia, ridotta a critica della conoscenza,
opera la kantiana rivoluzione copernicana, per la quale al centro di tutto c’è il soggetto
pensante: il pensiero non è più l’atto di una facoltà che si adegua alla realtà conosciuta, ma è
un’attività costitutiva dell’oggetto.
La realtà in sé o realtà sostanziale si trasformerà in realtà per il soggetto o realtà
“fenomenica”, dove l’accento è posto sull’insignificante presenza del mondo quale mi appare
nelle sue manifestazioni fenomeniche, percepite dai sensi.
La concezione del pensiero come vuoto o come attività costruttiva può concepire solo la
verità come coerenza formale.
A Kant la nozione di verità come corrispondenza arriva già intrinsecamente alterata dal
soggettivismo rappresentazionistico post-cartesiano; ma se al posto della realtà del mondo e
dell'uomo c’è solo il soggetto con le sue strutture a priori, la filo-sofia non è più altro che
studio del pensiero.
L’opportuna distinzione tra verità ontologica (l’intelligibilità delle cose create dall’intelletto
divino) e verità logica (l’effettiva adeguazione dell’intelletto umano a qualche aspetto
dell’intelligibilità delle cose con le quali è in contatto) comporta l’inscindibilità di tale teoria
gnoseologica dalla metafisica della creazione. L’adaequatio è stabilita da Avicenna e
Tommaso tra l’intelletto che formula il giudizio e la res intendendo per res ogni ente, anche la
propria persona.
Schema riassuntivo sul concetto di lògos:
Logos (in greco: λόγος) deriva dal greco λέγειν (léghein) che significa scegliere, raccontare,
enumerare. I termini latini corrispondenti (ratio, oratio) si rifanno con il loro significato di calcolo,
discorso al senso originario della parola. Successivamente la parola logos ha assunto nella lingua
greca molteplici significati: "discorso", "legge", "logica", "intelligenza ", "pensiero", "ragione".
Secondo Martin Heidegger nella lingua greca antica i verbi parlare, dire, raccontare si riferivano
non solo al sostantivo corrispondente logos ma anche al verbo leghein che significava anche
conservare, raccogliere, accogliere ciò che viene detto e quindi ascoltare.
Nello sviluppo della cultura occidentale, a suo parere, il valore del pensare e del dire ha prevalso su
quello dell'ascoltare mentre l'udire e il dire, come si riproponeva nel dialogo socratico, sono
entrambi essenziali «L’udire autentico appartiene al logos. Perciò questo udire stesso è un leghein.
In quanto tale, l’udire autentico dei mortali è in un certo senso lo stesso logos»
Lo stesso Heidegger ha individuato il significato di raccolta, nel termine derivato da logos: silloge
riportandolo all'interpretazione del logos eracliteo.
Da un frammento di Leucippo sembra possa attribuirsi ad Eraclito un significato del Logos come
"legge universale" che regola secondo ragione e necessità tutte le cose:
« Nessuna cosa avviene per caso ma tutto secondo logos e necessità. »
(Leucippo, fr.2)
Agli uomini è stata rivelata questa legge ma essi continuano ad ignorarla anche dopo averla
ascoltata. Il Logos appartiene a tutti gli uomini ma in effetti ognuno di loro si comporta secondo una
sua personale phronenis, una propria saggezza. I veri saggi invece sono quelli che riconoscono in
loro il Logos e ad esso s'ispirano come fanno coloro che governano la città adeguando le leggi alla
razionalità universale della legge divina.
Un ulteriore significato del logos inteso come "ascolto" è nella affermazione di Eraclito che sostiene
che molti non capiscono la sua "oscura" dottrina poiché si sforzano di ascoltare lui invece che il
logos, il quale risulterà chiaro solo a chi saprà prestargli attenzione (il sapiente).
Con Parmenide si attribuisce esplicitamente al logos il potere di dire la verità stabilendo, in tal
modo, un principio di discriminazione tra ciò che è vero e ciò che non lo è, ossia tra la via della
verità e la via dell'errore. La critica ha messo in luce come questa curvatura del logos verso la verità
avvii la specializzazione del logos come discorso veridico e veritativo.
La connessione tra il logos e aletheia era già implicita in Eraclito e preannunciata nelle Elegie di
Senofane, il maestro di Parmenide, quando annunciava la sua verità sul dio uno: «Or novellamente
intraprenderò un altro discorso (logos) e mostrerò la via», evidentemente la via della verità. In
Parmenide la connessione viene operata nella prima parte del suo poema, in cui è esposta la via
della verità; l'esposizione avviene utilizzando due termini che potrebbero apparire, a prima vista e
secondo una certa tradizione, incompatibili tra loro: logos e mythos. Ma analizziamo dapprima i
passi del Poema sulla natura.
Nel proemio, il discepolo, arrivato al cospetto di Dike, viene rassicurato che non un'infausta sorte lo
ha ivi condotto, ma legge divina e giustizia: «Bisogna che tu tutto apprenda: e il solido cuore della
Verità (aletheies) ben rotonda e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza» (fr. 1,
28-30). La dea è rivelatrice della verità e può quindi essere intesa anche come verità che si svela.
Nel fr. 2 la dea rivela i contenuti di questa verità:
Orbene, io ti dirò -- e tu ascolta e ricevi la mia parola (mython): quali sono le vie di ricerca che sole
si possono pensare: «l'una che "è" e che non è possibile che non sia. È il sentiero della Persuasione,
perché tien dietro alla Verità (aletheiei). L'altra che "non è" e che è necessario che non sia. E io ti
dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende (fr. 2, 1-5).
Il discorso di verità afferma che l'unica via percorribile è quella dell'essere. A questo punto, la dea
esorta il discepolo a mettere da parte i sensi e a indagare questa via con il logos:
Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono! Ma tu da questa via di ricerca
allontana il pensiero, né l'abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere
l'occhio che non vede, l'orecchio che rimbomba e la lingua, ma con la ragione (de logo) giudica la
prova molto discussa che da me ti è stata fornita» (fr. 7).
Rileviamo che il logos costituisce una modalità di conoscenza che si oppone ai sensi: al pari del
logos di Eraclito il logos di Parmenide consente di conoscere l'autentica realtà superando le
apparenze illusorie.
Vediamo cosa accade al logos intorno alla metà del V sec. a. C. Diogene Laerzio scrive che
Protagora «Fu il primo a sostenere che esistono su ogni argomento due argomentazioni (logoi)
contrastanti tra loro». Protagora afferma che non è possibile conoscere una verità certa e assoluta, in
quanto essendo possibile fare argomentazioni o discorsi contraddittori su ogni cosa, consegue che è
impossibile fare un unico discorso di verità. Protagora non crede più alla verità, ed è questo l'aspetto
rivoluzionario della sua opera. Questa concezione rappresenta una novità rispetto al pensiero del
mondo arcaico, in cui il sapiente è maestro di verità: il logos del saggio è logos di verità, e aletheia
è possesso sicuro perché rivelata direttamente dalla divinità.
Che l'opera di Protagora si contrapponga al sistema di idee anteriore, in particolare alla filosofia
eleatica, è confermato anche da quanto riferisce Porfirio quando dice che Protagora scrisse un'opera
contro i sostenitori dell'unico ente. In tal modo Protagora, negando l'unicità dell'essere e la
possibilità di effettuare un unico logos su di esso, è il primo filosofo in cui si manifesta un salto
teoretico radicale, dove muta non tanto la logica, quanto la credenza nella verità, ossia la possibilità
per l'uomo di una certezza e di una terra sicura.
Socrate nel Critone dichiara che il suo comportamento non è governato dall’opinione delle masse
ma da una parte di sé che chiama lògos. Mentre il discorso (lògos) “democratico” usato dai sofisti è
variabile, il lògos di cui parla Socrate non può mutare a seconda della contingenza temporale se non
si vuole ridurre a chiacchiera vuota e insignificante. Si legge infatti: «Io sempre sono stato tale da
non lasciarmi persuadere da nessun’altra cosa di me se non al lògos: a quello, dico, che ragionando,
mi sembri il lògos migliore» La ragione di Socrate è dunque una ragione individuale ma non
relativa: un discorso che si dimostra fondato deve essere radicato nella verità che ha caratteri di
universalità e immutabilità.
Platone riferendosi a un sapere definito come «credenza vera associata a un logos» identifica in
quest'ultimo tre diversi significati:
è l'espressione tramite suoni linguistici del pensiero
è l'enumerazione delle caratteristiche di una cosa
è l'individuazione della "differenza" (diaphorotes) di una cosa, vale a dire di quel particolare
segno che la differenzia da tutte le altre cose e la definisce nella sua realtà specifica
Da questi significati ne deriva che per Platone il logos filosofico va riportato nell'ambito del
discorso definitorio (il logos apophantikòs o dichiarativo, che serve a stabilire la verità o falsità di
una proposizione, di cui Aristotele si occuperà nella sua Logica).
Tra i vari significati di logos c'è anche quello di "giudizio". A questo proposito Aristotele, nel De
interpretatione, offre una definizione molto precisa, dicendo che il discorso (logos) "è un suono
della voce significativo, di cui è significativa ogni parte presa separatamente, come enunciazione e
non come affermazione" (De Int. 4, 16 b 26-28). Nell’opera sulla Politica, Aristotele afferma che
l'uomo, solo fra gli animali, ha il logos, la ragione. E il linguaggio vale a mostrare l'utile e il
dannoso, così come anche il giusto e l'ingiusto, perché questo è proprio degli uomini rispetto agli
altri animali: l'aver egli solo il senso del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto».
E' piuttosto singolare che questa definizione aristotelica dell'uomo, questo zoòn lògon èchon (che
significa, traducendo alla lettera, "animale dotato di parola", o per meglio dire: "animale dotato di
logos"), abbia dato origine all'altra famosa definizione "l'uomo è un animale razionale". Ma non era
questo che Aristotele intendeva. Aristotele voleva dire soltanto che, naturalmente, il logos è una
lotta per la razionalità. Ma l'uomo non è un essere razionale. E' invece, secondo questa famosa
definizione, un essere che parla, che muove la lingua - quella cosa così reale e così fisica che è la
lingua - e muovendola produce un suono semantico, dei suoni che creano comunità, che creano
polis, che creano uno spazio collettivo.
E' perciò interessante osservare che entrambe le grandi definizioni aristoteliche dell'uomo - animale
politico e animale dotato di logos - sono unite, perché sia la politica sia il possedere logos si
necessitano reciprocamente. Non esiste politica, non esiste reticolo collettivo, non esiste spazio di
intelligenza collettivo, gli uomini non potrebbero vivere in società, vivere in modo comunitario, se
non parlassero o, per meglio dire, se non comunicassero fra loro.
Se per Platone il logos era principalmente la manifestazione del pensiero, una vera e propria
"filosofia del logos" la si ritrova invece nello Stoicismo. Cleante, richiamandosi ad Eraclito, afferma
la dottrina del logos spermatikòs, la "ragione seminale", un principio vivente ed attivo (poioun) che
si diffonde nella materia inerte animandola e portando alla vita i diversi enti. Il logos è presente in
tutte le cose, dalle più grandi alle più piccole, dalle cose terrene sino alle stelle garantendo così
l'unità razionale dell'intero cosmo:
«[il logos] attraversa tutte le cose mescolandosi al grande come ai piccoli astri luminosi»
Esiste dunque un comune sentire (una συμπάθεια (sympatheia), "simpatia") universale, una legge
naturale seguendo la quale lo stoicismo insegna a «vivere conformemente alla natura».
Dal punto di vista fisico il logos è identificato col fuoco, che contiene in sé le diverse "ragioni
seminali" individuali. Alla fine dei tempi avverrà una conflagrazione che consumerà l'intero
universo, in cui però si salveranno le "ragioni seminali", per garantire la generazione del nuovo
mondo che sarà nuovamente arso secondo un andamento ciclico.
Il logos inteso come "calcolo" (ratio) e "discorso" (oratio) è mantenuto dallo stoicismo che
distingue tra il "discorso interiore" (logos endiathetos, oratio concepta) la riflessione razionale e il
"discorso profferito", il discorso parlato, (logos prophorikos, oratio prolata)
Plotino riprenderà questa teoria stoica delle ragioni seminali che sono presenti nell'anima del
mondo, ne spiegano i movimenti e fanno in modo che gli individui siano diversi tra loro.
Il Giudaismo alessandrino, con Filone Alessandrino come esponente, riprende il logos della
tradizione stoica incorporandolo nella sua teologia e connettendolo al tema biblico della "parola di
Dio", acquisendo la fisionomia di un agente quasi personale, cosciente, della volontà creatrice e
provvidente di Dio; la Parola a cui si unisce o sostituisce, con valore di sinonimo, la Sapienza. Per
Filone, che si rifà anche al Timeo di Platone, Dio è trascendente rispetto al mondo, e a far da
mediatore tra il primo e il secondo è proprio il Logos, fonte degli archetipi sulla cui base il mondo
viene modellato, costituendo da cornice e, in un certo senso, da sintesi a tutte le realtà intermedie: le
Idee, la Sapienza, gli angeli, lo Spirito e le potenze; il Logos, infatti è lo strumento con il quale Dio
ha fatto tutte le cose ed è la Luce divina offerta agli uomini. Nella dottrina di Filone si riconoscono
temi e concetti che poi torneranno nel Cristianesimo.
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο,
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ
γέγονεν
4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ
φῶς τῶν ἀνθρώπων·
5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
« In principio era il Logos
e il Logos era verso Dio
e Dio era, il Logos
Questi era in principio verso Dio.
Tutto è venuto ad essere
per mezzo di Lui,
e senza di Lui
nulla è venuto ad essere
di ciò che esiste.
In Lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini
e questa luce splende ancora nelle tenebre
poiché le tenebre non riuscirono ad offuscarla. »
L’avvento del cristianesimo: il Logos fatto Persona.
Nel Cristianesimo il logos compare all'inizio del Vangelo di Giovanni, dov'è coincidente con Dio
creatore e poi storicamente incarnato in Cristo e quindi negli uomini venendo ad «abitare in mezzo
a noi». Gli spunti del Vangelo di Giovanni trovano in seguito una loro conclusione nella definizione
dei due dogmi, quello della trinità e dell'incarnazione di Dio, formulati nel Concilio di Nicea.
Il termine "logos" in ambito cristiano è reso in italiano come "Verbo", riprendendo con un calco il
latino "verbum" o con "Parola".
Alcuni studiosi della Bibbia ritengono che Giovanni abbia usato il termine "logos" in una doppia
accezione: sia per rendere comprensibile agli ambienti ebraici, familiari, il concetto della divina
sapienza, sia per rimanere connesso con gli ambienti della filosofia ellenistica, dove il "logos" era
un concetto filosofico radicato da tempo.
Sant'Agostino insegnava che il Logos è prima di tutto relazione: «Come il Figlio dice relazione al
Padre, così il Verbo dice relazione a colui di cui è il Verbo».
Nella filosofia contemporanea spesso il termine "logos" è adoperato in senso generico opponendolo
al termine mythos. In questa opposizione il mythos corrisponde al pensiero mitico, basato sulle
immagini, sull'autorità della tradizione arcaica, su princìpi accettati e condivisi acriticamente,
mentre il logos corrisponde al pensiero critico, razionale e oggettivo, in grado di sottoporre al suo
vaglio credenze e pregiudizi.
Il termine logos compare come etimo di -logia, suffisso di moltissime parole le quali indicano
generalmente discipline e campi specifici di studio, come ad es. teologia, biologia, epistemologia.
In questo senso il termine può essere tradotto con "discorso razionale su..." o "ciò che si può dire di
ragionevole su..." (per replicare i quattro esempi succitati, le discipline indicherebbero ciò che è
riconosciuto come discorso ragionevole rispettivamente su Dio, il vivente, la conoscenza).
Etimologicamente quindi, le discipline stanno per il totale delle affermazioni riconosciute come
razionali (e quindi argomentabili secondo ragione) sul singolo campo studiato (specificato nel
prefisso).
I primi filosofi iniziarono le loro ricerche con l’obiettivo di giungere a conoscere la verità, mossi
dall’amore per la sapienza o desiderio di sapere (filo-sofia). In tal senso la verità si configura come
causa e fine della filo-sofia. Questa ricerca presupponeva che l’indagine razionale procedesse
attraverso un percorso (o metodo da metà-òdos=mediante una strada) che si concludeva quando il
lògos esistente nell’uomo impegnato nella ricerca giungeva ad essere adeguato a quello esistente
nella realtà (espressione del Lògos divino).
All’interno di questa nozione originaria di verità che si identifica con un corrispondentismo
spontaneo possiamo individuare due itinerari principali elaborati rispettivamente da Platone e
Aristotele.
1. Il primo consiste nel cercare la verità delle cose nell’anima razionale, che prima di cadere
prigioniera del corpo l’ha contemplata nell’iperuranio
2. Il secondo consiste nel cercare la verità nelle cose stesse, dal momento che essa non
sussiste in un mondo trascendente e separato ma è il fondamento immanente della realtà.
La via platonica intende la verità come idea, condizione trascendente di intelligibilità delle
cose, modello unificante della realtà molteplice, la via aristotelica intende la verità come
concetto che viene ricavato (mediante l’induzione) dalla realtà. Entrambe le vie giungono,
attraverso ulteriori elaborazioni, a Tommaso d’Aquino il quale le organizza in un’unica
prospettiva centrata sulla nozione giudaico-cristiana di creazione. Da una parte infatti,
nella concezione tommasiana, le idee esistono nell’intelletto divino e sono gli esemplari
secondo i quali Dio ha creato ogni essere. Dall’altra, le idee, una volta che sono incarnate
nelle realtà create come loro essenze, vengono astratte dall’intelletto umano, nel momento
in cui questo le conosce. Ciò significa che l’uomo, quando esercita la sua facoltà
conoscitiva, finisce per concepire le cose così come Dio stesso le aveva concepite prima di
crearle.
Da sottolineare che sebbene in Aristotele la verità esista formalmente nell’atto del giudizio
con cui l’intelletto afferma o nega qualcosa, permane il nesso inscindibile tra verità logica
e verità metafisica.
La via platonica verso la verità:
Le idee platoniche permangono immutabili nella loro essenza, non possono cioè essere
piegate dall’uomo per acquistare sensi diversi da quelli che esse possiedono in se stesse.
Ciò che rende possibile la conoscenza della verità delle cose è che le idee sono in rapporto
solo con se stesse, non subiscono trasformazioni, come invece accade per le cose
appartenenti al mondo sensibile.
L’uomo quindi conosce la verità delle cose a causa dell’impossibilità che le idee si
adeguino e si modellino sull’anima razionale. Di fronte alle idee l’uomo è completamente
passivo: le subisce nella loro struttura intelligibile e nei loro rapporti, quando le contempla
da semplice spettatore. Sono queste le ragioni per le quali Platone respinge la dottrina
protagorea della conoscenza fondata sull’affermazione: «L’uomo è misura di tutte le cose».
Due sono i punti da memorizzare:
1. Platone pone la misura delle cose al di fuori dell’uomo, nel Lògos divino.
2. Ciò che fa vero il pensiero è la sua adaequatio all’oggettiva immutabilità delle idee
e indipendenza dalle nostre sensazioni mutevoli.
In Platone emerge una tesi epistemologica fondamentale di tutta la filosofia
classica: il realismo metafisico e gnoseologico: la realtà ha in assoluto un essere
in sé, indipendente da noi. Le idee platoniche infatti non sono in alcun modo
“condizionate” dal rapporto con noi ma sono trascendenti, sciolte (ab-solutae) da
qualsiasi legame con il mondo del divenire. Secondo Platone, la ricerca della verità
intorno alle cose, non può prescindere da questa considerazione assoluta e l’anima
giungerà alla conoscenza della verità delle cose, quando, risvegliando il ricordo
(reminescenza)della propria contemplazione delle idee “subìta” in una vita
precedente, vi si adeguerà totalmente. È possibile a questo punto comprendere il
duplice significato della parola greca alètheia che deriva dal verbo lanthàno
(nascondo e dimentico): conoscere la verità significa:
a) vedere con l’intelletto ciò che è nascosto ai sensi
b) ricordare ciò che è stato dimenticato.
In sintesi che cos’è quindi per Platone la verità? È conoscenza dell’idea, mentre il
ricordo è la via per far riaffiorare l’idea nell’anima.
La teoria dell’adeguazione o “corrispondentismo” trova in Platone il suo primo
grande formulatore anche se l’accento è posto più sul modello metafisico
dell’adeguazione (l’idea) che sull’atto compiuto dall’intelletto (che è passivo
rispetto al modello metafisico).
La via aristotelica verso la verità
Il nucleo portante della concezione della verità in Aristotele consiste nel fatto che sia il
soggetto sia il predicato rimandano ad una realtà esterna all’intelletto e che funge da
misura nelle operazioni con cui l’intelletto conosce e giudica la cosa. L’enunciato non ha
la giustificazione della propria verità in se stesso, ma in qualcosa che è al di là di esso e che
esiste effettivamente nelle cose, le quali sono causa della sua verità. Che la realtà effettiva
sia causa della verità dell’enunciato è affermato da Aristotele in modo inequivocabile.
«Non perché noi ti pensiamo bianco tu sei veramente bianco – scrive nella Metafisica – ma
per il fatto che tu sei bianco, noi, che affermiamo questo, siamo nel vero». Un enunciato in
cui il soggetto e il predicato designano cose reali non è vero per il semplice fatto che è
corretto in se stesso quanto alla forma: ciò potrebbe valere per gli enunciati matematici: ma
è piuttosto ciò che è reale e non solo ciò che è pensato a far diventare un enunciato vero
oppure falso.
C’è per Aristotele tra intelletto e verità una specie di connaturalità, sulla quale S. Tommaso
calibrerà la nozione di verum poiché lo distingue concettualmente dagli altri trascendentali
per il suo rapporto con l’intelletto, come distinguerà il bonum per il suo rapporto alla
volontà. L’intelletto si porta mediante un movimento spontaneo verso la natura della cosa e
questo suo movimento, essendo naturale, è sempre retto (òrthos logos).
Che cosa si intende per “natura” o essenza di una cosa? Si intende ciò che appartiene in
senso proprio a ciascuna cosa, l’insieme delle attribuzioni possedute da un soggetto che
accompagnano il soggetto per tutto il tempo in cui esso rimane ciò che è.
È ciò che della cosa permane immutabile nel tempo. Esempio: si può legittimamente
parlare di natura umana o dell’essere uomo in quanto anche se un determinato soggetto si
corrompe, la sua natura si perpetua sempre identica in altri appartenenti alla medesima.
Detto più semplicemente: muore un uomo (particolare) non muore l’uomo come essere
umano.
Come già abbiamo visto per Platone anche per Aristotele sussiste un rapporto tra essenza e
verità: uno dei commentatori medievali di Aristotele – l’arabo Avicenna – definisce la
verità di ciascuna cosa come la proprietà del suo essere, che ad essa è stato determinato.
Dunque la cosa è misura dell’intelletto per mezzo della sua essenza (ad esempio: non posso
affermare come verità che Socrate, dal momento che è un uomo, ha becco e ali per volare).
La “rettitudine” della verità logica può essere colta solo dalla mente, in quanto il concetto,
che è il risultato di un’operazione dell’intelletto, è astrazione dell’essenza dalle singole
cose. L’intelletto, secondo Aristotele non può mai ingannarsi quando conosce – attraverso
l’attività congiunta dei sensi – le essenze delle cose: di contro all’argomentazione scettica
secondo cui i sensi ci ingannano, Aristotele sostiene che l’epistème comincia da una
positività, non da un dubbio radicale. Ad esempio: l’occhio vede il bastone spezzato
riflesso nell’ acqua, ma l’intelletto sa che è intero. Se non lo sapesse, non potrebbe dire che
i sensi ingannano. Al di là di ciò che i sensi vedono nelle cose nel loro perenne fluire e
mutare, al di là dei fenomeni con cui le cose si manifestano sensibilmente e che nello stesso
tempo fanno da schermo a ciò che esse sono nella verità del loro essere, ci dovranno essere
altre realtà, nascoste ai sensi e che l’intelletto è capace di vedere, sollevando il velo
dell’apparenza che le copre.
Avendo inserito le idee nelle cose, Aristotele è costretto a
considerare l’intelletto non più solo alla maniera platonica, cioè passivo di fronte agli
intellegibili, che sono i suoi propri oggetti. Affinché la verità gli si manifesti dietro quel
velo che la occulta ai sensi, l’intelletto deve essere anche attivo (intelletto agente), deve
eliminare tutto ciò che è soggetto a quel flusso perenne, di cui parlava Eraclito, spogliando
l’oggetto di quelle incrostazioni temporali, accidentali e particolari, per intus-legere (vedere
dentro) il sostrato della realtà stessa, dove risiede non soltanto il fondamento ontologico
della realtà naturale, ma anche il fondamento logico di ogni epistème. L’intelletto agente,
attraverso la sua attività astrattiva, porta alla luce il ciò che è (essenza) delle cose allo stato
di intelligibilità (comprensione-conoscenza). L’intelletto di Aristotele è attivo in quanto
agisce sulle rappresentazioni sensibili delle cose, fornitegli dai sensi, per adeguarle alla
propria natura intellegibile.
Due sono i punti da memorizzare:
1. La realtà esterna è misura del giudizio: questa definizione aristotelica della
verità colloca – rispetto alla via platonica della trascendenza – tutto il problema in
una dimensione umana universale, sulla quale ogni uomo può legittimamente
esprimersi e appare soggetta sia alla sua verificazione sia alla sua falsificazione. Da
questo metodo di riconoscimento della verità discende il paradigma sperimentale
della rivoluzione scientifica. (L’epistème o scienza coglie un aspetto particolare
della verità delle cose, ossia ciò che in esse si manifesta costantemente presente).
2. Per Aristotele non c’è conoscenza se l’intelletto non si adegua all’oggetto, se esso
cioè non acquista la stessa della forma dell’oggetto da conoscere. A causa di
quest’adeguazione l’oggetto, trasformato nel proprio del soggetto, acquista la
stessa natura universale e intelligibile del soggetto, mentre il soggetto, lo incorpora
in sé e fa proprie le proprietà dell’oggetto.
Schema riassuntivo su Platone:
1. All’elaborazione della dottrina delle idee Platone giunge tramite l’approfondimento della
questione gnoseologica generata dalla battaglia anti-sofistica e anti-scettica (passaggio dai
dialoghi della giovinezza a quelli della maturità). L’idea è:
a) Criterio di giudizio delle cose, dal punto di vista gnoseologico. (Ad esempio:
diciamo che due cose sono uguali sulla base dell’idea di uguaglianza).
b) Causa o condizione di esistenza delle cose, per partecipazione (metèssi) – per
imitazione (mìmesi) – per presenza (parusìa), dal punto di vista ontologico.
2. L’essere platonico è plurale o multiplo (pluralismo ontologico come quello di Leibniz),
diversamente dall’essere univoco parmenideo, che faceva della molteplicità un non-essere.
3. Il mondo sensibile dell’esperienza, contrariamente a quanto affermato da Parmenide, che lo
considerava non-essere, svolge un ruolo importante nella filosofia platonica: è infatti
l’esperienza sensibile a sollecitare continuamente il filo-sofo ad andare al di là di essa, per
scoprirne la legge, la logica, il senso. Nonostante ciò, per Platone merita il nome di scienza
(epistème) soltanto la conoscenza dell’universale (la forma), di ciò che trascende la
singolarità materiale delle cose (privilegiamento del metodo deduttivo e dimostrativo della
matematica e geometria, considerata da Platone una “sintassi del mondo”, soprattutto
nell’ultima fase dei dialoghi della vecchiaia, (dove si avverte una forte influenza del
pitagorismo). Delle cose empiriche non si può dimostrare come siano, le si può
semplicemente descrivere, essendo la verità in senso proprio riservata alla dimostrazione
logica.
4.
conoscere=ricordare→innatismo latente che necessita di un risveglio e di una presa di
coscienza. In questo senso la verità è qualcosa che l’uomo ricorda, in quanto si è offerta
all’anima umana durante la sua permanenza nell’iperuranio, prima di cadere prigioniera in
un corpo.
La verità per Platone quindi è:
a) Il risultato di un processo personale di ricerca (la verità abita nell’anima umana).
b) Qualcosa che trascende l’individuo, che gli si impone come un dato inconfutabile esterno
rispetto al soggetto che la cerca (metafora della luce del sole, che illumina dall’alto).
c) La radice immutabile delle cose in divenire, la loro essenza o èidos che sul piano
gnoseologico coincide con la definizione socratica.
Il linguaggio ordinario non fa altro che confermare la tendenza dell’uomo a cercare ciò che
unifica (esempio del “nome comune” in grammatica: esso si applica a una moltitudine di
oggetti, senza che nessuno di essi sia perfettamente identico all’altro. Ciononostante ci
sentiamo in diritto di chiamare tali realtà allo stesso modo. Senza nomi comuni non
saremmo neppure in grado di formulare, a noi stessi o agli altri, alcun discorso. In sintesi
non potremmo né comunicare, né conoscere). Qualsiasi atto di comunicazione e di
conoscenza, implica la tensione verso il riconoscimento di ciò che è identico nel diverso
(una radice immutabile).
Schema riassuntivo su Aristotele:
1) Secondo Aristotele ciò che costituisce l’essenza (forma) delle cose, il loro
fondamento può essere soltanto immanente ad esse, e mai al di fuori (trascendente)
cioè dotato di una sussistenza propria, separata dalla realtà empirica. Da Platone
Aristotele eredita la nozione di epistème come conoscenza certa, stabile e universale,
inaugurando però una sorta di empirismo metafisico che consiste nel partire dai dati
sensibili, scorgendo in essi l’essenza e l’esistenza delle cose (cioè realtà intelligibili)
→ dialettica fondazionale
2) Secondo Aristotele (che rifiuta la dottrina platonica delle idee e della preesistenza
delle anime), conoscere non significa “ricordare” ma primariamente sperimentare e
astrarre. Nella conoscenza umana egli distingue 3 operazioni fondamentali:
a) La semplice apprensione (con cui cogliamo la natura delle cose ed
elaboriamo i concetti)
b) Il giudizio (che pone in relazione i concetti tra loro)
c) Il raziocinio (con cui procediamo da giudizi già formulati ad altri da
formulare)
Da ciò consegue l’adozione di una diversa metodologia conoscitiva (l’induzione o
generalizzazione fondata sull’osservazione di un certo numero di casi particolari)
rispetto a quella platonica. Per condurre qualsiasi indagine sulla realtà e sulle sue
cause Aristotele ritiene necessario fissare dei criteri per stabilire la correttezza dei
ragionamenti (òrthos logos). Per questo lo studio della logica (che Aristotele chiama
analitica) ovvero la questione del metodo della conoscenza è propedeutico alla
comprensione dell’intera filosofia aristotelica. Tutta la logica aristotelica – ritenuta
spesso il capolavoro di Aristotele che con essa avrebbe scoperto le forme immutabili
e necessarie del ragionamento – si fonda sul primo principio logico della metafisica,
il principio di non contraddizione, che non può essere dimostrato (in quanto ogni
possibile dimostrazione lo deve necessariamente presupporre). Le parti dell’Organon
aristotelico trattano di oggetti che vanno dal semplice al complesso, cominciando dai
più semplici, cioè dagli elementi (cioè tutti i termini che non entrano in alcuna
combinazione,
perché
sono
considerati
isolatamente).
Di
questi
termini
(corrispondenti a dei concetti) non si può dire né che siano veri né che siano falsi,
giacché vera o falsa è solo una qualche combinazione di essi (per esempio “il cane
abbaia”). Aristotele li classifica nelle dieci categorie ontologiche (→ le categorie,
prima di essere dei concetti logici inerenti alla conoscenza, sono i modi di essere
della realtà, dotate cioè di un valore ontologico).
1) Sostanza
2) Quantità
3) Qualità
4) Relazione
5) Luogo
6) Tempo
7) Situazione
8) Avere
9) Agire
10) Subire
Se uniamo i termini tra loro affermando (o negando) qualcosa, otteniamo il giudizio
(che è l’atto con cui affermiamo (o neghiamo) un concetto in rapporto a un soggetto.
L’asserzione o proposizione = espressione logica del giudizio ed è, a differenza dei
termini, sempre vera o falsa.
Tema centrale degli Analitici primi: il legame tra proposizioni (sillogismo) o la
struttura del ragionamento (logica formale).
Tema centrale degli Analitici secondi: l’impiego del raziocinio nelle scienze
(distinzione tra il metodo dell’induzione e i diversi tipi di deduzione). La scienza è la
conoscenza certa di un fatto attraverso le sue cause.
Tema centrale dei Topici: rapporto tra dialettica e verità («L’interlocutore deve
esaminare la proposizione non solamente da un punto di vista formale e dialettico ma
anche in rapporto al contenuto». La dialettica aristotelica è ricerca della verità.
3) L’oggetto della fisica o filosofia del mondo in quanto mobile (per questo “filosofia
seconda”) è il movimento degli enti che costituiscono la realtà sensibile e delle cause
che lo generano. Osservando le sostanze del mondo empirico, Aristotele interpreta la
loro costituzione fisica attraverso le nozioni di materia (hyle) e forma (morphé).
La materia è l’elemento determinabile (suscettibile di determinazione) della sostanza
corporea.
La forma è invece l’elemento determinante, ciò che fa sì che quella sostanza sia di
quel genere; materia e forma sono cause intrinseche dell’essere della sostanza,
estrinseche invece sono la causa efficiente e la causa finale. Il divenire presuppone
il passaggio dalla potenza all’atto: non può esserci passaggio dalla potenza all’atto
se non esiste una forma che causi il movimento. Tale forma che causa il movimento
viene identificata da Aristotele con la natura stessa delle cose (entelècheia).
Quest’ultima è sia ciò che un ente è (causa formale) sia ciò che lo muove (causa
efficiente), sia il fine stesso cui tende (causa finale). Le cause (materiale, formale,
efficiente, finale) sono quindi i principi che sovrintendono e regolano il divenire
della natura.
4) La metafisica o filosofia prima è per Aristotele:
a) La scienza che ricerca le cause prime e i principi ultimi della realtà
b) La scienza che ha come oggetto l’essere in quanto essere
c) La disciplina filosofica che si occupa non degli accidenti degli enti ma
dell’ente in quanto sostanza (che è sinolo= unione di materia e forma)
d) Il sapere che arriva a dire qualcosa su Dio come fine ultimo
dell’universo.
La questione della filosofia prima è dunque stabilire il significato
dell’essere. La soluzione di Aristotele rappresenta uno sforzo per
garantire contestualmente senso al concetto di essere e realtà alla
molteplicità degli enti. Da un lato egli afferma che l’essere si dice in
molti modi e che tali significati sono quelli sintetizzati dalle categorie
esaminate nella logica. Dall’altro le categorie, pur essendo molteplici,
sono strettamente collegate tra loro in quanto rappresentano tutte
modalità diverse della sostanza. La domanda sul significato dell’essere è
dunque la domanda sul significato della sostanza. Perché sia possibile il
sinolo di materia e forma e si attivi il passaggio dalla potenza all’atto per
Aristotele è necessario pensare a una sostanza che sia da sempre in atto e
che si ponga come condizione di possibilità dell’esistenza dell’intero
cosmo.
Dal momento che non è possibile risalire all’infinito, bisogna giungere
necessariamente a una causa prima intesa come
Atto puro (forma pienamente attuata, priva di qualsiasi
potenzialità e di qualsiasi materialità)
Motore immobile (in quanto sostanza prima essa causa il
movimento dell’intero universo pur rimanendo immobile,
essendo il fine ultimo di tutto il reale)
Pensiero di pensiero (in continua e totale contemplazione di se
stesso. In lui non vi è passaggio da conoscenza in potenza a
conoscenza in atto, come accade nell’uomo).
Schema riassuntivo su Agostino:
Metafisica dell’interiorità: la matrice del pensiero agostiniano è prevalentemente
socratico- platonica.
La verità delle cose secondo Agostino non è creata dall’intelligenza umana ma dall’intelletto
divino (il Lògos). Il lume naturale della ragione→via d’accesso privilegiata alla verità→lo
ha infuso Dio in ogni uomo nel momento in cui l’ha creato. Da quel momento la verità abita
nell’intimo dell’uomo (innatismo latente = in interiore homine habitat veritas) e il redire in
se ipsum è lo strumento per portarla alla luce della coscienza.
In cosa consiste la dottrina dell’illuminazione?
Punto di vista gnoseologico (presenza della verità nella mente umana):
per Agostino conoscere=apprendere col pensiero un oggetto che non cambia. Una verità è
tutt’altra cosa dalla constatazione empirica di un fatto: è la scoperta di una regola da parte
del pensiero che vi si sottomette (ad esempio, se io vedo che 2+2=4, o che bisogna fare il
bene ed evitare il male, apprendo delle verità non sensibili ma puramente intellegibili, il cui
carattere fondamentale è la loro necessità. Necessarie, immutabili, eterne: questi tre attributi
si sintetizzano nell’aggettivo “vero”. La loro verità dipende dal fatto che esse possiedono
l’essere, perché soltanto ciò che veramente è, è vero. La presenza nell’anima di conoscenze
vere pone un notevole problema: come spiegarle? Sarei io stesso, la fonte delle mie
conoscenze vere? Ma io non sono meno contingente e mutevole delle cose, ed è proprio per
questo che per la ragione, la necessità del vero non è che il segno della sua trascendenza su
di lei. La verità è, nella ragione, al di sopra della ragione. C’è dunque nell’uomo qualcosa
che supera l’uomo (Blaise Pascal, molti secoli più tardi, riprendendo Agostino userà
l’espressione l’homme passe l’homme). E poiché è verità, questo qualcosa è una realtà
puramente intellegibile, necessaria, immutabile, eterna (cioè Dio).
Passaggio dalla teoria gnoseologica improntata ad un radicale e ben argomentato realismo e
corrispondentismo ad una metafisica essenzialistica. Agostino comprende che la verità
logica (quella cioè che l’intelletto può esprimere con i suoi giudizi) dipende totalmente dalla
verità ontologica (il Lògos o intelligibilità delle cose, create dall’Intelletto divino). L’uomo
dunque non crea la verità ma la scopre e tenta di esprimerla con l’intelletto e con le parole,
cercando sempre di conformarsi alla realtà delle cose (adaequatio intellectus ad rem). Scrive
Agostino a tale riguardo: «Se la verità (delle cose) fosse sullo stesso piano della nostra
mente, sarebbe anch’essa soggetta al divenire: infatti la nostra mente intuisce la verità a
volte di più e a volte di meno, il che dimostra che la nostra mente è soggetta al divenire,
mentre la verità permane sempre uguale a se stessa, e non aumenta quando ci si manifesta di
più, né diminuisce quando ci si manifesta di meno […]». La mente dunque riesce a capire la
realtà nella misura in cui si adegua alla verità delle cose la quale è immutabile. È riflettendo
su di sé e avvertendo acutamente l’esigenza della piena verità che l’intelletto scopre la causa
prima del suo essere, sorgente e forza per cercare e per raggiungere gradualmente la verità.
Dio=il Maestro interiore, il sole intellegibile alla cui luce la ragione vede la verità. Questa
realtà divina è vita della nostra vita, più interiore a noi stessi di quanto non lo sia il nostro
proprio intimo. È per questo che tutte le vie agostiniane verso Dio seguono itinerari
analoghi, dall’esterno all’interno e dall’interno al superno. Dio si presenta anche come una
verità contemporaneamente intima al pensiero e trascendente il pensiero. La sua presenza è
attestata da ogni giudizio vero, sia nella scienza, sia in estetica o in morale, ma la sua natura
stessa ci sfugge. Sebbene Dio sia ineffabile, tra tutti i nomi che gli si possono dare, ce n’è
uno che meglio degli altri lo designa, quello sotto il quale Egli stesso ha voluto farsi
conoscere dagli uomini, quando ha detto a Mosé: Ego sum qui sum. Egli è l’essere stesso
(ipsum esse), la realtà piena e totale (essentia) a tal punto che, strettamente parlando, questo
titolo di essentia conviene solo a Lui. Essere veramente, infatti, secondo Agostino, sulla scia
di Platone, significa essere sempre nello stesso modo: Dio solo è sempre lo stesso: Egli è
l’essere perché è immutabilità.
Poiché Dio è Intelligenza pura (Lògos), deve possedere in sé tutti gli intellegibili, cioè le
forme che saranno più tardi quelle delle cose, ma che non esistono ancora altro che nel suo
pensiero. Queste forme delle cose (che noi chiamiamo le Idee) preesistono in Dio stesso
come i modelli delle cose che saranno create e come gli oggetti della conoscenza divina.
Punto di vista metafisico: così come il Supremo Bene e il Supremo Essere sono una cosa
sola in Dio, Agostino, sulla scia del platonismo, identifica bene ed essere. Dio infatti,
essendo immutabilità, è la pienezze dell’essere, il bene assoluto e immutabile. Ciò significa
che il bene è proporzionale all’essere: questo rapporto di proporzionalità lo porta a negare
qualsiasi realtà di pienezza ontologica al male e quindi a negare l’esistenza di un principio
maligno contrapposto a Dio. Male=mancanza di essere o non-essere (non ha una sua propria
consistenza), una sorta di deficit metafisico, (mancanza di qualche qualità positiva richiesta
dalla natura di un ente) e non come un’entità in sé. Ciò permette di evitare lo smarrimento
della ragione di fronte al male. Agostino cioè capisce che il male non è all’origine del
mondo, non ha un potere illimitato, non può avere mai l’ultima parola, perché la prima e
l’ultima parola spettano a Dio creatore e provvidente. La creazione di Dio cioè può essere
deformata ma non distrutta dal male morale, che è il peccato della creatura libera e
responsabile. Le colpe morali derivano quindi dal cattivo uso che l’uomo fa del suo libero
arbitrio: è lui ad esserne responsabile, non Dio.
Punto di partenza dell’itinerario verso Dio→riconquista dell’interiorità personale (“anima”):
la predilezione di Agostino per l’analisi dei dati della vita interiore è senz’altro la nota
distintiva del suo grande genio: gli dobbiamo le Confessioni, questo libro unico che
sintetizza tutta la sua sapienza filosofica, dove ogni pagina ha la freschezza e il fascino della
vita. Nella percezione intellettuale del proprio mondo interiore – contraddistinto dal libero
arbitrio e dalla permanenza della verità – l’uomo coglie la differenza ontologica col
mondo esteriore (il mondo della materia, caratterizzato da una mutevolezza inconsapevole
e necessaria); ma questa differenza ontologica non porta Agostino a ritenere (come facevano
i neoplatonici, gli gnostici e i manichei) che la materia sia il male: egli, fedelmente alla
concezione antropologica cristiana riconosce che tutti gli enti materiali, in quanto partecipi
dell’essere, sono buoni, poiché l’esistenza (avere l’essere) è già di per sé il bene
fondamentale. Se percepisco il mondo delle cose materiali come imperfetto è perché la loro
bontà ontologica è limitata dalla mutevolezza e dal loro carattere partecipato. Soltanto
l’anima umana è capace di scienza e di coscienza e ritornando in se stessa può avere
coscienza anche della sua superiorità rispetto alla materia e della sua dipendenza metafisica
dall’Assoluto.
Dottrina agostiniana sull’armonia tra ragione e fede:
qual è in Agostino il compito della filosofia nei confronti della Rivelazione?
La filosofia viene configurata come una sapienza propedeutica alla fede. Agostino è il primo
ad enunciare in modo chiaro la dottrina circa i rapporti che intercorrono tra la ragione
filosofica e la fede nella rivelazione cristiana (esemplificata dal celebre motto: credo ut
intelligam, intelligo ut credam). Questa dialettica viene precisata da Agostino in modo
mirabile: si tratta di un atto della ragione che scopre in primo luogo nella ragione (il mondo
esterno e l’interiorità personale) la traccia del Dio trascendente e creatore, e poi riconosce
negli eventi dell’Incarnazione la credibilità di una rivelazione divina, riguardante i misteri
soprannaturali. La ragione meramente “naturale” e la ragione credente
sono forme di
razionalità entrambe e non avrebbe senso separarle o metterle l’una in opposizione con
l’altra.
Schema riassuntivo su Tommaso d’Aquino:
I principi della metafisica tommasiana:
Centralità dell’essere: «L’essere è più nobile di qualsiasi altro elemento che l’accompagni.
Perciò, in sede assoluta, l’essere è più nobile anche del conoscere […]». Tommaso ha,
rispetto a tutti gli altri filosofi precedenti, un concetto fortissimo (intensivo) dell’essere:
l’essere tutto racchiude e dall’essere tutto promana; gli enti sono partecipazioni dell’essere.
L’essere non è soltanto l’esse commune rerum (idea o nozione prima e generalissima
posseduta da ogni uomo e attribuibile a ogni esistente) ma è l’essere delle cose, la prima
notitia metafisica della realtà, la causa e il fondamento di ciò che è. Tommaso chiarisce
questo concetto spiegando che delle cose possiamo cogliere il che cos’è (l’essenza) ma
l’essenza non ci dice ancora nulla relativamente all’esistenza reale. Solo se un’essenza è
colta nell’atto d’essere ci troviamo di fronte a un ente realmente esistente. L’essere, in
quanto attualità di ogni forma, coincide con la perfezione di ogni cosa.
Tommaso, quindi scopre la chiave metafisica decisiva ignota ad Aristotele: la distinzione
tra essenza ed esistenza. Aristotele distingue nel divenire i principi metafisici di potenza e
atto e nell’essere le cause di materia e forma, ma soltanto l’Aquinate giunge all’elaborazione
della distinzione tra essenza ed esistenza. Quale percorso (metodo) lo conduce a questo
fondamentale traguardo?
È innanzitutto la Rivelazione di Dio creatore a permettergli di pensare la natura delle cose in
attesa di diventare esistenti. In altri termini, mentre la filosofia greca vede in Dio colui che
dà forma alla materia, Tommaso vede in Dio il creatore, l’esse visto come actus essendi.
L’essenza è semplicemente la natura di ciascuna cosa ma è potenza che limita il suo essere,
è come inerte e vuota se non interviene l’actus essendi, cioè l’esistenza intesa come
attuazione dell’essenza.
Tutte le cose che abbiano l’essenza distinta dall’esistenza richiedono una Causa Prima che
sia per sé, cioè un Essere in cui l’essenza e l’esistenza facciano una sola cosa (in un rapporto
di coincidenza o identità). Tommaso definisce Dio Ipsum Esse Subsistens (l’Essere per se
stesso sussistente, l’agostiniano e biblico (“Io sono Colui che è”). Le creature partecipano
dell’essere di Dio in quanto Dio (L’Essere come Persona) dona loro l’essere. Tra l’essere di
Dio e quello delle creature non può sussistere identità (Solo Dio è Atto puro o Essere
totalmente privo di potenzialità), ma neppure totale separazione. Per esplicitare il rapporto
che intercorre tra Creatore e creatura Tommaso recupera le nozioni platoniche di:
1. Mìmesi (che corrisponde all’analogia entis=distinzione ontologica e qualitativa tra
il piano della trascendenza e quello del mondo creato)
2. Metèssi (che corrisponde alla nozione agostiniana di partecipazione)
Per Tommaso partecipare significa→possedere il proprio essere e riceverlo da un altro
essere e il fatto di riceverlo da lui è proprio la prova che non ci si identifica con lui. Il
mondo nasce dall’essere senza che si sia prodotto nessun cambiamento nell’essenza divina.
I principi di gnoseologia:
Dal punto di vista gnoseologico nella creatura umana resta qualche bagliore affievolito del
raggio divino; dal momento che noi riconosciamo nelle cose la traccia dell’intellegibile che
ha presieduto alla loro formazione, vuol dire che noi partecipiamo ancora in qualche punto
dell’irradiazione di cui Dio è la fonte luminosa.
La funzione più alta dell’intelletto agente (che ogni anima umana possiede), è la conoscenza
dei principi primi; essi preesistono in noi allo stato potenziale e sono le prime concezioni
dell’intelletto.
Come per Aristotele, l’origine della nostra conoscenza è nei sensi; spiegare la conoscenza
umana significa definire la collaborazione che si stabilisce tra le cose materiali, i sensi e
l’intelletto. L’aristotelismo di Tommaso è una necessità teoretica, derivante dall’intuizione
metafisica dell’intelligibilità intrinseca del reale, a suo avviso, non sufficientemente
garantita dal platonismo (che è facilmente incline verso uno scetticismo relativo
all’intelligibilità del mondo materiale).
Il metodo della filosofia, secondo Tommaso si articola in due momenti principali:
1. Quello risolutivo (via ascendente dell’induzione)
2. Quello compositivo(via discendente della logica deduttiva).
Nella concezione tommasiana la filosofia ha come suo inizio un momento fenomenologico
(dall’esperienza nella quale tutti si riconoscono), ed è stato proprio questo criterio a ispirare
l’indagine metafisica di Tommaso che procede solo in un secondo momento (quando l’analisi
dell’esperienza gli ha fornito sufficienti informazioni circa alcune qualità degli enti con cui viene a
contatto) alla scoperta delle radici profonde, dei fondamenti: è il momento risolutivo, che si
conclude con la scoperta di Dio come causa prima trascendente, e quindi come Esse ipsum
subsistens (=l’essere stesso come Persona). Solo a questo punto può subentrare il momento
compositivo→la mente ripercorre il cammino in senso inverso per perlustrare i plessi che collegano
le radici della realtà con gli enti particolari.
La conoscenza per Tommaso→è il risultato di un processo astrattivo (già insegnato da Socrate e
approfondito da Aristotele, non, come per Agostino, il risultato di un’intuizione dell’azione di Dio
nel mondo a opera di una illuminazione divina. Nel processo conoscitivo è necessario rilevare la
connessione del momento intellettivo con la sensazione. La conoscenza cioè, non si identifica con la
sensazione, ma riconosce nell’esperienza sensibile il presupposto fondamentale perché sia possibile
l’apprensione dell’universale e la formulazione dei giudizi. La verità è→la visione intellettiva della
corrispondenza tra l’oggetto percepito dai sensi e il concetto che l’intelletto se ne fa, possedendone
la forma, che ha acquistato con la sua intelligibilità astrattiva; la verità è adaequatio intellectus ad
rem. Intelligere (leggere dentro), per Tommaso è sempre actus intellectus che si esplica in tre
momenti:
1. Nella semplice apprensione (che coglie direttamente l’essenza della cosa ma attinge
indirettamente l’essere della cosa)
2. Nel giudizio (che attinge direttamente l’essere come atto fondante la cosa)
3. Nel raziocinio (che consiste nell’indagare intorno alla cosa conosciuta, con l’obiettivo di
operare una scomposizione delle varie parti, proprietà, relazioni).
Tommaso riconosce esplicitamente i limiti della conoscenza intellettuale a contatto con le
realtà sensibili. Scrive infatti: «Vi sono deficienze che riscontriamo ogni giorno nella
nostra conoscenza. Ignoriamo infatti molte proprietà delle cose sensibili, e anche di quelle
apprese dai sensi non siamo in grado di scoprire perfettamente il perché dei molteplici
aspetti».
I rapporti tra ragione e fede:
Tommaso
D’Aquino
rappresenta,
nella
storia
della
filosofia,
il
coronamento
dell’armonizzazione tra ragione e fede: la luce della ragione e quella della fede provengono
entrambe da Dio, perciò non possono contraddirsi tra loro. Egli riconosce che la natura,
oggetto proprio della filosofia, può contribuire alla comprensione della rivelazione divina:
come la grazia suppone la natura e la porta a compimento, così la fede suppone e perfeziona
la ragione. La teologia ha bisogno della filosofia come interlocutrice per verificare
l’intelligibilità e la verità universale dei suoi asserti.
Sintesi sull’età moderna:
La cosiddetta età moderna si contraddistingue per una forte interazione tra società e filosofia
che assume quattro connotazioni principali:
1. Sviluppo della “nuova scienza” (Copernico, Keplero, Galileo, Newton, Bacone) →
centralità della matematica come “sapere certo” e privilegiamento, da parte di molti filosofi
del suo metodo, applicabile non soltanto alla fisica ma anche alla teoria della conoscenza
(mathesis universalis). L’egemonia dell’aristotelismo in campo fisico non viene meno nel
trapasso dal Medioevo all’Età moderna, anzi si rafforza nel ‘400 e nel ‘500: crolla
improvvisamente e definitivamente nel ‘600 sotto i colpi degli autori della cosiddetta
“Rivoluzione scientifica”, una volta sostituito l’eliocentrismo al geocentrismo. Si giunge
così a individuare nel procedimento tipico delle discipline logico-matematiche il modo più
rigoroso ed efficace per passare dai dati sperimentali alle leggi generali in grado di
descrivere la struttura dell’universo.
2. Perdita dell’unità religiosa (genesi del protestantesimo e conseguente crisi del rapporto tra
ragione e fede) e diffusione di una frammentazione politica (soprattutto in Italia e in
Germania) e conseguente sviluppo della riflessione filosofica sulla politica.
3. Allargamento dei “confini geografici” del mondo (scoperta del nuovo mondo e contatti con
le culture e civiltà extra-europee).
Schema riassuntivo su Cartesio:
Centralità della questione metodologica: secondo Cartesio, la filosofia scolastica, estranea
a quell’insieme di nuove teorizzazioni e di scoperte scientifiche ormai consolidate nel XVII
secolo, non può più reggere all’urto delle recenti “acquisizioni”: occorre una nuova filosofia
che superi lo scetticismo sulla base di una metafisica capace di esibire un metodo sicuro e
inoppugnabile. (Metafisica = radice di tutti i saperi scientifici)
Dal problema del fondamento del sapere dipende la solidità dell’edificio
che occorre
costruire al posto di quello aristotelico, sul quale poggiava allora tutta la tradizione
scientifica.
Nel Discorso sul metodo Cartesio espone quattro principi necessari a condurre ricerche che
diano vita a una forma di sapere caratterizzata dall’indubitabilità, chiarezza ed evidenza
(Verità=idee chiare e distinte)
1) L’adozione di un criterio puramente logico fondato sull’intuizione
2) La divisione di ogni problema nelle sue parti semplici, attraverso l’analisi
3) L’organizzazione dei pensieri partendo dagli oggetti più semplici per giungere alla
conoscenza dei più complessi, attraverso la sintesi
4) Il controllo della completezza dell’analisi e la revisione generale attraverso
l’enumerazione
Metodo dell’immanenza gnoseologica: ciò che Cartesio designa come il semplice è
→l’idea di nature semplici, non più – come nella filosofia classica e realista – l’universale;
ciò che designa come intuizione è →intuizione del pensiero come atto cogitativo, non più la
semplice apprensione o il corrispondente dell’astrazione. L’universale e l’astrazione
vengono cioè soppiantati dalle idee di nature semplici e dall’atto intuitivo. La conoscenza,
secondo il metodo cartesiano, deve procedere di certezza in certezza, partendo da idee chiare
e distinte e da principi logici evidenti; il modello dell’evidenza è l’autotrasparenza del
pensiero a sé stesso.
Significato del dubbio “metodico”: non si tratta del dubbio sistematico e definitivo che
caratterizza lo scetticismo→in Cartesio il dubbio è praticato con l’obiettivo di superarlo, per
questo è strumento metodologico o “passaggio obbligato e provvisorio, per giungere a una
certezza che sia “fondata”. Quando invece parliamo di dubbio iperbolico ci riferiamo a quel
dubbio che viene esteso a tutte le certezze abituali e ordinarie, senza escludere quelle
certezze che tutti ritengono indubitabili. Il sapere matematico sembra una costruzione
apparentemente inconfutabile (Ad esempio che 2+2=4 è vero in qualsiasi luogo e
circostanza), ma Cartesio si domanda se non sia anch’esso un abbaglio. Scrive infatti: «Io
suppongo che vi sia non già un vero Dio, che è fonte sovrana di verità, ma un certo genio
maligno, non meno astuto e ingannatore che potente, che abbia impiegato tutta la sua
industria a ingannarmi». Ammessa questa ipotesi, non c’è settore del sapere che regga,
niente resiste alla forza corrosiva del dubbio. Una volta fatta tabula rasa di tutte le certezze,
Cartesio pensa di aver scoperto che ogni uomo può trovare nella propria mente l’unica
certezza capace di resistere al dubbio, “primo principio della filosofia”, passato alla storia
nella formulazione latina: cogito, ergo sum.
Considerazioni sul cogito cartesiano:
1. L’assoluta certezza del cogito deriva dal nesso logico evidente che unisce l’atto di
pensare e l’esistenza di un soggetto del pensare o di una realtà pensante (res cogitans).
2. Carattere logico e non empirico di questa certezza che consente a Cartesio di costituire
un sistema filosofico modellato sulla matematica, strutturata su elementi puramente
logici, privi di quella precarietà e di quella incertezza (→metafisica del divenire) che
contraddistinguono invece i dati dell’esperienza di vita.
3. Il cogito è una certezza di tipo riflessivo, ossia una riflessione della coscienza sui suoi
contenuti, e non sulla res in quanto tale (Da qui la comune derivazione da Cartesio sia
del razionalismo di Spinoza e di Leibniz e dell’empirismo di Locke e di Berkeley. In
entrambi i casi infatti si tratta di filosofie che partono da contenuti di coscienza o da
rappresentazioni, che per i razionalisti sono concetti mentre per gli empiristi sono
sensazioni).
4. L’intuizione del cogito non è apprensione dell’essere dell’io che pensa ma ci fa cogliere
l’io come pensiero in atto, con una consistenza limitata all’atto (per questo res cogitans).
5. D’ora in poi la filosofia – a parte rare eccezioni – non vorrà più essere “scienza
dell’essere”, bensì scienza del pensiero, conoscenza riflessiva dei meccanismi logici
della conoscenza stessa (il sistema di Hegel rappresenterà con il panlogismo il termine
finale, l’espressione più coerente di questo paradigma filosofico).
La “funzione logica” dell’esistenza di Dio: L’esistenza di Dio è più certa della stessa
esistenza del mondo: anzi la considera come la garanzia della verità di tutte le idee chiare e
distinte. Queste ultime infatti sono vere proprio perché ci vengono da Dio, il quale, essendo
perfetto, deve essere anche verace e quindi non può aver immesso in noi idee false. Le idee
chiare e distinte (che sono poi le idee della matematica) sono state date da Dio alla nostra
ragione nel momento in cui ci ha creati, cioè sono idee innate, e queste sole sono vere.
Schema riassuntivo su Giambattista Vico
Nel De antiquissima Italorum sapientia Vico, considerando il linguaggio come oggettivazione del
pensiero, è convinto che dall'analisi etimologica di alcune parole latine si possano rintracciare
originarie forme del pensiero: applicando questo originale metodo, Vico risale ad un antico sapere
filosofico delle primitive popolazioni italiche. Il fulcro di queste arcaiche concezioni filosofiche è
la convinzione antichissima che « Per i Latini il "vero" e i "fatto" sono reciproci, ossia, come come
afferma il volgo delle scuole, si scambiano di posto. »che cioè «il criterio e la regola del vero
consiste nell'averlo fatto»: per cui possiamo dire ad esempio di conoscere le proposizioni
matematiche perché siamo noi a farle tramite postulati, definizioni, ma non potremo mai dire di
conoscere nello stesso modo la natura perché non siamo noi ad averla creata. Conoscere una cosa
significa rintracciarne i principi primi, le cause, poiché, secondo l'insegnamento aristotelico,
veramente la scienza è «scire per causas» ma questi elementi primi li possiede realmente solo chi li
produce, «provare per cause una cosa equivale a farla».
Le obiezioni a Cartesio: Il principio del verum ipsum factum non era una nuova ed
originale scoperta di Vico ma era già presente nell'occasionalismo, nel metodo baconiano
che richiedeva l'esperimento come verifica della verità, nel volontarismo scolastico che,
tramite la tradizione scotista, era presente nella cultura filosofica napoletana del tempo di
Vico. La tesi fondamentale di queste concezioni filosofiche è che la piena verità di una cosa
sia accessibile solo a colui che tale cosa produce; il principio del verum-factum, proponendo
la dimensione fattiva del vero, ridimensiona le pretese conoscitive del razionalismo
cartesiano che Vico inoltre giudica insufficiente come metodo per la conoscenza della storia
umana, che non può essere analizzata solo in astratto, perché essa ha sempre un margine di
imprevedibilità. Vico però si serve di quel principio per avanzare in modo originale le sue
obiezioni alla filosofia cartesiana trionfante in quel periodo. Il cogito cartesiano infatti potrà
darmi certezza della mia esistenza ma questo non vuol dire conoscenza della natura del mio
essere, coscienza non è conoscenza: avrò coscienza di me ma non conoscenza poiché non ho
prodotto il mio essere ma l'ho solo riconosciuto. « L'uomo, egli dice, può dubitare se senta,
se viva, se sia esteso, e infine in senso assoluto, se sia; a sostegno della sua argomentazione
escogita un certo genio ingannatore e maligno...Ma è assolutamente impossibile che uno non
sia conscio di pensare, e che da tale coscienza non concluda con certezza che egli è. Pertanto
Descartes svela che il primo vero è questo: "Penso dunque sono" ». Il criterio del metodo
cartesiano dell'evidenza procurerà dunque una conoscenza chiara e distinta, che però per
Vico non è scienza se non è capace di produrre ciò che conosce. In questa prospettiva,
dell'essere umano e della natura solo Dio, creatore di entrambi, possiede la verità. Mentre
quindi la mente umana procedendo astrattamente nelle sue costruzioni, come accade per la
matematica, la geometria crea una realtà che le appartiene, essendo il risultato del suo
operare, giungendo così a una verità sicura, la stessa mente non arriva alle stesse certezze
per quelle scienze di cui non può costruire l'oggetto come accade per la meccanica, meno
certa della matematica, la fisica meno certa della meccanica, la morale meno certa della
fisica. « Noi dimostriamo le verità geometriche poiché le facciamo, e se potessimo
dimostrare le verità fisiche le potremmo anche fare »
Mente umana e mente divina: « I latini... dicevano che la mente è data, immessa negli
uomini dagli dei. È dunque ragionevole congetturare che gli autori di queste espressioni
abbiano pensato che le idee negli animi umani siano create e risvegliate da Dio [...] La
mente umana si manifesta pensando, ma è Dio che in me pensa, dunque in Dio conosco la
mia propria mente. » . Il valore di verità che l'uomo ricava dalle scienze e dalle arti, i cui
oggetti egli costruisce, è garantito dal fatto che la mente umana, pur nella sua inferiorità,
esplica un'attività che appartiene in primo luogo a Dio. La mente dell'uomo è anch'essa
creatrice nell'atto in cui imita la mente, le idee, di Dio, partecipando metafisicamente ad
esse.
L'ingegno:Imitazione e partecipazione alla mente divina avvengono ad opera di quella
facoltà che Vico chiama ingegno che è «la facoltà propria del conoscere...per cui l'uomo è
capace di contemplare e di imitare le cose». L'ingegno è lo strumento principe, e non
l'applicazione delle regole del metodo cartesiano, per il progresso, ad esempio, della fisica
che si sviluppa proprio attraverso gli esperimenti escogitati dall'ingegno secondo il criterio
del vero e del fatto. L'ingegno dimostra, inoltre, i limiti del conoscere umano e la
contemporanea presenza della verità divina che si rivela proprio attraverso l'errore: « Dio
mai si allontana dalla nostra presenza, neppure quando erriamo, poiché abbracciamo il falso
sotto l'aspetto del vero e i mali sotto l'apparenza dei beni; vediamo le cose finite e ci
sentiamo
noi
stessi
finiti,
ma
ciò
dimostra
l'infinito. »(Giambattista Vico, De antiquissima, 6)
che
siamo
capaci
di
pensare
Il sapere metafisico: Contro lo scetticismo Vico sostiene che è proprio tramite l'errore che
l'uomo giunge al sapere metafisico: Il chiarore del vero metafisico è pari a quello della luce,
che percepiamo soltanto in relazione ai corpi opachi...Tale è lo splendore del vero metafisico
non circoscritto da limiti, né di forma discernibile, poiché è il principio infinito di tutte le
forme. Le cose fisiche sono quei corpi opachi, cioè formati e limitati, nei quali vediamo la
luce del vero metafisico. » (Giambattista Vico, De antiquissima, 3). Il sapere metafisico non
è il sapere in assoluto: esso è superato dalla matematica e dalle scienze ma, d'altro canto, «la
metafisica è la fonte di ogni verità, che da lei discende in tutte le altre scienze.» Vi è dunque
un "primo vero", «comprensione di tutte le cause», originaria spiegazione causale di tutti gli
effetti; esso è infinito e di natura spirituale poiché è antecedente a tutti i corpi e che quindi si
identifica con Dio. In Lui sono presenti le forme, simili alle idee platoniche, modelli della
creazione divina. « Il primo vero è in Dio, perché Dio è il primo facitore (primus Factor);
codesto primo vero è infinito, in quanto facitore di tutte le cose; è compiutissimo, poiché
mette dinanzi a Dio, in quanto li contiene, gli elementi estrinseci e intrinseci delle cose »
Schema riassuntivo su Kant:
Nel pensiero di Kant (→criticismo) confluiscono il razionalismo di matrice cartesiana e
l’empirismo scettico di Hume.
Il criticismo o la filosofia trascendentale è→la scienza che indaga il nostro modo di
conoscere i fenomeni, il sistema filosofico che si occupa della valutazione critica dei
principi che strutturano il processo di conoscenza.
Secondo la definizione kantiana trascendentale è→ogni conoscenza che si occupa del
nostro modo di conoscenza degli oggetti, delle condizioni di possibilità del sapere.
Come già sottolineato nelle lezioni precedenti, la gnoseologia realista pre-cartesiana
“parametrava” la verità conoscitiva sul criterio della adeguatezza oggettiva→il paradigma
della adaequatio rei et intellectus fa consistere la verità di un enunciato nel fatto di
riprodurre in modo speculare la realtà cui si riferisce. In cosa consiste la rivoluzione
copernicana attuata da Kant? Egli ha impresso una svolta indelebile nella filosofia moderna
identificando il criterio di verità di un giudizio nella universalità soggettiva→le funzioni
della mente sono comuni a tutti gli uomini. Tale rivoluzione –operata già in precedenza da
Cartesio e portata a compimento da Kant – trasforma il paradigma originario della filosofia
che si fondava sull’intenzionalità metafisica tra soggetto e res (realtà intellegibile), facendo
perno sul soggetto conoscente, che filtra i caratteri della realtà oggettiva, e li sintetizza con
le caratteristiche a priori, specifiche dell’intelletto umano.
Fenomeno = oggetto di conoscenza→la realtà non così com’è in sé (noumeno) ma sempre
filtrata attraverso le forme a priori della conoscenza (spazio, tempo, dodici categorie) che
organizzano e sintetizzano i dati dell’esperienza e la rendono intellegibile. Diversamente dal
realismo metodico della filosofia classica, ogni nostra conoscenza comincia sì con
l’esperienza, ma quest’ultima non ci fa accedere direttamente alla realtà così come essa è in
se stessa ma ci presenta la realtà “mediata” o filtrata dalla sintesi trascendentale. Nella
sensazione cioè i contenuti dell’esperienza sono sempre spazio-temporalizzati, pertanto non
come sono in se stessi, bensì nella forma “fenomenica” risultante dalle condizioni strutturali
della “recettività” (=spazio e tempo o forme pure a priori della sensibilità).
Il bisogno di fondare l’universalità della conoscenza, pur tenendo presenti le riserve espresse
dall’empirismo e dallo scetticismo, induce Kant all’elaborazione del suo sistema critico,
esposto nella Critica della ragion pura (che analizza le condizioni di possibilità
dell’intelletto di raggiungere conoscenze universali e fondate sull’esperienza, attraverso la
formulazione dei giudizi sintetici a priori ≠ sia dai giudizi analitici (o esplicativi) a priori,
sia dai giudizi sintetici (o ampliativi) a posteriori. Cosa contraddistingue questo tipo di
giudizi?
a) Il carattere di sintesi che conferisce estensione alla conoscenza (come nei giudizi
ampliativi)
b) Il carattere di apriorità che conferisce universalità e necessità alla conoscenza (come nei
giudizi esplicativi che sono interamente regolati dal principio di non contraddizione)
La Critica della ragion pura è suddivisa in tre parti:
1) L’estetica trascendentale (che ricerca le condizioni a priori della sensibilità→dal greco
àisthesis = sensazione). Lo spazio e il tempo, come forme pure a priori dell’intuizione
sensibile sono le condizioni della recettività: né sono concetti innati, né derivano dal
contenuto delle percezioni, anzi lo rendono intellegibile alla mente. Più precisamente lo
spazio = forma della nostra sensibilità esterna (determina la figura degli oggetti, la
grandezza e i rapporti reciproci), la sola mediante la quale l’uomo (universalmente) ha
intuizione di oggetti sensibili. Il tempo = forma che consente l’intuizione dell’unitarietà,
simultaneità e successione degli eventi.
2) L’analitica trascendentale (che ricerca e determina le forme a priori del giudizio)→ è la
parte della Logica che tratta degli elementi a priori della conoscenza intellettiva che
Kant identifica con i concetti puri a priori (12 categorie o funzioni mediante le quali
l’intelletto unifica le percezioni≠dagli aristotelici modi d’essere della realtà; il sistema
delle categorie si articola su tre per ciascuno dei seguenti gruppi: qualità, quantità,
relazione, modalità). Scrive Kant nell’Analitica: «La validità oggettiva delle categorie,
come concetti a priori, si fonda sul fatto che l’esperienza è possibile soltanto attraverso
di esse […] solo mediante esse può essere pensato un qualsiasi oggetto dell’esperienza».
Io penso o appercezione trascendentale→è la particolare funzione dell’intuizione e
dell’intelletto che sta alla base di ogni conoscenza possibile. È la coscienza di un’identità
che unifica, rappresentandosele, le molteplici realtà esterne. Essa costituisce la garanzia
dell’universalità della conoscenza perché è una e medesima in tutti gli uomini. Kant è
distante dal’idealismo tedesco in quanto tiene sempre a precisare che l’Io penso o
appercezione trascendentale non è realtà in sé, capace di produrre i propri contenuti, ma
condizione della determinazione trascendentale dei fenomeni e chiude così ogni
equivoca analogia con le teorie fichtiane circa l’Io come autocoscienza creatrice. È più
corretta
l’attribuzione
a
Kant
di
una
prospettiva
trascendentalistica
o
immanentistica→che equivale ad assegnare centralità alla ragione nella fondazione della
verità (da questo punto di vista il Criticismo rappresenta lo sviluppo più coerente della
tradizione cartesiana).
3) La dialettica trascendentale (che discute le idee a priori della ragione). Diversamente
dall’intelletto, che è facoltà attiva della conoscenza solo del mondo fenomenico,
(attraverso la sintesi del materiale empirico con le forme pure dell’intuizione e le dodici
categorie), la ragione estende indebitamente le categorie oltre l’uso proprio, unificando
tutte le caratteristiche di un’idea, senza riferimento all’esperienza (ad esempio unifica
una molteplicità di esperienze interiori, dando vita all’idea di anima). Kant definisce
l’idea prodotta dalla ragione come un’elaborazione razionale, riferita a una molteplicità
di fenomeni, di cui non si può avere un’intuizione precisa perché risponde all’esigenza
di raggiungere l’incondizionato, e di trascendere il mondo dell’esperienza. Le idee
pertanto
possono svolgere soltanto un “uso regolativo” (=indicare all’uomo la via
dell’unificazione delle conoscenze fenomeniche, tenendo viva nell’intelletto l’esigenza
di un sapere superiore) e non conoscitivo-concettuale come i giudizi dell’intelletto.
La dialettica non è una forma scientifica di sapere, perché il suo strumento principale –
il sillogismo dialettico – è un’arte sofistica, iper-fisica, cioè priva di riferimenti empirici,
al mondo dell’esperienza. Essa può solo dimostrare l’impossibilità di questo tentativo
attraverso le antinomie generate dalle tre idee fondamentali prodotte dalla ragione:
1) L’idea di Dio (oggetto della teologia naturale)
2) L’idea dell’anima immortale (oggetto della psicologia razionale)
3) L’idea del mondo (oggetto della cosmologia).
Schema riassuntivo su Hegel:
Hegel inaugura una nuova concezione dell'Assoluto, in grado di risolvere le aporie delle
metafisiche precedenti, incapaci secondo lui di spiegare perché Esso abbia bisogno di
generare la molteplicità. Egli Lo concepisce come l'Uno di Plotino in senso rovesciato:
mentre quest'ultimo restava collocato su un piano mistico e trascendente, a partire dal quale
generava il divenire e si disperdeva nel molteplice senza una ragione apparente, l'Assoluto
hegeliano entra nel divenire per rendere ragione di sé. La molteplicità serve, dunque, all'Uno
per poter diventare alla fine consapevole di sé, per riconoscersi, attraverso vari passaggi, in
se stesso.
La prospettiva plotiniana, dove la consapevolezza che l'Uno ha di sé era posta all'origine e si
affievoliva man mano che esso si sperdeva nel molteplice, risulta così capovolta: per Hegel
l'Uno si trova all'inizio disperso nel molteplice e prenderà coscienza di sé solo alla fine,
acquistando concretezza nel suo percorso mondano.
Questa nuova concezione comporta il sovvertimento della logica di non-contraddizione,
dato che l'Uno viene ora a coincidere con il suo contrario, cioè con la molteplicità.
L'Assoluto hegeliano non è più qualcosa di statico, che si trovi già «in sé e per sé», ma è un
divenire, un essere per sé, la cui verità scaturisce da una dimostrazione dialettica, anziché
essere posta con un'intuizione originaria. In Hegel certezza e verità tornano a coincidere,
così come pensiero ed essere, ma in forma mediata (dalla ragione).
La filosofia di Hegel intende attuare l’unità di finito e infinito, attraverso la coscienza di sé
che L’assoluto raggiunge proprio attraverso la filosofia che è scienza della logica, ossia
conoscenza piena della dialettica con cui si dispiega la storia dello spirito: esso è prima
“spirito soggettivo” (è il soggetto trascendentale come conoscenza, volontà e libertà), poi
“spirito oggettivo” (è il soggetto che si identifica con l’autorità sociale: diritto, moralità ed
eticità), infine “spirito assoluto” (piena auto rivelazione dell’Idea: arte, religione e filosofia
che esprimono, rispettivamente con immagini e con sentimenti, quello che la filosofia
esprime in modo perfetto e compiuto, con “concetti”.
Identità tra essere e pensiero: Hegel, come già Fichte prima di lui, parte dall’ideale
razionalistico cartesiano di realizzazione di una scienza assoluta e totale, fondata sulla
coscienza intellettiva. Il sistema di Hegel si definisce pertanto come panlogismo (tutto ciò
che è reale è razionaìle) e come storicismo (tutto è divenire, storia, processo dialettico).
Filosofia = perfetta autocoscienza della storia universale dello spirito.
Sin dagli scritti teologici giovanili Hegel si oppone energicamente al cosiddetto "principio
del nord", a quella separazione tra ideale e reale che era tipica del kantismo e che non
lasciava spazio alla conoscenza del Reale, inteso questo come l'Intero dal quale la Ragione
traeva il suo senso e il suo perché. Per Hegel il presupposto della verità della conoscenza è
un monismo assoluto di forme spirituali che si evolvono e si assolutizzano in un'unicità
diveniente continua, dove il materiale e lo spirituale sono indistinguibili e connessi in un
continuo superamento di "momenti" necessari del divenire storico per mezzo di una
fenomenologia dove ciò che è posto trova la sua negazione e poi il suo superamento in una
nuova figura (o appunto "fenomeno").
La separazione tra ideale e reale, tra cielo e terra, ebbe luogo, secondo Hegel, con l'avvento
del pensiero ebraico e con il successivo pensiero cristiano. La religione cristiana, derivata da
quella ebraica, aveva staccato il senso della propria vita dalla vita stessa, ponendolo al di
sopra della terra, in un dio lontano posto in cielo. Dio non apparteneva più all'intima natura
delle cose, com'era, per esempio, presso gli antichi Greci, ma veniva scisso dal mondo;
l'uomo così, lasciato al suo destino, viveva in uno stato, per così dire, di minorità dal quale,
attraverso il senso del peccato e l'insoddisfazione per la propria esistenza, sentiva il bisogno
di ricongiungersi con il senso vero delle cose. Con il cristianesimo era nato perciò quel
senso di frustrazione e di pena, di infelicità concettuale nella "scissione", che per
millesettecento anni aveva impedito di capire il vero senso dello Spirito. Hegel definisce tale
stato di scissione o alienazione "Coscienza infelice". Quest'ultima è una situazione
necessaria che serve all'uomo per ricercare quel senso dell'armonia perduta, per creare in lui
la consapevolezza della propria esperienza tragica, la quale si risolve nell'aspirare alla
riconciliazione finale con Dio, in una sorta d'armonia dinamica, con lo stesso significato che
ne aveva dato Platone nel Sofista, quando si trovò a definire la Dialettica come rapporto
dell'unità con la molteplicità. L'atteggiamento di Hegel si pone allora come una negazione
del cristianesimo ma anche come suo assorbimento nel procedere storico.
È su questa strada speculativa che si determina la nuova definizione dell'Assoluto come
unione di finito ed infinito ma anche come non-unione, opposizione di finito ed infinito e
immanenza dell'Assoluto nel mondo. Questa concezione può sembrare, quindi, simile alla
visione spinoziana dell'assoluto che coincide con la natura del Deus sive Natura; ma
Spinoza intende una coincidenza statica di sostanza come assoluto con la natura mentre per
Hegel è soggetto spirituale in divenire ovvero egli afferma che la realtà non è sostanza,
qualcosa d'immutabile ma soggetto in continuo divenire.
La Fenomenologia dello spirito cerca di spiegare la storia del pensiero, attraverso un
divenire, nel tempo e nelle epoche, dell'esperienza della coscienza, che Hegel intese come
sottotitolo alla sua opera e che meglio inquadra il suo testo. L'opera descrive i tre momenti
che, nella storia, hanno caratterizzato la cultura umana e che si ripetono continuamente nella
vita di ciascun individuo, con l'intento di dimostrare, laddove ce ne fosse bisogno, la
contemporaneità del modello astratto e del modello concreto, affinché, attraverso i fatti della
storia, possa dispiegarsi, rendendo conto di sé, il divenire dello Spirito.
1. La prima posizione che lo Spirito ha assunto nella storia è quella dello stato ingenuo
dell'armonia originaria, rappresentata dai Greci, dove le forze del dio erano presenti
nella natura stessa delle cose, un aspetto del pensiero che contraddistingueva anche le
religioni più primitive (animismo).
2. Il secondo momento è quello della scissione dal dio, introdotto dalla religioni
abramitiche; Dio si manifesta all'uomo, ma, attraverso il peccato originale, opera la
scissione; l'uomo, come un angelo caduto, sperimenta l'angoscia e il dolore nella Valle di
lacrime che il Padre celeste ha posto per lui: è il Medioevo, l'età che precede la
modernità fino a Kant.
3. Il terzo momento è scandito dall'avvento della Ragione, lo Spirito si eleva ad una
consapevolezza compiuta, conscio della tristezza della scissione, vuole riconciliarsi con
il mondo, diventa così Autocoscienza, la presenza attiva di uno Spirito nel mondo che si
riconcilia con il mondo stesso, è, dunque, lo Spirito infinito, non più rappresentato dalla
sostanza che è posta staticamente al di sotto delle cose, ricoperte dalla loro apparenza
fenomenica. La realtà è Soggetto, attività e automovimento.
Non sono le cose che procedono dall'Assoluto, ma l'Assoluto è questo stesso procedere. Da
ciò se ne deduce che per Hegel la Realtà è infinita, è un Soggetto che tiene i fili della storia e
che parla attraverso i suoi uomini, quegli uomini che la storia l'hanno sempre fatta in prima
persona, che come strumenti nelle mani di questo ineluttabile essere supremo, ne operano il
naturale svolgimento. Cosicché le vicende del mondo non sono estranee alla storia dello
Spirito perché la storia del mondo è la storia stessa di Dio, è la storia dell'avvento dello
Spirito, del realizzarsi della Ragione. Secondo questa prospettiva, lo sviluppo della realtà è
ragione in movimento. Tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale
(nel senso che è inconcepibile che nella realtà ci sia qualcosa di refrattario al pensiero,
qualcosa di estraneo ad esso).
Allora la logica, che studia i processi del pensiero, troverà la sua corrispondenza nella
metafisica, che studia i processi della realtà. Una delle colpe di Kant è stata quella di avere
privato con il criticismo il popolo tedesco della metafisica, ma un popolo senza metafisica è
come «un tempio senza santuario». Bisogna restituire alla speculazione la metafisica
identificandola con la logica.
La logica hegeliana vuole presentarsi come la logica del concreto opponendosi a quella
aristotelica, logica dell'astratto, che coglie la realtà nella sua struttura formale, che astrae dal
contenuto. È una logica quella aristotelica che esprime un pensiero che astrae dalla vita.
Hegel realizza, in questo percorso della Ragione, l'unità di forma e contenuto; la vita intesa
non più come astrazione formale, con un insieme di nozioni tra loro isolate, ma compresa in
un suo sviluppo interno. Hegel riconosce nel pensiero di Kant l'oggettività di questo
pensiero puro, ma esso è rimasto prigioniero della finitezza umana, di quell'orizzonte che
per forza di cose ci fa fantasticare di mondi separati o cose in sé, senza costruire niente di
veramente razionale, di veramente oggettivo. Hegel definì il trascendentale di Kant come
una sorta di psicologismo che si fermava al fenomeno ed era perciò incapace di andare alla
cosa in sé.