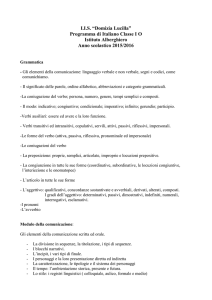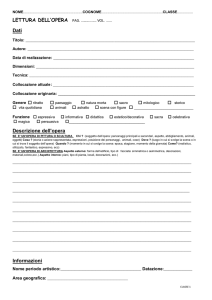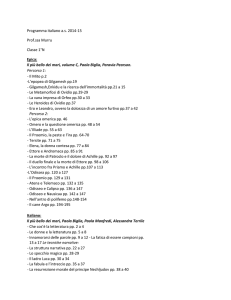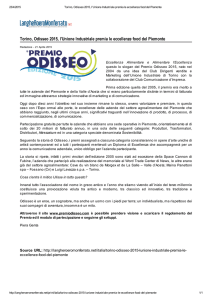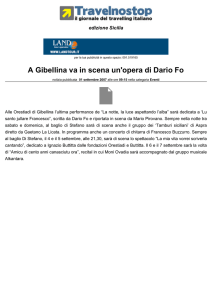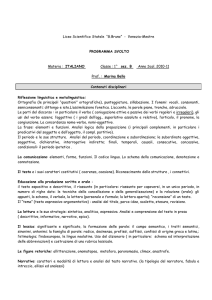Arianna Frattali e Susanna Pietrosanti
!
!
Homer’s wave machine:
Odyssey di Simon Armitage per la regia di Robert Wilson
1. Una favola greca molto molto antica: dall’epos alla scena
!
Esiste un’Itaca possibile? La città per chi ci vive e per chi ci arriva, può essere vissuta come
un “porto” definitivo o la sua stessa identità si esprime nel continuo viaggio? Intorno a
Odyssey per la regia di Robert Wilson – co-produzione del Piccolo Teatro di Milano col
Teatro Nazionale di Atene1 – lo Stabile milanese ha organizzato infatti una rassegna dedicata
ad Ulissi/Viaggio nelle odissee, secondo quello spirito di educazione e fidelizzazione dello
spettatore che anima il teatro lombardo, sin dalla sua fondazione.
Ma Piccolo Teatro è anche d’Europa e, proprio nel contesto della crisi europea di cui la
Grecia è stata protagonista, questo spettacolo nasce e si sviluppa, ponendoci di fronte a tutte
le facce di un viaggio, per poi collocarsi nel contesto metropolitano della città milanese, al
crocevia economico-sociale tra realtà industriale del secolo scorso e le suggestive proiezioni
internazionali di Expo 2015.
La sfida da cui nasce questa co-produzione è infatti isolare ed evidenziare, all’interno
del testo omerico, ciò che rende contemporaneo un classico: in tale ottica Ulisse è cittadino
del mondo e l’Odissea un viaggio nella complessità del mondo odierno. Così infatti Robert
Wilson immagina il capolavoro omerico: un viaggio della vita e della morte, perché Ulisse
non è un eroe, ma rappresenta ogni uomo.
Il poema in ventiquattro libri è pertanto condensato in uno spettacolo di tre ore –
ventiquattro scene con un prologo ed un epilogo – seguendo la drammaturgia che il poeta
inglese Simon Armitage rielaborò, nel 2004, per la versione radiofonica della BBC. E il testo
derivato dalla versione anglosassone, poi tradotto in greco moderno, è andato in scena, prima
ad Atene2 e poi a Milano (con didascalie in italiano) nella stagione teatrale che sta per
concludersi3. Si tratta dunque di una ri-creazione fantastica della saga odissiaca costruita
attorno alle peripezie di Ulisse, uomo che impara, anche con astuzia, a conoscere la grande
arte di essere se stesso, usando, a tal fine, il suo innegabile ascendente sulle donne. Non è un
1!
Odyssey di Simon Armitage da Omero; regia di Robert Wilson produzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro
d’Europa National Theatre of Greece, Athens in greco sottotitolato in italiano. Progetto, regia, scene e luci
Robert Wilson; testo di Simon Armitage; drammaturgia di Wolfang Wiens; musica di Theodoris Ekonomou;
collaborazione alla regia di Ann-Christin Rommen/Tilman Hecker; costumi di Yashi Tabassomi; collaborazione
alle scene Stephanie Engeln; supervisione musicale Hal Willner; collaborazione alle luci Scott Bolman;
traduzione in greco moderno Yorgos Depastas; voice coach Melina Paionidou; suono Studio 19 - Kostas Bokos,
Vassilis Kountouris; scenografie, oggetti di scena e costumi realizzati dai Laboratori del Piccolo Teatro;
pianoforte Theodoris Ekonomou; Ciclope (voce fuori scena) Dimitris Piatas; produzione Piccolo Teatro di
Milano - Teatro d’Europa, National Theatre of Greece, Athens con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri
d’Italia e del Ministero degli Affari Esteri di Grecia.
2!
Lo spettacolo è andato in scena la prima volta il 26 ottobre 2012 presso il Teatro Nazionale di Grecia.
3!
Cf. BANDETTINI (2012); GREGORI (2013).
caso, infatti, che la stessa interprete – Maria Nafpliotou – porti in scena Calipso, Circe e
Penelope, perché, seppure nelle differenti declinazioni della femminilità, nella lettura
wilsoniana, l’eroe greco ama sempre la stessa donna.
Pur mantenendo la struttura narrativa del poema epico, la scansione del tempo non
procede in maniera lineare, ma circolare; gli attori – sono diciassette quelli della compagnia
greca – interpretano più ruoli, sdoppiandosi e triplicandosi in una sorta di liason des scenes
contemporanea che vede, appunto, Calipso trasformarsi in Penelope ed Hermes convergere su
Telemaco, da un quadro all’altro, da un personaggio all’altro, colmando i vuoti del
palcoscenico. La scenografia, infatti, maestosa ed essenziale allo stesso tempo, perché
costituita da linee rette, oggetti metonimici e gigantesche installazioni, lascia proprio agli
ampi spazi vuoti la sorridente responsabilità di accogliere l’immaginazione dello spettatore.
Wilson sceglie di rappresentare il poema epico attraverso i mezzi di un teatro anch’esso
epico, in cui non esiste una gerarchia fra i vari elementi che costituiscono la messinscena nel
suo insieme, ma i cui elementi costitutivi – corpi, suoni, immagini e scenografia – sono
presentati, paratatticamente, alla visione del pubblico in sala. Questo processo, traducendo la
cornice narrativa omerica in immagine, ne ricrea lo spirito originario, rinnovandolo
dall’esterno; la sfilata di tableaux vivants mette a nudo la natura della finzione scenica senza
tradirne affatto il significato profondo. La volontà che sottende l’operazione è rendere, non
tanto la ciclicità del tempo, quanto la sua pienezza; in quest’ottica, gli stacchi musicali, i
cambi di scena a vista, il curioso personaggio punk che saltella clownescamente fra dèi e
semidei rappresentano elementi stranianti di brechtiana memoria, che ripropongono la favola
antica sui toni dell’intrattenimento – costruttivo ed educativo insieme – di un magico cabaret
dei nostri giorni.
Quello che si vede è un’immagine, ma quello che si sente è anche un testo, talvolta
ridotto a pura materia fonica; il teatro greco antico rivive così nella sua essenza di rito
collettivo fatto di visione, danza, ritmo, musica, non tanto attraverso procedimenti
archeologici o filologici, quanto tradotto in uno stile minimalista/visivo costruito su linee e
silhouette. E proprio alle silhouette della pittura vascolare greca sono ispirati tutti i costumi di
Yashi Tabassomi, giocati sul bi-cromatismo dominante bianco/nero con cascate di oro per
vestire gli dèi dell’Olimpo i cui panneggi geometrici – richiamati da pettinature scultoree – si
vedono spesso in controluce. Siamo di fronte, dunque, ad un gioco di ombre cinesi costruite
da luci a neon, che, richiamando le Icons dell’artista statunitense Dan Flavin, rendono la luce
fredda puntello visivo per chi costruisce significato non sotto le luci della ribalta, ma nel buio
dietro il proscenio.
Se gli oggetti di scena diventano scultura – al pari del corpo degli attori – e la
scenografia non è decorazione, ma immagine che agisce come una maschera nei confronti del
volto, il punto di partenza per la costruzione dell’immagine è la luce; in più luoghi e in più
interviste Bob Wilson ha dichiarato di prendere a modello Strehler e Visconti, perché questi
maestri della regia italiana hanno pensato e dipinto la scena proprio con la luce. Folgorazione
è stata infatti la celebre regia strehleriana di Le nozze di Figaro a cui l’artista statunitense ha
2
assistito nel 1973 presso il Teatrino di corte della reggia di Versailles4. E da una luce aurorale
nasce questa Odissea; non si tratta dell’accecante biancore che dalle scene di Strehler e
Visconti si irradia sui corpi in lento movimento di Einstein on the beach5, ma della luce blu
che, all’alba, l’artista texano ha contemplato durante uno dei suoi viaggi in Grecia. Brillante e
radiosa, essa esplode nelle tonalità di rosso e arancio nelle scene di sangue e di passione e c’è
molto viola nel finale, per accompagnare la tracotanza e l’empietà dei Proci intorno al loro
sordido banchetto: quasi un presagio cromatico di sventura, visto che il colore è, per ragioni
scaramantiche, un vero tabù dei teatranti.
La luce dipinge la scenografia e i corpi illuminano le ombre: ai diciassette attori greci è
richiesta una leggerezza piena di immaginazione e di idee per illustrare questa favola resa con
ironia, tenerezza e sensibilità quasi infantile. L’immaginario dell’infanzia sembra infatti
essere l’unico in grado di ricreare in teatro lo spirito della favola: i pupazzi in scena – capre,
aragoste, granchi giganteschi – esprimono metonimicamente didascalie ambientali inesistenti.
Lo spirito è quello dell’ironia e della risata che alleggerisce i significati profondi del mito,
aprendoli a nuove possibilità espressive e in questo richiamo al fanciullino che alberga in ogni
attore c’è forse l’esperienza newyorkese dei laboratori teatrali per l’infanzia fatta da Wilson
agli inizi della sua formazione.
Dal punto di vista della recitazione esiste comunque un compromesso fra libertà e
disciplina all’interno del training svolto dalla compagnia: da un lato c’è un teatro formalista,
fondato su precisione e rigore, dall’altro un’azione che si svolge in un tempo lento, poiché
ciascun attore, da poche indicazioni fornite dal regista, deve trovare sul palco il ritmo e i toni
che gli appartengono. Qualcuno lo definisce un puzzle di recitazione in cui si fondono
pantomima, burlesque e clownerie per ricreare, in chiave antinaturalistica, uno stato emotivo
condiviso e un tono omogeneo che conferisca continuità alla vicenda. L’idea-guida è aprirsi
alla situazione, senza interpretarla troppo, andando così ad evidenziare i vuoti dell’actio,
anziché a rappresentarne i pieni, secondo una logica di sottrazione che ricorre in molte
creazioni teatrali contemporanee che hanno fatto dello scarto e dei silenzi principi di poetica;
pensiamo infatti al Trobleyn Jan Fabre per il processo di exformation – ripetizione e scarto nel
montaggio delle sequenze performative6 – e alla Societas Raffaello Sanzio per la centralità
dell’immagine nell’iter creativo.
La sequenza delle sirene risulta pertanto significativa, là dove le ombre delle creature
marine, incastonate in scogli verdi fluorescenti, si stagliano come silhouette in movimento in
una luce azzurrata; dotate di ali e coda nere appaiono sospese tra cielo e mare, tra paradiso e
4!
L’allestimento con la direzione di Riccardo Muti, le scene di Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino
debuttò trionfalmente al Teatro alla Scala di Milano nel 1981 ed è stato protagonista del Ravenna Festival 2002
dove è andato in scena al Teatro Alighieri con la regia ripresa da Michael Heltau e musica eseguita da Wiener
Philharmoniker e Wiener Staatsoperhchor. Cf. MAMONE (2004).
5!
Einstein on the Beach è stata eseguita per la prima volta il 25 luglio 1976, in Francia, dalla Philip Glass
Ensemble e messa in scena anche ad Amburgo, Parigi, Belgrado, Venezia, Bruxelles, Rotterdam ed al
Metropolitan Opera House di New York, durante il 1976. Composta da Philip Glass, ma progettata e diretta da
Robert Wilson su testi scritti da Christopher Knowles, Samuel M. Johnson e Lucinda Childs. È il primo e più
lungo spartito per opera di Philip Glass e dura approssimativamente cinque ore (tre ore e mezza su CD) da
eseguire senza interruzioni.
6!
Cf. FRATTALI (2012, 71-87).
inferi, emettendo suoni gutturali di gabbiani sul sottofondo rumoristico delle onde marine e
annaspando, come angeli neri, con gesti ripetitivi e lenti. La tecnica della slow motion,
imparata a New York dall’insegnante di danza Miss Hoffman come cura alla balbuzie,
sciogliendo la tensione del corpo attraverso movimenti lenti, sta infatti alla base del training
fisico imposto da Wilson ai suoi performer, e si traduce in cifra stilistica che segna tutti i suoi
spettacoli.
In quest’ottica di continuità – seppure nella dilatazione temporale – non conta tanto il
lavoro del singolo, ma quello d’ensemble, perché tutti s’inseriscano nell’azione con
un’autonomia ed un’armonia paragonabile a quella dei pianeti che si muovono insieme
nell’universo. Il quadro del canto delle sirene si presenta pertanto visivamente disposto su tre
piani: in proscenio, sulla destra, vogano spasmodicamente i marinai greci, specularmente,
sulla sinistra, Ulisse è legato all’albero maestro e sullo sfondo si divincolano le sirene, che qui
assomigliano di più a sinuose arpie. Tutti eseguono movimenti lenti, ritmici e cadenzati,
collocandosi nella sincronia perfetta, ma polifonica, della partitura visiva che il regista
statunitense scrive sulla scena.
Da non trascurare, poi, è la tessitura sonora, che risulta determinante per collegare e
creare fratture fra i quadri, riempirne i vuoti, sottolinearne i pieni, colmare o evidenziare le
lacune del testo recitato. In prima analisi, l’accompagnamento musicale eseguito dal vivo dal
compositore Theodoris Ekonomou svolge la funzione di straniamento già appartenuta alle
songs brechtiane, andando a riempire i tempi morti dei cambi di scena e svelandone la nuda
finzione. Richiama così alla mente gli knee plays composti da Philip Glass per le nove scene
di Einstein on the beach: in quell’opera monumentale l’assenza di trama si traduceva infatti in
segmenti di testo e di poesia intercalati da sillabe solfeggiate, che accompagnavano le lunghe
ripetizioni di piccole sequenze di movimento sul tema della scienza e della relatività in
generale.
In quel caso si trattava però di mettere in scena un poethical work dedicato ad Einstein,
qui siamo in presenza di un testo forte di riferimento come l’Odissea, poema fondativo della
civiltà occidentale e la parola recitata continua ad esistere, evocata dai personaggi e proiettata
– nella versione italiana – al centro della scena. Non si può destrutturare l’azione che anima il
mito e pertanto, non sparendo del tutto la narrazione, la musica l’accompagna,
sottolineandone i significati e collegandone i passaggi, come in un film muto, che però muto
non può essere. In questo senso la colonna sonora di Odyssey ha sicuramente anche una
funzione espressiva autonoma, creando Leitmotiv che conferiscono riconoscibilità alle
sequenze e andando a riempire i vuoti lasciati dalla parola al gesto come il lungo abbraccio tra
Penelope e Ulisse che chiude la vicenda.
Si può pertanto parlare di Odyssey nei termini di un Singspiel contemporaneo in cui
l’orchestrazione non è seconda alla regia e alla recitazione, armonizzando perfettamente
partitura vocale degli attori, rumoristica di scena e momenti di vera melodia. In questa chiave,
i movimenti dei performers e i tempi delle luci s’inseriscono in sequenze ritmiche ben
individuate che ricreano il mito omerico attraverso una percezione sensoriale che non
rinuncia, però, totalmente alla significatività della parola. Se la drammaturgia di Armitage –
come dimostreremo – conserva la narrazione del mito, seppur lasciando molti vuoti da
riempire, su tali vuoti s’installano le immagini-guida ed i virtuosismi sonori di questo wor-ton
4
drama costruito da Wilson con la leggerezza di una favola per bambini. Perché proprio nella
favola risiedono i significati più antichi e più profondi della nostra civiltà ormai in crisi per il
vacillare di quella prospettiva eurocentrica che dall’economia mondiale si estende anche ai
riferimenti culturali.
!
2. Dalla scena al testo: la riscrittura di un mito
!
Cos’è dunque Odyssey di Robert Wilson? È facile notare subito quello che non è: una fedele
ricostruzione filologica dell’epos omerico. Non lo è dichiaratamente, in quanto il regista ha
scelto di adattare la riscrittura del poeta inglese Simon Armitage, ultimo episodio, però, di una
vera e propria onda di «versions and reversions and metaversions and paraversions of
Homer»7 che negli ultimi tempi hanno popolato la letteratura inglese, o di lingua inglese.
Ammettendo che il mito vive nelle sue continue riscritture, e che, come scrive Roberto
Calasso a proposito della «mnemic wave»8 di Aby Warburg, ci sono privilegiati momenti in
cui qualcosa della classicità ci ritorna vicino, cavalcando un’onda mnemica difficilmente
motivabile, vale la pena di interrogarci sui vari flussi di questa onda, che hanno portato al
superbo risultato della versione teatrale di Wilson.
In principio è stato Derek Walcott, con la sua Odyssey. A Stage Version, che nel 1993 ha
inaugurato, e costruito un vertice forse difficilmente superabile, la stagione delle riscritture
omeriche. Se nel famoso discorso tenuto al conferimento del Nobel l’autore ha asserito che
concepiva l’arte come la ricomposizione dei frammenti di un vaso rotto («break a vase, and
the love that reassembles the fragments is stronger than the love which took its simmetry for
granted when it was whole: and this is the exact process of the making of poetry: remaking
the fragmented memory»9), la ricomposizione, la riscrittura dell’epica omerica, racconto per
eccellenza, si presenta subito come irrinunciabile, per il suo carattere polifonico e
infinitamente intertestuale. Del resto la maschera di Odisseo, migrante, viaggiatore, aveva già
abitato intensamente la fantasia di Walcott: John Thieme ha dedicato un intero capitolo del
suo saggio alle molteplici manipolazioni dell’epica omerica in Walcott, a partire dalle poesie
giovanili, fino a The Prodigal10. Il valore di guida assunto da Odisseo nella ricerca poetica
walcottiana è evidente ad esempio in The Schooner ‘Flight’11, dove il protagonista, un
marinaio che ha percorso infiniti viaggi, è consapevole di aver viaggiato anche dentro di sé,
nella ricerca della propria identità, e di sentirsi insieme “just a red nigger who loves the sea / I
had a sound colonial education, / I have a Dutch, nigger and English in me, / and either I’m
nobody, or I’am a nation /…I had no nation now but the imagination”. Odisseo dunque, nella
7! TAPLIN
8!
(2006, 56).
CALASSO (2001, 33).
9! WALCOTT
! THIEME
10
(1997).
(1999).
11
! WALCOTT
(1992, 112-22).
chiara citazione di Nobody e nell’altrettanto chiara allusione alla patria che è meta primaria
della sua ricerca, Itaca e se stesso.
Infestato quindi da tempo da germi odissiaci, Derek Walcott decide di produrre una
versione drammatica del poema, senza lasciarsi spaventare dalle caratteristiche
apparentemente poco concentrabili in scena – la vastità del paesaggio marino, la molteplicità
dei luoghi, il fitto numero di personaggi. Crea quindi un testo estremamente articolato e fedele
alla cronologia e alla fabula omerica, diviso in due atti, rispettivamente di 14 e 6 scene. Il
primo rimanda alla guerra di Troia e rende visibile l’antefatto, mostrandoci Odisseo sotto le
mura della città da conquistare: la scena successiva, con enorme salto, prevede uno
spostamento spaziale e temporale – Itaca, dieci anni dopo – vertiginoso. Da qui, la vicenda si
dipana secondo la fabula omerica, compreso lo slittamento narratore esterno-narratore interno
che avviene quando la voce di Odisseo si sostituisce a quella del poeta nei libri di flash-back.
All’interno di questa fedeltà al testo di partenza, Walcott attua una celebre ‘creolizzazione’
dell’Odissea, che consiste certamente nell’aggiunta di elementi extravaganti (la
trasformazione dell’isola di Circe in un’isola tropicale, ad esempio, con il coro dei marinai
itacesi che, inebriati, cantano un calypso), ma che, nel profondo, si presenta come una scelta
artistica di grande necessità. Come fa notare Matteo Campagnoli, curatore dell’edizione
italiana, «l’esametro è qui usato non con puntiglio classicistico (i versi di Walcott non sono un
calco di quelli omerici) ma perché è il metro del mare, che, estraneo a quanto succede e si
succede sulla terra, continua a battere sulle coste di St. Lucia e su quelle di Itaca con la stessa
scansione con cui lo faceva ai tempi di Omero, e che, come il cuore dell’uomo, non ha mai
alterato il proprio ritmo per adeguarsi alle mode»12.
Come sostiene Umberto Eco13 preoccupandosi di quanto ‘trasmigra’ nell’adattamento di
un testo composto in un sistema di segnali a un altro – intersemioticamente –, la tra-duzione è
un problema di negoziazione: si sceglie quanto è irrinunciabile, senza arretrare di fronte a
scelte all’apparenza meno fedeli di altre, ma invece profondamente fedeli allo spirito
dell’originale. Così, non è la fedeltà apparente la vera fedeltà. Nella scena in cui Nestore
ricorda a Telemaco le sfide e il coraggio di Odisseo, questo balza agli occhi: «Nestor: He
enraged the sea, your father Odysseus. / First Attendant: The sea’s a maw that devours. /
Nestor: A god who saves. / Telemachus: He saved you. The sea’s ungovernable, is that what
you mean? / First Attendant: He scorned the sea. / Second Attendant: He defied the sea»14. La
rievocazione, con ogni evidenza, è tutta concentrata sulla grande sfida tra Odisseo e il mare, al
punto che alla scena successiva, l’incontro con Elena e Menelao, la tensione di Telemaco è
tale che riesce a produrre un’apparizione del padre: «Odysseus appears. Telemachus rises,
walks down to the morning beach. Telemachus: Echo me, islands! Odys-seus! Odysee… /
Echo: Sea, sea, sea…Odyseee… / Telemachus: I want to see you, father… / Echo: Farther,
!
12
CAMPAGNOLI (2006).
!
13
ECO (2010).
14
! WALCOTT
(1993, 68s.).
6
farther…»15. Il gioco di parole creato dalla manipolazione del nome attraverso l’eco, un
procedimento che non era mai balzato più vivo dai tempi di Ovidio, produce la confluenza
dell’immagine dell’eroe nel mare. Nulla potrebbe essere più odissiaco: se ha ragione Luca
Canali, ed Enea è «il contrario del mare, tutto razionalità e obbedienza ai disegni del fato»16,
Odisseo è il mare stesso, «coi suoi mille volti fallaci»17. E, se vogliamo, il mare è addirittura
Omero stesso, come spiega Pietro Citati nel suo splendido La mente colorata: «tutti i poeti,
fino ai tempi moderni, l’hanno saputo: scrivere poesia è l’esperienza della liquidità. Le Muse
versano sulla lingua del re-poeta ‘dolce rugiada’. In quest’acqua che non sta mai ferma non
c’è nulla di effimero: anzi è proprio lo scorrere incessante della sostanza oceanica che rende
eterni i versi e chi li compone. Per un rapido passaggio analogico, l’acqua dell’Oceano
diventa miele»18. Perciò, una cornice di apparente infedeltà – la creolizzazione del poema – si
conferma un prisma di profonda comprensione e consonanza, e nell’opera di Walcott Omero
parla.
!
3. Narrare o lasciarsi narrare? L’inversione della prospettiva androcentrica
!
A seguire cronologicamente, è il 2005 quando Margaret Atwood, su invito dell’editrice
Canongate, nella cui Myth Series molti autori contemporanei si sono cimentati nella
riscrittura di antichi miti, pubblica il romanzo breve The Penelopiad. Omero, e l’Odissea,
ovviamente, ma con molteplici variazioni. La voce narrante è appunto quella di Penelope, che
narra dopo la sua morte («Now that I’m dead I know everything. This is what I wished would
happen, but like so many of my wishes it failed to come true…»19), ricordando dal suo punto
di vista la fabula che ben conosciamo, il suo rapporto con Odisseo, il soggiorno nell’Ade, il
confronto con Elena e coi propri genitori. Un coro di venti ancelle, quelle supposte sleali e
alleate dei Proci, interrompe la voce narrante contrappuntandola come in un dialogo tragico, e
usando un nuovo genere di scrittura ad ogni intervento: dalla jump-rope rhyme (un ritmo
infantile usato nel salto alla corda per ritmare i punti) al lamento, dalla ballata ad una specie di
udienza legale recitata, con Odisseo come accusato e le serve come accusatrici, e a vari tipi di
canzoni, per finire con un poema in dimetri giambici. Come Walcott, la Atwood conclude col
breve romanzo un percorso di attrazione rispetto ai motivi odissiaci, già presenti in alcune sue
opere di poesia20 e qui portati alla massima elaborazione: e come per Walcott, era inevitabile
15
!
Ivi, p. 90.
16
!
CANALI (2007, 110).
! WALCOTT
17
18
!
CITATI (2004, 46).
19
! ATWOOD
20
!
(1993, 109).
(2005, 1).
Cf. ATWOOD (2005, 201). dove viene subito alterata l’immagine di Penelope come sposa ideale: «She’s up to
something, she’s weaving/ histories, they are never right, / she has to do them over, / she is weaving her
version». Oppure ATWOOD (1996).
una versione teatrale, coprodotta nel 2007 dal Canadian National Arts Centre e dalla British
Royal Shakespeare Company, e rappresentata sia a Stratford che a Toronto.
Il fascino che la critica ha colto nel breve testo è rappresentato dal lavoro sui punti di
vista – peraltro, una delle categorie critiche più comunemente usate per l’autrice è proprio la
celebre distopia di Margaret Atwood… Odisseo, l’eroe che uccide mostri, compie imprese
straordinarie e seduce divinità, qui «had been in a fight with a giant one-eyed Cyclops, said
some: no, it was only a one-eyed tavern keeper, said another, and the fight was over non
payment of the bill»21: e la stessa Penelope confessa di essersi decisa a narrare dal suo punto
di vista perché insoddisfatta della versione che di lei offre Omero, la moglie fedele, la sposa
ideale, ponendosi come una persona che ha invece solo cercato, con vari espedienti, di
sopravvivere al meglio, anche conoscendo carnalmente tutti i suoi pretendenti e generando da
loro il piccolo Pan: e anche le ancelle, traditrici in Omero, sono presentate come vittime, usate
da Penelope per spiare, violentate dai Proci e infine assassinate. Si tratta di vari tentativi di
giustizia narrativa, che si susseguono nel testo. Da un certo punto di vista, infatti, uno dei
grandi temi della novella è proprio il narrare nel suo farsi: «rumours came, carried by other
ships. Odysseus and his men had got drunk at their first port of call and the men had mutinied,
said some: no, said others, they’d eaten a magic plant that had caused them to lose their
memories, and Odysseus had saved them by having them tied up and carried onto the ships….
Needless to say, the minstrels took up these themes and embroidered them considerably…»22.
Così, qual è la verità? «It was hard to know what to believe»23, conclude l’eroina, con una
sentenza estremamente omerica: nell’Odissea stessa la tensione fra credere e non credere è
sempre attiva, motore immobile, ad esempio, della scena finale del rimandato riconoscimento
di Odisseo da parte di Penelope: e sempre l’eroe dai mille volti offre mille immagini di sé,
narrandosi o lasciandosi narrare, infinito prisma di mutevole seduzione.
In questo, la versione della Atwood conserva lo scintillare omerico, e non si allontana
neppure da uno dei temi archetipici già dominante in Walcott – il mare. Qui, con uno
slittamento anch’esso molto omerico (è una costante accezione della critica omerica il
sostenere che Penelope è un alter ego dell’eroe dalla mente colorata), viene riversato sulla
protagonista stessa, condannata dal padre ad essere tuffata in mare quand’era bambina, rito
non molto temibile per la figlia di una Naiade: «no matter – into the sea I was thrown. Do I
remember the waves closing over me, do I remember the breath leaving my lungs and the
sound of bells people say the drowning hear? Not in the least»24. L’episodio ha un forte valore
simbolico e non si configura affatto come privo di necessità, come la stessa madre di
Penelope, in occasione del matrimonio della figlia, spiegherà: «water does not resist. Water
flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it
will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can
21
! ATWOOD
!
22
Ivi, p. 84.
!
23
Ivi, p. 91.
24
!
Ivi, p. 9.
(2005, 83).
8
stand against it. Water is patient»25. Pieghevole e irrefrenabile, l’elemento acquoreo definisce
insieme le caratteristiche di base dei due protagonisti, ribadendo la loro corrispondenza
irrimediabile e la loro inseparabile attrazione, fatta insieme di somiglianze e di differenze, ma
comunque indistruttibile26.
Da molti punti di vista, dunque, l’adattamento della Atwood si presenta insieme come
funzionale e come profondamente omerico: «luckily, this plainspoken cheekiness and
postmodern noodling is balanced by a genuine and sustained sense of outrage and elegy. It
reminds us that if myths are powerful, they are also fragile, malleable things»27. La splendida
verve con cui i personaggi vengono messi in scena ammette anche un dècalage lessicale
ironico, postmoderno e spesso molto funzionale («the oracle herself misheard – the gods often
mumble»28) che non corre quasi mai il rischio della banalizzazione, o dell’eccesso di
avvicinamento, o dello svilimento – rischi che, altrove, purtroppo, possono concretizzarsi. La
modernità del linguaggio della Atwood è vitale, è «as a piece of writing that refuses to stop
winking at the reader, it still manages to evoke true pathos. In the Odyssey, the maids ‘feet do
not twitch for very long: in The Penelopiad, they never stop twitching»29.
!
4. Un contenitore per l’immagine: la drammaturgia di Armitage
!
Infine, dunque, il lavoro di Simon Armitage. I problemi di valutazione cominciano già dal
titolo: The Odyssey. Come Oliver Taplin ha subito sottolineato, la scelta appare quasi
«hubristic, if the emphasis were on “The”»30, perché ovviamente questa non è, in nessun
senso, una traduzione di Omero, non è, eccetto che nel titolo, quanto pretende di essere. In
realtà, come notavamo prima, non è la fedeltà apparente quella più profonda. Diversamente da
Walcott e dalla Atwood, che hanno operato brillanti recastings della versione omerica,
Armitage segue strettamente la fabula odissiaca, ma la sottopone a una revisione che è spesso
uno snellimento: riduce e semplifica, teso apparentemente a una maggiore agilità (brevi scene,
una sorta di scattante scelta dei ‘motivi liberi’ dell’epica omerica).
Non esiste un narratore – stranamente. Era una figura di prestigio negli altri due testi:
Penelope nella versione della Atwood costituiva la spina dorsale, colei che narrava, costruiva
25
!
Ivi, p. 43.
26
!
Del resto, il contatto affettuoso e polemico tra Odisseo e la moglie non è una categoria nuova per la cultura
inglese. Basti pensare alla Penelope di Dorothy Parker, che rappresenta l’eroe nel campo semantico del viaggio
(«in the pathway of the sun, / in the footsteps of the breeze, / where the world and sky are one, / he shall ride the
silver seas, / he shall cut the glittering wave»), mentre la moglie lo aspetta in casa, immersa nelle cure
domestiche («brew my tea, and snip my thread: / bleach the linen for my bed»). Ad ambedue, però, allude la
sentenza finale: «they will call him brave». E il vero coraggio, forse, è quello femminile. Al valore delle
categorie di gender nell’Odissea si rifà il saggio di CLAYTON (2004).
27
!
BIRRELL (2005).
! ATWOOD
28
!
29
(2005, 8).
BIRRELL (2005).
30
! TAPLIN
(2006).
una versione, contraddetta e riecheggiata dal gruppo delle schiave: e Robert Hamner ha
sostenuto che una delle grandi innovazioni introdotte da Derek Walcott fosse proprio la
creazione del narratore presente sulla scena, Billy Blue31. Il narratore presente in scena,
caratteristica rintracciabile in altre opere di Walcott, da Malcochon a The Joker, è sia
l’incarnazione della voce del poeta – Omero e lo stesso Walcott – sia una voce corale, il coro
del dramma classico, sia l’artista caraibico che modula il proprio canto al ritmo del calypso.
Nel prologo, lo dichiara lui stesso: «Gone sing ‘bout that man because his stories please us, /
who saw trials and tempests for ten years after Troy. / I’m Blind Billy Blue, my main man’s
sea, – smart Odysseus, / who the God of the Sea drove crazy and tried to destroy»32. Questo
cieco narratore-cantore rimanda quindi ad Omero, e a tutti gli aedi e i profeti della classicità,
ma la sua funzione attiva nella vicenda è fitta di significato, favorendo il passaggio dall’epica
classica a quella caraibica, e l’appropriazione intertestuale da parte di Walcott di un grande
testo della cultura mondiale.
Nessun narratore, invece, in Armitage. Appropriandosi del testo, Robert Wilson sembra
aver percepito la stranezza di questa scelta, e avere ovviato: Omero è infatti in scena da
subito, prima dell’inizio dell’opera e il fitto intrecciarsi di luce che lo scandiscono, pronto ad
aprire la recitazione con l’oracolare incipit del testo classico. Anzi, proprio sull’alternanza
della voce narrante sembra giocare molto la regia, che insiste sulla variazione: è la madre di
Nausicaa a narrare alla figlia, col pretesto che la giovane principessa non possa partecipare al
banchetto, e questa scelta da un lato oggettiva Odisseo in scena, togliendogli la facoltà di
usare la voce e mettendolo solo in azione, dall’altro esalta al meglio l’aspetto favolistico di
questa fabula.
In Armitage, inoltre, risultano scarsi i monologhi, fitti invece i dialoghi, la cui frequenza
disequilibra il testo: aumentano ovviamente le parti riservate ai compagni di viaggio di
Odisseo, che hanno molte più battute rispetto a quanto accade nell’Odissea, così come
avviene per i Proci: si moltiplicano anche i dialoghi tra Atena e Zeus sull’Olimpo, tra Alcinoo
e Nausicaa alla corte dei Feaci. E se qualcosa aumenta, qualcosa diminuisce: il giorno
dall’alba al tramonto del quale Odisseo consuma il suo sanguinoso ritorno e si sbarazza dei
nemici dura nel poema quattro interi libri, nella versione di Armitage quindici pagine scarse.
Del resto, costruire «a dramatic retelling» dell’Odissea non è questione di poco conto.
Sempre si corre il rischio di complicare troppo o rallentare o tralasciare, perdendo la
percezione, o l’auscultazione, del sotto-senso omerico, o lasciando prevalere la propria
intenzionalità su quella della fonte – mai con buone motivazioni, raramente con buoni
risultati. Ad esempio, l’episodio in cui Odisseo e Telemaco giustiziano le schiave traditrici ha
una forza icastica e narrativa in grado di affascinare, e respingere, qualunque interprete. Ha
ovviamente affascinato la Atwood, come si è già detto: e Walcott fa sì che la sua Penelope,
sulla scia di Yeats, rimproveri Odisseo di voler riprodurre «a second Troy», facendola
concludere «when will men learn?»33. L’episodio, con i suoi risvolti violenti, ha costituito
!
31
HAMNER (2001, 47).
! WALCOTT
32
33
!
(1993, 12).
Ivi, p. 165.
10
motivo ispiratore anche per Michael Longley, nel suo The Butchers (2006), che connette la
bestialità animalesca dei due eroi omerici assassini di donne con le stragi perpetrate in quel
periodo in Irlanda («their heads bobbing in a row, / their feet twitching but not for long»: versi
di indiscutibile, omerica fedeltà). In Armitage l’intero episodio è assente. Perché, come ha
scolpito Oliver Taplin, «this is an Odyssey without discomfort»34.
E, lessicalmente parlando, anche senza epicità. Ovviamente, poiché Simon Armitage è
un celebre poeta, il suo dettato è in versi, non in un definito sistema di versi, ma in una ‘nonprosa’ resa tale dalla presenza di frequenti metafore, lontane, ovviamente, anni luce dalle
celebri similitudini omeriche, ma tali da marcare il testo poeticamente. Alcune immagini
funzionano splendidamente (ad esempio, la roccia sulla quale Odisseo passa le giornate
struggendosi di nostalgia durante la prigionia di Calipso è «bleached white, and not by the
dung of birds / or the thrown of the sea, but by a man’s tears»35) altre sostituiscono
inspiegabilmente luoghi omerici ben più famosi e più perfetti (la celebre similitudine di
Nausicaa come giovane palma presso l’altare di Apollo, ad esempio, viene rimpiazzata qui da
«to her whose arms / spill like milk from her shoulders»36 – chissà perché…), altre veramente
stridono in un abbassamento troppo forte, che non può essere percepito neppure come ironia
postmoderna, ma solo come involontariamente comica stecca, stonatura (Zeus, lamentandosi
dell’indifferenza degli umani agli avvertimenti degli dèi, dichiara che «when we send eagles /
to signal our thoughts in the sky, / what do they do – stand and point and stare, / like
birdwatchers!»37). Altra carenza di epicità è rappresentata inoltre dalla totale assenza di
epiteti, che hanno sempre costituito una delle marche omeriche più efficaci e ai quali
Armitage ha, sintomaticamente, del tutto rinunciato.
Raccontare di nuovo, e adattare, può porsi l’obiettivo di avvicinare – vero. Il mito, nella
sua infinita necessità, ammette di essere ridetto, anzi di questo si nutre, ampliandosi ad
assorbire scelte lessicali quotidiane, contemporanee, che lo rivitalizzino, come sangue nuovo
– vero, e questo è spesso il senso e lo scopo della riscrittura. Anzi, talvolta la grandezza di un
poeta, il suo enciclopedismo, la sua dilatabilità pluristilistica, plurilessicale, attende e ammette
operazioni coraggiose. Mary Jo Bang, traducendo l’Inferno di Dante, ha innervato la sua
versione di richiami espliciti alla tradizione anglosassone, citazioni segrete e esibite, e non
solo di altri poeti sfociati nelle terzine dantesche come nel loro luogo d’arrivo, ma addirittura
richiami a testi non canonici – così, Capaneo, «quei che cadde a Tebe giù da’ muri», diventa
nella traduzione della Bang «who Humpty Dumptied off the walls of Thebes»38. Simon
Armitage sembra aver seguito questo stesso disegno, in molteplici luoghi del suo lavoro:
Odisseo è «stranger in a strange land», in un chiaro richiamo all’Esodo nella Bibbia di Re
Giacomo: la citazione dal Macbeth («screw your courage to the sticking-place») balza agli
34
! TAPLIN
(2006).
35
! ARMITAGE
(2006, 37).
!
36
Ivi, p. 61.
!
37
Ivi, p. 5.
38
!
BANG (2012, 237).
occhi. Ma c’è altro. Penelope che, davanti all’obbligatoria scelta di un nuovo marito, «can’t
say no and can’t say yes», si intona irrefrenabilmente a un celeberrimo brano dei Beatles: e
l’anaforico how many che per ventuno versi punteggia il canto di Femio insiste fin troppo
chiaramente sull’accostamento con Blowin’ in the wind. Fin qui, sono scelte interessanti, e
non prive di interna necessità. Molto più problematici appaiono i punti in cui la versione di
Armitage si sposta deliberatamente dall’accezione omerica, e non solo nell’ordine di
alleggerire, espungere-adattare, ma proprio antropologicamente, compiendo inscusabili
fraintendimenti. Da subito. Calipso, reagendo all’ingiustizia che gli dèi le impongono, non si
limita a denunciarne l’invidia ma grida che «you Gods on your mountain perch, you’re a joke.
/ You’re the high-priest of hypocrisy. When a male God swoops down on a woman / or forces
himself on some innocent young thing, / you call it Fate. When a female God / falls for a
mortal or takes a man into her bed, / an earthquake of disapproval blows its top»39 –
mutazione in chiave femminista del dettato omerico, accettabile nell’ordine di una
modernizzazione, forse, ma stonata comunque. Come stonata e inspiegabile risulta la fine,
privata dell’annuncio a Penelope da parte di Odisseo della sua prossima partenza e consumata
in un’ultima patetica sentenza, d’effetto, ma ben poco funzionale al tono dell’epicità: «you’re
my Ithaca», dice Odisseo, la sua ultima battuta. E lo stridore aumenta se l’analisi viene
condotta a livello lessicale. Per definire la voce di Circe, Polite usa l’aggettivo «angelic» –
scelta imperdonabile. Quasi quanto il sussurro di Circe stessa che dice a Odisseo «you’ll fuck
me, Odysseus…». Non si sarà meravigliato, del resto, questo Odisseo di Armitage, che
davanti a Nausicaa ha appena detto «I apologize me», ricreando lo skyline di Londra nel cielo
del Mediterraneo.
Non è epico, quindi, né sempre esatto. Non è il ruggito del mare dei mostri, ma semmai
il frusciare della «wave machine» a cui lo paragona la recensione di Oliver Taplin. Però,
proprio quando di mare si parla, il picco dell’omericità improvvisamente si impenna: «that act
was to haunt us. From then on / we were marked men, locked on a collision course / with the
God of the Sea. / He lurked in the depths, / a constant presence. We sensed him under the
waves. / The boat shivered when he stirred. / And if we ‘d have known the chain of events
we’d set in place, the cruelty / and agony that stretched ahead, year after year, / the horror and
terror and sadness and loss still to come – / who knows, / perhaps we’d have chosen to die
right there, in the black / cave, / out of sight of heaven and without sound»40. Rime interne,
omoteleuti e allitterazioni ricostruiscono bruscamente il vero clima odissiaco: l’attesa del
lampo blu della luce di Wilson è oggettivata, ed è facile rendersi conto del perché proprio la
traduzione di Armitage, con tutti i suoi lati deboli, sia stata prescelta. Persino la mancanza di
epiteti si presta meravigliosamente a far a ricreare la formularità del testo omerico attraverso i
Leitmotive della musica dal vivo. Fiabesca e giocosa, fast and furious, schema
riempibilissimo, non aspettava altro che la ri-creazione visiva di un grande artista per brillare:
e per far sì che qualcosa, così bene, ci riempia, bisogna aprire spazi a questo qualcosa.
! ARMITAGE
39
40
!
(2006, 38).
Ivi, pp. 97s.
12
Se nella metamorfosi strutturale subita dal poema di Omero sino alla rivisitazione di
Armitage si va perdendo il concetto di autorialità (come dimostra anche l’assenza di narratore
in quest’ultima versione), tale concetto converge, inevitabilmente, nella lettura wilsoniana, su
quello di regia (e non è un caso che Wilson re-inserisca invece la voce narrante). Siamo di
fronte dunque ad un regista che, come “secondo creatore”41, si sostituisce all’autore del testo,
segnandone profondamente la drammaturgia. La rivoluzione, però, anziché avvenire
dall’interno, lasciando intatti gli aspetti formali della rappresentazione, avviene in direzione
opposta, dall’esterno: l’immagine, il suono, perfino il corpo dell’attore non costituiscono più
l’impalcatura perfetta su cui s’innesta la pregnanza semantica della parola; è la parola ad
essere cornice di un mondo di percezioni che rivive nella leggerezza di una favola antica,
fossile di un mondo che non c’è più, ma che si ricrea dentro lo spettatore, in una luce aurorale.
!
!
!
!
!
riferimenti bibliografici
!
ALONGE 2006
R. Alonge, Il teatro dei registi, Roma-Bari.
!
ARMITAGE 2006
S. Armitage, The Odyssey, New York.
!
ATWOOD 1996
M. Atwood, Helen of Troy does Counter Dancing, Morning in the Burned House, Toronto
!
ATWOOD 1997
Cf. PERRELLI (2005); ALONGE (2006). In particolare, Alonge, nell’ultima sezione del volume dedicata ai poeti
della scena, analizzando due allestimenti di Luca Ronconi, Spettri e Orlando furioso, osserva come il regista
aspiri, di fatto, «a risolversi compiutamente nell’autore, e a comunicare direttamente col pubblico» (p. 139).
L’invenzione di grandiose macchine scenografiche tradirebbe quindi un’insoddisfazione interiore del regista
rispetto all’orizzonte del testo, un desiderio di essere egli stesso drammaturgo. Psicanaliticamente parlando, lo
studioso vede inserirsi su questa linea anche Grotowski, Barba e Kantor, registi che tendono ad emanciparsi dal
testo uccidendone (metaforicamente) il padre, l’autore. Secondo questa ottica – che ci sentiamo di accogliere in
pieno –, la nascita della regia, quando si fa pratica creativa, è dunque la grande scommessa che si consuma fra
Otto e Novecento, «il grande tentativo di ristabilire un collegamento con l’antica radice divina che è nel
testo» (p. 182). E di questa sfida, a nostro avviso, Robert Wilson è un indiscusso protagonista.
41
M. Atwood, Circe: Mud Poems, in Selected Poems, 1965-1975, Toronto.
!
ATWOOD 2005
M. Atwood, The Penelopiad, Edinburgh.
!
BANDETTINI 2012
A. Bandettini, Bob Wilson: “Mi sento come Ulisse, ma in Italia c’è la mia casa”, «La
Repubblica» 4 giugno.
!
BANG 2012
M.J. Bang, Dante Alighieri Inferno, Minneapolis.
!
BIRRELL 2005
H. Birrell, The Penelopiad: the Myth of Penelope and Odysseus, «Quill and Quire» 20
October.
!
CALASSO 2001
R. Calasso, La letteratura e gli dei, Milano.
!
CAMPAGNOLI 2006 M. Campagnoli, Appunti a margine dell’Odissea di Derek Walcott, in Odissea. Una versione
teatrale, Milano, 86.
!
CANALI 2007
L. Canali, Il tridente latino. Lucrezio, Virgilio, Petronio, Roma.
!
CITATI 2004
P. Citati, La mente colorata, Milano.
!
CLAYTON 2004
B. Clayton, A Penelopean Poetics. Reweaving the Feminine in Homer’s Odyssey, Lanham.
!
ECO 2010
U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Saggio sulla traduzione, Milano.
!
!
!
!
FRATTALI 2012
A. Frattali, Corpo e immagine: Preparatio mortis di Jan Fabre. Leggere il testo performativo,
in Testo e performance dal Settecento al Duemila. Esempi di scrittura critica sulla teatralità,
Milano, 71-87.
!
GREGORI 2013
M.G. Gregori, Un’Odissea da sogno, «L’Unità» 5 aprile.
!
14
HAMNER 2001
R.D. Hamner, Creolizing Homer for the Stage: Walcott’s Odyssey, «Twentieth Century
Literature» XLVII/3 54-87.
!
MAMONE 2004
S. Mamone, Una corrispondenza di sensi artistici, www.Drammaturgia.it, 1/5/2004.
!
PERRELLI 2005 F. Perrelli, La seconda creazione. Fondamenti della regia teatrale, Torino.
!
TAPLIN 2006
O. Taplin, Homer’s wave machine, «The Guardian» 20 May, 56.
!
THIEME 1999
J. Thieme, Derek Walcott, Manchester.
!
WALCOTT 1992
D. Walcott, Mappa del Nuovo Mondo, Milano.
!
WALCOTT 1993
D. Walcott, The Odyssey. A Stage version, New York.
!
WALCOTT 1997
D. Walcott, The Antilles. Fragments of Epic Memory, in Nobel Lectures. Literature
1991-1995, Singapore.
!

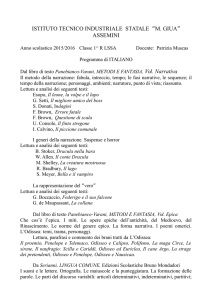
![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007566322_1-58d70b56b536a079f8882415348ab4fa-300x300.png)