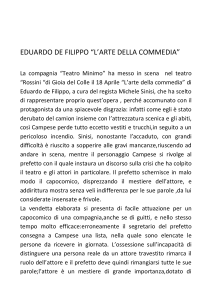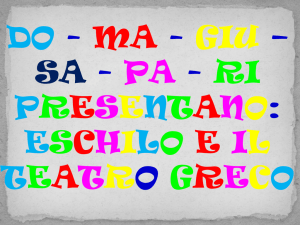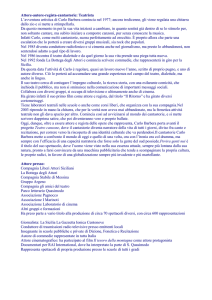Eugenio Barba
PAROLE NUOVE PER ANTICHI SENTIERI
Discorso di Eugenio Barba in occasione del titolo di Dottore in Lettere honoris causa conferitogli
dall’Università Queen Margaret di Edinburgo il 1° luglio 2014.
Ogni epoca sogna l’anteriore, diceva Jules Michelet. Così, fantasticando sui teatri del passato, inventiamo le
nostre tecniche percorrendo strade antiche. Sentiamo la necessità di forgiare parole che ci appartengono per
evocare i nostri miraggi e presunti progressi. È bene riflettere sui nomi delle antiche strade, ma è anche utile
ribattezzare regolarmente i termini della nostra lingua di lavoro.
Oggi gli attori hanno delle tecniche che non mirano a forme fisse né rispettano circoscritte regole del
gioco, come accade per gli spettacoli dalle forme codificate come il balletto, il kabuki o il kathakali. Sto
parlando degli attori di quei teatri caratterizzati dalla mancanza o dal rifiuto di una tradizione codificata,
senza una stilizzazione specifica o una maniera riconoscibile. Sono teatri con un particolare destino o
vocazione: vivono come se fossero sempre in statu nascendi, anche quando la loro esperienza è lunga.
Questi teatri vengono in genere qualificati sperimentali, laboratori o semplicemente di gruppo.
Equivalgono a un’importante tradizione indipendente. Una tradizione del nuovo sembra un ossimoro poetico,
ed è sicuramente una contraddizione. Ma questa contraddizione è una parte essenziale della storia del teatro
moderno.
È evidente che la tradizione del nuovo non può applicare dei procedimenti che assicurino dei risultati
dentro un ragionevole margine di errore. Eppure questo teatro perpetuamente in statu nascendi, o eterno
principiante, è stato il paradosso vivente che ha ispirato Stanislavski e Craig, Copeau, Brook e Grotowski.
Si usano spesso espressioni come “lingua” del corpo, del teatro, dell’attore. Ma nel contesto del teatro
che vive come se fosse sempre in statu nascendi, insegnare le tecniche dell’attore non è mai stato come
insegnare una “lingua” difficile ma dalla struttura definita. La conoscenza e la pratica del latino, sanscrito o
greco antico può essere trasmessa con metodi sperimentati, e l’apprendimento è possibile per chiunque in
un tempo più o meno lungo.
Al contrario, in un teatro in statu nascendi ed eterno principiante, l’insegnamento non può far altro che
mettere in moto e orientare un processo personale. Può forse giungere a buon fine, ma purtroppo non
conduce sempre alla meta malgrado l’impegno e la dedizione.
Mi riferisco a tecniche d’attore che sono davvero tali solo quando qualcuno le ha incorporate, e voltandosi
indietro può dimenticare le molte sconfitte e mostrare le poche scoperte. Sono tecniche chiare e consistenti
solo se osservate a posteriori. In realtà, ognuna di queste tecniche è una particolare microstoria, la
conseguenza di una biografia irrepetibile.
Tutti questi paradossi e contraddizioni sono la causa della venerazione e del rigetto, dello scetticismo e
del feticismo che circondano l’idea di tecniche dell’attore. Ci troviamo quindi in presenza di tecniche d’un tipo
particolare, che lo studioso italiano di teatro Franco Ruffini paragona agli ornitorinchi.
Gli ornitorinchi sono mammiferi, ma la loro natura sembra contraddire le classificazioni naturali: sono
mammiferi che fanno le uova, che hanno i denti ed il becco, le cui estremità sono palmate come quelle delle
anatre, con in più un piccolo pericoloso sperone velenoso alla fine delle zampe posteriori.
Anche le tecniche d’attore hanno speroni velenosi. Non possono essere insegnate in maniera metodica,
un passo dopo l’altro, come un pacchetto di conoscenze riutilizzabili - nel modo in cui si possono
trasmettere, per esempio, i comportamenti di base per il tennis, le ricette per cucinare o una rotta aerea o
navale. Non sono neppure come le cosiddette “tecniche del corpo” che si apprendono senza accorgersene
semplicemente crescendo in un determinato ambiente. Le tecniche dell’attore non sono tecniche del corpo,
ma della personalità, di un corpo-mente particolare e unico.
Come mai, allora, si è materializzata lungo tutto il teatro del Novecento l’idea di un training dell’attore?
Come è nata l’idea di un apprendistato che non si indirizza verso una forma, uno stile o un genere
spettacolare prestabilito? E’ stata superficialità o illusione?
Si è sempre trattato di un anti-training o di una finzione pedagogica. E’ stata una rivolta, un bisogno di
distruggere il teatro per reinventarlo. Gli esercizi non servivano ad addestrare l’attore a un teatro dal preciso
e riconoscibile profilo. Al contrario, questi esercizi tendevano a liberarlo dai comportamenti obbligati degli
attori, dai loro condizionamenti scenici, atteggiamenti mimetici e cliché.
In teatro, cliché è una parola che incute timore. Ogni attore sperimentato ha una propria personalità
scenica, un proprio comportamento ricorrente, un proprio peculiare modo di amministrare le energie, un
riconoscibile ritmo del proprio bios scenico. Come distinguere questa riconoscibilità ricorrente dai famigerati
1
www.odinteatret.dk
cliché? Più che una domanda tecnica, questa è un’inquietudine, e riguarda la disciplina personale dell’attore.
Ha a che vedere non con l’estetica, ma con l’ansia di diventare artisticamente sterili: stagnare.
Gli esercizi e il training insegnano innanzi tutto la disciplina. Anche questa parola incute timore. Un
riflesso automatico fa subito pensare a qualcuno che limita la nostra libertà imponendo regole di pensiero e
di condotta. In realtà, nell’arte, la disciplina oscilla tra due processi diversi ma praticamente impastati l’uno
con l’altro: l’azione di apprendere (in latino: discere), e la coerenza nel rispettare rigorose regole autoimposte.
Gli esercizi inventati nel Novecento provengono dall’ansia di sperimentare e di cambiare e, nello stesso
tempo, di sottomettersi a una disciplina. Ma riflettono anche il desiderio di guidare l’attore verso una zona
non addomesticata del proprio paesaggio interiore.
I risultati, quando emergono, sono per ognuno diversi. Si ottengono attraverso un lungo percorso fatto di
pratica, pensiero e ripensamento, fatica, innumerevoli tentativi e sterminati errori. Alla fine di questo
percorso, si possono a volte mostrare alcuni risultati dal valore evidente. Ma l’evidenza non basta a chi
desidera impadronirsi di quelle conoscenze. Non gli basta sapere cosa vuol trovare, se non sa come.
Stanislavskij spiegava questo dilemma con un’immagine molto chiara. Diceva di sentirsi come un
cercatore d’oro che ha passato anni a scavare montagne di terra e di pietre. E’ piombato cento volte nello
sconforto, e si è rialzato per cento e una volta. Alla fine possiede un piccolo gruzzolo d’oro grezzo. Lo
mostra. Il valore del suo lavoro e della sua ricerca tutti lo capiscono per la forza dell’evidenza. Sta tutto in un
pugno. Ma tutti capiscono anche che sapere che l’oro esiste e lo si può trovare non significa saperlo trovare.
Soprattutto tutti si rendono conto che la tecnica per trovare l’oro consiste al 99% nel lavoro dello
spaccapietre e per l’1% nella testardaggine d’un innamorato.
Il vero problema non è imparare, ma imparare a disimparare. Questa esortazione alla dotta ignoranza, a
estrarre il difficile dal difficile, è stata la bussola dell’Odin Teatret per mezzo secolo.
I metodi, le teorie e le immagini che cercano di tradurre il sapere incorporato dell’attore - quello che
chiamiamo la sua tecnica - servono a mettere in moto visioni e lingue personali provvisorie. Possono
assumere la credibilità di una mitologia che per qualcuno ha funzionato e che può a volte funzionare per
altri. Non sono mai metodi, teorie e immagini garantiti.
Si possono elencare innumerevoli regole tecniche e artistiche. Ma quando si ha a che fare con un
processo creativo, ogni cosiddetta regola funziona sia per il diritto che per il rovescio. Negarla sforzandosi di
contraddirla fino in fondo, a volte, è più efficace che affannarsi ad applicarla.
Anche se le parole che usiamo quando parliamo delle tecniche dell’attore non sono teorie né ricette,
siamo spesso costretti a travestirle da teorie e ricette. Questo travestimento è il più delle volte il solo mezzo
per dare credibilità non alle proprie parole, ma a ciò cui esse accennano.
Nutriamo una diffidenza nei confronti delle parole. Ma le parole, nella pratica, non sono mai imprecise
quando vengono usate in un determinato contesto e in un rapporto faccia-a-faccia, con tempi lunghi che
permettono di metabolizzare incomprensioni ed errori. Le parole sono pericolose quando danno l’illusione di
definire una volta per tutte il proprio contenuto e la propria via.
Sono a volte parole nutrienti. E come tutto ciò che nutre, sono anche cariche di virus. A forza di ripeterle,
il loro nutrimento deperisce, si banalizza, e i virus si scatenano.
Per questo le parole vanno cambiate spesso per non lasciarle stagnare. Sono come palle di neve. Buone
per colpire. Ma non possiamo conservarle a lungo, come se fossero pietre o pepite. Una palla di neve può
essere un’arma, ma è anche una pietra d’acqua. Una contraddizione in termini, come le frecce di ghiaccio di
alcuni romanzi polizieschi: colpiscono, si fanno strada fino al cuore e ne arrestano il battito. Poi spariscono
senza lasciare traccia.
Come trasformare le parole tecniche in parole efficaci pronte a sparire? Come sfuggire alla rigidità delle
formule senza perdere il rigore del mestiere? Dobbiamo saper sciogliere le vecchie formule in nuove
immagini che aprano un sentiero nella nostra geografia interna. Dobbiamo saper ingurgitare petrolio e
sputare fuoco.
Qual è la lingua dell’attore? Gli antichi dicevano: è il dialogo. Pensavano solo al testo che può essere
agevolmente scritto e parlato tra due o più persone. Ma l’attore, in scena, dialoga sempre. Anche nel
monologo, in realtà, si rivolge agli spettatori, agli dei, al fantasma di suo padre o a una parte di sé che egli
sente separata, quella parte che vive in esilio dentro di sé.
Anche la presenza scenica, extra-quotidiana dell’attore è un dialogo incessante di impulsi e tensioni il cui
flusso multiforme provoca una sensazione di vita intensificata nello spettatore. Questo effetto organico, che
agisce sui sensi e sulla memoria dello spettatore, può essere generato solo dal sapere incorporato
dell’attore.
Come spiegare a parole questo continuo dialogo interno materiale e mentale? Come rivitalizzare le nostre
parole senza indebolirne la loro suggestività e i loro morsi precipitandole nell’automatismo e nell’astrazione?
www.odinteatret.dk
Ai suoi esordi, ogni attore è dotato di tre lingue. Solo se ne è consapevole potrà sviluppare le caratteristiche
di ognuna di esse e, intrecciandole, renderle consonanti o dissonanti, orchestrando così una sinfonia di
stimoli sensoriali e mentali dialettici.
Queste tre lingue sono, la sonorità della voce, il senso delle parole che sono dette, e i gesti e le attitudini che
le accompagnano. Già Mejerchol’d aveva individuato due lingue - quella delle reazioni fisiche e quella del
significato del testo. A queste si deve aggiungere la lingua della sonorità che può facilmente negare il
significato con un’inflessione ironica, patetica o aggressiva. Da qui un apprendistato - un training - il cui fine
è sviluppare il potere suggestivo della voce, le sue possibilità melodiose ed effetti emotivi. Le intonazioni
della voce sono musica che induce associazioni, atmosfere, stati d‘animo. La lingua sonora trasmette
informazioni non-concettuali che, come degli armonici indipendenti, commentano in continuazione il testo.
Anche la lingua della “spontaneità”, delle attitudini e dei gesti quotidiani, può essere sottomessa a un
training per svincolarsi dalle sue connotazioni ovvie di gesticolazione ripetitiva. La lingua di cliché che
caratterizza la nostra personalità privata e sociale può essere rivitalizzata attraverso impulsi mentali e fisici
che accoppiano realtà tra loro distanti, pensieri antitetici e idee mutualmente irriconciliabili. Un training
fisico e vocale familiarizza l’attore a questo modo paradossale di pensare con l’intero corpo-mente. “Posare
baci come uno sguardo, piantare sguardi come alberi, imprigionare alberi come uccelli, annaffiare uccelli
come eliotropi”. Il programma che Vicente Huidobro proponeva alla generazione di poeti suoi coetanei
potrebbe valere anche per l’attore.
Come un ossimoro - l’immagine contradittoria plasmata dal nero fulgore delle parole di un poeta - il
comportamento dell’attore diventa un chiaro enigma: evidente per le sue conseguenze sensoriali ed emotive,
ma difficile a spiegare in termini razionali. Grazie a questo processo di poesia mentale/somatica (non
dimentichiamo che in greco poiein significa forgiare materialmente) l’attore trasforma i cliché fisici e vocali in
segni insoliti ed efficaci, una sintesi di intenzioni e stimoli contrastanti che trasportano lo spettatore in un
universo di metafore e autobiografia.
Oggi pochi attori sanno distillare dall’impasto e dal dialogo delle loro tre lingue altrettante ombre che
bisbigliano. Se queste ombre si manifestano, lo spettatore le avverte e si sente interrogato dal loro bisbiglio.
Tre ombre si proiettano in direzioni divergenti dalle tre lingue materiali della sonorità, del significato e dei
dinamismi somatici. Ogni ombra bisbiglia in una sua lingua: Švejk, tigre e angelo.
La lingua di Švejk, il personaggio di Hašek e di Brecht, nasconde con le parole il vero senso delle sue azioni.
Il suo parlare è l’arte della reticenza.
La lingua della tigre è quella del pericolo incombente e dissimulato che a volte lo spettatore intuisce senza
spiegarselo. La tigre non fa un passo senza essere pronta ad attaccare. Si riposa accingendosi a scagliarsi.
Quando è immobile, è il momento più temibile. La sua grazia è ferocia. Adora tutto ciò che è vivo, e di ciò
che adora fa il suo cibo.
La lingua dell’angelo è la più difficile da raccontare. Gli angeli - la loro stessa etimologia lo dice -sono
messaggeri allo stato puro. Esistono solo nel momento in cui eseguono un compito carico di destino. La loro
vita è tutta nel messaggio che è loro affidato. Il messaggero è il messaggio, e anche la più infima sfumatura
del messaggio è essenziale. L’angelo si concentra sulla potenza di ogni cenno, di ogni sguardo, di ogni
sillaba e intonazione, della più lieve cadenza e dell’immobilità più fugace senza essere consapevole di ciò che
il messaggio dice a chi lo riceve. Non pretende di interpretarlo: lo trasmette. Coniuga tutto questo con la sua
vocazione cieca - incomprensibile anche a lui stesso - di non poter essere che un angelo: un messaggero
consapevole di non essere in grado di sapere se in quel che trasmette vi sia un senso, e quale esso sia per
ogni singolo spettatore.
Non pensate che stia prendendo le parole per la coda e le faccia squittire roteandole in aria. Dico solo
un’ovvietà. Chi di noi non ha sperimentato almeno una volta la lingua angelica di un attore che ci ha
bisbigliato, suo malgrado, un nostro segreto?