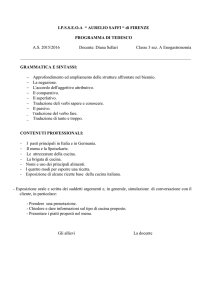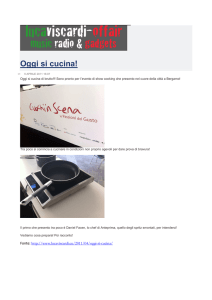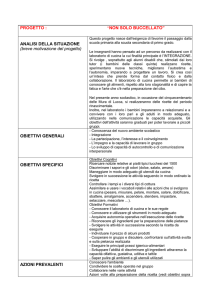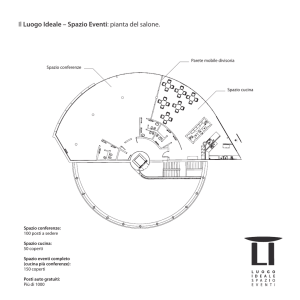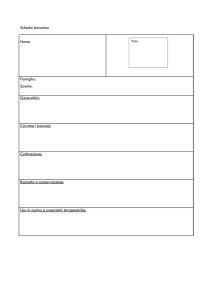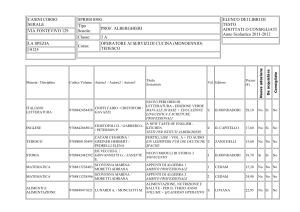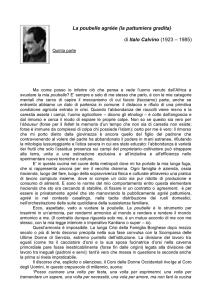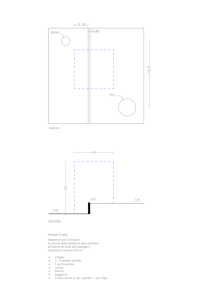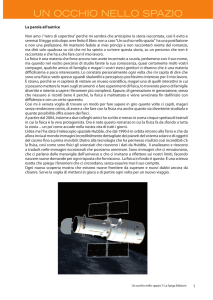il fatto, il commento
Legge «Harlem»,
l’autarchia in cucina
D
Anna Casella
Paltrinieri
Docente di
Antropologia culturale
presso le varie sedi
dell’Università Cattolica,
ha svolto ricerche
e viaggi in diversi
Paesi dell’America
meridionale.
Dal 2009 cura
su Popoli una rubrica
di etnogastronomia.
etta così può anche
sembrare una buona
mossa. Parliamo della
legge «Harlem» (chiamata anche
legge anti-kebab) approvata il
14 febbraio dalla Giunta regionale lombarda (poi impugnata
dal governo italiano davanti
alla Corte costituzionale) e che
vorrebbe, con precise norme,
impedire il sorgere di quartierighetto nelle nostre città. Giusto.
Poi, però, sorge il sospetto. E
allora si scopre che la legge
pensa di impedire la formazione
di ghetti limitando l’apertura
dei locali di ristorazione etnici.
Vale a dire quei locali che non
servono la cotoletta alla milanese o il risotto allo zafferano,
ma, magari, involtini primavera
o kebab. La ragione? Dipende se
si è di destra o di sinistra. Perché nei Comuni italiani (e sono
tanti) che hanno già adottato
misure anologhe le spiegazioni
sono di due tipi e distinguono
equamente tra destra e sinistra.
Per cui, il rottamatore sindaco
di Firenze, il quale pare abbia bloccato la concessione di
nuove licenze per fast food,
Internet point e negozi etnici,
ha in mente il decoro della
sua italianissima città (e per
questo motivo, vorrebbe anche
far sparire i gadget prodotti in
Cina), quello di Forte dei Marmi
tira in ballo il genius loci per
vietare sul lungomare qualsiasi
ristorante che non sia «locale».
Invece la Giunta lombarda, di
centro-destra, pensa piuttosto
alla sicurezza dei cittadini e
al degrado ambientale, come
quella di Bergamo che parla di
«difesa dell’ordine pubblico» e
lotta al degrado.
Siamo di fronte, non c’è dubbio, a una versione popolare e militante dei dottissimi dibattiti sull’identità. Identità che si sente minacciata, a quanto pare, dagli involtini,
o dai sushi, per trovare riposo, invece, sulla cassoela o
sulla ribollita, o magari sul caciucco alla livornese.
Che la cucina sia un confine difficile da attraversare
ormai lo si sa da tempo. Un conto è fare incursioni in
campo «nemico», magari per provare il kebab su una
spiaggia mediorientale, sempre con la riserva mentale
di trovarlo inferiore ai propri spaghetti. Da queste incursioni vacanziere, infatti, si può sempre recedere, non
mettono in discussione nulla, ci si può anche pentire o,
magari, servirsene per dimostrare la propria onestà intellettuale. Ma permettere che nei luoghi-simbolo, come
il centro storico, si insedi stabilmente un avamposto
culinario, questo appare come una capitolazione, un
Decidere che il fast food cinese stona con il
Castello Sforzesco comporta il pensare a una
comunità finta, un palcoscenico nel quale
si recita un’Italia che non c’è più. La legge
«Harlem» non salva neppure il senso del ridicolo
rinnegare l’atavica «identità». E allora, ecco la ragione
di queste singolari restrizioni ed ecco pronte le giustificazioni: per il decoro o per la sicurezza, per il made in
Italy o per il degrado.
Ci si aspetterebbe dai nostri amministratori più senso
storico. La cucina è sempre, e da sempre, meticciata.
E non solo perché le materie prime vengono spesso da
lontano (come si sarebbero chiamati gli uomini del Nord
prima dell’arrivo del mais per la polenta?), ma anche
perché le ricette sono tutto un copiare gli uni dagli altri
e, infine, perché sempre i commerci sono fioriti perché le
comunità dipendevano da prodotti che non trovavano
in casa, che fosse il pepe o lo zenzero o la patata. L’autarchia in cucina pare proprio un’invenzione. Il fatto è,
però, che l’universo della cucina assorbe tutti i significati: gli odori separano, le ritualità separano, la distinzione
tra commestibile e non commestibile separa.
Però, decidere che il fast food cinese stona con il profilo
del Castello Sforzesco comporta il pensare a una comunità finta, una sorta di palcoscenico nel quale si recita
una Italia che non c’è più. La legge «Harlem» non salva
neppure il senso del ridicolo.
Una ciotola e due bacchette giapponesi.