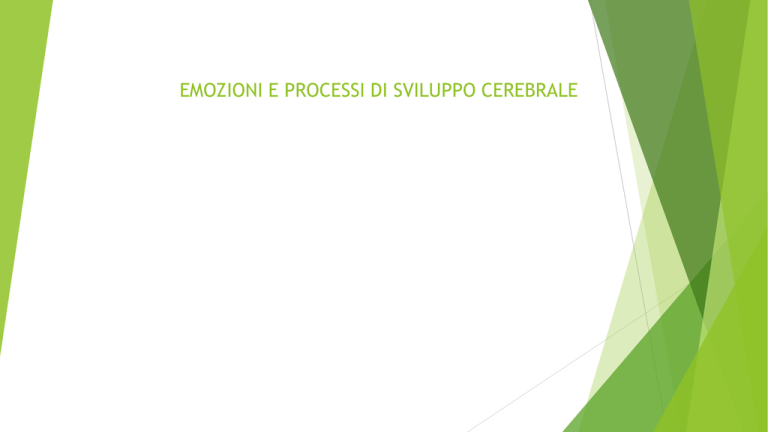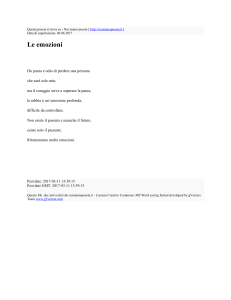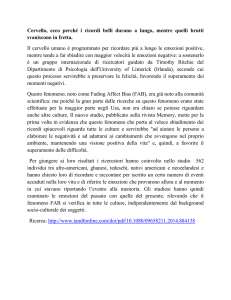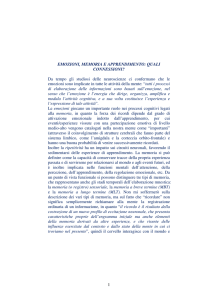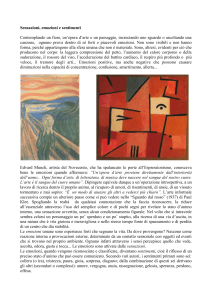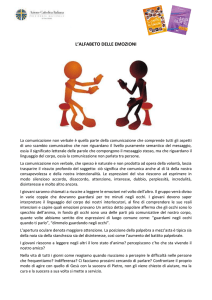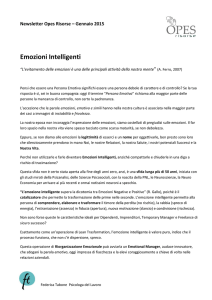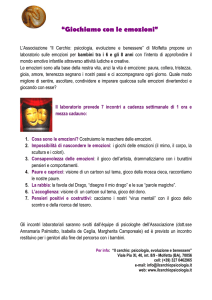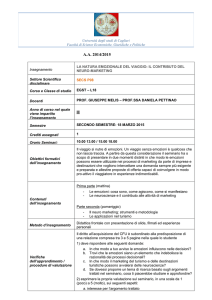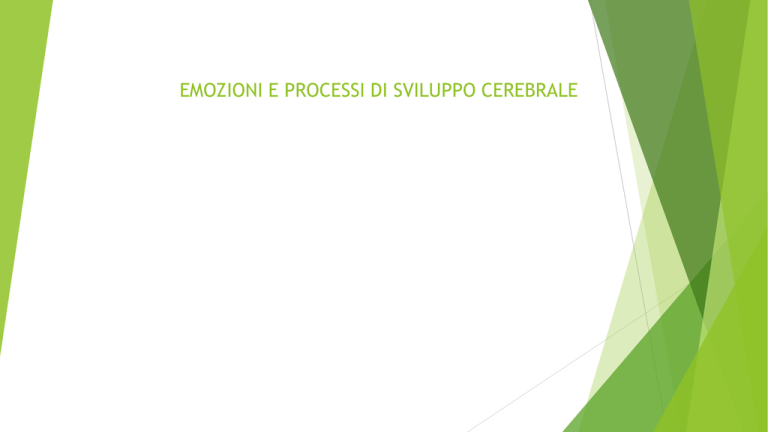
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Le emozioni non sono circoscritte a determinati circuiti o ad aree
cerebrali specifiche; al contrario, le regioni limbiche sembrano
mediare attività che influenzano la maggior parte delle funzioni del
cervello e dei processi della mente.
Il sistema limbico è responsabile dei meccanismi che portano
all’attribuzione dei significati e valori agli stimoli, è anche implicato
nel sistema di elaborazione delle informazioni che media le funzioni
cognitive sociali e la teoria della mente.
Le emozioni coinvolgono l’intero cervello (LeDoux, 1996).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
«Tutti i processi di elaborazione delle informazioni sono basati
sull’emozione, nel senso che l’emozione è l’energia che dirige,
organizza, amplifica e modula l’attività cognitiva, e a sua volta
costituisce l’esperienza e l’espressione di tale abilità (Dodge, 1991)».
Questa visione sottolinea la natura ubiquitaria delle emozioni, e allo
stesso tempo indica che la distinzione tra processi cognitivi ed emotivi
siano artificiali e possano ostacolare la nostra comprensione delle
attività della mente.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Le emozioni implicano «una reazione soggettiva a un evento saliente,
caratterizzata da cambiamenti fisiologici, esperienziali e
comportamentali» (Sroufe, 1995).
Simili interpretazioni suggeriscono che l’emozione può essere vista
come un processo che coinvolge componenti fisiologiche, esperienziali
ed espressive.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
EMOZIONI E AFFETTI si collegano a un insieme complesso di sistemi e
processi evolutivi interni e interpersonali che creano l’esperienza
soggettiva del Sé, la cui organizzazione dipende dal modo in cui
emozioni e affetti sono regolati.
Le emozioni e le loro modulazioni sono processi strettamente
intrecciati, ossia le emozioni sono regolate e possono svolgere al
tempo stesso funzioni regolative (Gross, Thompson, 2007): hanno il
duplice compito di esprimere e gestire l’affetto (Stroufe, 1995).
L’affetto è il modo in cui uno stato emotivo si rivela esternamente
attraverso segnali non verbali. Queste espressioni esterne possono
essere definite affetti primari o affetti fondamentali, in base alla
natura primaria o differenziata degli stati emotivi a cui
corrispondono.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
ORIENTAMENTO INIZIALE, VALUTAZIONE E AROUSAL
In seguito a determinati stimoli, il cervello entra in uno stato di
aumentata vigilanza, (qualcosa di importante sta succedendo) si ha
una risposta orientativa iniziale. Questa reazione attiva meccanismi
cognitivi («Fare attenzione!») che non richiedono una partecipazione
a livello conscio.
Subentra una fase di valutazione elaborativa e arousal, caratterizzata
da processi che modulano i flussi di energia all’interno nel cervello,
attraverso l’attivazione di determinati circuiti e la de-attivazione di
altri, e che portano alla differenziazione degli stati della mente
dell’individuo.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
I processi di valutazione – appraisal - elaborativa determinano se uno
stimolo è buono o cattivo, e di conseguenza determina il processo di
avvicinamento o allontanamento.
I circuiti attivati in risposta a questa prima valutazione
«buono/cattivo» portano a un’ulteriore valutazione: il processing
emozionale prepara il cervello e il resto dell’organismo all’azione
(«Agire!»).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
EMOZIONI PRIMARIE
Gli stati cerebrali generati dalle risposte orientative e dai processi di
arousal e valutazione elaborativa sono descritti come emozioni
primarie.
Queste sensazioni emozionali primarie sono non verbali, spesso
inconsce e derivano dalle variazioni nei flussi di energia che sono
associate ai fenomeni di attivazione e disattivazione all’interno del
sistema legati ai processi di valutazione.
Riflettono cambiamenti negli stati della mente; possono essere sottili
o intense, fugaci o persistenti. Contribuiscono a determinare come ci
sentiamo in ogni determinato momento.
In accordo con il concetto di dinamiche delle emozioni che coinvolge
l’immediatezza, l’intensità e la specificità delle risposte emozionali
(Thompson, 1994).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Quindi, in un primo momento, uno stimolo (interno o esterno) può
evocare uno stato di orientamento iniziale, che è associato alla
sensazione «Sta accadendo qualcosa: fare attenzione».
Tale risposta è automatica, e non richiede necessariamente il
coinvolgimento della coscienza.
Successivamente, lo stimolo e la stessa reazione iniziale continuano
ad essere valutati attraverso l’attivazione di circuiti che mediano
processi di valutazione elaborativa o arousal, e può incominciare a
svilupparsi la sensazione «Questo è buono o cattivo».
Queste prime due fasi della risposta emozionale contengono profili di
attivazione che possono essere definiti come emozioni primarie, e che
possono essere considerati come processi con cui la mente inizia a
creare significati.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Le emozioni primarie si manifestano esternamente attraverso stati di
attivazione del corpo, espressioni facciali, gesti, toni di voce e altri
segnali non verbali.
Nel corso dei suoi primi anni di vita, questi affetti primari
costituiscono la principale forma di comunicazione fra il bambino e i
genitori; ciò rivela come i sistemi di valutazione siano
particolarmente sensibili alle interazioni sociali.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
La terza fase della risposta emozionale corrisponde a quello che in
genere si intende normalmente per emozione: la differenziazione
degli stati di orientamento iniziale e di valutazione elaborativa e
arousal in emozioni fondamentali – come tristezza, rabbia, disgusto,
sorpresa, gioia, paura e vergogna.
Generate dai sistemi cerebrali di valutazione, queste attivazioni
emozionali influenzano tutte le funzioni della nostra mente, e danno
significato agli eventi della nostra vita.
Emozioni e significati sono creati dagli stessi processi.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
EMOZIONI FONDAMENTALI
Alla risposta orientativa iniziale e ai processi di valutazione-arousal
può far seguito una terza fase, che porta a una differenziazione dei
pattern di attivazione associati agli stati emozionali primari.
Le emozioni fondamentali possono essere considerate come stati
della mente differenziati che si sono sviluppati come pattern di
attivazione specifici.
Si riferiscono a sensazioni universalmente diffuse: paura, sorpresa,
gioia; questi stati emotivi sono spesso comunicati attraverso
espressioni del volto e si manifestano con profili fisiologici tipici.
UMORE si riferisce al tono generale delle emozioni nel tempo: può
essere considerato come un’inclinazione del sistema nei confronti di
determinare emozioni fondamentali, che influenza l’interpretazione
dei processi percettivi e il modo di pensare.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
VALUTAZIONE DI SIGNIFICATI
I sistemi di valutazione del cervello agiscono inducendo stati di arousal.
Lo stato di arousal innesca meccanismi attenzionali che vengono diretti in
maniera specifica su uno stimolo particolare, regolando flussi di elaborazione
delle informazioni. In termini di processing percettivo ciò significa che
l’individuo presterà maggiore attenzione.
Per quanto riguarda la memoria, lo stato di arousal facilita i processi di
registrazione, favorendo la creazione di nuove sinapsi e aumentando quindi la
probabilità di successivi richiami (McGaugh, 1992).
Alcuni aspetti del nostro sistema di valutazione sono innati, come quelli legati
ai sistemi motivazionali dell’attaccamento e della ricerca di novità, mentre
altri sono acquisiti attraverso l’esperienza.
La ricerca della prossimità e dello sguardo del caregiver non sono
comportamenti appresi, ma sono iscritti nel cervello del bambino fin dalla
nascita.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
L’elaborazione di informazioni coinvolge la creazione e la
manipolazione di rappresentazioni cognitive. I flussi di processing
delle informazioni sono diretti da meccanismi attenzionali, e
all’interno della percezione e della memoria le rappresentazioni
vengono etichettate come significative dai sistemi di valutazione.
In questo modo, i processi di valutazione e arousal, le componenti
fondamentali dell’emozione, sono strettamente intrecciati con i
processi rappresentazionali del pensiero.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Le strutture cerebrali responsabili dei meccanismi emozionali di
valutazione/arousal – partecipano anche ad altri processi cognitivi,
tra i quali la memoria emozionale (soprattutto per la paura),
l’empatia e le emozioni fondamentali (LeDoux, 1996; Izard, 1991).
La corteccia orbito-frontale è coinvolta nei processi di valutazione
(che conferiscono agli stimoli un significato o una valenza
emozionale), nella regolazione affettiva (la capacità del cervello di
modulare gli stati psicofisiologici), nella cognitività sociale (i
complessi meccanismi che consentono di leggere e di percepire gli
stati della mente degli altri) e nella coscienza autonoetica (la
capacità di viaggiare mentalmente nel tempo) (Damasio, 1994;
Schore, 1994; Baron-Choen, 1995; Wheeler et al., 1997).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
FLESSIBILITA’ DI RISPOSTA
La corteccia orbito-frontale registra cambiamenti inaspettati delle
condizioni interne e induce risposte comportamentali e cognitive
nuove e flessibili, che si sostituiscono a reazioni automatiche riflesse
(Freedman et al., 1998).
La flessibilità di risposta è mediata dalle regioni prefrontali può
implicare il coordinamento di processi che coinvolgono meccanismi
sensoriali, percettivi e valutativi, e determina la capacità di elaborare
risposte nuove e significative.
La flessibilità di risposta permette alla mente di valutare gli stimoli e
gli stati emotivi, e di modificare sia i comportamenti esterni, sia le
reazioni interne. Costituisce una componente importante della
comunicazione collaborativa e dei processi di sintonizzazione
affettiva.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Durante i primi anni di vita, le forme più precoci di comunicazione si
basano sulla condivisione di stati emotivi primari, e hanno un ruolo
fondamentale nel determinare le modalità con cui l’individuo si
metterà successivamente in relazione con gli altri.
Lo stabilirsi di queste forme reciproche e collaborative di
comunicazione potrebbe facilitare lo sviluppo di un processo
prefrontale parallelo, la flessibilità di risposta, che consente di
rispondere in maniera adattiva, internamente collaborativa, al variare
dei contesti interiori e interpersonali.
Attraverso questa forma di collaborazione interna processi diversi
possono venire collegati in uno stato della mente flessibile, adattivo
nei confronti di una gamma di fattori interni ed esterni.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
La flessibilità di risposta mediata dalle regioni prefrontali può
implicare il coordinamento di processi che coinvolgono meccanismi
sensoriali, percettivi e valutativi, e determina la capacità di elaborare
risposte nuove e personalmente significative.
Questa funzione integrativa ci può permettere, per esempio, di
prendere decisioni o di gestire i nostri rapporti con gli altri alla luce di
considerazioni sul nostro passato, presente, futuro.
La capacità di rispondere in maniera flessibile può essere collegata
funzionalmente ad altri processi prefrontali come la coscienza
autonoetica, la cognitività sociale o la memoria di lavoro.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Le narrative incoerenti fornite dai soggetti che presentano un
attaccamento insicuro, potrebbero rispecchiare una compromissione
di tale capacità.
La flessibilità di risposta può essere considerata come un elemento
implicato nelle correlazioni tra attaccamento genitore-figlio e
processi narrativi dell’adulto. Il mancato sviluppo di questa funzione,
o una sua insufficiente integrazione con altri processi, e in particolare
con quelli mediati dalle regione prefrontali, potrebbe avere effetti
generali e persistenti sulle esperienze interne e interpersonali.
E’ probabile che la flessibilità di risposta sia stato-dipendente, e possa
essere facilitata o inibita a seconda del contesto interno o
interpersonale.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
I centri di valutazione del cervello sono localizzati a livello del sistema
limbico (amigdala, la corteccia cingolare anteriore, la corteccia orbitofrontale).
Gli stimoli che provengono dall’ambiente esterno arrivano al cervello
attraverso i sistemi sensoriali.
Le rappresentazioni generate da questi processi percettivi vengono filtrate
attraverso il talamo e inoltrate all’amigdala, dove vengono sottoposte a una
valutazione iniziale: Questa cosa è buona o cattiva?
L’amigdala partecipa direttamente ai processi percettivi e valutativi
fondamentali, e nello stesso tempo trasmette queste rappresentazioni al giro
del cingolo e alla corteccia orbito-frontale per un’ulteriore valutazione.
Le informazioni vengono quindi inviate all’ippocampo, quale organizzatore
cognitivo, e in qualche caso trasferite nella memoria esplicita.
La corteccia orbito-frontale gioca anche un ruolo importante nel coordinare
questi processi di arousal e di valutazione con le rappresentazioni complesse
del pensiero superiore e dei processi cognitivi sociali.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
EMOZIONI E AUTOREGOLAZIONE
Le emozioni costituiscono processi organizzativi e integrativi e svolgono un
ruolo centrale nel coordinare diverse attività della mente: conferiscono agli
stimoli significati specifici e direzioni motivazionali; partecipano a processi
della memoria stato-dipendenti; collegano processi mentali distinti
sincronicamente e diacronicamente (in un dato momento e nel corso del
tempo); creano associazioni complesse tra processi rappresentazionali
astratti, sintonizzano le attività dell’intero organismo in funzione delle
particolari esigenze del momento (Ciompi, 1991).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI
I processi di regolazione delle emozioni possono variare
significativamente da individuo a individuo: livello di intensità, soglia
di sensibilità, la specificità dei processi di valutazione, accesso alla
coscienza.
Il temperamento si riferisce ad alcuni aspetti di caratteristiche
innate, come la sensibilità nei confronti dell’ambiente, l’intensità
delle risposte emozionali, l’umore complessivo di base, la regolarità
dei cicli biologici, la tendenza all’avvicinamento o all’allontanamento
di fronte a situazioni nuove o insolite.
Il temperamento può evocare un certo tipo di risposte nei genitori che
possono ulteriormente influenzare le caratteristiche innate di
partenza.
Nella regolazione delle emozioni partecipano sia
temperamentali sia passate esperienze di attaccamento.
fattori
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Intensità
Il processing delle emozioni si basa sulle attività dei sistemi di valutazione e
arousal, che possono rispondere agli stimoli con diversi gradi di intensità.
Il cervello, sembra essere in grado di modificare l’intensità delle sue reazioni
variando il numero dei neuroni attivati e la quantità di neurotrasmettitori
secreti in risposta ad un determinato stimolo.
In ciascuno di noi i livelli di intensità con cui in generale rispondiamo agli
stimoli possono essere determinati sia da fattori costituzionali, sia dalla storia
delle nostre precedenti esperienze. Per esempio, persone che hanno un
temperamento timido presentano una tendenza innata a reagire con
particolare intensità a situazioni per loro insolite, che spesso evocano
comportamenti di allontanamento o ritiro.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Sensibilità
Ognuno di noi ha una soglia di sensibilità caratteristica, il livello minimo al di
sotto del quale sensazioni o stimoli non inducono un’attivazione dei nostri
sistemi di valutazione.
Ma in che modo la mente può modificare la soglia di sensibilità?
Il nostro cervello può aumentare o ridurre in maniera diretta la sua sensibilità
all’ambiente innalzando o abbassando i livelli di stimolazione necessari per
attivare i suoi sistemi di valutazione (se per esempio, abbiamo visto un film
violento, uscendo dal cinema, mentre cerchiamo la nostra macchina, se
sentiamo un rumore violento, la nostra mente reagisce con uno stato di
attivazione, valutando la situazione pericolosa).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Sensibilità
Allo stesso modo il ripetersi di esperienze emotivamente intense di un certo
tipo può portare ad alterazione croniche del grado di sensibilità.
Per esempio, esperienze terrorizzanti, soprattutto in età infantile, possono
modificare in maniera permanente la sensibilità di un individuo nei riguardi di
stimoli correlati a tali eventi traumatici.
Se un bambino molto piccolo viene graffiato e morso da un gatto, è possibile
che anche a distanza di anni la vista di un gatto evochi in lui un’intensa
risposta emozionale di paura.
Traumi che si verificano durante i primi anni di vita possono essere associati a
un’aumentata secrezione di ormoni implicati nelle risposte allo stress, anche
in normali situazioni della vita quotidiana (Post et al., 1998).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Sensibilità
Alterazioni precoci dei circuiti cerebrali implicati nei processi di valutazione e
attribuzione di significati possono quindi avere profondi effetti sui
meccanismi che influenzano direttamente la natura delle esperienze emotive
e la regolazione delle emozioni.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Specificità
I processi di regolazione possono anche determinare quali regioni del cervello
vengono attivate negli stati di arousal emozionale.
Definendo la specificità dei processi di valutazione – le modalità con cui i
centri di valutazione stabiliscono il significato delle rappresentazioni – il
cervello è in grado di regolare i flussi di energia nei cambiamenti degli stati
del sistema.
La specificità determina non solo il significato che attribuiamo ai diversi
stimoli, ma anche la forma e il significato degli stessi processi emozionali,
attraverso meccanismi di «valutazione della valutazione».
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
ACCESSO ALLA COSCIENZA ci permette di modificare reazioni automatiche e
riflesse e di introdurre elementi di scelta nei nostri comportamenti.
Processi che vengono collegati all’interno della coscienza possono essere
manipolati e alterati intenzionalmente, allo scopo di generare risposte
maggiormente adattive.
La coscienza è collegata ai processi attenzionali e alla memoria di lavoro che
ci permette di riflettere simultaneamente su una serie di informazioni. La
memoria di lavoro permette processi di autoriflessione e scelte cognitive:
rende possibile intenzioni personali e comportamenti strategici, che non sono
il risultato di processi automatici.
La coscienza coinvolge l’attivazione e il legame selettivo di rappresentazioni
che vengono manipolate intenzionalmente all’interno della memoria di lavoro
(ovvero ci permette di rispondere in maniera più flessibile agli stimoli
ambientali).
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Memoria di lavoro è stata definita come lavagna della mente, un sorta di
deposito temporaneo che ci permette di tenere a mente e di riflettere
simultaneamente su una serie di informazioni e dati diversi.
Tali riflessioni ci consentono di manipolare queste varie rappresentazioni, di
elaborarle ulteriormente (per esempio, di osservare similarità e differenze, o
di creare generalizzazioni) e di stabilire fra loro nuove associazioni.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Ma qual è il ruolo specifico della coscienza nella regolazione delle
emozioni?
La coscienza può influenzare l’outcome dei processi emozionali:
permette processi di autoriflessione, che a loro volta rendono
possibile la mobilizzazione di pensieri e comportamenti che facilitano
il raggiungimento di particolari obiettivi, attraverso l’acquisizione di
nuovi livelli di integrazione.
È coinvolta in due processi della regolazione delle emozioni: la
modulazione dei flussi di energia all’interno del cervello e
l’alterazione adattiva dei processi di elaborazione delle informazioni.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Ma perché i processi emozionali sono accessibili alla coscienza?
La capacità di coinvolgere la coscienza in processi fondamentali come
l’attribuzione di significati o l’elaborazione delle percezioni ci consente di
rispondere in maniera più flessibile agli stimoli ambientali.
È essenziale per la nostra sopravvivenza: ci permette di riconoscere
intenzioni, nostre e altrui, di gestire le complesse interazioni con il mondo
interpersonale in maniera più efficace ed adeguata al soddisfacimento dei
nostri bisogni e al raggiungimento dei nostri obiettivi.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Il Sé è capace di almeno due stati contestuali: un Sé interno privato e un Sé
esterno, pubblico e adattivo (Harter et al., 1997).
Nell’ambito di determinate situazioni sociali la capacità di nascondere le
proprie emozioni può essere adattivamente importante.
I problemi sorgono quando questi processi di modulazione sono
eccessivamente rigidi, e l’inibizione delle espressioni emozionali diventa uno
stato tipico, un tratto dell’individuo.
Se nel corso del suo sviluppo il bambino non trova contesti sociali in cui il Sé
privato può interagire liberamente e pienamente con altre persone; il Sé
pubblico e adattivo può diventare dominante; le sue emozioni vengono
sistematicamente mascherate e nascoste non solo agli altri, ma anche a se
stesso.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Bloccando ripetutamente le sue espressioni affettive l’individuo corre il
rischio di inibire cronicamente l’accesso delle emozioni alla coscienza.
I meccanismi che determinano un blocco delle espressioni emozionali non
sono chiari, ma probabilmente coinvolgono un’inibizione temporanea dei
circuiti che controllano tali espressioni, situati, soprattutto nell’emisfero
destro, e in particolare a livello dell’amigdala e della corteccia orbitofrontale.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Caratteristiche costituzionali, esperienze traumatiche o relazioni di
attaccamento non ottimali possono produrre una regolazione maladattiva
delle emozioni, che limita la resistenza emotiva e la flessibilità
comportamentale dell’individuo; se le capacità del sistema limbico di
modulare intensi stati di arousal sono ridotte, può essere particolarmente
utile imparare a usare funzioni neocorticali che permettono di analizzare e
quindi di intervenire sulle risposte disregolative iniziali.
Cioè, quando una persona perde la capacità di pensare razionalmente;
modificare le reazioni automatiche iniziali può essere molto difficile,
soprattutto se si tratta di risposte radicate, che sono state inscritte
precocemente nei suoi circuiti limbici.
Strategie che coinvolgono attività neocorticali possono aiutare l’individuo a
riportare l’intensità di queste risposte emozionali entro livelli più tollerabili
(per esempio, attraverso dialoghi riflessivi interni) e a renderle meno
frequenti e più facilmente controllabili.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
PATTERN DI AUTOREGOLAZIONE DISFUNZIONALI
Molte patologie psichiatriche possono essere viste come disturbi dei processi
di autoregolazione.
Negli individui che soffrono di patologie, con il passare del tempo l’instabilità
degli stati della mente può diventare una caratteristica tipica, un tratto
stabile dei loro processi disfunzionali di autoregolazione.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Le emozioni come processi integrativi.
Le emozioni collegano tra loro processi fisiologici (dell’organismo),
cognitivi (elaborazione delle informazioni), soggettivi (sensoriali
interni) e sociali (interpersonali).
Le emozioni regolano la mente e sono regolate dalla mente: la
regolazione delle emozioni e le emozioni come processi regolativi.
L’integrazione è un processo attraverso il quale componenti separati
vengono collegate in un sistema più ampio; l’integrazione neurale
collega tra loro l’attività di diverse aree del cervello e dell’organismo.
A livello cerebrale, zone di convergenza, sono formate da cellule
nervose i cui prolungamenti si estendono diffusamente a numerose
regioni, raccogliendo in un unico insieme funzionale impulsi e
informazioni che derivano da una serie di aree distinte.
EMOZIONI E PROCESSI DI SVILUPPO CEREBRALE
Zone di convergenza che integrano le attività di varie regioni cerebrali sono:
la corteccia orbitofrontale, l’ippocampo, il cervelletto;
Altre attività sono integrate dal corpo calloso, che connette i due emisferi
cerebrali, o dall’amigdala, che attraverso un esteso sistema di fibre afferenti
ed efferenti può collegare processi che coinvolgono elementi percettivi,
azioni motorie, risposte dell’organismo e interazioni sociali.
Alterazioni dei processi di integrazione, che normalmente garantiscono il
mantenimento di un equilibrio tre le varie attività cerebrali, sono in grado di
dare origine a disfunzioni emozionali generando quadri di dis-integrazione.
Funzionamento sociale e competenza emotiva: espressività e regolazione
delle emozioni
L’espressività e la regolazione emotiva sono legate al funzionamento
sociale (Campos et al., 1989).
È stato dimostrato che gli stati emotivi, specialmente quelli negativi,
e la loro regolazione influenzano una molteplicità di aspetti rilevanti
della vita sociale (Eisenberg, 2000). Si ritiene che gli individui
incapaci
di
regolare
i
propri
comportamenti
di
reazione,
probabilmente non riusciranno a gestire quell’arousal emotivo che
scatta nelle situazioni sociali, e di conseguenza, potrebbero adottare,
con molta più facilità, modalità di comportamento inappropriate o
distruttive (Rothbart, Bates, 1998).
Funzionamento sociale e competenza emotiva: espressività e regolazione
delle emozioni
Alte frequenze di emozioni negative potrebbero costituire un fattore
predittivo di scarse competenze sociali (Eisenberg et al., 1993), di carenti
abilità prosociali (Eisenberg et al., 1996), di problemi della condotta
(Eisenberg et al., 1996), e di abuso di sostanze negli adolescenti (Chassin et
al., 1993).
Lo sviluppo dell’espressività e la regolazione emotiva, oltre a seguire
l’andamento di crescita fisiologica del soggetto, sembra essere condizionato
da particolari situazioni contestuali (le reazioni altrui) che potrebbero
rinforzare positivamente o inibire l’evoluzione di tali fattori (Caspi, 1998).
Ad esempio, bambini emotivamente poco regolati, ricevono con molta più
frequenza rispetto ai loro coetanei maggiormente competenti, punizioni da
parte degli adulti; ciò impedisce l’apprendimento di modalità più funzionali di
regolazione di arousal emotivo, e quindi, anche le interazioni sociali
successive potrebbero risultare compromesse.
Funzionamento sociale e competenza emotiva: espressività e regolazione
delle emozioni
Tra i fattori ambientali che possono favorire o ostacolare una continuità nel
funzionamento sociale: pratiche educative genitoriali, le relazioni con i pari,
l’espressività emotiva a casa e l’attaccamento genitore-figlio.
Alti livelli di accuratezza nella decodifica delle proprie emozioni testimoniano
una storia individuale in cui la comunicazione delle emozioni è stata
valorizzata da reazioni positive da parte del contesto sociale e da risposte
empatiche (Dunn, 2000).
Inoltre, è stato dimostrato che apprendere ad esprimere i propri sentimenti
ed emozioni, in maniera accurata, è strettamente connesso al livello di
competenza linguistica del bambino. Un adeguato linguaggio espressivo
costituisce un fattore predittivo sia di un uso consapevole di strategie
cognitive funzionali alla regolazione di stati emotivi negativi sia di un elevato
livello di self-efficacy circa tali competenze.
Codifica delle intenzioni e delle emozioni
La formazione di un repertorio sociale adeguato è strettamente
correlata alla capacità personale di codifica e comprensione degli
eventi, in termini di azioni, intenzioni ed emozioni.
Difficoltà nei processi di elaborazione dell’informazione, in
particolare a livello di codifica delle intenzioni e delle emozioni altrui
spinge il soggetto a interpretazioni errate che crea presupposti per
risposte comportamentali inadeguate, e nella maggior parte dei casi,
aggressive (Crick, Dodge, 1994).
Codifica delle intenzioni e delle emozioni
Una maggiore percezione delle emozioni (sia positive o negative) è
strettamente connessa alla comparsa di comportamenti socialmente
adeguati, ad una efficace soluzione di conflitti e all’accettazione da parte dei
pari.
Tale relazione sembra essere condizionata dalla qualità dell’ambiente
familiare, infatti, bambini che vivono in contesti favorevoli (a basso rischio) si
dimostrano maggiormente empatici e più abili nel riconoscimento emotivo
rispetto ai loro coetanei inseriti in situazioni più svantaggiate.
Da ciò emerge l’importanza dell’attività di codifica delle emozioni quale
elemento predittivo dell’evoluzione delle traiettorie comportamentali del
soggetto.
Studi neurobiologici sull’autismo
Neuroni mirror
Meccanismi neurofisiologici che sottendono processi cognitivi: neuroni mirror
(Rizzolatti et al., 1996; 1998; 2000).
I neuroni specchio furono originariamente identificati nell’area F5 della
corteccia premotoria nelle scimmie (Gallese, Fadiga, Fogassi et al., 1996;
Rizzolatti, Fadiga, Gallese et al., 1996): i neuroni di questa area si attivano
non solo quando le scimmie muovevano la mano o la bocca ma anche quando
vedevano un altro individuo compiere la stessa azione. Ulteriori ricerche
hanno messo in luce la presenza dei neuroni specchio nell’uomo utilizzando
tecniche di visualizzazione cerebrale.
Dopo la scoperta iniziale si è visto che esiste una rete di aree in rapporto tra
loro, come pars opercularis del gyrus frontale inferiore (IFG), la corteccia
frontale anteriore, il lobulo parietale inferiore e il sulcus temporale
superiore che si attivano durante l’osservazione e l’imitazione di un’azione.
Studi neurobiologici sull’autismo
Studi di neuroimaging funzionale hanno evidenziato anomalie dei
neuroni specchio nell’autismo rilevate attraverso prove di
osservazione e di imitazione delle espressioni emotive.
I soggetti autistici ha superato le prove imitative al pari del gruppo di
bambini normali. Tuttavia le strategie sono differenti: i bambini
normali utilizzano l’emisfero destro e il sistema dei neuroni specchio,
il sistema limbico attraverso l’insula; nel caso del gruppo dei bambini
con DSA il sistema dei neuroni specchio non è attivato per cui vi è una
strategia alternativa e probabilmente il significato soggettivo delle
emozioni non è sperimentato.
Si ritiene che la disfunzione precoce dei neuroni specchio possa
costituire il nucleo dei deficit sociali dell’autismo (Dapretto et coll.,
2006).
Studi neurobiologici sull’autismo
Studi neurobiologici sull’autismo
Studi del sistema limbico, amigdala e ippocampo: sono state messe in
luce anomalie in queste aree, come densità ridotta, dimensione
cellulare e arborizzazione dendritica nell’amigdala, nell’ippocampo,
nel setto.
L’amigdala gioca un ruolo importante nell’attivazione delle emozioni,
nell’assegnare significato agli stimoli ambientali e nel mediare
l’apprendimento emozionale (LeDoux, 1996). Numerosi studi hanno
messo in luce una ipoattivazione dell’amigdala nell’autismo durante i
compiti che implicano la percezione delle espressioni facciali e la
teoria della mente (Baron-Choen, Ring et al., 1999; Castelli, Frith,
Happe et al., 2002).
Studi neurobiologici sull’autismo
Studi neurobiologici sull’autismo
L’ipoattivazione dell’amigdala darebbe sostegno all’ipotesi della
motivazione sociale nella genesi dell’autismo. L’amigdala, ha dei
neuroni che sono sensibili alla direzione dello sguardo, infatti, i
bambini autistici hanno difficoltà ad interpretare le informazioni dello
sguardo.
I bambini autistici non mostrano differenti reazioni del sistema
nervoso autonomo quando osservano la faccia della madre oppure una
tazza. Questa risposta sarebbe legata alla disfunzione dell’amigdala
che avrebbe un ruolo eccitatorio nel produrre risposte autonomiche.
Studi neurobiologici sull’autismo
Deficit nel campo della teoria della mente (Theory of Mind, ToM)
È la conseguenza del fallimento nell’acquisire la capacità di concepire
e comprendere la mente degli altri oltre che la propria;
Incapacità di costruire un mondo sociale guidato da emozioni, desideri
e convinzioni (Baron-Cohen et al., 2000);
Incapacità di sviluppare processi cognitivi che consentono di orientarsi
socialmente.
Funzionamento sociale e competenza emotiva: espressività e regolazione
delle emozioni
Disturbo primario dell’intersoggettività (Hobson, 1993)
Focus sul versante degli affetti e del legame affettivo: i primi
comportamenti sociali presenti nei primi mesi non evolvono verso
comportamenti sociali più complessi e quindi anche i comportamenti
semplici tendono progressivamente a scomparire.
Da qui deriverebbero i deficit cognitivi, di apprendimento, del
linguaggio e della ToM.
Funzionamento sociale e competenza emotiva: espressività e regolazione
delle emozioni
Deficit di attenzione condivisa
Disfunzioni precoci come le competenze di attenzione condivisa (joint
attention) capacità di condividere un focus comune di attenzione con
un’altra persona, come per esempio guardare nella direzione dello
sguardo di un’altra persona che sta guardando un oggetto (sviluppo
tipico 10-14 mesi; difettuale nei bambini autistici).
Deficit che riguarda l’imitazione, una competenza decisiva per
l’apprendimento sociale che facilita anche i processi intersoggettivi;
Deficit nell’orientamento preferenziale verso gli stimoli sociali e la
spinta al coinvolgimento sociale.
Interazioni madre-bambino con disturbo dello spettro autistico
Si ipotizza che nei DSA, i disturbi neurologici di base, alterando la capacità
del bambino di imparare a codificare e decodificare gli stati emotivi propri ed
altrui e compromettendo la naturale tendenza a condividere con l’altro i
propri interessi, impediscano l’instaurarsi della reciprocità relazionale con la
madre che normalmente assolve la funzione di supporto emotivo per lo
sviluppo cognitivo del bambino;
Il deficit neurologico di base produce, come sintomo secondario, un
disfunzionamento a livello interattivo che a sua volta ha una ricaduta
negativa sullo sviluppo cognitivo (Trevarthen, 1998; Venuti, 2003).
Le madri di bambini con DSA sembrano avere la tendenza a un maggior
controllo e una maggiore direttività, mostrando più tentativi di agganciare
l’attenzione del bambino soprattutto attraverso approcci di tipo fisico
(Lemanek, Stone, Fishel, 1993).
Le alterazioni nella relazione madre-bambino
Sintonia: il bambino non sperimenta la capacità di risposta pronta e
immediata da parte della madre e quindi può attivare una relazione di
attaccamento insicura. Crescere con una carenza nella sintonia conduce a
sentirsi spesso minacciato dal mondo esterno, per far fronte al quale è facile
che attivi comportamenti di aggressività e opposizione;
Reciprocità: ossia il bambino non sperimenta quegli stati di condivisione in
cui attraverso lo sguardo e l’interazione reciproca. È alla base delle
acquisizioni relative all’alternanza del turno e alla referenzialità degli
oggetti. Una sua alterazione conduce a difficoltà nello sviluppo linguistico e
nelle acquisizioni competenze sociali, comprensione sentimenti e regolazione
propri stati emotivi;
Intenzionalità: ossia il rendersi conto che le proprie azioni hanno effetto sugli
altri. Se il bambino non ha ottenuto risposte adeguate alle sue richieste e se
l’adulto non ha dato significato ai suoi gesti, l’intenzionalità non può essere
pienamente acquisita, ciò conduce a difficoltà nello sviluppo linguistico e
comunicativo, oltre che ad una scarsa autonomia e decisionalità. Difficoltà di
progettazione di azione e piani sequenziali di comportamenti.
Classificazione DSM 5 disturbo dello spettro autistico
I disturbi dello spettro autistico sono accorpati in un’unica categoria
diagnostica - disturbo dello spettro autistico – unificando in due sole
categorie diagnostiche i sintomi: 1) deficit nella comunicazione
sociale e nelle interazioni e 2) presenza di pattern di comportamento,
interessi e attività ripetitivi.
La diagnosi viene personalizzata indicando la gravità dei sintomi, le
abilità verbali o eventuali anomalie genetiche. Comportamento
sociale e comunicazione sono aspetti inscindibili nel funzionamento
individuale e le difficoltà nella mentalizzazione, nel riconoscimento
empatico e nell’uso pragmatico del linguaggio, vanno trattati come
insieme coerente.
Studi e ricerche DSA
In uno studio sistematico di più di 200 lavori di neuroimaging con
soggetti affetti da uno dei disturbi dello spettro autistico (PinaCamacho, Villero, Fraguas et al., 2011) ha permesso di individuare
irregolarità nel funzionamento e nella struttura delle aree frontotemporale e limbica in relazione alle diverse forme di disturbi
nell’interazione sociale e nella difficoltà di usare propriamente gli
aspetti pragmatici del linguaggio e irrigolarità nel funzionamento e
nella struttura delle aree fronto-striato-cerebellari in associazione ai
comportamenti ritualistici e ossessivi dei pazienti con DSA.
Studi e ricerche DSA
Studi di risonanza magnetica funzionale convergono sull’ipotesi che i
disturbi dello spettro autistico possano essere legati anche a una
connettività atipica tra differenti aree del cervello, che sembrerebbe
portare a un sistema non del tutto adeguato all’elaborazione di alcune
forme di informazioni complesse (ipotesi da verificare) (Anagnostou,
Taylor, 2011).
Studi e ricerche DSA
Il cervello è un sistema estremamente plastico, e le connessioni tra
regioni e aree si creano o vengono inibite in risposta alle esperienze
fatte (Kandel, Jessell, Sanes, 2000) e la connettività funzionale è un
processo dinamico in costante evoluzione: il cervello è plasmato
dall’esperienza e l’autismo sarebbe legato sia a differenti tipi di
connessioni tra aree del cervello, sia ad aspetti strutturali differenti
come anomalie dia volume sia nella materia grigia sia in quella bianca
(Muller, 2008).
Studi e ricerche DSA
Nuove ricerche hanno anche evidenziato la
funzionamento dei neuroni a specchio e i
relazionali in soggetti con disturbo spettro
Asperger, disturbo autistico non altrimenti
Ramachandran, 2007).
relazione tra il cattivo
deficit comunicativi e
autistico, sindrome di
specificato (Oberman,
Studi e ricerche DSA
La dimensione biologica costituisce soltanto metà del problema.
L’altra metà sono i fattori ambientali che, sia attraverso meccanismi
neurobiologici diretti, sia interagendo con i geni, interferiscono con lo
sviluppo neurale normale e portano all’autismo.
Le circostanze ambientali che hanno attirato l’attenzione dei
ricercatori sono diverse. Per diversi anni si è cercato di capire se
alcuni vaccini o i conservanti contenuti nei vaccini fossero responsabili
dell’incremento dei casi di autismo, ma non sono mai state trovate
prove a sostegno di quest’ipotesi.
Bibliografia
Ciompi L., (1991) «Affects as central organising and integrating factors: a new
psychosocial/biological model of the psyche». In British Journal pf Psychiatry,
159.
Damasio A.R. (1995) L’errore di Cartesio. Emozione, regione e cervello. Tr. It.
Adelphi.
Iacoboni M., Woods R.P., Brass M., Bekkering H., Mazziotta J.C., Rizzolatti G.,
(1999) «Cortical mechanisms of human imitation». In Science, 286.
Lewis M.D., Granic I. (2000) (a cura di) Emotion, Development and Selforganization. Cambridge University Press, New York.
Thompson R., (1994) «Emotion regulation: A theme in search of definition». In
Fox, N.A. (a cura di), The Development of Emotion Regulation: Biological and
Behavioral Consideration. Monographs of the Society for Research in Child
Development, 59.