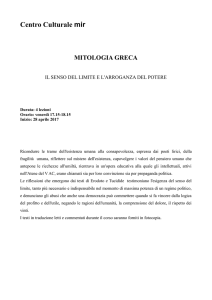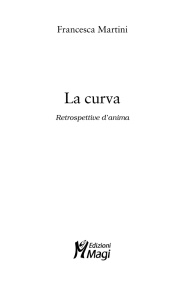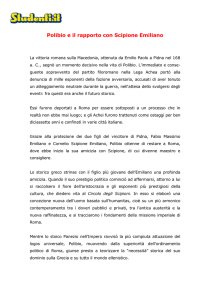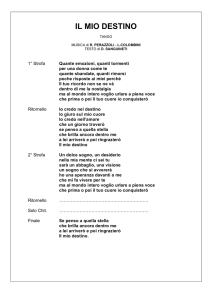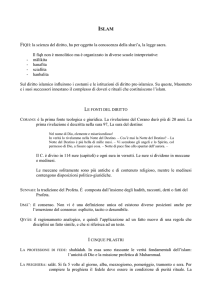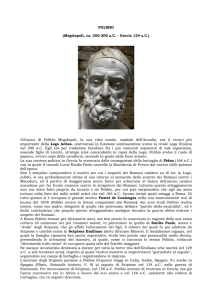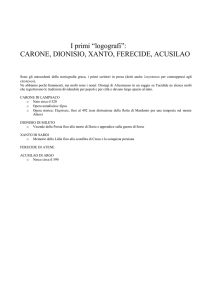Karl Lowith, Significato e fine della storia. Introduzione
L'interpretazione della storia è in ultima analisi un tentativo di comprendere il senso dell'agire e
del patire degli uomini in essa. Nel nostro tempo milioni di uomini hanno portato in silenzio la
croce della storia, e se qualcosa induce a pensare che il « senso » di quest'ultima potrebbe essere
compreso teologicamente, ciò è appunto la concezione cristiana della sofferenza. Al problema del
dolore il mondo occidentale ha dato due differenti risposte: il mito di Prometeo e la fede nel
Crocifisso. Né il paganesimo né il cristianesimo hanno comunque ceduto all'illusione moderna che
la storia costituisca uno sviluppo progressivo, che risolve il problema del male e del dolore con la
sua graduale eliminazione.
E privilegio della teologia e della filosofia porre problemi che non sono suscettibili di una soluzione
empirica. Di questo tipo sono i problemi che riguardano l'essere primo ed ultimo delle cose; essi
conservano la loro importanza proprio perché nessuna risposta riesce ad esaurirli. Non vi sarebbe
alcun problema intorno al senso della storia se questo apparisse già manifesto negli eventi storici.
D'altro lato la storia, anche soltanto riguardo ad un significato ultimo, può però apparire priva di
senso. Si possono avere delusioni solo ove ci si aspetti qualcosa. Ma la stessa impostazione della
ricerca del senso o del non-senso della storia è già storicamente condizionata: il pensiero ebraico e
cristiano hanno sollevato questa smisurata questione. Ricercare seriamente il senso ultimo della
storia supera ogni possibilità conoscitiva e ci mozza il respiro; ci precipita in un vuoto che soltanto
la speranza e la fede sono in grado di colmare.
I greci erano più modesti. Non si cimentarono nell'approfondire il significato ultimo della storia
universale. Essi erano presi dall'ordinamento visibile e dalla bellezza del cosmo naturale, e la legge
cosmica del divenire e del fluire delle cose costituiva anche il modello della loro comprensione
della storia. Secondo la visione greca del mondo tutto si muove in un eterno ricorso, in cui il
risultato finale si riconnette al suo principio. Questa visione comporta una concezione naturalistica
dell'universo, che congiunge la conoscenza del mutamento temporale con quella di una periodica
regolarità, costanza ed immutabilità. L'immutabile, quale anzitutto si manifesta nel movimento
ordinato dei corpi celesti, aveva per loro un interesse maggiore e un significato ben più profondo
di ogni progressivo e radicale mutamento. La « rivoluzione » è originariamente un'orbita circolare
naturale, e non la rottura con una tradizione storica.
In questo clima spirituale dominato dalla visione del mondo naturale non poteva affermarsi il
principio del significato storico-universale di un singolo evento. I greci ricercarono in ultima analisi
il lògos o del kòsmos, non già il Signore della storia. Perfino il precettore di Alessandro Magno non
ha dedicato alla storia alcuno scritto particolare e la teneva in poco conto rispetto alla poesia,
poiché la storia ha per oggetto il singolare e l'accidentale, mentre la poesia e la filosofia hanno per
oggetto invece il permanente. Per i pensatori greci una « filosofia della storia » sarebbe stata un
controsenso. La storia è storia politica e come tale è compito degli statisti e degli storici politici.
Per gli ebrei e per i cristiani la storia significa anzitutto il divenire della salvezza. Come tale essa è
di pertinenza dei profeti e dei predicatori. La filosofia della storia e la sua ricerca di un senso
ultimo sono scaturite dalla fede escatologica in un fine ultimo della storia della salvezza. Durante
l'era cristiana anche la storia politica fu sottoposta all'influenza fatale di questo sostrato teologico.
Il destino dei popoli fu interpretato come predestinazione divina.
Non è affatto un caso che nell'uso linguistico vengano scambiate le parole « senso » e « scopo »,
come pure « senso » e « fine »: è in generale il fine che determina l'importanza del « senso ». Il
senso di tutte le cose che non sono quello che sono per natura, ma che sono invece volute e
create da Dio o dall'uomo, è definito dal loro perché o dal loro scopo. Un tavolo è un « tavolo »
proprio perché si riferisce ad una finalità che trascende il suo essere materiale.
Anche gli eventi storici sono giustificati soltanto se rimandano ad uno scopo che trascende i fatti; e
poiché la storia si muove nel tempo, lo scopo deve essere una meta futura. Né gli eventi singoli né
una successione di eventi sono in quanto tali significativi e riferiti ad un fine.
La pienezza del significato richiede un compimento temporale. t possibile arrischiare un giudizio
sul senso degli avvenimenti storici quando il loro télos ro si fa manifesto. Quando un movimento
storico palesa la sua portata, allora noi riflettiamo sul suo primo sorgere per determinare il
significato dell'evento totale, benché particolare — «totale», in quanto ha un determinato punto
di partenza e un ultimo punto di arrivo escatologico. L'assunzione che la storia abbia un senso
ultimo prospetta dunque uno scopo finale come meta ultima che trascende gli eventi di fatto.
Questa identificazione di significato e scopo non esclude l'importanza relativa degli eventi, così
come la storia nella sua totalità non esclude i singoli accadimenti.
La dimensione temporale di un fine ultimo è perciò un futuro escatologico, e il futuro è per noi
attuale soltanto nell'attesa e nella speranza. Il senso ultimo è il punto focale di un futuro atteso,
che è oggetto di sapere solo nel modo della speranza e della fede. Una simile attesa era vivissima
presso i profeti ebrei; rimase invece estranea ai filosofi greci. Se si pensa che Isaia ed Erodoto
erano quasi contemporanei, si può misurare l'abisso incolmabile tra la sapienza greca e la fede
ebraica. La visione cristiana e post-cristiana della storia è essenzialmente rivolta al futuro: essa
inverte il significato classico di istorein, che si riferisce al divenire presente e passato. Nelle
mitologie e nelle genealogie greche e romane il passato viene ripresentato come origine
permanente; secondo la concezione ebraica e cristiana della storia il passato è una promessa del
futuro. Conseguentemente l'interpretazione del passato diviene una profezia retrospettiva, che lo
rappresenta come una « preparazione » significativa del futuro. I filosofi e gli storici erano invece
convinti che qualsiasi cosa accadesse nel futuro, si sarebbe attuata secondo un identico lògos e
avrebbe avuto una struttura conforme al divenire passato e presente.
Questa tesi trova conferma in Erodoto, Tucidide e Polibio1. Erodoto si proponeva di narrare i fatti
accaduti nel passato « affinché le azioni degli uomini non vadano perdute col tempo ed opere
grandi e mirabili non rimangano senza fama ». Il « senso » degli avvenimenti narrati non viene
espresso: esso non si pone al di là degli eventi considerati, ma è implicito nella narrazione stessa,
che esprime semplicemente ciò che i suoi momenti rivelano. Dietro a questi significati manifesti ve
ne sono pure altri, in parte occulti, che si palesano occasionalmente in parole, gesti, segni e
oracoli. E quando le azioni e gli eventi umani coincidono con i cenni sovra-umani, allora si chiude
un cerchio in cui il principio e la fine di una storia si illuminano reciprocamente. Lo schema
temporale della narrazione di Erodoto non è un processo significativo della storia universale, che si
riferisca ad un fine futuro, ma è, in corrispondenza con la concezione greca del tempo in generale,
un movimento circolare periodico all'interno del quale l'alterna vicenda dei destini è regolata da
un equilibrio di hybris e di némesis.
In Tucidide mancano lo sfondo religioso e i caratteri epici della storiografia di Erodoto, che lascia
indeterminati i confini tra l'umano e il divino. La sua rappresentazione degli avvenimenti vuol
fornire un'analisi precisa dei nessi pragmatici. La storia è per lui storia di lotte politiche, che hanno
il loro fondamento nella natura umana. E poiché la natura umana essenzialmente non muta, ciò
che è accaduto si verificherà anche nel futuro « in modo eguale o analogo ». Il futuro non può
portare nulla di completamente nuovo, in quanto « la natura di tutte le cose è di crescere e di
perire ». Può darsi che generazioni e individui futuri in determinate circostanze agiscano in modo
più saggio, ma la storia in quanto tale non muterà mai essenzialmente.
Soltanto Polibio sembra avvicinarsi alla nostra concezione della storia, in quanto rappresenta gli
avvenimenti come se convergessero tutti verso un determinato fine — la potenza mondiale di
Roma. Tuttavia anche Polibio non ebbe alcun interesse per il futuro in quanto tale. La storia si
1
Erodoto, I, 1; Tucidide, I, 22 e II, 64; Polibio, I, 35 e IV, 3, 9, 51, 57.
svolge in un processo circolare di rivolgimenti politici: le costituzioni mutano, scompaiono e
ritornano di nuovo in una vicenda prefissata dalla natura del divenire. In base a questa fatalità
naturale del divenire lo storico può prevedere il futuro di una determinata struttura politica. Egli
può sbagliarsi nel valutare la durata di questo processo; ma, finché il suo giudizio non è turbato da
passioni, difficilmente si ingannerà sullo stadio di sviluppo o di decadenza raggiunto da una
costituzione politica, e sulla forma del suo sviluppo successivo.
Legge suprema della storia politica è il mutamento: l'improvviso passaggio di un estremo nel suo
opposto. Polibio, dopo esser stato testimone del tramonto della potenza macedone, si
compiacque di richiamare alla memoria le parole profetiche di Demetrio, con cui questi, in un
trattato sulla Fortuna, aveva predetto ciò che accadde centocinquant'anni dopo la conquista
dell'impero persiano da parte di Alessandro Magno.
Infatti, se tu non prendi in considerazione un infinito numero di anni o molte generazioni,
ma soltanto questi ultimi cinquant'anni, vedrai in essi la crudeltà del destino. Io ti chiedo
se ritieni possibile che cinquant'anni fa i persiani e il re dei persiani o i macedoni e il re dei
macedoni, se un Dio avesse loro predetto il futuro, avrebbero mai creduto che nel tempo
in cui noi viviamo perfino il nome dei persiani sarebbe stato completamente spento — i
persiani che erano i dominatori di quasi tutto il mondo — e che i macedoni, il cui nome
prima era quasi sconosciuto, ora sarebbero stati i dominatori del mondo? Ma nondimeno
questo destino, che non viene mai a patti con la vita, che sempre butta a mare con nuovi
colpi tutti i nostri calcoli, questo destino che suole dimostrare la sua potenza
nell'annientare le nostre speranze, anche ora, così mi sembra, che ha concesso ai
macedoni tutta la potenza dei persiani, fa manifesto a tutti gli uomini di aver dato loro
queste benedizioni solo finché non decida di distribuirle altrimenti (Polibio, Storie, XXIX,
21).
Di fronte a questa incostanza della fortuna gli antichi non si rassegnarono, ma la riconobbero e
l'accettarono virilmente. Riflettendo sul destino Polibio trasse il principio che tutti i popoli, le città
e le autorità sono destinati a perire, al pari dei singoli individui. Riferendo le famose parole
pronunciate da Scipione dopo la caduta di Cartagine, secondo le quali anche Roma vincitrice
avrebbe dovuto un giorno soggiacere allo stesso destino, aggiunge che sarebbe difficile trovare
un'espressione che fosse insieme « più conveniente ad un uomo di stato e più profonda ». Pensare
al possibile capovolgimento del destino nel momento del maggiore trionfo si addice ad una
personalità grande e compiuta, degna di essere ricordata. Polibio e il suo amico Scipione ripetono
semplicemente la stessa concezione classica espressa da Omero di fronte al destino di Troia. E là
dove la sensibilità classica è viva, questa rimane la saggezza ultima dello storico.
L'insegnamento morale che si ricava dall'esperienza storica dell'alternarsi della fortuna e
dell'avversità, è per Polibio tanto naturale quanto umano: non esaltarsi mai tracotanti e spietati di
fronte al nemico vinto, bensì pensare al mutamento del destino. Egli vorrebbe dunque mostrare al
lettore come dallo studio della storia si possa apprendere che cosa « in ogni tempo e in ogni
circostanza sia il meglio », cioè essere modesti nella buona fortuna e trarre ammaestramento dall'avversità altrui.
Polibio considerava « cosa facile » prevedere il futuro in base al passato. Gli autori dell'Antico
Testamento ritenevano invece che soltanto il Signore potesse rivelare il futuro per mezzo dei suoi
profeti. Esso è racchiuso nella volontà di Dio, e proprio perciò non può esser dedotto dal passato
come sua naturale conseguenza. Il compimento delle profezie, come lo intesero gli autori
dell'Antico e del Nuovo Testamento, è quindi qualcosa di completamente diverso dalla realizzazione di previsioni riguardanti eventi storico-naturali. Se il futuro è predeterminato dalla volontà
personale di Dio, allora l'uomo non può mai prevederlo, a meno che Dio stesso non gli riveli la sua
volontà. E poiché il compimento ultimo del destino ebraico e cristiano sta in un futuro
escatologico, il cui esito non può mai essere calcolato in base a nessuna legge naturale della storia,
il sentimento fondamentale riguardo al futuro diviene l'incertezza dell'imprevedibile.
Si conferma così l'asserzione di Burckhardt, secondo il quale ciò che ci separa più profondamente
dall'antichità è la convinzione che si possa prevedere il futuro o deducendolo razionalmente dal
passato o mediante i responsi degli oracoli e la divinazione, mentre noi non consideriamo ciò
neppure desiderabile.
Immaginiamo per esempio un individuo che conosca in anticipo il giorno della propria
morte e la situazione nella quale si troverebbe allora, oppure immaginiamoci un popolo
che conosca in anticipo il secolo della sua fine. Tutte e due le immagini non potranno non
mostrare come necessaria conseguenza lo scompiglio di ogni volontà e di ogni
aspirazione. Poiché volontà e aspirazione e attività per realizzarle si sviluppano completamente solo quando si vive e si agisce « alla cieca », cioè per se stessi e seguendo le
proprie forze interiori. Il futuro insomma prende forma soltanto quando avviene: e se così
non avvenisse, la continuazione della vita e poi la morte dell'uomo e del popolo si
conformerebbe altrimenti. Un futuro preconosciuto è un assurdo.
A prescindere dal fatto che non è augurabile, la previsione del futuro non è neppure
probabile. Anzitutto le intralciano la strada gli erramenti della conoscenza derivati dai
nostri desideri, speranze, timori; e poi la nostra ignoranza di tutto ciò che si suol chiamare
forze latenti, materiali ed intellettuali, e anche l'elemento incalcolabile dei contagi
intellettuali che possono all'improvviso trasformare il mondo. (J. Burckhardt,
Weltgeschtliche Betrachtungen, 1935)
Così la ragione ultima per cui « a noi » il futuro rimane oscuro è non già la miopia del nostro
conoscere, ma l'assenza di quei presupposti religiosi che rendevano accessibile agli antichi il
futuro. Gli antichi credevano, come la maggior parte delle civiltà pagane, che gli eventi
dell'avvenire potessero essere illuminati da una particolare arte divinatoria. Si può prevederli
perché sono predeterminati. Ad eccezione di alcuni filosofi, nell'antichità nessuno poneva in
dubbio la verità degli oracoli, dei sogni profetici e dei presagi, attraverso i quali gli eventi futuri si
rivelavano. Per gli antichi, che credevano in un fato predeterminato, le cose e i destini futuri erano
avvolti da un velo leggero, penetrabile da una mente ispirata. Perciò greci e romani prendevano le
loro decisioni dopo aver interrogato il futuro. Questa fede nella divinazione venne meno soltanto
quando la Chiesa la distrusse. Ma anche la Chiesa credeva nella predestinazione, mentre l'uomo
moderno, se non è superstizioso, non crede a nessuna guida: né a quella del destino né a quella
della Provvidenza. Egli si immagina di potersi creare in base a se stesso il suo futuro; ritiene che
questo non possa essergli rivelato perché vuole realizzarlo lui stesso.