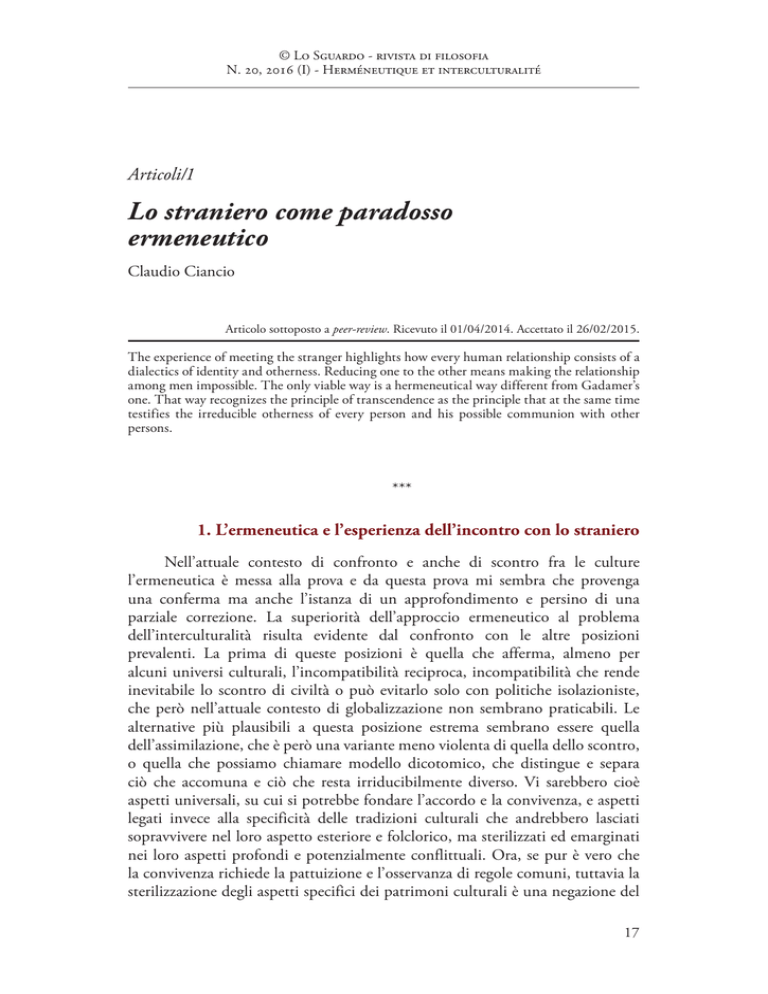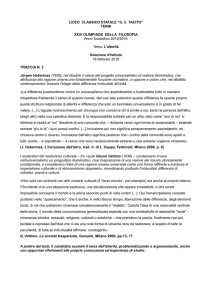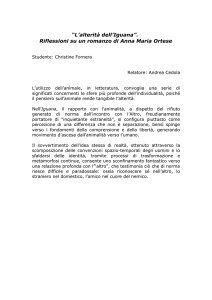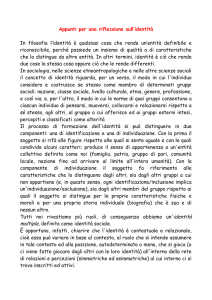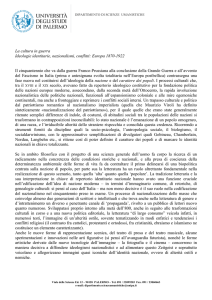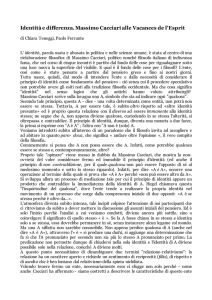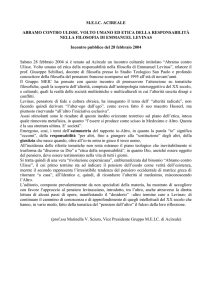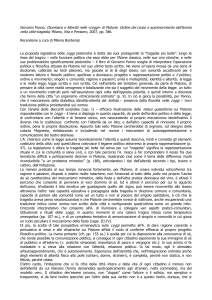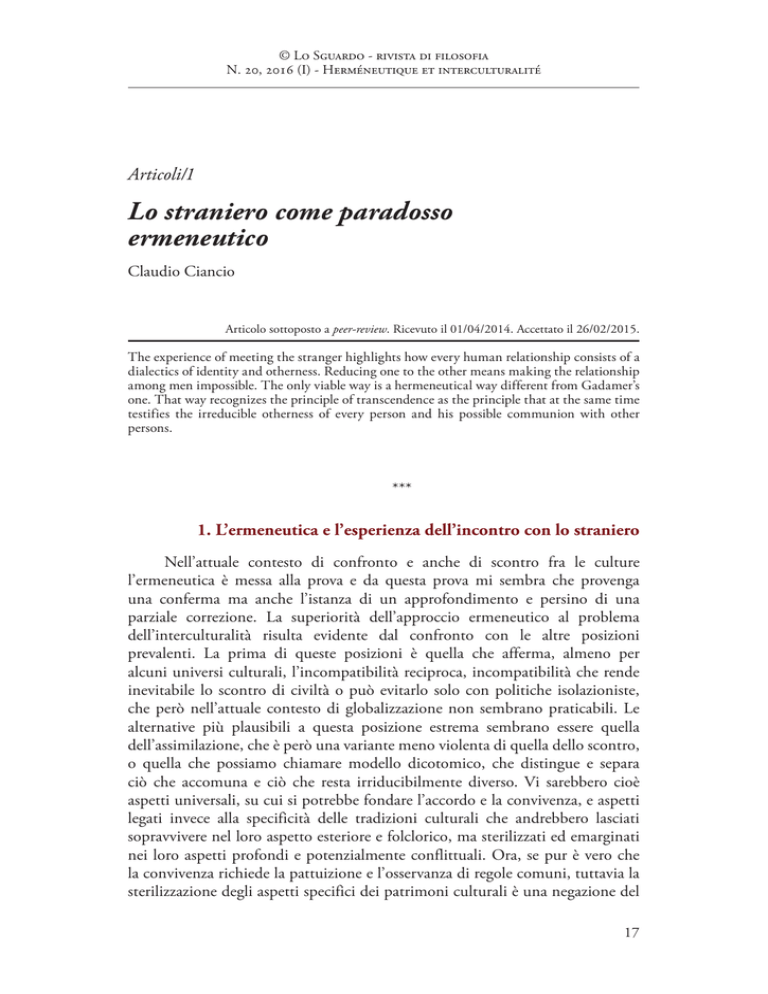
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
Articoli/1
Lo straniero come paradosso
ermeneutico
Claudio Ciancio
Articolo sottoposto a peer-review. Ricevuto il 01/04/2014. Accettato il 26/02/2015.
The experience of meeting the stranger highlights how every human relationship consists of a
dialectics of identity and otherness. Reducing one to the other means making the relationship
among men impossible. The only viable way is a hermeneutical way different from Gadamer’s
one. That way recognizes the principle of transcendence as the principle that at the same time
testifies the irreducible otherness of every person and his possible communion with other
persons.
***
1. L’ermeneutica e l’esperienza dell’incontro con lo straniero
Nell’attuale contesto di confronto e anche di scontro fra le culture
l’ermeneutica è messa alla prova e da questa prova mi sembra che provenga
una conferma ma anche l’istanza di un approfondimento e persino di una
parziale correzione. La superiorità dell’approccio ermeneutico al problema
dell’interculturalità risulta evidente dal confronto con le altre posizioni
prevalenti. La prima di queste posizioni è quella che afferma, almeno per
alcuni universi culturali, l’incompatibilità reciproca, incompatibilità che rende
inevitabile lo scontro di civiltà o può evitarlo solo con politiche isolazioniste,
che però nell’attuale contesto di globalizzazione non sembrano praticabili. Le
alternative più plausibili a questa posizione estrema sembrano essere quella
dell’assimilazione, che è però una variante meno violenta di quella dello scontro,
o quella che possiamo chiamare modello dicotomico, che distingue e separa
ciò che accomuna e ciò che resta irriducibilmente diverso. Vi sarebbero cioè
aspetti universali, su cui si potrebbe fondare l’accordo e la convivenza, e aspetti
legati invece alla specificità delle tradizioni culturali che andrebbero lasciati
sopravvivere nel loro aspetto esteriore e folclorico, ma sterilizzati ed emarginati
nei loro aspetti profondi e potenzialmente conflittuali. Ora, se pur è vero che
la convivenza richiede la pattuizione e l’osservanza di regole comuni, tuttavia la
sterilizzazione degli aspetti specifici dei patrimoni culturali è una negazione del
17
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
loro valore e dell’importanza del loro apporto e si configura di fatto anch’essa
come una riproposizione del modello dell’incompatibilità.
Rispetto a questi modelli la superiorità di quello ermeneutico sta nella
sua capacità di utilizzare le disposizioni specifiche di una cultura come possibili
vie di accesso alla comprensione di altre culture senza una preventiva opera di
riduzione e presupponendo, sia pure al limite, un’universale comunicabilità. Il
vantaggio di questo modello sarebbe la possibilità del riconoscimento reciproco
delle culture nella loro irriducibilità ma non incompatibilità, e una reciproca
fecondazione che consente di far emergere in ogni cultura possibilità inedite,
che, senza il confronto con altre culture, non si sarebbero configurate. Certo
questo modello sembra peccare di un eccesso di ottimismo, come se non facesse i
conti con l’insuperabile tendenza conflittuale che l’alterità come estraneità porta
con sé. E in effetti credo che l’esperienza dell’incontro con lo straniero metta, se
non in crisi, almeno in difficoltà il modello ermeneutico e specialmente quello
gadameriano. Come ci può infatti essere quella fusione degli orizzonti, che è
il presupposto della comprensione, quando manca qualsiasi continuità della
tradizione?
La relazione con lo straniero, con la persona di lingua, costume, cultura
e religione diversi e lontani dai nostri, sembra avere una sua specificità, che
non consiste semplicemente nel manifestare una più accentuata differenza.
Diversamente dalle relazioni con la famiglia o con la propria cerchia sociale o
con coloro che appartengono alla propria tradizione culturale, la relazione con lo
straniero prende le mosse dall’estraneità, non è cioè esperienza di una familiarità
talvolta interrotta o difficile, ma anzitutto esperienza di estraneità. Di fronte
allo straniero siamo immediatamente a disagio, angosciati dall’imprevedibile o
almeno diffidenti. Questa reazione non va trascurata o banalizzata, non può
essere attribuita moralisticamente a un deficit etico o illuministicamente a un
deficit culturale. È una reazione che rivela qualcosa di importante, e cioè che
l’alterità dell’altro è irriducibile e assolutamente indisponibile, portatrice di un
modello culturale che ci disorienta e che mette in discussione il nostro.
Quando si considerano poco rilevanti le differenze, allora ciò che costituisce
lo specifico dell’altro, la sua cultura, la sua religione, finisce per essere svilito
proprio da questa apparente apertura a lui. Occorre invece riconoscere che
l’incontro è difficile e lo è precisamente perché le differenze sono importanti. In
un certo senso si deve dire che è meglio ingigantirle piuttosto che assottigliarle.
Per passare dallo scontro a una forma di incontro non banale e superficiale,
occorre che la relazione con l’altro allo stesso tempo non sia ridotta, per far
prevalere i momenti di identità, e non sia dissolta, per far prevalere i momenti
di alterità.
Ma com’è possibile ciò? Cercherò di mostrare che lo è soltanto se,
paradossalmente, l›alterità è costitutiva dell›identità di ogni soggetto umano
singolo o collettivo. Se infatti vi è un momento di alterità costitutivo della stessa
identità, allora si potrà trovare la possibilità di convergenza con l›altro proprio a
partire da quella comune esperienza di alterità. Ora questa costitutiva esperienza
18
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
di alterità si dà precisamente in quell›aspetto della cultura che più di ogni altro
sembra oggi rendere inevitabile lo scontro, vale a dire nell’esperienza religiosa.
Per lo più si pensa che l’incontro fra culture diverse diventi possibile solo se le
religioni si secolarizzano, nel senso di ridursi a un nocciolo razionale condivisibile
da tutti gli uomini all’identico modo. Ma non è così. Si dovrà invece fare in modo
che esse siano più fedeli a se stesse, e cioè a quella verità trascendente (ecco qui
la dimensione di alterità!) che è propria di tutte le religioni in modo più o meno
chiaro e lineare. L’esperienza religiosa non è l’ostacolo maggiore all’incontro con
lo straniero, ma quella che può renderlo possibile, perché l’esperienza di Dio
è, almeno nelle religioni monoteistiche, la più profonda e radicale esperienza
dell’Altro.
2. L’essere straniero nell’esperienza biblica
Vediamo meglio questo paradossale costituirsi dell’identità religiosa come
esperienza dell’alterità nella religione biblica. Si pensi anzitutto a come si esprime
la vocazione del padre della fede, Abramo: «Vattene dal tuo paese, dalla tua
patria» (Gn 12, 1): abbandona dunque le tue radici, la tua identità; anzi Dio
gli cambia persino il nome (da Abram a Abraham). E la condizione di straniero
caratterizza i discendenti di Abramo fino all’Egitto e all’esperienza del deserto.
E pensiamo poi allo stesso patto di alleanza, che è sancito con la consegna della
legge. Il suo forte contenuto etico ne fa un’esperienza di alterità e di trascendenza:
la Torah sancisce un’alleanza che non ha lo scopo di avvicinare gli uomini a Dio
facendoli entrare nella sfera del sacro; la legge interrompe il soddisfacimento
del desiderio e la fusionalità, pone dei limiti, rende invalicabile il confine
che ci separa dall’altro e ne impone il rispetto. Si pensi infine all’attenzione
e all’accoglienza dello straniero che la legge comanda, spesso associandolo alla
vedova e all’orfano: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi
siete stati forestieri nel paese d’Egitto» (Es 22, 20). Ancora di più dice un passo
del Levitico (19, 34), che va al di là della semplice tolleranza per identificare
lo straniero con il prossimo (non più il lontano ma il vicino), con colui che è
come noi: «Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato
fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d’Egitto». In ambedue i casi si sottolinea l’uguaglianza di esperienza fra stranieri
e Israeliti: la condizione di forestiero è parte essenziale della vicenda di questi
ultimi. E il Salmo 38 lo dice espressamente: «Io sono un forestiero, uno straniero
come tutti i miei padri». Abbiamo qui dunque una dimensione di alterità che è
costitutiva dell’identità e proprio per questo rende possibile una relazione con
l’altro, che non sia una semplice negazione né dell’identità propria né di quella
dell’altro. Si tratta qui certo di un’alterità etnica e territoriale, che tuttavia si lega
strettamente all’esperienza religiosa.
Nel Nuovo Testamento, poi, mentre perde rilievo la definizione etnica e
politica di straniero, diventa centrale la condizione esistenziale di straniero propria
del cristiano. Come l’ebreo si sentiva esule e straniero lontano da Gerusalemme,
19
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
così il cristiano si sente esule e straniero rispetto alla nuova Gerusalemme. Nella
prima Lettera di Pietro i cristiani sono definiti «pellegrini e ospiti sulla terra» (2,
11) e nella Lettera agli Ebrei si pongono in continuità la fede dei patriarchi e quella
dei cristiani dicendo che tutti i credenti «ora aspirano a una patria migliore, cioè
a quella celeste» (11, 16). Senza cadere nell’interpretazione dualistica ed evasiva
che molta spiritualità cristiana ha conferito a questa estensione dell’esperienza di
estraneità, occorre riconoscere che è costitutiva dell’esperienza cristiana questa
tensione verso l’Altro, verso la novità radicale, anche se questa relazione con
l’Altro (con l’Infinito) entra in conflitto (a causa della condizione di peccato) con
la relazione (altrettanto costitutiva) che abbiamo con noi stessi e con il mondo.
Non si può perciò definire il cristianesimo come una religione della familiarità,
delle radici, dell’identità.
E nemmeno lo si può definire una religione dell’interiorità, che è un altro
modo per accentuare il momento dell’identità. Quando dice che la verità abita in
noi (in interiore homine) e che Dio è più intimo a noi di quanto noi lo siamo a noi
stessi, Agostino evidenzia una differenza fra l’intimità di Dio e la nostra intimità
e le due intimità entrano in tensione, una tensione paradossale perché sono due
dimensioni del medesimo soggetto, cioè di noi stessi. Il cristianesimo non è una
religione della conciliazione: non concilia né con se stessi né con le proprie radici
né con la ragione né con l’ordine sociale e politico. Il cristianesimo è sempre
anche essenzialmente tensione, contraddizione, estraniazione, differenza, perché
è sempre anche attesa del futuro escatologico.
Questa esperienza religiosa come esperienza di trascendenza sembra essere
la condizione fondamentale della possibilità di incontro con lo straniero, proprio
perché attraverso di essa l’io si scopre nella sua identità paradossalmente costituito
da un’alterità. Lo straniero diventa riconoscibile e relazionabile all’io perché già
abita in lui: lo straniero non ci confronta semplicemente con ciò che è fuori di
noi ma con ciò che già è in noi. Perché allora le religioni aggravano in molti
casi la difficoltà di incontro con lo straniero e favoriscono lo scontro di civiltà?
Perché in molti casi tradiscono la loro costitutiva relazione con la trascendenza
e si secolarizzano nel senso che diventano potenze mondane identitarie, ma in
questo modo, per la loro grande forza spirituale che esercitano, producono effetti
rovinosi: corruptio optimi pessima.
3. Ribaltamento del rapporto familiarità-estraneità
Il paradosso che definisce la relazione con lo straniero, come relazione che
è resa possibile precisamente da ciò che sembra impedirla, è quello di un’alterità
che può avvicinare. Ma il paradosso si ripropone simmetricamente riguardo ai
rapporti di familiarità, che sono fondati, come cercherò di mostrare, su una
vicinanza che diventa alterità.
La relazione di familiarità è anzitutto una relazione rassicurante. Non a
caso la xenofobia, soprattutto oggi, fa leva proprio sul richiamo alla sicurezza:
lo straniero è come tale un potenziale attentatore alla nostra sicurezza. La paura
20
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
che nasce dall’insicurezza trova conforto quando individua la sua causa nel volto
dello straniero, nei suoi abiti, nei suoi costumi e nella sua religione, invece che
in complessi fattori, economici, sociali e culturali. Si ha bisogno di spiegazioni
semplici, perché la stessa semplicità della spiegazione è rassicurante, e si ha
bisogno di capri espiatori facilmente identificabili; mentre invece le spiegazioni
complesse, difficili da comprendere, che individuano cause e responsabilità
diffuse rendono sfuggente la minaccia e, anziché liberarne, provocano angoscia.
Rassicurante è invece chi, in quanto familiare, immediatamente conferma la
nostra identità: è un altro nel quale troviamo una variazione di noi stessi o del
quale almeno possiamo comprendere e prevedere gli atteggiamenti. Ma è facile
vedere come questa familiarità sia, nel migliore dei casi, povera e riduttiva, e
come il senso di sicurezza possa degenerare in disinteresse e in noia. Quando
dall’altra persona non c’è più da attendersi nulla di nuovo, l’interesse per lei
si spegne, allo stesso modo in cui si spegne l’interesse per la vita quando ci si
può attendere soltanto una ripetizione del già vissuto, e ciò anche nel caso in
cui la nostra vita sembri felice. Quando i gesti e le reazioni diventano scontati,
abitudinari, la vita si spegne: l’abitudine, come ripetizione dell’identico, mentre
appare rassicurante, diventa immagine ed anzi anticipazione del rigor mortis.
Molte relazioni umane si estinguono per questa ragione, perché dall’altro non ci
si aspetta più nulla di nuovo, ma solo la ripetizione delle stesse cose e delle stesse
parole.
C’è una pagina straordinaria dei Diari di Max Frisch, che illustra bene
questo rischio in riferimento all’esperienza dell’amore. Ne riporto qualche
passaggio: «È degno di nota il fatto che proprio della persona che amiamo non
possiamo dire affatto come ella sia. La amiamo semplicemente. [...] L›amore
libera da qualsivoglia immagine. [...] La nostra convinzione di conoscere l›altro
è la fine dell›amore; [...] poiché il nostro amore è al termine, poiché ha esaurito
la sua forza, è per questo che la persona per noi è finita. [...] “Tu non sei”, dice
il deluso o la delusa, “chi ritenevo che tu fossi”. E chi ritenevano che fosse?
Un mistero, quale la persona sempre è, un enigma, ed è ciò che non abbiamo
più la forza di sopportare. Ci facciamo allora un’immagine. In ciò sta l’assenza
di amore, il tradimento»1. Il passo ricorda il divieto biblico di farci immagini:
farci un’immagine è pretendere di sottoporre l’alterità infinita al nostro sguardo
abbracciante e penetrante. Le patologie della famiglia, della comunità o
dell’amicizia hanno che fare con questa distorsione, cioè con il prevalere del
principio di assimilazione, che si esercita anzitutto come pretesa di conoscere
l’altro e che conduce d’altra parte a respingerlo nella misura in cui egli si sottrae
all’assimilazione o almeno alla prevedibilità del comportamento. In termini
psicologici si parla della mancanza del terzo (l’altro irriducibile), mancanza che
produce rapporti duali in cui l’uno mangia l’altro, lo assimila, e, quando non ci
riesce più, giunge a distruggerlo (come ben sappiamo dalla cronaca quotidiana).
La causa della crisi della famiglia va ricercata non esclusivamente ma certo anche
M. Frisch, Die Tagebücher 1946-49, in Gesammelte Werke, 2, Frankfurt/Main 1976, pp. 369370.
1
21
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
in questa distorsione psicologica e morale, per la quale si cerca di far prevalere il
principio dell’identità su quello dell’alterità.
Queste osservazioni, ovviamente, non vanno spinte fino a proporre
la semplice sostituzione dell’alterità all’identità, una sostituzione che non
risolverebbe il problema, perché produrrebbe soltanto una non relazione.
Al contrario si tratta di pensare una relazione nella quale l’identità cresce
parallelamente al crescere dell’alterità, l’assimilazione cresce parallelamente al
crescere della dissimilazione. E la condizione di possibilità di questa paradossale
coincidenza è quella che abbiamo detto e cioè la presenza nell’identità, come suo
principio costitutivo, della stessa alterità. Solo perché in me stesso riconosco la
presenza di una vera alterità, posso incontrare l’altro senza con ciò semplicemente
negare me stesso e senza negare l’altro. Il mancato riconoscimento di questa
presenza dell’alterità nell’identità, come produce la disgregazione dei rapporti
famigliari, amicali e sociali, così pure rende impossibile o fallimentare l’incontro
con lo straniero. Invece che incontrare si cercherà di catturare e assimilare l’altro;
ma questo è impossibile: quel che se ne assimila e cattura non è lui stesso, l’altro
sfugge alla presa. Come chi vuole afferrare Dio si ritrova con un idolo, così
chi vuole impadronirsi di un uomo può giungere anche a imprigionarlo, a
soggiogarlo e persino a ucciderlo, ma in questi modi non si impossessa della sua
alterità, perché lo riduce alla misura dei suoi poteri e si lascia perciò sfuggire ciò
che egli propriamente è.
4. L’universalità trascendente
L’unilateralità dei principi di identità e di alterità dovrà essere superata,
non però in una mediazione che dia luogo a un’identità più ricca, ma in un
principio di unità capace di reggere e tenere in comunicazione i due principi
dell’identità e dell’alterità evitando la riduzione dell’uno all’altro e quindi
l’impossibilità della relazione. Questo principio, che fonda allo stesso tempo
l’alterità costitutiva di ogni identità e l’identità costitutiva di ogni alterità, è la
trascendenza. La condizione ultima di possibilità di incontro, di comunicazione
e di fecondazione reciproca fra le diverse identità, personali e culturali, è che
vi sia una partecipazione comune degli uomini, per quanto turbata e nascosta,
all’unica verità trascendente. L’incontro infatti avviene e la relazione si istituisce
a condizione che le diverse identità siano riconosciute nella loro reciproca
irriducibilità ma non incompatibilità. E ciò è possibile appunto soltanto se
possono essere riportate a un comune principio di differente livello ontologico.
Ogni finito è altro non semplicemente nella sua particolarità, ma in quanto
quella particolarità è portatrice di un’infinità (che è poi l’infinità della libertà),
che rende impossibile ogni mediazione con altre analoghe finitezze, ogni
risoluzione in una superiore identità, e che tuttavia accomuna ad ogni altra
analoga finitezza essendo la sorgente inesauribile di tutte. Ogni finito è altro
in modo irriducibile in quanto è costituito dalla trascendenza, da quell’infinità
22
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
e inesauribilità da cui scaturisce e che fa sì che non possa essere determinato
e conosciuto senza rivelare sempre nuove inesauribili profondità. L’alterità di
questo finito-infinito rispetto agli altri finiti-infiniti non nasce dalla relazione
con essi, ma dall’alterità trascendente (dell’infinito) da cui è costituito e che
conferisce alla sua particolarità una profondità infinita, tale da impedire ogni
mediazione e risoluzione in un’identità superiore. D’altra parte questa medesima
alterità trascendente è ciò che rende possibile affermare l’unità (un’unità della
comunicazione e non della mediazione) dei finiti-infiniti, di modo che proprio
ciò che radicalizza l’alterità è ciò che fonda l’unità.
Il nesso di irriducibilità e compatibilità si scioglie quando prevalga o una
visione relativistica o al contrario una visione assolutistica della verità. Per i
relativisti non vi è propriamente nessuna verità, ma allora nessuna prospettiva
merita di essere presa sul serio, sono tutte indifferenti. Certo da questo punto
di vista non si fa la guerra all’altro motivandola con un presunto superiore
possesso della verità, ma nemmeno si valorizza la prospettiva dell’altro. Per
gli assolutisti della verità invece non resta che la distruzione della prospettiva
altrui (considerata falsa) o l’integrazione nella propria (considerata l’unica
vera). Al relativismo si dovrebbe invece sostituire il prospettivismo ermeneutico
e l’alternativa fra integrazione e distruzione dovrebbe essere sostituita dalla
fecondazione reciproca. La verità trascendente è principio di universalità, perché
le molteplici identità culturali e religiose possono essere viste come punti di vista
(magari mescolati con errori) sull’unica verità e come tali capaci di riconoscersi
reciprocamente senza peraltro integrarsi. Riconoscimento reciproco significa
non soltanto rispetto, ma anche fecondazione reciproca, perché l’incontro con
l’altro può non tanto aggiungere pezzi alla nostra identità o stravolgerla, quanto
piuttosto fare in modo che questa sviluppi meglio potenzialità, che restavano
nascoste e implicite, e che proprio l’incontro con l’altro fa emergere e può far
emergere in quanto proviene dalla comune verità trascendente.
Incontrare lo straniero significa allora apprendere anche su se stessi, imparare
a conoscere e ad approfondire la propria identità, abituandosi a non irrigidirla,
ma piuttosto a considerarla un’identità vivente e mobile, come identità che non
sta in rapporto soltanto con se stessa, un’identità che non è autoreferenziale,
ma un’identità che sta in rapporto con una verità che la costituisce ma anche la
trascende, abbracciando altre identità e mettendo in comunicazione con esse.
Lo straniero ci è maestro perché, più che coloro che ci sono familiari, ci aiuta
a incontrare la nostra identità e a renderla vivente. Ma, anzitutto, incontrare
lo straniero significa fare un’esperienza di trascendenza, di oltrepassamento
verso il totalmente Altro, verso quella verità che è la fondamentale condizione
dell’incontro.
E poiché nell’incontro con lo straniero siamo sollecitati a esplorare le vie
di una comunione nell’alterità, allora lo straniero ci è maestro anche in un altro
senso, nel senso che è proprio questa esperienza estrema dell’incontro con lui la
via attraverso la quale possiamo guadagnare un rapporto più autentico con chi
ci è più vicino e familiare. La relazione con lo straniero, con colui di cui non
23
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
si comprende la mentalità, la cultura, i costumi e anche la lingua, non fa che
evidenziare un carattere proprio e costitutivo di ogni relazione: l’eccezionalità del
rapporto con lo straniero non è poi così eccezionale. Essa c’insegna a riconoscere
l’alterità irriducibile al di sotto di ogni affinità, a riconoscere lo straniero anche
in chi ci è più familiare. La familiarità, se è una familiarità nella libertà, non
è infatti reciproca trasparenza fino alla fusione. La fusione priva della libertà,
che viene completamente soffocata dall’appartenenza e dall’identificazione. Se
la relazione di familiarità ha un vantaggio, è quello di presupporre la possibilità
della comunione per fondare su di essa l’accoglienza dell’alterità, ma questo
vantaggio è pagato con il rischio di dissolvere l’alterità.
Potremmo allora esprimere il paradosso che regge tutta la questione anche
in questi termini: non si tratta tanto di rendere lo straniero più familiare, quanto
piuttosto di rendere il familiare più straniero. Ciò che avvicina non va trascurato
o addirittura negato, ma deve essere oltrepassato per ritrovare l’irriducibile
alterità proprio in ciò che più avvicina. Si tratterà di mettere in luce le differenti
declinazioni che ciascuno offre degli stessi elementi comuni: lingua, orizzonte
culturale, religione, famiglia. E in questa forma, nella quale appaiono anche
le differenze irriducibili, gli elementi comuni non saranno uguaglianze ma
piuttosto convergenze e armonizzazioni che indicano l’unità possibile, unità
della comunione (della pluralità dei diversi) e non della conformità. L’incontro
con lo straniero sollecita allora una profonda revisione dei rapporti di familiarità,
che rende attenti all’alterità irriducibile, così come, d’altra parte, le esperienze di
familiarità sollecitano la ricerca della comunione nell’estraneità.
5. Trasformazione dell’ermeneutica in ermeneutica
della trascendenza e del paradosso
Questo riconoscimento dell’alterità né riduttivo né escludente può trovare
giustificazione filosofica solo in una prospettiva ermeneutica. E tuttavia il pensiero
ermeneutico prevalente, se giustifica la compatibilità e l’incontro dialogico fra
le molteplici prospettive sulla verità, non sembra misurarsi adeguatamente con
la dimensione dell’alterità considerata nella sua irriducibilità ultima. Il limite
dell’ermeneutica, soprattutto gadameriana, è quello dell’inclusività, anche se
riconosce le fratture, le interruzioni della comunicazione. Ma non si tratta solo
di riconoscere un limite della comprensione; si tratta piuttosto di recuperare
la dimensione qualitativa dell’interruzione. Si tratta cioè di considerare
l’interruzione della comunicazione non come caso-limite e come un limite
progressivamente erodibile, come fa Gadamer quando a questo proposito scrive
che «fra gli uomini sarebbe necessario un dialogo infinito»2. Gadamer pensa
che l’ermeneutica debba «servire a eliminare la separazione e l’estraneità tra io
e tu»3, e che il suo motivo centrale sia «quello del superamento dell’estraneità
H.G. Gadamer, ‘E tuttavia: potenza della volontà “buona” ‘, in «Aut-aut», CCXVII-CCXVIII,
1987, pp. 62-63.
3
H.G. Gadamer, Verità e metodo 2, trad. di R. Dottori, Milano 1995, p. 78.
2
24
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
e dell’appropriazione dell’estraneo»4. Ma si tratta piuttosto di pensare la radice
dell’incomunicabilità ultima come la condizione anche della comunicazione e
della familiarità. L’estraneità, la non comunicazione, la non comprensione, il
restare estranei, non è una distanza che si possa progressivamente erodere ma,
come dicevo, un momento costituivo della stessa familiarità.
L’ermeneutica deve allora assumere la forma di una dialettica paradossale
e ciò grazie proprio all’esperienza dell’incontro con lo straniero. Al definirsi di
questa esperienza nella forma di una dialettica paradossale conduce la recente
e brillante analisi di Umberto Curi in Straniero. Muovendo dall’analisi della
duplicità dello Unheimlich freudiano risale alle radici indoeuropee del concetto
di ospite come dono e minaccia5 analizzando in particolare la Xenia greca e
l’ambiguità dei termini hostis e hospes. Interessante nell’analisi di Curi è il fatto
che l’insuperabile ambiguità strutturale dello straniero sia declinata ricorrendo
al mito platonico di Eros e alla pratica greca del symbolon. Le due tessere del
symbolon rinviano a un’unità originaria nella quale non v’era duplicità ma
unità6. Analogamente l’Eros del Simposio, intermedio tra Penia e Poros, è
costitutivamente duplice7, una duplicità che rinvia al mito dell’androgino, per
il quale solo mettendo insieme le due parti divise si può ricostituire l’intero dal
quale gli uomini provengono8. Seguendo questi modelli classici, si dovrà pensare
che l’identità si costituisce solo attraverso la relazione con l’altro9, in quanto esso
è la parte a noi mancante. In questo senso Curi può affermare l’imprescindibilità
del rapporto con lo straniero dicendo che il confine tra il medesimo e l’altro è
problematico, che ogni forma di identità del sé è intaccata10 e che lo straniero è
più prossimo a me di me stesso11.
Questo modello ha molti punti di contatto con quello che intendo proporre,
il modello cioè del paradosso ermeneutico, che tuttavia riesce a giustificare
meglio quegli aspetti. Nel modello proposto da Curi la dimensione di alterità del
rapporto con lo straniero è allo stesso tempo assolutizzata e ridotta. Assolutizzata
perché diventa un rapporto di semplice esteriorità (le due metà stanno una
accanto all’altro senza aver nulla in comune); ridotto perché risolvibile, almeno
idealmente, in una perfetta superiore unità (le due metà combaciano).
Anche Derrida ha sostenuto una radicale alterità affermando, nel corso di
un confronto con Gadamer, che vi è un’interruzione, un’irriducibile intervallo,
che condiziona ogni possibile comprendere: «ci si può domandare se la condizione
del Verstehen, invece di essere il continuum del rapporto, […] non sia piuttosto
l’interruzione del rapporto, un certo rapporto di interruzione, la sospensione di
Ivi, p. 253.
U. Curi, Straniero, Milano 2010, p. 12.
6
Ivi, p. 66.
7
Ivi, p. 92.
8
Ivi, p. 96.
9
Ivi, p. 139.
10
Ivi, p. 149.
11
Ivi, p. 16.
4
5
25
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
qualsiasi mediazione?»12. Questa insuperabile interruzione dà luogo in Derrida
a una strategia del compromesso, peraltro più presente nel primo Derrida, che
prende le distanze dalla radicalità di Levinas per affermare l’inevitabilità di
una mediazione con l’altro, che pure non può non essere segnata da una certa
violenza.
Ma è possibile anche un altro esito, quello a cui conduce ad esempio lo
Straniero di Camus. Meursault attraversa la società come straniero, straniero
non tanto per lingua o cultura o religione, ma piuttosto come esistenzialmente
straniero, estraneo alla morte della madre, all’amore di Maria, all’uccisione
dell’arabo, alla sua propria morte, come a ogni condizione di vita. C’è
«un’indifferenza del mondo», che peraltro, svuotando ogni speranza, genera alla
fine un certo senso di felicità. Del resto il tema della rivolta, centrale nel pensiero
di Camus, implica non solo resistenza ma anche adeguamento, un imparare
a vivere e a morire, una lucida accettazione della finitezza quale essa è, senza
evasioni o compromessi.
Le posizioni di Camus, Derrida e Curi in modi diversi propongono
un’alterità assolutamente irriducibile, con la quale però ci si può conciliare. Ma
questa conciliazione resta del tutto estrinseca, e, proprio perché estrinseca, sta
sotto il segno dell’ambiguità: è la conciliazione dell’indifferenza in Camus, quella
del compromesso e della riduzione del conflitto in Derrida, o è quella della
giustapposizione di parti combacianti in Curi, una giustapposizione nella quale
si passa da una mera esteriorità a una risoluzione dell’alterità in una superiore
unità in cui essa scompare. Alterità e identità diventano compatibili senza
ridursi o addirittura annullarsi, solo se, come dicevo, il principio di unità è allo
stesso tempo principio che accomuna e che separa o, meglio, che accomuna nel
separare e separa nell’accomunare, principio di unità proprio nell’essere assoluta
alterità, principio trascendente costitutivo di ogni finitezza libera, che fa di ogni
finito un finito-infinito.
Tornando conclusivamente all’ermeneutica, riconosceremo ad
essa la capacità di giustificare un’universalità non riduttiva, così come
riconosceremo alle filosofie dell’alterità il merito di stabilire un limite
invalicabile alla mediazione, aggiungendo però che ambedue non fondano
la possibilità dell’incontro con l’altro, quando non riconoscano la verità
trascendente come radice che mette in comunione separando e separa
mettendo in comunione. In un’ermeneutica della trascendenza si può pensare
la compatibilità fra l’essere plurale e l’unità dell’essere, perché solo in essa si
pensa la pluralità come pluralità di irriducibili (uomini, religioni, culture, opere
e, più in generale, interpretazioni), che sono ciascuno manifestazione dell’unico
essere inesauribile.
Il riconoscimento dell’alterità esige quel rapporto ermeneutico nel quale
la congenialità e il processo di comprensione giungono al loro apice quando
si spalancano nuove inesauribili, ed anzi insondabili, dimensioni ed ogni
J. Derrida (1987), ‘Buone volontà di potenza (Una risposta a Hans-Georg Gadamer)’, in «Autaut», CCXVII-CCXVIII, 1987, p. 60.
12
26
© Lo Sguardo - rivista di filosofia
N. 20, 2016 (I) - Herméneutique et interculturalité
momento di assimilazione (di ciò che riconosciamo riconducendolo al già noto)
è attraversato da un contrario movimento di dissimilazione, per cui, quanto
più approfondiamo la conoscenza, tanto più diventa smisurato quel che non
sappiamo, più afferriamo e più la presa ci sfugge, più ci familiarizziamo e più
restiamo sorpresi, più troviamo somiglianze e più aumentano le differenze.
Proprio perché conosco meglio lo straniero, so che nel suo fondo egli resta
inconoscibile. Conoscere è sempre riportare a un universale, ma l’universale
ermeneutico non è un universale oggettivabile, perché vive soltanto nelle sue
particolari e irriducibili declinazioni, fra le quali si può riconoscere soltanto, per
così dire, una certa aria di famiglia. Se dunque conosco lo straniero in ciò che gli
è più proprio, ho una conoscenza che certo non è soltanto negativa o particolare,
ma tuttavia apre a un’inesauribilità di contenuto.
Un’ermeneutica della trascendenza è un’ermeneutica che si orienta verso
un pensiero del paradosso, che tiene insieme dialetticamente, senza mescolanze
né sintesi compiute, due movimenti contrari. Una comprensione autentica
dell’altro ci avvicina - ripeto - a lui proprio nel mostrarcene l’alterità irriducibile,
e in tale alterità irriducibile l’altro si mantiene in una lontananza estrema; l’alterità
inesauribile è contenuta soltanto in ciò che comprendiamo, e però vi è contenuta
solo nella forma di ciò che eccede la comprensione. Tra familiarità ed estraneità,
tra identità e alterità, tra comprensione e inafferrabilità vi è dunque un rapporto
di unità e opposizione, nel quale i due termini si sostengono reciprocamente.
A questa dialetticità paradossale l’ermeneutica è indirizzata proprio quando
esce dal tranquillo alveo della tradizione per prendere sul serio la drammatica
difficoltà dell’incontro con lo straniero.
Claudio Ciancio, Università del Piemonte Orientale
* [email protected]
27