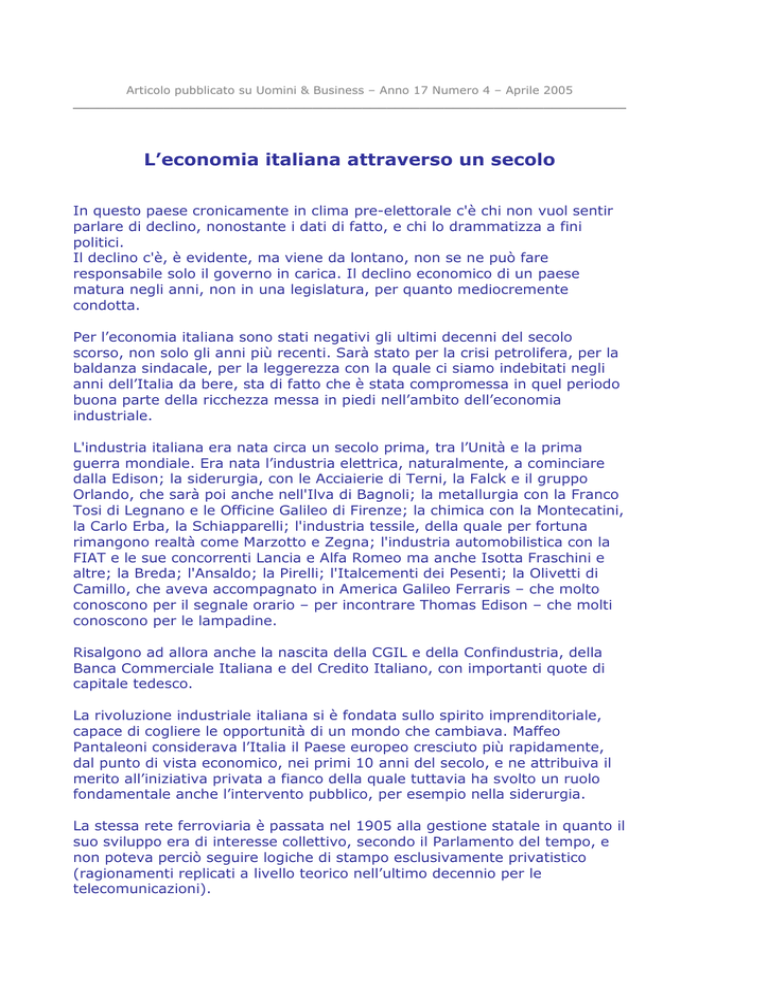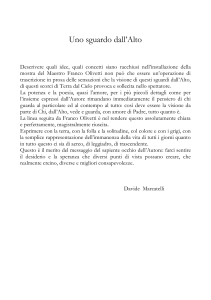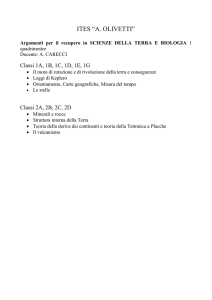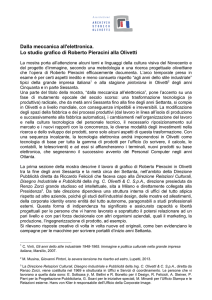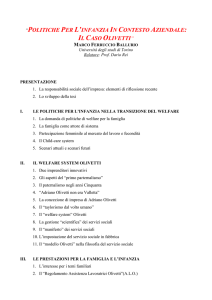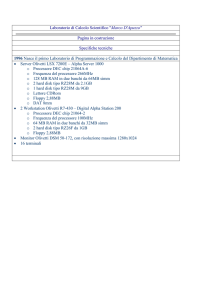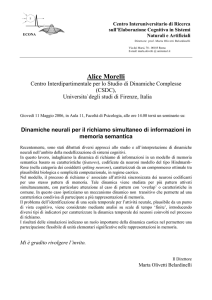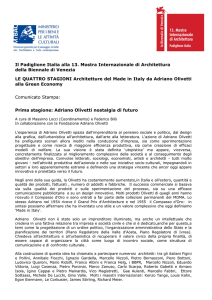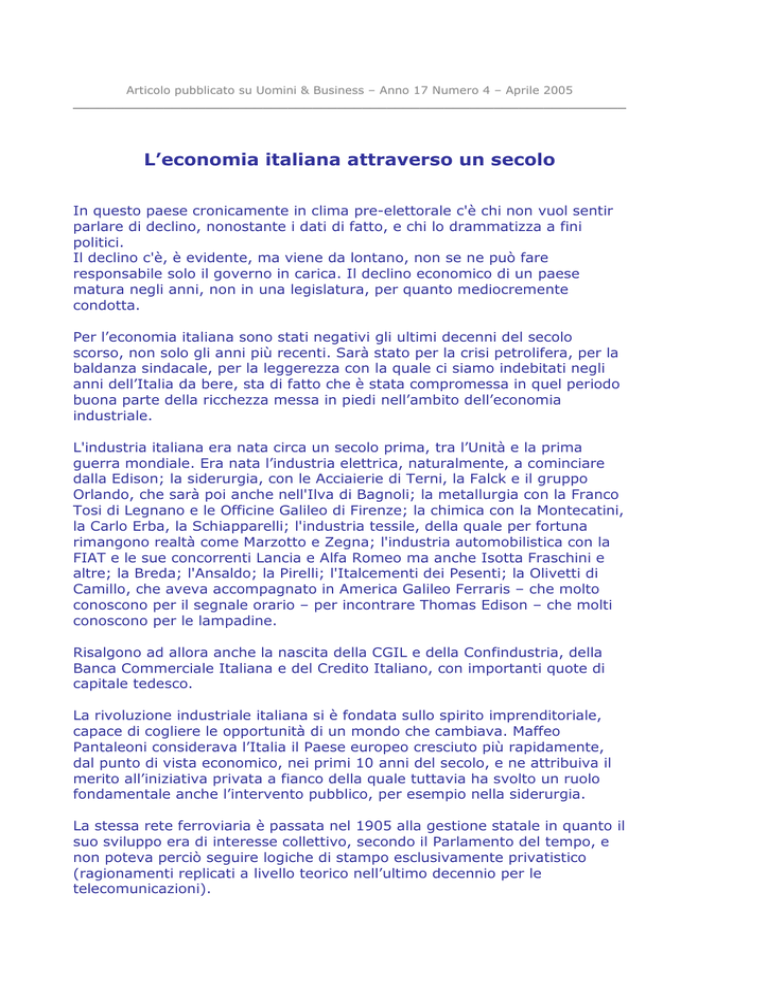
Articolo pubblicato su Uomini & Business – Anno 17 Numero 4 – Aprile 2005
___________________________________________________________________
L’economia italiana attraverso un secolo
In questo paese cronicamente in clima pre-elettorale c'è chi non vuol sentir
parlare di declino, nonostante i dati di fatto, e chi lo drammatizza a fini
politici.
Il declino c'è, è evidente, ma viene da lontano, non se ne può fare
responsabile solo il governo in carica. Il declino economico di un paese
matura negli anni, non in una legislatura, per quanto mediocremente
condotta.
Per l’economia italiana sono stati negativi gli ultimi decenni del secolo
scorso, non solo gli anni più recenti. Sarà stato per la crisi petrolifera, per la
baldanza sindacale, per la leggerezza con la quale ci siamo indebitati negli
anni dell’Italia da bere, sta di fatto che è stata compromessa in quel periodo
buona parte della ricchezza messa in piedi nell’ambito dell’economia
industriale.
L'industria italiana era nata circa un secolo prima, tra l’Unità e la prima
guerra mondiale. Era nata l’industria elettrica, naturalmente, a cominciare
dalla Edison; la siderurgia, con le Acciaierie di Terni, la Falck e il gruppo
Orlando, che sarà poi anche nell'Ilva di Bagnoli; la metallurgia con la Franco
Tosi di Legnano e le Officine Galileo di Firenze; la chimica con la Montecatini,
la Carlo Erba, la Schiapparelli; l'industria tessile, della quale per fortuna
rimangono realtà come Marzotto e Zegna; l'industria automobilistica con la
FIAT e le sue concorrenti Lancia e Alfa Romeo ma anche Isotta Fraschini e
altre; la Breda; l'Ansaldo; la Pirelli; l'Italcementi dei Pesenti; la Olivetti di
Camillo, che aveva accompagnato in America Galileo Ferraris – che molto
conoscono per il segnale orario – per incontrare Thomas Edison – che molti
conoscono per le lampadine.
Risalgono ad allora anche la nascita della CGIL e della Confindustria, della
Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, con importanti quote di
capitale tedesco.
La rivoluzione industriale italiana si è fondata sullo spirito imprenditoriale,
capace di cogliere le opportunità di un mondo che cambiava. Maffeo
Pantaleoni considerava l’Italia il Paese europeo cresciuto più rapidamente,
dal punto di vista economico, nei primi 10 anni del secolo, e ne attribuiva il
merito all’iniziativa privata a fianco della quale tuttavia ha svolto un ruolo
fondamentale anche l’intervento pubblico, per esempio nella siderurgia.
La stessa rete ferroviaria è passata nel 1905 alla gestione statale in quanto il
suo sviluppo era di interesse collettivo, secondo il Parlamento del tempo, e
non poteva perciò seguire logiche di stampo esclusivamente privatistico
(ragionamenti replicati a livello teorico nell’ultimo decennio per le
telecomunicazioni).
Il fascismo, nella ricostruzione post-bellica, accentuerà il ruolo pubblico, che
si trasformerà in Partecipazioni Statali nella seconda ricostruzione postbellica.
Da li, sempre da lontano, arriva anche il boom, auto-accreditato con qualche
eccesso alla lungimiranza dei governi democristiani e dovuto anche ad una
nuova imprenditoria e ad altre condizioni favorevoli.
Negli ultimi 30 anni è successo che ci siamo accartocciati nell’ottica di breve
termine, nell'assenza di visione prospettica, e poi nel gioco stupido della
ricerca delle colpe, che ovviamente sono sempre altrui: i governi e la politica
in genere; gli autunni caldi e i sindacati; gli imprenditori e la scuola; l'Euro; i
cinesi; eccetera.
In questa mediocre manfrina da comari ossessionate dalle necessità della
comunicazione ogni episodio viene spacciato per simbolo di una fase storica,
da un foulard contraffatto al rinnovo del contratto degli statali; da uno 0,1%
di differenza nel PIL tendenziale alla trincea contro lo straniero che vorrebbe
comprare, pagandole e rispettando le regole, banche italiane.
Adesso che succede?
Poco.
Ci sono le 300 aziende individuate da De Rita come presupposto per
l’ottimismo, ma cosa sono 300 aziende per la settima economia mondiale?
Forse un modello, ma chi ci lavora attorno per farlo diventare un modello di
sviluppo per tutto il Paese?
Di intervento pubblico se ne parla quasi di nascosto, malvolentieri.
Molte delle aziende create negli anni buoni sono diventate un'altra cosa o del
tutto sparite.
L’economia industriale si è ridotta o trasformata senza quasi ruolo italiano.
E’ stato e sarebbe ancora il momento di settori quali la grande distribuzione,
l'economia digitale, le biotecnologie, l'economia della conoscenza, della
salute, del tempo libero e del bello, che include natura, arte e turismo. Però
non si vede molto di italiano in giro, oltre lo sfruttamento più o meno
tradizionale delle eredità. Autogrill che compra in Spagna è un'eccezione,
non la regola. Come compagnie aeree siamo messi male, grandi catene
alberghiere non ne abbiamo più e quanto alla conoscenza non si può certo
dire che esportiamo modelli culturali.
Abbiamo il design, certo, ma comincio a temere che anche quello si stia
compattando nel talento di alcuni invece di espandersi come scuola a livello
internazionale.
Da un secolo all'altro è cambiato tutto, l'Italia e gli italiani; la classe
dirigente e la società; soprattutto si è passati da un clima di fiducia e
costruzione a quello depresso e pessimista attuale che ci sarebbe stato
comunque, con o senza Berlusconi.
Lui semmai aggrava la situazione intignandosi nell'ottimismo di facciata, nel
volere fare vedere una realtà fasulla, virtuale, raccontata a mezzo stampa o
via etere dalla sua corte di fans, servitori e beneficiati. Non pochi, peraltro, i
beneficiati a danno del paese.
Il problema del declino è reale, come dimostrano i dati sulle esportazioni,
l’andamento del PIL e anche i de profundis per alcune compiante aziende.
Ne ha scritto uno recentemente Elserino Piol ("Il sogno di un'impresa") per
celebrare l'Olivetti che non c'è più (per colpa dei politici, secondo una
recentissima intervista).
Conosco e stimo Piol, uno che ha tutt'ora intuizioni non comuni e che vede il
business prima di molti altri. Talvolta anche dove non c'è, ma questo è
inevitabile.
Piol dice però dell'Olivetti anche cose difficili da condividere, nel complesso.
Oppure non le dice. Possibile che nel drastico ridimensionamento dell'Olivetti
non siano quasi ravvisabili cause endogene, dico innanzi tutto errori e a
volte inadeguatezza manageriale, prodotti e strategie sbagliate o mal
applicate? E non ha influito sul destino dell’Olivetti anche l’avventura belga
di de Benedetti?
Come la FIAT: non andava bene, poi quando c’era Ghidella si è ripresa
producendo vetture di successo; allontanato Ghidella la FIAT è tornata a fare
auto di minore successo. Forse è stata una coincidenza, ma può anche darsi
che Romiti e i suoi dirigenti hanno commesso qualche errore. O no?
Anche per la FIAT si è sentito dire che però lo Stato avrebbe dovuto….
Perché cercare colpe sempre e solo all’esterno?
Ma quale Stato! Perché in Italia, in generale, se va male un'azienda piccola è
colpa del costo del lavoro e se ne va male una grande è colpa dello Stato?
Stato, per inciso, tradizionalmente grande, fedele e poco esigente cliente
tanto dell’Olivetti quanto della FIAT.
Se adesso è più difficile, se lo Stato può meno, se l'Euro esclude la mossa
della svalutazione per restare competitivi, se i lavoratori italiani non
accettano condizioni di lavoro cinesi e non li si può obbligare con un Bava
Beccaris, che vogliamo fare?
Non è una domanda retorica. E’ una domanda. Per i devoluzionisti senza
senso dello Stato; per il cardinalizio Antonio Fazio; per quelli che
eliminerebbero i giudici comunisti; per i sindacalisti che “le lotte operaie” e
per gli imprenditori che evadere è necessario e anche giusto; per il ministro
Siniscalco, uno dei credibili, e per tutti i politici che credibili non lo sono
affatto, specialmente in economia.
Una domanda semplice: adesso che siamo nell’economia post-industriale,
che ci sono l’Euro, l’Europa, i cinesi, gli immigrati eccetera, che facciamo?
Qual è il modello di sviluppo che vogliamo ipotizzare per questo Paese?
Non occorre che sia geniale. Basta che sia ragionevole e credibile.
Massimo Biondi