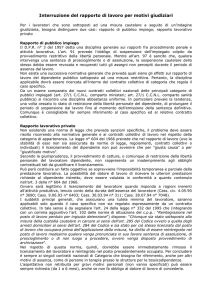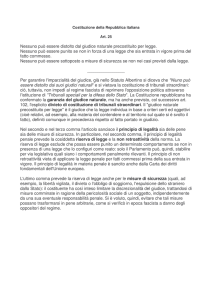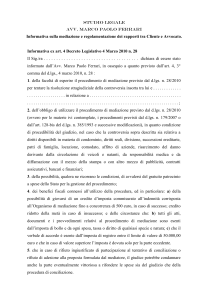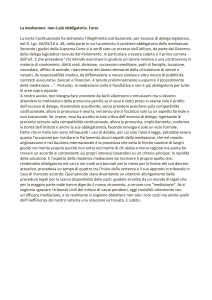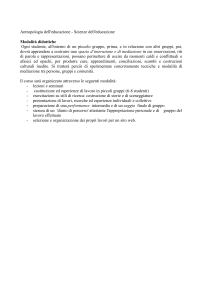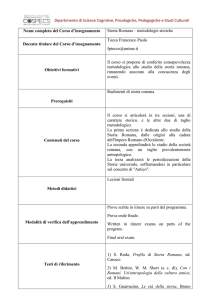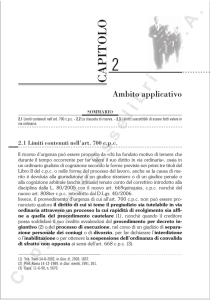2014
n° 1-2
Temi Romana
n° 1-2
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ANNO LXII
GENNAIO – GIUGNO 2014
Passeggiata in libreria
n° 1-2
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
In libreria
“CODICE DELL’UDIENZA FALLIMENTARE”
Antonio Caiafa DIKE GIURIDICA EDITRICE, ROMA
pp. 660, euro 25,00
Nell’epoca della “nevrosi” del legislatore si pone all’interprete l’esigenza di avere, per
ciascuna materia di riferimento, un quadro legislativo chiaro e puntuale delle norme di
applicazione quotidiana. La collana degli Oscar Dike vuole offrire al giurista una serie ben
ordinata di testi legislativi di facile e maneggevole consultazione, arricchita, per le norme
più importanti, dai testi storici delle disposizioni. Per conseguire l’auspicato fine, gli Oscar
Dike sono curati da Maestri indiscussi del diritto italiano e presentano la comodissima
veste del codice tascabile.
Direttore Responsabile: Mauro VAGLIO
Direttore Scientifico: Alessandro CASSIANI
Capo Redattore: Samantha LUPONIO
Comitato Scientifico:
Paola BALDUCCI, Antonio BRIGUGLIO, Luigi CANCRINI,
Pierpaolo DELL’ANNO, Antonio FIORELLA, Giovanni Maria FLICK
Giorgio LOMBARDI, Carlo MARTUCCELLI, Ugo PETRONIO
Eugenio PICOZZA, Giulio PROSPERETTI, Giorgio SPANGHER
Alfonso STILE, Federico TEDESCHINI, Roberta TISCINI,
Giancarlo UMANI RONCHI, Romano VACCARELLA
Comitato di Redazione:
Mauro VAGLIO, Pietro DI TOSTO, Antonino GALLETTI
Riccardo BOLOGNESI, Fabrizio BRUNI, Antonio CAIAFA
Alessandro CASSIANI, Domenico CONDELLO, Antonio CONTE
Mauro MAZZONI, Aldo MINGHELLI, Roberto NICODEMI
Matteo SANTINI, Mario SCIALLA, Isabella Maria STOPPANI
“PROCESSO AMMINISTRATIVO E TUTELA CAUTELARE”
Maria Vittoria Lumetti CEDAM, ASSAGO
pp. 736, euro 60,00
Si tratta della prima opera, dopo l’entrata in vigore del codice processuale
amministrativo, che affronta in maniera sistematica e globale tutta la problematica del
processo cautelare amministrativo in ogni fase e grado del giudizio, compresi il
processo di ottemperanza, la revocazione, l’accesso, il silenzio, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, il giudizio risarcitorio, la sospensione della sentenza
pendente ricorso in Cassazione e in Adunanza plenaria, la rimessione alla Corte di
giustizia e alla Corte costituzionale. Il libro, alimentato dalla passione che il processo
amministrativo è ancora in grado di suscitare ed arricchito dall’esperienza quotidiana
nelle aule giudiziarie, si propone di offrire una visuale completa della tutela cautelare
nel processo amministrativo, anche in raffronto con altri processi e alla luce delle
innovazioni recate dal codice e dal diritto comunitario.
“ABUSO SESSUALE SUI MINORI.
SCENARI, DINAMICHE, TESTIMONIANZE”
Giuliana Olzai ANTIGONE, TORINO
pp. 375, euro 28,00
Coordinatori:
Antonio ANDREOZZI, Andrea BARONE, Camilla BENEDUCE
Domenico BENINCASA, Marina BINDA, Ersi BOZEKHU
Francesco CASALE, Francesco CIANI, Benedetto CIMINO, Irma CONTI
Antonio CORDASCO, Alessandro CRASTA, Carmelita DE FINIS
Annalisa DI GIOVANNI, Ruggero FRASCAROLI, Maria Vittoria FERRONI
Fabrizio GALLUZZO, Alessandro GENTILONI SILVERI, Mario LANA
Paola LICCI, Andrea LONGO, Giuseppe MARAZZITA, Franco MARCONI
Alessandra MARI, Gabriella MAZZEI, Arturo MEGLIO, Chiara PACIFICI
Ginevra PAOLETTI, Chiara PETRILLO, Tommaso PIETROCARLO
Aurelio RICHICHI, Sabrina RONDINELLI, Serafino RUSCICA
Marco Valerio SANTONOCITO, Massimiliano SILVETTI, Luciano TAMBURRO
Federico TELA, Antonio TESTA, Federica UMANI RONCHI, Clara VENETO
Segretario di redazione: Natale ESPOSITO
L’orrore degli orrori, quello che nessuno ha voglia di scoprire. L’abuso sessuale sui
bambini e le bambine è forse l’ultimo tabù rimasto, quello su cui gravano ancora una
forte condanna da parte dell’opinione pubblica e una pesante sanzione di mass media e
rappresentanti politici. Su questo reato odioso cerca di far luce il volume di Giuliana
Olzai, laureata in Statistica e specializzata in Metodi e tecniche per la ricerca sociale,
che ha analizzato i 288 procedimenti giudiziari del Tribunale penale di Roma nel
quadriennio 2000-2003 riguardanti proprio gli abusi sui minori di 14 anni.
Con un lavoro accurato, l’autrice ha seguito i percorsi processuali delle denunce, ha
ripercorso l’iter giudiziario compiuto dalle vittime che denunciano una violenza,
perpetrata quasi sempre da persone che conoscono bene, con le quali hanno spesso un
legame affettivo. Un’analisi che cerca di aiutare il lettore a comprendere come questo
stretto legame fra vittima e carnefice abbia un effetto diretto sull’invasività e la gravità
degli abusi, sulla ripetizione delle violenze così come sul tempo che trascorre prima
che il bambino o la bambina abbia il coraggio di denunciare.
“MANUALE PRATICO DEI MARCHI E BREVETTI” (CON CD ROM)
Andrea Sirotti Gaudenzi MAGGIOLI EDITORE, SANTARCANGELO DI ROMAGNA
pp. 666, euro 74,00
Progetto grafico: Alessandra GUGLIELMETTI
Disegno di copertina: Rodrigo UGARTE
____________
Temi Romana - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 320 del 17 luglio 2001 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via C. T. Masala, 42 - 00148 Roma
L’opera, aggiornata al D.L. 1/2012 convertito con modifiche in L. 27/2012 che modifica il codice della
proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) e alla recente giurisprudenza, caratterizzata da un’impostazione
sistematica degli argomenti, ripercorre con taglio agile tutti i principali temi legati alla proprietà
industriale, offrendo all’operatore tutti i necessari strumenti pratici. Il testo è suddiviso in sette parti
con i rispettivi capitoli e paragrafi che analizzano in modo completo ed esaustivo le materie di
“marchi, segni distintivi e brevetti per invenzioni e modelli”.
Sommario
n°1-2
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
2
PIERO CALAMANDREI: LA STORIA
4
SAGGI
A cura della Redazione
I delitti di criminalità organizzata e il c.d. regime del doppio binario nella sua articolazione penale,
investigativo-processuale e del trattamento penitenziario previsto nei confronti dei soggetti detenuti
per tali fattispecie di reato
Iole Falco
11
La duttilità della fase cautelare: intrecci, compressione, ampliamento e conversione in altri riti. Alla
ricerca della fase di merito nella costellazione dei segmenti cautelari
Maria Vittoria Lumetti
24
L’ascolto del minore: dovere del giudice e diritto del figlio. Riferimenti normativi
Samantha Luponio
29
Il fenomeno del pentitismo nella prospettiva criminologica integrata
Giovanni Neri
35
Competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e vincoli
di riequilibrio finanziari anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in
tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma
Maria Giulia Putaturo Donati
43
Criteri d’individuazione del titolare della qualifica soggettiva nell’ambito delle organizzazioni
complesse e operatività della delega di funzioni, con particolare riferimento, alla responsabilità
di Amministratori e Sindaci di società - Parte I - Delega di funzioni, teorie e criteri
Francesca Zignani
52 OSSERVATORIO LEGISLATIVO
Sulla non equivalenza del credito per retribuzioni e quello di regresso per t.f.r.
Antonio Caiafa
59
La disciplina del contratto a termine dopo il decreto Poletti e la legge di conversione
Andrea Lutri
62 NOTE A SENTENZA
La depenalizzazione della colpa lieve nell’attività medico-chirurgica
Roberta Mencarelli
67
Quando il potere diventa arbitrio
Angelo Miele
69 CRONACHE E ATTUALITÀ
L’Avvocatura Pubblica quale strumento per la realizzazione dei principi di legalità,
economicità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa
Stefania Ricci
74 La mediazione in Europa e in Italia
Giorgio Santacroce
Temi Romana
1
Piero Calamandrei: la storia
A cura della Redazione
P
gruenze e le possibili debolezze future. Una lezione di
metodo democratico e di passione civile che non ha
perso la sua straordinaria carica ideale. Così disse
Calamandrei: “È un po’ successo, agli articoli di questa
Costituzione, quello che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età, che aveva i capelli grigi ed aveva due
amanti, una giovane e una vecchia: la giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia gli strappava i capelli neri; e lui rimase calvo. Nella Costituzione ci sono
purtroppo alcuni articoli che sono rimasti calvi”.
Nel 1948 fu deputato per «Unità socialista». Nel 1953
prese parte alla fondazione del movimento di «Unità
popolare» assieme a Ferruccio Parri, Tristano
Codignola e altri.
Fondatore nel 1945 del settimanale politico-letterario Il
Ponte, che diresse per dodici anni, Piero Calamandrei
fu anche direttore con Carnelutti della Rivista di diritto
processuale, con Finzi, Lessona e Paoli della rivista Il
Foro toscano, con Alessandro Levi del Commentario
sistematico della Costituzione italiana, Accademico
nazionale dei Lincei e direttore dell’Istituto di diritto
processuale comparato dell’Università di Firenze.
Molto apprezzato dai cultori del Diritto, il suo Elogio dei
giudici scritto da un avvocato e, memorabile per efficacia, l’epigrafe dettata da Calamandrei per la Lapide ad
ignominia, che il Comune di Cuneo ha dedicato al generale nazista, criminale di guerra, Albert Kesselring.
iero Calamandrei nasce a Firenze il 21 aprile
1889, città dove muore il 27 settembre 1956. Di
antica famiglia di giuristi (suo padre, professore e
avvocato, era stato anche deputato repubblicano) si laurea a Pisa nel 1912.
Nel 1915 è già docente di procedura civile all’Università di Messina e, se si esclude la parentesi della prima
guerra mondiale (dove partecipò come ufficiale volontario combattente nel 218° reggimento di fanteria, conseguendo dapprima il grado di Capitano e, successivamente, la promozione a Tenente Colonnello) ha sempre
insegnato: Modena (1918), Siena (1920) e, dal 1924
sino ai suoi ultimi giorni, nell’Ateneo fiorentino (di cui
fu anche Rettore) come Professore ordinario di Diritto
processuale civile.
Subito dopo l’avvento del fascismo fece parte del
Consiglio direttivo dell’«Unione Nazionale», fondata da
Giovanni Amendola. Durante il ventennio fascista fu uno
dei pochi professori che non ebbe né chiese la tessera, continuando sempre a far parte di movimenti clandestini.
Collaborò a «Non mollare», nel 1941 aderì a «Giustizia e
Libertà» e, nel 1942, fu tra i fondatori del Partito d’Azione.
Dopo l’8 settembre fu colpito da mandato di cattura.
Assieme a Francesco Carnelutti e a Enrico Redenti fu
uno dei principali ispiratori del Codice di procedura
civile del 1940, dove trovarono formulazione legislativa gli insegnamenti fondamentali della scuola di
Chiovenda. Si dimise da professore universitario per
non sottoscrivere una lettera di sottomissione al
«Duce» che gli veniva richiesta dal Rettore del tempo.
Presidente del Consiglio Nazionale Forense dal 1946
alla morte, fece parte della Consulta Nazionale e della
Costituente in rappresentanza del Partito d’Azione.
Partecipò attivamente ai lavori parlamentari come componente della Giunta delle elezioni della commissione
d’inchiesta e della Commissione per la Costituzione.
I suoi interventi nei dibattiti dell’assemblea ebbero
larga risonanza, specialmente quelli sul piano generale
della Costituzione, sugli accordi lateranensi, sulla
indissolubilità del matrimonio, sul potere giudiziario.
Celebre il discorso tenuto il 4 marzo 1947 sulla “chiarezza” nella Costituzione, esortazione (a volte spiritosa, a volte accorata o solenne) a costruire un testo giuridicamente limpido quale strumento effettivo di democrazia. Un documento che ci riporta a un altro
Calamandrei: non il paladino della piena attuazione
della nostra legge fondamentale ma il giurista di rango,
capace di coglierne in statu nascenti tutte le incon-
ALCUNI DEI SUOI TESTI
Non c’è libertà senza legalità
“La legalità è condizione di libertà. Senza certezza del
diritto non può sussistere libertà politica”. Di fronte allo
“spaventoso caos di un mondo in rovina”, nel terribile
inverno tra il 1943 e il 1944, Piero Calamandrei comprese come ogni speranza di “duratura rinascita” non
poteva non fare affidamento sul ripristino del principio
di legalità a “metodo di governo”. Se il fascismo era
stato il regime dell’illegalità dispiegata, una legalità
repubblicana non soltanto doveva essere considerata
come fondamento essenziale della libertà, ma doveva
anche essere “una legalità che può modificare tutte le
leggi meno quelle poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà”. “La libertà di culto, di
stampa, di pensiero, di riunione, la uguaglianza dei cittadini nonostante ogni diversità di razza o di religione,
sono considerate come estrinsecazioni insopprimibili
2
Temi Romana
Piero Calamandrei: la storia
della personalità umana, che non si potrebbero menomare senza per questo sopprimere la libertà. Le leggi
possono far tutto meno che sopprimere questi diritti
intangibili: il liberalismo si può dunque considerare un
regime di legalità entro le barriere dei diritti di libertà”.
rendo ingiusto, che ad essere ingiusto apparendo giusto.
“La legge è uguale per tutti” è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei
giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma
quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della
legge a sua difesa, è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra
una beffa alla sua miseria.
Il fascismo come regime della menzogna
In questa opera Calamandrei redige un bilancio del
ventennio all’indomani della Liberazione, un inno alla
libertà ritrovata, un’analisi a caldo del regime in cui
“Bisogna fare di tutto perché quella intossicazione
vischiosa non ci riafferri: bisogna tenerla d’occhio,
imparare a riconoscerla in tutti i suoi travestimenti. In
quel ventennio c’è ancora il nostro specchio. Solo guardando ogni tanto in quello specchio possiamo accorgerci che la guerra di Liberazione, nel profondo delle
coscienze, non è ancora terminata”.
Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi
dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita
perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta.
L’avvocato che si lagna di non essere capito dal giudice, biasima non il giudice, ma sé stesso. Il giudice non
ha il dovere di capire: è l’avvocato che ha il dovere di
farsi capire.
Elogio dei giudici scritto da un avvocato
Principi processuali, aneddoti, ambiente e vita giudiziaria si trovano in questo nobile libro di Piero
Calamandrei. Come in un caleidoscopio, incalzano
vivide scenette. Attualissime discussioni si accendono
tra fautori del collegio e fautori del giudice unico.
Seguono considerazioni dissacranti, secondo cui,
molte volte, il cliente dovrebbe ringraziare della vittoria non il proprio ma l’avvocato dell’avversario.
Intercalati, compaiono ritrattini di giudici fin troppo
assorti nel proprio magistero, tanto da ignorare la vitale realtà che tumultua (magari a sproposito) fuori dalla
camera di consiglio.
Proprio per questo dovrebbero essere i giudici i più
strenui difensori dell’avvocatura: poiché solo là dove
gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati,
sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura,
colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa
assai più difficile ed angosciosa la loro missione di
giustizia.
Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come
tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede.
La nobile passione dell’avvocato dev’essere in ogni
caso consapevole e ragionante: avere i nervi così solidi
da saper rispondere alla offesa con un sorriso amabile,
e da ringraziare con un garbato inchino il presidente
burbanzoso che ti toglie la parola.
CITAZIONI
Al giudice occorre più coraggio ad essere giusto appa-
Temi Romana
3
Saggi
I delitti di criminalità organizzata e il c.d. regime
del doppio binario nella sua articolazione penale,
investigativo-processuale e del trattamento penitenziario
previsto nei confronti dei soggetti detenuti
per tali fattispecie di reato
Iole Falco
Commissario di Polizia Penitenziaria
I
l nostro ordinamento giuridico non fornisce una
precisa nozione di criminalità organizzata e, al
contempo, non individua specifiche fattispecie
configurabili appunto quali “delitti di criminalità organizzata”.
Pertanto, il concetto di criminalità organizzata, pur prestandosi a svariate e disparate letture, può comunemente identificarsi – in una chiave dai marcati connotati
sociocriminologici – con l’attività di quelle associazioni criminali contraddistinte da strutture organizzative
particolarmente complesse e sofisticate, in cui è proprio
l’elemento dell’“organizzazione” ad assumere un ruolo
preminente ed autonomo rispetto ai singoli associati.
Ne consegue che si considerano delitti di criminalità
organizzata tutti quei reati posti in essere da una pluralità di soggetti che operano attraverso un’articolata rete
organizzativa, al fine di perseguire uno specifico programma criminoso, in grado di suscitare un particolare
allarme sociale.
Nell’attuale situazione normativa è possibile individuare due serie principali di delitti: quella contenuta nel
comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p. e quella risultante dall’art. 407 co. 2 lett. a c.p.p..
In particolare, la norma da ultimo citata – in tema di
termini massimi di durata delle indagini – comprende
un gruppo molto vasto ed eterogeneo di norme incriminatrici.
In essa si annoverano, infatti, taluni delitti obiettivamente collegati a strutture associative e talaltri reati che
non presuppongono necessariamente il substrato di
un’organizzazione criminale. La seconda elencazione
di delitti è quella prevista dal comma 3 bis dell’art. 51
c.p.p., introdotto dalla L. 306/92 e funzionale all’individuazione dei c.d. “reati distrettuali” (cioè i delitti le
cui indagini sono attribuite alle Direzioni Distrettuali
Antimafia).
Ciò premesso, non stupisce che il catalogo in esame
contenga, per prima cosa, i delitti tipicamente connessi
alla criminalità organizzata e cioè il reato di cui all’art.
416 bis e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla predetta norma ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p..
Tale fattispecie di reato, introdotta dalla L. 646/82 c.d.
legge Rognoni-La Torre, spicca all’interno dei reati
associativi, in quanto rappresenta il fulcro sistematico
di un reticolato di disposizioni di diritto penale speciale finalizzate alla lotta contro il fenomeno della criminalità organizzata.
La previsione contenuta nella legge Rognoni-La Torre
è, infatti, una fondamentale chiave di volta dell’intero
sistema di contrasto alle compagini criminali e merita
attenta lettura soprattutto quando focalizza il nucleo di
antistatualità della condotta del reato nel far parte della
associazione organizzata in una struttura stabile, al fine
di avvalersi dell’accordo associativo e di utilizzare la
forza di intimidazione derivante da tale vincolo per
trarre vantaggio dalla condizione di assoggettamento e
di omertà, diffuse nel territorio, con il fine di commettere ulteriori delitti ed acquisire utilità non solo economiche ma delle più varie tipologie.
Le vicende legate ai fatti di criminalità organizzata
4
Temi Romana
Saggi
hanno influenzato massicciamente l’attività legislativa
in materia di giustizia e sicurezza, dando vita ad una
serie di norme e di interventi imposti dall’emergenza.
Il quadro normativo che ne è venuto fuori, insieme alla
frammentarietà delle disposizioni di legge contro la criminalità organizzata, si caratterizza per la scelta differenziata, all’interno del sistema, tra fattispecie di criminalità comune e reati commessi nel contesto di organizzazioni criminali.
Va però detto che la disciplina presente nell’attuale
sistema penale, investigativo-processuale e penitenziario impone l’adozione in via stabile e permanente di un
sistema di c.d. doppio binario, volto a coniugare le esigenze di difesa sociale con la necessità di assicurare le
adeguate garanzie degne di un moderno stato di diritto.
In relazione al profilo del trattamento penale differenziato il legislatore, in piena attuazione del regime del
doppio binario, ha previsto a carico di chi commette
delitti tipici di criminalità organizzata uno speciale
sistema di circostanze aggravanti tra le quali assume
particolare rilievo l’aggravante speciale di cui all’art. 7
del D.L. 152/91 che risulta applicabile quando un delitto, punito con una pena diversa dall’ergastolo, sia compiuto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis c.p. o al fine di agevolare l’associazione di cui
allo stesso articolo e causa un aumento della pena prevista per quel delitto da un terzo alla metà.
La ratio di tale disposizione è, essenzialmente, quella
di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, gli
atteggiamenti di coloro che partecipi o meno in reati
associativi, ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente
intimidazione propria delle organizzazioni criminali.
Da ricordare è, altresì, il comma 6 dell’art. 416 c.p.
come modificato dalla recente L. 94/2009 la quale ha
introdotto un aggravamento di pena sia per i promotori, costitutori e organizzatori dell’associazione, sia per
i partecipi della stessa, non solo nel caso in cui il sodalizio sia diretto a commettere i delitti di c.d. tratta (artt.
600, 601 e 602 c.p.) ma anche quando lo scopo comune sia quello di realizzare fatti di sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
Sempre in relazione al profilo del trattamento penale
sono, all’inverso, previste speciali diminuzioni di pena
Temi Romana
per chi, dopo avere commesso tali fattispecie di reato,
decide di dissociarsi e di collaborare con l’Autorità
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e l’individuazione dei colpevoli.
Sotto il profilo investigativo e processuale, l’insieme
delle deroghe alla disciplina ordinaria ha creato un vero
e proprio “sottosistema processuale” volto ad assicurare un contrasto effettivo alla criminalità organizzata.
Innanzitutto la specialità della procedura antimafia si
riscontra nella fase preliminare e, in special modo, in
quell’insieme di norme finalizzate a modellare l’organizzazione delle indagini alle peculiari modalità investigative richieste dal fenomeno del crimine organizzato.
L’azione di contrasto del fenomeno mafioso è assicurata da organi investigativi specializzati, tra i quali si
annoverano i servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria (art. 12 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991) e la Direzione investigativa antimafia (art. 3 D.L. n. 345 del 1991).
Ma la diversificazione soggettiva più significativa è,
sine dubio, quella che ha riguardato l’organizzazione
degli uffici dell’accusa.
Invero, con il decreto legge n. 367 del 1991 (poi convertito nella legge n. 8 del 1992) intitolato, appunto
“Coordinamento delle indagini nei procedimenti per
reati di criminalità organizzata” si è differenziata la
disciplina in tema di acquisizione della notizia di reato
mediante l’istituzione delle Direzioni Distrettuali
Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, cui è
preposto il Procuratore Nazionale Antimafia.
A seguito di tale intervento legislativo, le indagini sui
reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. sono concentrate presso uno speciale ufficio del pubblico ministero,
appositamente costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto (le DDA, appunto), in modo da rafforzare l’unitarietà dell’accusa e annullare la possibilità che possa insorgere un contrasto.
Alle singole procure distrettuali è stato preposto –
secondo una “logica verticale” – un organo istituito
nell’ambito della Procura Generale presso la Corte di
Cassazione: la “Procura Nazionale Antimafia”, cui
sono demandate funzioni di impulso dell’attività investigativa, di ricerca e sistemazione delle informazioni
attinenti al crimine organizzato (art. 371 bis c.p.p.),
nonché di investigazione preventiva come previsto dal
c.d. “Decreto sicurezza” del 2008 (D.L. n. 92 del
5
Saggi
2008). Sempre con riguardo alle indagini preliminari,
la specialità investe altresì la tempistica e i meccanismi
di proroga.
Ed invero, le esigenze di assicurare la completezza di
investigazioni complesse e di garantirne la segretezza
nei procedimenti per i “delitti di grande criminalità”
(art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.) hanno portato il legislatore a predisporre un secondo gruppo di disposizioni derogatorie:
- l’art. 407 comma 2 lett. a. c.p.p. che allunga a due
anni la durata massima complessiva delle indagini
preliminari, contro un termine ordinario di diciotto
mesi;
- l’art. 405 comma 2 c.p.p. che, in maniera analoga,
fissa in un anno (il doppio rispetto ai procedimenti
per reati “comuni”) il termine entro il quale il pubblico ministero è normalmente tenuto alla conclusione delle indagini preliminari;
- l’art. 406 comma 5 bis c.p.p. che contempla una
disciplina ampiamente derogatoria rispetto al regime
ordinario di comunicazioni e avvisi per una serie più
ristretta di reati, escludendo, infatti, ogni forma di
contraddittorio con la persona sottoposta alle indagini riguardo alla proroga, perciò definita “coperta”, al
fine di salvaguardare gli sviluppi delle attività investigative dai tentativi di depistaggio o inquinamento
che puntualmente si registrano nelle inchieste relative ai delitti di criminalità organizzata;
- l’art. 335 comma 3 c.p.p. che, analogamente, deroga al regime ordinario di conoscibilità dell’indagine
sancendo la non comunicabilità esterna delle informazioni iscritte nel registro delle notizie di reato.
Continuando la carrellata sugli elementi di specialità, una
significativa differenziazione si registra anche in relazione alle attività esperibili nell’indagine preliminare.
Nei procedimenti di criminalità organizzata è, infatti,
incrementata la facoltà di iniziativa, nonché l’incisività
dei poteri investigativi e coercitivi attribuiti alla polizia
giudiziaria.
Si segnala, a tal proposito, la possibilità affidata agli
ufficiali e agli agenti di p.g. di procedere – nel corso di
procedimenti per la prevenzione e la repressione del
reato di cui all’art. 416 bis C.P. e di quelli commessi in
relazione ad esso – a controlli, ispezioni e perquisizioni con l’autorizzazione, anche successiva, del pubblico
ministero (art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 55 del
1990). Altrettanto degno di nota è il potere in capo agli
organi di p.g. di compiere, previo controllo dell’autorità giurisdizionale, perquisizioni in interi edifici o blocchi di essi attribuito dall’art. 25 bis D.L. n. 306 del
1992 per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. e
recentemente esteso nell’ambito del contrasto al terrorismo internazionale.
Ciò consente un allargamento eccezionale dei poteri di
ricerca degli organi di polizia, qualora ci sia fondato
motivo di sospettare che un latitante o un evaso stia trovando riparo in un contesto urbano.
Un’ultima menzione, per concludere, si rivolge alla
possibilità da parte del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia appartenenti alle strutture investigative
specializzate di raccogliere, previa autorizzazione, le
dichiarazioni dei soggetti detenuti o internati, a fini
preventivi o repressivi, attraverso colloqui riservati e
informali, per i quali non è nemmeno prevista la presenza del difensore (art. 18 bis legge n. 354/75, introdotto dalla legge n. 306 del 1992).
Nella dissertazione sulla specialità degli strumenti
investigativi, le intercettazioni meritano uno spazio
autonomo.
Infatti, l’art. 13 D.L. n. 152 del 1991 (convertito nella
legge n. 203 del 1991, come modificato, da ultimo, dalla
legge n. 63 del 2001) prevede specifici presupposti e
differenti limiti di durata per l’ascolto occulto delle conversazioni telefoniche e ambientali, in deroga ai parametri imposti dagli artt. 266 e 267 c.p.p. per la concessione di questi invasivi mezzi di ricerca della prova.
In particolare, per quanto riguarda la captazione di
comunicazioni telefoniche, si attenua il rigore dei presupposti richiesti per l’atto di autorizzazione (il riscontro di “sufficienti indizi” di tale tipologia di reato, un
parametro meno stringente rispetto a quello ordinario
della “assoluta indispensabilità”, dello strumento “per
la continuazione delle indagini”) e si allungano i tempi
di durata per le operazioni (quaranta giorni con proroga di venti, anziché quindici giorni con proroga della
medesima durata).
Inoltre, ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento di
intercettazioni di conversazioni “tra presenti” nei luoghi indicati dall’art. 614 C.P., non è necessario un fondato motivo che al loro interno si stiano svolgendo attività criminose, potendo tale ultima particolare modalità di captazione essere ammessa anche “quando si trat-
6
Temi Romana
Saggi
ta di agevolare le ricerche di un latitante” (art. 295
comma 3 c.p.p.).
Per i “delitti distrettuali”, l’art. 226 disp.att. c.p.p. prevede, altresì, che la polizia giudiziaria, con un provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica,
possa svolgere controlli sulle comunicazioni quando
questi siano indispensabili per la prevenzione del crimine organizzato.
Si ricorda, però, che – in quanto strumenti preventivi –
i risultati di tali intercettazioni saranno sprovvisti di
qualsiasi valore processuale, valendo quindi unicamente a giustificare successive attività idonee a costituire
autonoma fonte di acquisizione di notizie di reato.
Dall’analisi sinora compiuta, si ricava che uno dei tratti di specialità più marcati dei procedimenti per fatti di
criminalità organizzata riguarda l’attività di ricerca – in
maniera costante e diretta – della notitia criminis da
parte degli organi inquirenti.
A questo scopo il legislatore è andato implementando
sempre più quello che è stato efficacemente definito
come un “apparato di auto-approvvigionamento di
informazioni” sui sodalizi criminali (dati ambientali,
forme organizzative ecc.).
Tale apparato si traduce, quindi, in una “super indagine” rivolta a porre le basi conoscitive sull’associazione
criminale, funzionali alla stessa indagine preliminare.
In altri termini, si registra la predisposizione di uno
strumentario giuridico finalizzato a disciplinare quelle
“inchieste preparatorie” favorite dalla stessa fattispecie
del reato di cui all’art. 416 bis c.p..
Si tratta, dunque, di una fase che il legislatore qualifica
come “preventiva”, per la quale dispone che gli elementi raccolti in essa non siano in alcun modo utilizzabili nel procedimento penale in senso stretto.
Un ulteriore profilo di specialità dei procedimenti in
esame si registra sul terreno delle misure cautelari.
Invero, in materia di compiti cautelari del giudice, vige
un regime differenziato in base al quale, per gli accusati di delitti di criminalità organizzata, si realizza un
arretramento del principio di inviolabilità della libertà
personale e si nota una netta prevalenza del carcere
rispetto alle altre modalità di custodia.
In particolare, l’art. 274 lett. c c.p.p. ammette la possibilità di disporre un provvedimento cautelare non solo
quando vi sia un pericolo di fuga o di inquinamento del
materiale probatorio, ma anche quando sussista il
Temi Romana
rischio che l’indagato torni a commettere determinati
delitti particolarmente efferati, tra cui quelli connessi
all’associazionismo criminale.
La descritta occorrenza cautelare – definita “esigenza
di tutela della collettività” – è espressione di una logica in cui si confondono le istanze preventive con quelle direttamente sanzionatorie.
Ma la disposizione di cui sopra deve essere letta congiuntamente a quella prevista dal terzo comma dell’art.
275 c.p.p., il quale fissa, per i procedimenti in esame,
una presunzione di inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, invertendo in tal modo la regola “ordinaria” del carcere come
extrema ratio.
Occorre aggiungere sul punto che il regime speciale
sopra descritto – nonostante sia caratterizzato da una
“presunzione relativa di periculum libertatis” e da una
“presunzione assoluta” circa l’adeguatezza del carcere
– ha regolarmente superato il vaglio di legittimità da
parte della Corte Costituzionale e della Corte europea
dei diritti dell’uomo, le quali ne hanno giustificato la
sussistenza in ragione delle peculiarità strutturali e criminologiche dei delitti per cui è predisposto.
La differenziazione sul versante processuale per l’accertamento dei reati di criminalità organizzata ha
riguardato anche la fase dibattimentale.
Tra queste norme occorre ricordare quelle che, dal
1998 hanno contribuito a disciplinare il c.d. processo
“virtuale”.
Si tratta, invero, di particolari modalità di formazione
della prova, quali la partecipazione a distanza della persona in stato di detenzione (art. 146 bis disp. att. c.p.p.) e
l’esame delle persone che collaborano con la giustizia o
degli imputati di reato connesso (147 bis disp. att. c.p.p.).
In particolare, mediante la prima disposizione citata, il
legislatore ha predisposto un apposito sistema di collegamento audiovisivo per l’esame di una persona che si
trovi in stato di detenzione in carcere e versi in una
delle ipotesi tassative previste dalla norma.
Si tratta, quindi, di una disposizione che, limitando gli
spostamenti dei detenuti, consente di evitare dilatazioni dei tempi processuali, in procedimenti già afflitti
dalle lungaggini del gigantismo processuale e di garantire la tutela della sicurezza pubblica, poiché riguarda il
trattamento di detenuti particolarmente pericolosi.
Per concludere, è sufficiente ricordare – in questa sede
7
Saggi
– come la specialità dei processi di criminalità organizzata sia arrivata a permeare anche il versante del procedimento probatorio in senso stretto.
Nei procedimenti di criminalità organizzata si riscontrano, infatti: una peculiare limitazione del diritto alla
prova per evitare la c.d. “usura delle fonti” (art. 190 bis
c.p.p.); un particolare uso probatorio delle sentenze
(art. 238 bis c.p.p.) e un singolare atteggiarsi del meccanismo di accertamento dell’intimidazione, ai fini del
recupero delle precedenti dichiarazioni (art. 500 commi
4 e 5 c.p.p.).
Parallelamente al corpus di norme costituenti il regime
processuale ed investigativo differenziato per coloro
che rispondono dei delitti di criminalità organizzata
esistono altri strumenti atti a differenziare sul piano
penitenziario l’attività di contrasto alla criminalità
organizzata da tutte le altre forme di difesa sociale contro il crimine.
Nei primi anni ’90 alla recrudescenza della criminalità
organizzata e, in particolare, ad alcuni feroci attacchi
alle istituzioni lo Stato rispose, in materia penitenziaria,
attraverso l’introduzione di un vero e proprio “doppio
binario trattamentale”: da un lato i condannati ordinari,
nei cui confronti continua ad essere prevalente la finalità specialpreventiva e rieducativa della pena e ai
quali, pertanto, è offerto un trattamento penitenziario
ed extrapenitenziario funzionale alla risocializzazione;
dall’altro lato, i detenuti per i delitti di maggiore allarme sociale, in relazione ai quali appare necessario rafforzare le esigenze di prevenzione generale e di neutralizzazione.
Dal 1991 in poi, infatti, per quest’ultima categoria di
detenuti, la possibilità di procedere ad un trattamento e
ad un regime differenziato per assicurare la sicurezza
sia interna degli istituti che pubblica, si è fatta strada in
due diverse direzioni: da un lato, attraverso l’individuazione di un accesso differenziato ai benefici e alle
misure alternative, secondo le previsioni introdotte dall’art. 4 bis o.p. e, dall’altro, attraverso la sospensione in
tutto o in parte, per taluni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge penitenziaria, mediante l’introduzione dell’art. 41 bis co. 2 o.p. ad
opera della legge 356/92.
A questa categoria di detenuti, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità criminale o sociale, è
preclusa o limitata la concessione delle misure alterna-
tive alla detenzione (fatta eccezione per la liberazione
anticipata), dei permessi premio e del lavoro all’esterno, fruibili solo mediante l’offerta della “collaborazione con la giustizia” qualificata ex art. 58 ter o.p., essendo questo l’unico modo per dimostrare l’avvenuta rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata
che, altrimenti, si presumono sempre esistenti. Da qui,
la necessità, secondo il legislatore, di intervenire non
solo nel settore delle misure alternative alla detenzione,
ma anche in quello del trattamento penitenziario,
restringendo al massimo le opportunità di contatto dei
detenuti ex art. 4 bis o.p. con l’esterno.
Per soddisfare tale esigenza, il legislatore, con legge
356/92, ha introdotto nell’art. 41 bis un 2° comma relativo ad un’ipotesi particolare di sospensione delle normali regole trattamentali (sostanzialmente identica alla
abrogata disciplina di cui all’art. 90 o.p.).
Il provvedimento ministeriale consente l’adozione di
misure in deroga al regime ordinario che comportano la
sospensione, nei confronti dei detenuti o internati per
taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1
dell’art. 4 bis o.p. e in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con un’organizzazione criminale, terroristica o eversiva, dell’applicazione delle regole di trattamento e degli
istituti che possano porsi in concreto contrasto con le
esigenze di ordine e di sicurezza.
La formula presente nella versione originaria del 2° co.
dell’art. 41 bis o.p. è stata arricchita dalla precisazione
che le restrizioni adottate devono essere necessarie per
il soddisfacimento di tali esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza.
La Corte Cost., pur riconoscendo all’amministrazione
penitenziaria il potere di adottare provvedimenti in
ordine alle modalità di esecuzione della pena, ha specificato, con sentenza n. 349/93, che tali provvedimenti
restano comunque soggetti ai limiti e alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13 co. 4 Cost.) o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 co. 3) ed al diritto di difesa (art. 24).
Le modifiche apportate dalla legge 94/2009 rispondendo all’intento di spezzare ogni legame tra il carcere e il
mondo esterno, allo scopo di isolare gli appartenenti a
organizzazioni criminali per indebolire la loro posizione, hanno inciso in modo particolarmente pesante sul
8
Temi Romana
Saggi
contenuto del provvedimento sospensivo delle regole
trattamentali delineato nel co. 2 quater dell’art. 41 bis
o.p. La nuova formulazione premette all’elenco delle
restrizioni la precisazione che i soggetti sottoposti al
regime in peius sono ristretti all’interno di istituti a loro
esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in
aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria (il c.d. GOM – Gruppo Operativo Mobile).
Prima di analizzare le singole restrizioni è interessante
evidenziare che nel secondo periodo del co. 2 quater
dell’articolato normativo in esame si dice che la
sospensione prevede, anziché, come nella versione precedente, può prevedere, volendo in tal modo significare che non è possibile modulare il contenuto del decreto ministeriale in ragione delle esigenze riscontrate nel
caso concreto ma che necessariamente sono imposte
tutte le limitazione indicate, le quali, dunque, sono ritenute tutte presuntivamente necessarie, eliminando ogni
possibile spazio discrezionale.
Per quanto concerne le singole limitazioni elencate nel
comma in esame, occorre rilevare che si tratta delle
stesse che già caratterizzavano i decreti ministeriali
nella vigenza del vecchio co. 2 dell’art. 41 bis o.p. e che
sono dirette ad incidere su due fronti: quello dei rapporti con il mondo esterno e quello relativo alla vita intramuraria, determinando un ulteriore inasprimento del
regime a seguito dell’intervento legislativo del 2009.
Per quanto concerne il primo versante la sospensione
incide sui colloqui con i terzi che sono esclusi, salvo
casi eccezionali determinati di volta in volta dal direttore (o dall’A.G. procedente per gli imputati), nonché
sui colloqui con i familiari ridotti ora ad uno solo mensile e da svolgersi in locali muniti di vetri divisori e di
citofoni, onde evitare il passaggio di oggetti.
I colloqui inoltre possono essere sottoposti a controllo
auditivo e a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’A.G. competente, diversamente dunque da
quanto previsto dal regime ordinario che all’art. 18 o.p.
consente il controllo a vista non auditivo.
La sospensione incide, altresì, sulla corrispondenza
telefonica che, tuttavia, può essere autorizzata nella
misura di una telefonata mensile solo nei confronti di
coloro che non effettuano colloqui, purché siano decorsi sei mesi dall’applicazione del 41 bis ed è comunque
Temi Romana
sempre sottoposta a registrazione.
La volontà di inasprire il regime e soprattutto di rendere ancora più duro l’isolamento di tali soggetti non ha
risparmiato neppure i contatti con il difensore.
Infatti, tali colloqui sono stati ridotti al numero massimo di tre alla settimana, sia che si tratti di colloqui
diretti o di conversazioni telefoniche che avranno la
stessa durata di quelli con i familiari. Parimenti volta
ad incidere sui rapporti con il mondo esterno è la disposizione di cui alla lett. e del comma in esame che consente il visto di censura sulla corrispondenza, fatta
salva quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di
giustizia.
Pur non contenendo alcun riferimento all’intervento
autorizzativo dell’A.G. si deve ritenere che la prescrizione di tale lettera abbia efficacia solo a patto che
intervenga l’autorizzazione al visto di controllo da
parte dell’A.G. competente.
Per quanto concerne le attività che strettamente afferiscono alla vita in carcere è prevista nella lett. d del co.
2 quater l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti
e degli internati e nella lettera f la permanenza all’aria
aperta ridotta, a seguito dell’intervento del 2009, da
quattro a due ore e in gruppi che non possono essere
composti da più di quattro persone.
Si pone, nella prospettiva di incidere sulla vita interna
all’istituto e nel contempo indirettamente sui contatti
con il mondo esterno, la prescrizione della lett. c volta
a limitare le somme, i beni e gli oggetti che possono
essere ricevuti dall’esterno e, non anche inviati, al fine
di garantire esigenze di ordine e sicurezza atte ad impedire illecite comunicazioni all’interno e all’esterno dell’istituto.
Si noti che, mentre nei decreti ministeriali applicativi
del regime differenziato antecedenti alla legge
279/2002, si poneva un divieto assoluto di invio e di
ricezione di somme, nella lett. c in esame è prevista la
possibilità di imporre limitazioni la cui entità è lasciata
alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria.
La lettera a del co. 2 quater in esame afferma che le
misure di elevata sicurezza interna ed esterna adottate
sono finalizzate a prevenire contatti con l’organizzazione di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti
con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla mede-
9
Saggi
sima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate.
Si tratta, dunque, di misure di difficile individuazione
certamente volte ad ampliare la gamma, peraltro già
assai ampia, degli interventi limitativi ad opera dell’amministrazione penitenziaria.
Il secondo comma dell’art. 41 bis o.p. rappresenta, dunque, uno strumento di politica criminale volto a neutralizzare la pericolosità sociale di taluni detenuti e a indurre scelte di rottura con l’organizzazione di appartenenza
senza con ciò incidere sugli istituti trattamentali.
Le differenziazioni sopra esposte, infatti, non dovranno
mai implicare disparità nel concreto esercizio dei diritti, nella fruizione delle opportunità trattamentali offerte dall’o.p., né tantomeno nell’osservanza dei doveri
dei detenuti, essendo connesse solo a garantire nei confronti degli interessati un livello superiore di sicurezza.
Invero, le attività del trattamento penitenziario devono
comunque essere consentite nel rispetto delle finalità
rieducative della pena, mantenendo però un atteggiamento di osservazione dei fenomeni che consenta di
valutare possibili strumentalizzazioni di attività legittime per fini illeciti. È noto, infatti, che operare con
atteggiamento burocratico nei confronti di soggetti
organizzati e che operano utilizzando precise strategie
comportamentali, aumenta il rischio di deviazioni dalle
finalità istituzionali.
È necessario, pertanto, controllare che il trattamento
consegua correttamente il suo scopo ed impedire che lo
stato detentivo dei soggetti in questione invece che
configurarsi quale ostacolo all’ulteriore delinquere ne
costituisca il veicolo o faciliti l’incontro di personalità
e alleanze.
10
Temi Romana
Saggi
La duttilità della fase cautelare: intrecci, compressione,
ampliamento e conversione in altri riti. Alla ricerca della
fase di merito nella costellazione dei segmenti cautelari
Maria Vittoria Lumetti
Avvocato dello Stato dell’Avvocatura Generale
SOMMARIO: 1. Gli intrecci cautelari. Il processo cautelare e i suoi segmenti processuali o microgiudizi cautelari –
2. La conversione dell’incidente cautelare in decisione sul merito: dal rito cautelare al rito immediato –
3. Compressione o ampliamento della fase cautelare – 4. Rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di merito; la
accentuata connessione tra fase della cautela e fase di merito prevista dal c.p.a; l’Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato n. 917/2011 – 5. Il deficit culturale della fase di merito: sua eventualità e sviluppo sostenibile – 6.
L’anticipazione della soglia di tutela: merito come “appello domestico”? – 7. La bulla aurea del processo cautelare: declino della fase di merito… – 8. …o declino della fase cautelare? – 9. La rivincita dell’udienza di merito:
la conversione della fase cautelare nella fase di merito e il corto circuito cautelare – 10. Il nuovo codice e l’abbondanza delle corsie acceleratorie – 11. La tutela cautelare come momento unificante – 12. Il grande processo
cautelare – 13. Il processo amministrativo è il processo cautelare?
1.
Gli intrecci cautelari. Il processo cautelare e
i suoi segmenti processuali o microgiudizi
cautelari
Il meccanismo tipico del rito cautelare viene utilizzato
in altre tipologie processuali come una sorta di rito
passe-partout per risolvere problemi altrimenti di difficile soluzione.
Il rito del processo cautelare è il modello di riferimento, seppure con qualche variante, anche dei riti camerali speciali. Questi ultimi, che si sviluppano in microsegmenti cautelari, privilegiano, senza alcuna distorsione
prospettica, l’obiettivo di velocizzare la definizione di
giudizi il cui esito si pone in rapporto di strumentalità
e di accessorietà con eventuali processi pendenti o successive azioni giurisdizionali. Il processo cautelare è
ormai costituito da segmenti cautelari, microgiudizi,
miniprocedimenti: si profila una cautela caratterizzata
da tanti innesti.
Oltre che nel giudizio contro il silenzio (art. 117 c.p.a.),
la legge prevede lo schema del giudizio cautelare nella
fase di esecuzione delle pronunce cautelari (art. 114 co
5 c.p.a.), nel rito dell’accesso (art. 116 c.p.a.)1 e anche
nell’ipotesi di regolamento preventivo di competenza
da parte del Consiglio di Stato (art. 15 comma 3). Il
principio è stato codificato in via generalizzata dall’art.
Temi Romana
87 c.p.a. comma 2, il quale espressamente dispone che
“oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano
in camera di consiglio i giudizi cautelari, quelli relativi
all’esecuzione delle misure cautelari collegiali, il giudizio in materia di silenzio, di accesso ai documenti
amministrativi, di ottemperanza, di opposizione ai
decreti che pronunciano l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio”.
È evidente l’intento del legislatore di imporre, per particolari materie, che i ricorsi concernenti pretese lesioni di posizioni giuridiche dei singoli debbano essere
decisi dal giudice amministrativo entro tempi brevissimi, che si configurano come del tutto incompatibili con
quelli tipici della procedura ordinaria2. Si è parlato
anche di rito camerale accelerato e deformalizzato3 non
tanto per la previsione, in alcuni casi, di un termine
massimo per la pronuncia, ma per il rito processuale,
che è quello proprio del rito camerale ordinario.
Abbiamo visto che nel processo cautelare sono prospettabili vari innesti: l’innesto del giudizio immediato nel
processo cautelare e abbreviato, l’innesto della tutela
ante causam e della tutela monocratica in quella collegiale, l’innesto della tutela ante causam nel giudizio
immediato e abbreviato. È innegabile che siamo passati
dal procedimento cautelare ai procedimenti cautelari.
11
Saggi
2. La conversione dell’incidente cautelare in decisione sul merito: dal rito cautelare al rito immediato
Come è stato esaminato è possibile anche l’innesto del
giudizio immediato nel processo cautelare e abbreviato.
La conversione del rito cautelare in rito immediato4 si
verifica in quattro ipotesi: nel caso dell’artt. 60 che
regola il giudizio immediato in generale, dell’art. 74,
riguardante i casi speciali di giudizio immediato, applicabile solo in determinati casi previsti dalla legge
(manifesta fondatezza, irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso), nell’ambito del giudizio abbreviato (art. 119 comma 3) ed ancora del giudizio abbreviato speciale (art. 120 comma 6).
Entrambe le disposizioni di cui agli artt. 119 comma 3
e 120 comma 6 rinviano all’art. 60 e alla disciplina ivi
contenuta, che è quella relativa al rito immediato.
La conversione dell’incidente cautelare in decisione sul
merito della controversia può verificarsi anche senza il
passaggio attraverso il rito immediato.
L’art. 55 comma 10 infatti, introducendo una forma di
tutela intermedia, elimina la fase cautelare in presenza
di determinati presupposti individuati dal giudice.
Lo stesso accade nel caso dell’art. 71 comma 5 che
consente la fissazione “di un merito a breve” in cambio
della rinuncia della parte al cautelare o dell’art. 72, che
legittima il giudice ad obliterare la fase cautelare e di
fissare con priorità l’udienza di merito in presenza di
ricorsi vertenti su un’unica questione.
Lo strumento della conversione della fase cautelare o,
il che è lo stesso, della sua eliminazione, costituisce un
importante mezzo di accelerazione del processo amministrativo e indica uno sfavor legislativo nei confronti
della tutela cautelare stessa, in quanto la spinta innovativa è ormai tutta proiettata verso il processo di merito
e, in ogni caso, in direzione dell’esecuzione coattiva
della pronunzia della sentenza di primo grado, che è
emanata sulla base di una cognizione piena.
La norma si pone in linea con la nuova formulazione
dell’art. 111 della Costituzione che afferma il principio
del rispetto del giusto processo, nonché del 1° comma
dell’art. 117 Costituzione, come novellato con la legge
costituzionale 12 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), che impone
una interpretazione conforme anche ai vincoli ed agli
obblighi internazionali.
3. Compressione o ampliamento della fase cautelare
La duttilità della fase cautelare si ravvisa non solo nella
sua attitudine alla conversione in altri riti, ma anche
nella sua compressione o nel suo ampliamento, a
seconda dei casi.
Come si è detto il congegno regolato dall’art. 199
comma 3 c.p.a. provoca una compressione della tutelare cautelare che non decolla, ma si prepara a convertire in giudizio di merito, pur sussistendo i presupposti
per poterla prendere in esame. Si tratta di una fase cautelare “finta”, che tuttavia si amplia in un’altra direzione: nella dilatazione della fase istruttoria, che diventa
piena, come nel giudizio di merito, proprio perché il
processo sta mutando, attraverso una metamorfosi che
sfocerà nel vero e proprio giudizio di merito. Nel caso
del rito abbreviato speciale questo non avviene e,
fermo restando la conversione in rito immediato ai
sensi dell’art. 60, il giudice può comunque adottare le
misure cautelari, qualora ravvisi i presupposti ordinari
del fumus e del periculum.
Ma anche in questo caso, la fase cautelare, che non è
più finta, si amplia: l’art. 120 comma 8 dispone che il
giudice, proprio in quella fase, possa ordinare adempimenti istruttori e concedere termini a difesa
La norma sembra voler indicare che anche in questo
caso trattasi di fase cautelare anomala, comunque proiettata verso il giudizio di merito, che anzi viene addirittura anticipato in parte nella fase cautelare stessa.
Può accadere che il giudice non ritenga di disporre
alcuna misura cautelare e, anche in tal caso, assistiamo
ad una curiosa conversione della fase cautelare in fase
di merito.
È la prova evidente che l’allocazione incidentale del
procedimento cautelare non va necessariamente a scapito dell’efficienza della tutela, e questo grazie alla duttilità dello strumento cautelare.
4. Rapporti tra giudizio cautelare e giudizio di
merito; la accentuata connessione tra fase della
cautela e fase di merito prevista dal c.p.a.;
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.
917/2011
La riforma apportata dal c.p.a. alla struttura della tutela cautelare e che ne ha ampliato la portata, incide sulle
misure che tutelano la fruttuosità dell’azione di merito5.
L’art. 55 comma 4 evidenzia il carattere accessorio
12
Temi Romana
Saggi
della tutela d’urgenza rispetto al giudizio di merito,
prevedendo l’improcedibilità della domanda cautelare
fino a quando non viene presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, a meno che quest’ultima non
debba essere fissata d’ufficio6.
La stessa legge 205 del 2000 aveva attribuito al giudice
amministrativo il potere di adottare “le misure cautelari... che appaiano, secondo le circostanze più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso” (art. 21 comma 8 della L. 6.12.1971 n. 1034 così
come sostituito dall’art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205).
La misura cautelare atipica delineata dal legislatore del
2000 e confermata dal codice appare più idonea della
mera sospensiva dell’atto impugnato a tutelare soprattutto gli interessi pretensivi. Si riconosce, di fatto,
all’autorità giudiziaria, la possibilità di emettere ordinanze non solo di natura propulsiva, ordinando alla
P.A. di provvedere nuovamente, fatto salvo l’esito definitivo del processo, ma anche di natura decisoria,
mediante l’adozione di un nuovo provvedimento emesso direttamente dal giudice in provvisoria sostituzione
dell’atto impugnato, sino alla definizione del merito
della causa.
Le aperture della giurisprudenza prima delle ultime
riforme volte a riconoscere la possibilità di ricorrere
alla “sospensiva” anche avverso i provvedimenti negativi, pur se condizionate dalla necessità che il giudice
non utilizzi i poteri esclusivi della P.A., hanno sicuramente influenzato il legislatore7. La disposizione di cui
all’art. 55 comma 4 mira a contemperare l’esigenza
della rapida definizione del giudizio con quella della
salvaguardia del diritto alla difesa. Tale fine viene perseguito mediante l’attribuzione al giudice cautelare del
potere di emettere una decisione immediata nel merito,
previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, estendendo così alla generalità
delle controversie la disciplina finora prevista solo per
le cause in materia di aggiudicazione di appalti di opere
pubbliche9.
La norma dispone anche che in caso di estrema gravità
ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
sino alla data della camera di consiglio, l’autorità giudiziaria possa, su domanda di parte ed anche inaudita
altera parte, disporre misure provvisorie, efficaci fino
alla pronuncia cautelare del collegio, cui la questione è
sottoposta alla prima camera di consiglio utile. Si trat-
Temi Romana
ta della c.d. tutela cautelare anticipata, disciplinata ora
dall’art. 56 del c.p.c. e precedentemente regolata dall’art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205 abr. che a sua volta
sostituiva l’originario settimo comma dell’art. 21, L.
6.12.1971, n. 1034. E ancora, nel caso in cui l’amministrazione non dia ottemperanza alle misure cautelari,
l’art. 59 del c.p.a. attribuisce al Tribunale che ha concesso la misura cautelare il potere di disporre le misure
attuative, con la potestà estesa al merito propria del
giudice dell’ottemperanza, dettando gli opportuni provvedimenti attuativi e le modalità10.
Inoltre, l’art. 62 del c.p.a. riduce notevolmente i termini rispetto alla normativa precedente: i termini per proporre l’appello cautelare sono di 30 giorni dalla notificazione e 60 giorni dalla pubblicazione della ordinanza
cautelare.
Nei casi in cui dall’esecuzione della misura cautelare
possano derivare effetti irreversibili, il giudice può
subordinare l’efficacia della misura cautelare concessa
alla prestazione di una cauzione, peraltro esclusa qualora l’istanza riguardi interessi essenziali della persona,
quali il diritto alla salute, all’integrità dell’ambiente
ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
L’accoglimento della domanda cautelare presuppone,
secondo i principi della disciplina processualistica, un
giudizio sulla sussistenza del fumus bonis iuris e del
periculum in mora. Quanto al primo elemento, è necessario sottolineare come in seguito alla riforma esso
abbia assunto una rilevanza ben maggiore del periculum in mora. La riforma, infatti, impone al giudice cautelare di pronunciarsi sulla base della “ragionevole”
previsione dell’esito del ricorso.
Pertanto, il giudizio sulla sussistenza dell’elemento non
ha ad oggetto l’approssimativa verosimiglianza dell’esistenza del diritto ma, di fatto, rappresenta l’anticipazione del giudizio di merito. Da questo mutato quadro normativo, decisione cautelare e decisione di merito risultano intimamente collegate, tanto che la nuova
legge impone all’autorità giudiziaria cautelare non più
un obbligo generico di motivazione, come si limitava a
fare la disciplina previgente, ma prevede la descrizione
dell’iter logico che ha portato alla decisione11.
I presupposti della pronuncia cautelare sono differenti
da quelli della decisione di merito: se il pericolo attuale di un pregiudizio grave e irreparabile, a fronte di un
danno presuntivamente ritenuto sempre rimediabile
13
Saggi
non sia ritenuto sussistente, il giudice cautelare non
può affrontare l’esame dei profili di merito della causa.
Se risulta invece ravvisabile, l’esame del merito deve
essere limitato alla parvenza di fondatezza del ricorso.
Al contrario, il giudice del merito deve esaminare le
censure per acquisire la prova piena della loro fondatezza: anche l’evidenza del fumus non ha nulla a che
vedere con quella della fondatezza della controversia.
La connessione tra fase della cautela e fase di merito si
riscontra anche nella possibilità da parte del TAR o del
Consiglio di Stato, in sede cautelare, di fissare l’ordinanza collegiale e la data di discussione del ricorso nel
merito (art. 55 comma 10 c.p.a.) in caso di accoglimento del ricorso in sede cautelare (art. 55 comma 11 c.p.c.
e art. 3 L. 205/2000 abr.). L’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato n. 917/2011 ha evidenziato e accentuato la connessione tra fase cautelare e fase di merito
prendendo atto che, in presenza di un orientamento non
omogeneo circa l’interpretazione di norme di legge,
anche tenendo conto della natura cautelare del provvedimento appellato, è necessario attendere che l’esame
dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di
merito, dinanzi al giudice di primo grado12.
Tale pronuncia potrebbe essere considerata sintomo
della non utilità del processo cautelare nella trattazione
di determinate questioni complesse e di notevole difficoltà interpretativa, che possono essere approfondite,
per quanto attiene all’esame dei profili di diritto, solo
in sede di merito. La Corte Costituzionale ha, da
tempo, proprio in riferimento alla giurisdizione amministrativa calibrata essenzialmente sull’annullamento
degli atti illegittimi, posto in luce il carattere essenziale della procedura cautelare e l’intima compenetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando
illegittima l’esclusione o la limitazione del potere cautelare di determinate categorie di atti amministrativi o
al tipo di vizio denunciato (sentenze n. 227 del 1975 e
n. 284 del 1974)13.
Il raccordo rapido tra fase cautelare e fase di merito è
favorito anche dall’art. 55 comma 12 c.p.a. che, recependo una prassi già in uso presso i TAR, dispone che
in sede di esame della domanda cautelare il collegio
possa adottare, su istanza di parte, i procedimenti
necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria
e l’integrità del contraddittorio.
Quanto al processo civile è noto che la tutela cautelare
è da considerarsi distinta dalla tutela cognitiva ed esecutiva in quanto non ha funzione autonoma ma strumentale: si è precisato tuttavia che la strumentalità
della tutela ordinaria rispetto al giudizio ordinario non
ne esclude l’autonomia14.
5. Il deficit culturale della fase di merito: sua eventualità e sviluppo sostenibile
L’art. 21, comma 8 della legge n. 1034 del 1971, ora
abrogato dal codice, attribuiva valore di diritto positivo
al principio di strumentalità della misura cautelare che
la dottrina aveva individuato come carattere ontologico
di tali rimedi processuali15.
L’art. 55 comma 10 del codice processuale introduce
una novità: la possibilità da parte del TAR o del
Consiglio di Stato, in sede cautelare, di fissare con
ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso
nel merito. Il presupposto di tale concessione è che le
esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito. L’art. 55 comma 10
c.p.a. che, come abbiamo visto, introduce la possibilità
da parte del TAR o del Consiglio di Stato, in sede cautelare, di fissare con ordinanza collegiale la data di
discussione del ricorso nel merito, potrebbe indurre a
ritenere che in questi casi i presupposti per la richiesta
cautelare non sussistano.
Stessa cosa potrebbe ritenersi riguardo al comma 11 del
medesimo articolo 55, il quale prevede che l’ordinanza
con cui è disposta una misura cautelare fissi anche la
data di discussione del ricorso nel merito.
Un intervento normativo di qualche anno fa ha mutato
i termini della questione anche nel processo cautelare
civile. L’art. 669 octies comma 6 dispone che “Le
disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell’art. 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice
civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti
emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno
temuto ai sensi dell’art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”.
Il comma è stato aggiunto dall’art. 23, lett. e bis, n. 2.3,
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni,
dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. La modifica legislativa
14
Temi Romana
Saggi
suale e non anche sotto il profilo sostanziale: non produce utilità finali diverse e comunque disomogenee da
quelle che la decisione di merito può procurare alla
parte22. Laddove il provvedimento anticipatorio fosse
materialmente e totalmente satisfattivo delle pretese
vantate dall’istante, il giudizio di merito costituirebbe
nulla più che una sorta di ripetizione, se non di duplicazione della fase già svolta, con evidente spreco di
economia processuale23.
Può tuttavia accadere che l’ampliamento della tipologia delle misure d’urgenza, determinato come abbiamo
detto, dalla lunga elaborazione giurisprudenziale e
volto a garantire la satisfattività della sentenza, releghi
talora la fase di merito a un ruolo di vero e proprio
“appello domestico”.
Da un ruolo di supplente, il rito cautelare ha acquisito
non solo un ruolo integrativo e creativo delle disposizioni di legge, ma si è sviluppato al punto da far retrocedere, in molto casi, la parte principale del processo a
una fase di mero controllo dell’operato del giudice cautelare.
dell’art. 669 octies c.p.c. ha reso meramente eventuale
la fase di merito: le disposizioni relative alla prosecuzione nel merito del procedimento cautelare definito
con ordinanza non si applicano ai provvedimenti d’urgenza emessi ex art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito nonché ai provvedimenti emessi a seguito
di nuova opera e di danno temuto ex art. 688 c.p.c.16.
Ne consegue che solo nei casi di sequestri e procedimenti cautelari previsti da leggi speciali si richiede la
verifica della natura anticipatoria o conservativa del
provvedimento.
Ma la stessa giurisprudenza aveva individuato nella
struttura bifasica del procedimento possessorio una
ragione non ostativa alla concentrazione delle due fasi
allorché gli elementi raccolti nella fase a cognizione
sommaria consentano al giudice di definire la causa
con un provvedimento unico che, in quanto conclusivo
dell’intero procedimento, abbia natura di sentenza17. Il
termine per l’inizio del giudizio di merito dopo la concessione del provvedimento cautelare ai sensi dell’art.
669 octies c.p.c. decorre dalla comunicazione di cancelleria dell’avvenuto deposito del provvedimento cautelare18. Prima della riforma si insisteva sulla natura
interinale e strumentale del provvedimento d’urgenza19,
ora la dottrina processualcivilistica pone l’accento sulla
attenuazione del nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e la sua necessaria correlazione con un
provvedimento principale, chiedendosi se non si debba
ora parlare di autonomia ed esaustività del procedimento cautelare20. Di conseguenza ci si chiede se i provvedimenti di cui al 6° comma dell’art. 669 octies siano
ancora da qualificare come cautelari, o invece da inserire in una diversa categoria di provvedimenti decisori
sommari di cognizione a contenuto anticipatorio21.
Il dibattito ha avuto ripercussioni anche nel diritto processuale amministrativo a proposito della sentenza succintamente motivata: la strumentalità della misura cautelare non pregiudica infatti l’autonomia della fase
d’urgenza da quella di merito.
7. La bulla aurea del processo cautelare: declino
della fase di merito...
Sorge il dubbio che il trascinamento della fase di merito in quella cautelare comporti una inversione cronologico-temporale degli eventi processuali. Ormai la sensazione è che la fase di merito sia un mero contenitore
dove va a confluire la pregressa attività cautelare,
ormai “finta” forma di tutela ancillare24.
La dilatazione della fase cautelare è stata nel tempo alimentata dalla lentezza della fase di merito, che ora
viene annientata, spazzata via quasi come per una sorta
di “nemesi”, dalla irruenza strabordante della fase cautelare. Il “paziente malato” si è trasformato in una vittima dei correttivi adottati per limitare o arginarne la
eccessiva lunghezza dei tempi di definizione della
causa. Orbene, visto e considerato che la sempre maggiore importanza della tutela cautelare è stata originata
come stampella della languente fase di merito, come
mezzo di fortuna insomma, forse è il caso di ristabilire
un po’ di ordine e riconoscere che il rappezzo del cautelare si è talmente trasformato sì da raggiungere una
compiutezza tale da rendere inutile e non più necessaria la fase di merito.
Eliminare qualche corsia acceleratoria potrebbe resti-
6. L’anticipazione della soglia di tutela: merito
come “appello domestico”?
Nel processo amministrativo il giudizio cautelare, che
ha carattere strumentale rispetto al giudizio di merito, è
autonomo da quest’ultimo solo sotto l’aspetto proces-
Temi Romana
15
Saggi
tuire la dignità perduta a un processo che da sempre ha
dovuto fare i conti con l’arretrato, anche a causa del
radicamento di contenziosi talora temerari e al proliferare inutile di parecchi altri proposti al solo fine di mettere alle strette l’amministrazione o nella speranza di
ottenere una “sospensiva” (tanto poi il merito arriva
dopo anni e anni…), quasi come fosse una sorta di lotteria, di ruota della fortuna.
La fase ancillare, servente, diventa centrale fondamentale e definitiva e determina la decentralizzazione del
processo amministrativo. In dottrina si invoca infatti la
dovuta cautela nell’elaborazione di concetti che
rischiano di modificare il baricentro della giustizia
amministrativa. Determinate teorie possono infatti
creare confusione a causa del rimescolamento di competenze e di funzioni cui possono dar luogo25.
“La fase cautelare diventa il centro del giudizio, quale
momento ravvicinato di delibazione della fondatezza
della domanda” e la “centralità della tutela cautelare la
si rinviene all’interno del giudizio di merito26.
Si ravvisa una svalutazione del requisito del periculum
in mora in vantaggio di una più attenta disamina del
fumus che coinvolge la valutazione da parte del giudice della loro rilevanza reciproca dei caratteri dell’attività lesiva posta in essere dal ricorrente e contestata dal
ricorrente.
Il processo interviene pur sempre su una vicenda sostanziale di esercizio del potere e che, in quanto tale, non è
statica, ma deve essere portata a compimento, poiché la
cura dell’interesse pubblico non può arrestarsi: ma allora anche da questo punto di vista, come emerge dalle
norme esaminate, la fase cautelare diventa il centro del
giudizio quale momento ravvicinato di delibazione
della fondatezza della domanda.
Oramai è inconfutabile la capacità della tutela cautelare, nell’esperienza del processo amministrativo, di offrire strumenti di tutela particolarmente completi e dunque
effettivi.
La valorizzazione della probabile fondatezza del ricorso induce a domandarsi se il giudizio in questione sia
ancora un giudizio cautelare oppure sia l’anello di congiunzione tra la fase cautelare e il merito: una sorta di
fase preliminare, in quanto sono assenti provvedimenti
cautelari, ma anticipatoria della futura sentenza31.
Come già osservato, non vi è alcun dubbio che il legislatore del codice abbia manifestato un favor per l’immediata definizione del merito della controversia.
Diversi sono i dati normativi che è possibile richiamare a conferma di tale assunto: può farsi riferimento alla
previsione che impone, in caso di concessione della
misura cautelare, la doverosa fissazione con carattere
di priorità della data di trattazione del ricorso nel merito o a quella che generalizza un meccanismo di conversione della decisione sull’istanza cautelare in decisione
intesa a definire il merito della vicenda processuale
(prima contemplato, ancorché con non indifferenti differenze di disciplina, nel settore degli appalti dall’art.
19, D.L. n. 67/97)32. Qualche perplessità viene espressa
in dottrina anche in ordine al particolare profilo del
carattere strumentale del giudizio cautelare relativo ai
rapporti tra ordinanza cautelare e decisione di merito33.
Una volta indicati i profili di accoglimento o di rigetto
della chiesta misura cautelare, appare difficile che il
giudizio espresso in quella sede possa essere disatteso
nella fase di decisione di merito, nonostante la norma
nulla dica a tal proposito. Sino ad ora, dottrina e giuri-
8. …o declino della fase cautelare?
Non tutta la dottrina è concorde nel ritenere così pregnante la metamorfosi o quantomeno la trasformazione
del rito cautelare nonché la sua conversione in giudizio
di merito27.
Ma altra parte della dottrina è convinta che ci sia
comunque una trasformazione da cogliere nella sempre
più rilevante funzione di raccordo che la fase cautelare
esercita (percepibile soprattutto nel rito abbreviato)28, o
in ogni caso un sensibile riavvicinamento tra le fasi
processuali29.
Solo in caso di pregiudizio particolarmente qualificato
da estrema gravità e urgenza il collegio può disporre
misure cautelari. Ma allora è il tasso di gravità e urgenza a orientare il giudice nella scelta della concessione o
meno della misura cautelare: un tasso medio non giustifica l’accoglimento della domanda cautelare, tenuto
conto della brevità del termine entro il quale il ricorso
può essere definito nel merito30.
Ormai l’ordinanza non interviene dopo una significativa delibazione del ricorso principale, tenuto conto
anche della delibazione non propriamente sommaria
che caratterizza l’esame della domanda cautelare avanti il collegio e appare altresì difficilmente ribaltabile nel
merito.
16
Temi Romana
Saggi
sprudenza, hanno ritenuto ininfluente il giudizio
espresso in sede cautelare rispetto a quello finale34.
Una evoluzione legislativa da un lato, e giurisprudenziale dall’altro, è tuttavia in corso, e tende ad avvicinare gli opposti sistemi. Nell’ordinamento processuale in
generale abbiamo riscontrato la tendenza dei recenti
interventi normativi a rendere autonomo il provvedimento d’urgenza dalla causa di merito, dichiarando
inapplicabili ad esso le norme (artt. 669 octies e 669
novies) che ne sanciscono la caducazione in caso di
mancata instaurazione della causa in un termine perentorio. E in più occasioni parte della dottrina ha affermato che, in via di principio, l’art. 669 quaterdecies, c.p.c.
si estende sino a ricomprendere il processo cautelare
amministrativo35.
In virtù di tale norma si applicherebbero le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 669 bis a 669 terdecies i quali, dettando la nuova disciplina unitaria od
uniforme dei procedimenti cautelari in generali, si
estenderebbero anche, in quanto compatibili, agli altri
provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e
dalle leggi speciali36.
solo eventuale costituendo essa una eccezione: l’art.
119 comma 4 la subordina alla presenza di un periculum particolarmente qualificato (l’estrema gravità e
urgenza). Nel caso del giudizio abbreviato speciale
invece tale limitazione all’operatività della tutela cautelare non sussiste, in quanto il giudice può disporla
qualora ravvisi il fumus e il danno grave e irreparabile:
tale congegno rimane tuttavia eventuale, ben potendo il
giudice fissare direttamente l’udienza di merito ai sensi
dell’art. 119 comma 3 o fissare immediatamente d’ufficio con assoluta priorità37.
10. Il nuovo codice e l’abbondanza delle corsie acceleratorie
Non si può negare l’attuale sovrabbondanza di corsie
acceleratorie che catterizza la definizione del giudizio
amministrativo e che consente la predisposizione di
una cautela preprocessuale ed endoprocessuale.
Ci troviamo di fronte alla particolarità di una tutela
cautelare fruibile più di una volta, di provvedimento
cautelare servente una seguente fase cautelare che, a
sua volta, è servente di una fase a cognizione piena, ove
le misure cautelari provvisorie sono destinate ad avere
efficacia sino alla decisione sul ricorso principale, e il
decreto monocratico è destinato a durare fino all’eventuale adozione delle misure cautelari adottate con contraddittorio, in una sorta di cautela strumentale alla
cautela strumentale al merito38.
Se si pensa che la finalità è quella di ovviare al ritardo
con cui l’udienza di merito viene celebrata e che sussiste la concreta possibilità che in sede cautelare ordinaria il giudizio possa essere definito con una sentenza
“breve”, può accadere che risultino superflue tali corsie
acceleratorie che, oltre ad appesantire il processo, lo
rendono talora oltremodo complesso.
È evidente l’intento del legislatore di imporre, per particolari materie, che i ricorsi concernenti pretese lesioni di posizioni giuridiche dei singoli vengano decisi dal
giudice amministrativo entro tempi brevissimi, che si
configurano del tutto incompatibili con quelli tipici
della procedura ordinaria.
Peraltro, se il dato normativo non viene applicato alla
lettera, il rischio che si corre è che si realizzi una duplicazione della tutela cautelare nel processo amministrativo: da una fase precautelare a una fase cautelare, con
il profilarsi di un doppione a volte inutile.
9. La rivincita dell’udienza di merito: la conversione della fase cautelare nella fase di merito e il
corto circuito cautelare
Non sempre tutto ciò che avviene nella fase cautelare
condiziona il merito e la sua stessa esistenza.
Vi sono casi in cui accade il contrario e in cui la ghigliottina normativa investe la fase cautelare.
Il codice processuale disciplina non solo ipotesi di conversione della fase cautelare già previste e regolate
dalla pregressa disciplina, ma ne introduce altre. La
spinta propulsiva del legislatore è volta in tali casi a
consentire e, anzi, agevolare la compresione o di saltare la fase cautelare.
Come abbiamo esaminato, la tecnica adottata è quella
della conversione dell’udienza cautelare in udienza di
merito o nel rito immediato, per giungere direttamente
al merito, minimizzando la cautela a favore di una più
compiuta analisi nella fase successiva.
La conversione dell’udienza cautelare in giudizio di
merito rimane tuttavia circoscritta allo speciale rito
abbreviato. In sintesi, si ravvisano due casi previsti e
regolati dall’art. 119 comma 3 e 120 comma 8 c.p.a.
Nel giudizio abbreviato ordinario la fase cautelare è
Temi Romana
17
Saggi
Si pensi anche alla circostanza che possano sopravvenire in sequenza, nella sola fase cautelare: provvedimento
dell’Amministrazione, pronuncia cautelare del giudice
di prime cure, esecuzione dell’Amministrazione, nel
caso a seguito di nuovo intervento del giudice cautelare, quale giudice dell’esecuzione, pronuncia cautelare di
secondo grado e nuovo provvedimento dell’Amministrazione.
È ben possibile, inoltre, che si creino sovrapposizioni
di pronunce giudiziali rese nel corso di separati, e pur
tuttavia connessi, procedimenti amministrativi e/o giudiziari, ad esempio in riferimento al controinteressato
pretermesso39.
Non si configura più un solo modello di processo
amministrativo di cognizione, a struttura prevalentemente monofasica, bensì tanti processi, speciali e differenti a secondo della materia da trattare, con diversi termini processuali e, spesso, interamente celebrati in
camera di consiglio, che tendono a loro volta a divenire micro-sistemi, contrapposti al rito c.d. ordinario.
Tali corsie acceleratorie non dovrebbero attentare alla
unitarietà del processo amministrativo, che conserva la
semplicità e la linearità che dai suoi albori lo caratterizza, soprattutto ora che la disciplina è stata riordinata in
un codice.
È stato osservato che la concessione del decreto cautelare provvisorio potrebbe avere una qualche utilità
nel periodo feriale, in cui le camere di consiglio sono
limitate.
A ciò si aggiunga che esistono ormai tante regole diverse in base al settore cui la domanda di giustizia inerisce. Anche se il processo amministrativo è regolato dal
principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo
esclusivamente interessi privati, ma devono trovare
composizione e soddisfazione anche interessi pubblici.
La misura cautelare reca in sé delle enormi potenzialità. Ma tali potenzialità richiedono di non travalicare i
limiti da osservare al fine di non provocare “strappi” al
potere processuale assegnato dalla legge.
Il processo amministrativo ricorda quello penale in cui,
la previsione di riti alternativi alla fase dibattimentale,
hanno fatto retrocedere quest’ultima a un ruolo almeno
statisticamente meno rilevante.
utilizzato, seppure con qualche variante, anche nei riti
camerali speciali. Questi ultimi privilegiano l’obiettivo
di velocizzare le definizione di giudizi il cui esito si
pone in rapporto di strumentalità e di accessorietà con
eventuali processi pendenti o successive azioni giurisdizionali. Il meccanismo tipico di questo riti accelerati viene utilizzato in altri tipi di processo come una
sorta di rito passe-partout per risolvere problemi altrimenti di difficile soluzione. Oltre che nel giudizio contro il silenzio, la legge lo prevede nella fase di esecuzione delle pronunce cautelari, nel rito dell’accesso.
La strumentalità sia strutturale sia funzionale era già
stata superata dal legislatore: la legge n. 205 del 2000
all’art. 21 faceva riferimento agli effetti interinali fino
alla pronuncia finale e agli effetti sostanziali.
L’autonomia cautelare è un danno da pericolo, diverso
dal merito e ci si chiede se la tutela cautelare stia oltrepassando il fronte della strumentalità. L’obiettivo principale è stato quello di semplificare il processo amministrativo ristrutturando in modo organico le norme
succedutesi nel tempo e garantendo efficienza, efficacia e legalità a questo particolare settore.
12. Il grande processo cautelare
Si va delineando un nuovo rito, un nuovo processo
scandito da momenti e da parentesi che nulla a che fare
hanno con la strutturazione originaria basata sulla netta
distinzione tra fase cautelare e di merito.
Oppure, il che è ancora più pregnante, si può parlare di
tutela cautelare come (piccolo) processo amministrativo breve, abbandonando la maschera ideologica di un
processo in cui il merito ha sempre avuto una legittimazione concettuale predominante: ora tutto ciò che
avviene nella fase cautelare condiziona il merito e la
sua stessa esistenza.
L’allievo insomma ha superato il maestro e il piccolo
processo si è proiettato verso una metamorfosi che, da
una posizione dapprima dominante, ha preso l’abbrivio, quasi per un moto inerziale, anche dopo la cessazione della sua spinta propulsiva, per la configurazione
di un nuovo processo amministrativo, che non è più né
fase della cautela né di merito o dove, il che è lo stesso, cautela e merito si confondono.
La sensazione è che il processo amministrativo sia
diventato nel corso degli anni “un grande processo cautelare”. Basti pensare all’ampliamento della fase istrut-
11. La tutela cautelare come momento unificante
Come abbiamo visto il rito del processo cautelare viene
18
Temi Romana
Saggi
toria cautelare che, oltre che ad essere previsto in taluni casi dal codice stesso (art. 119 comma 3), sta diventando prassi diffusa del giudice cautelare40.
Ma si rinvengono altri casi, non individuati legislativamente ma utilizzati dalla giurisprudenza, in cui la fase
cautelare viene utilizzata dal giudice per soddisfare
l’esigenza di una istruttoria compiuta e approfondita o
per attendere verifiche o la produzione di ulteriore
documentazione41.
Per non parlare, poi, delle varie tipologie di urgenza: il
«pregiudizio grave ed irreparabile» (art. 55), la «estrema
gravità ed urgenza» (art. 56), che legittima l’intervento
del Presidente, prima dell’udienza settimanale, la «eccezionale gravità ed urgenza» (art. 61), nel caso in cui non
vi sia nemmeno il tempo di presentare il ricorso.
Altra novità riguarda la possibilità per il TAR, in sede
cautelare, di fissare nell’ordinanza cautelare anche la
data di discussione nel merito, una volta valutato che le
esigenze del ricorrente siano apprezzabili e si possano
tutelare con una sollecita decisione di merito (art. 55
comma 10). Lo stesso può fare il Consiglio di Stato,
che nel riformare l’ordinanza cautelare di primo grado,
ritrasmette gli atti al TAR perché fissi in modo sollecito l’udienza (art. 55 comma 10, ult. cpv.). Tutto questo
ci delinea, probabilmente, un nuovo processo, un processo “unico” che passa attraverso la soppressione
della fase di merito ma anche della fase cautelare,
subendo entrambe le fasi una mutazione, laddove una è
servente dell’altra, a causa dell’attenuazione del carattere ancillare del rito cautelare. Tra compressioni,
metamorfosi, obliterazioni, definizioni per saltum si
delinea la nuova tutela cautelare: la sua centralizzazione determina un bilanciamento delle due fasi del pro-
cesso amministrativo. Fase cautelare al centro del giudizio di merito e del processo in genere. Ma a questo
punto esiste ancora la fase di merito?
O forse esiste ormai una nuova fase, un nuovo processo, che stravolge l’impostazione processuale originaria? È ormai una mera formalità la fase di merito?
13. Il processo amministrativo è il processo cautelare?
Le linee di fondo del processo cautelare possono essere sintetizzate in pochi assunti. In primo luogo, nel
rispetto del principio del contraddittorio, che è stato
riportato a cardine essenziale del procedimento, pur nel
necessario coordinamento con le esigenze dell’urgenza, coessenziali alla materia. In secondo luogo, nella
valorizzazione del carattere strumentale di questa
forma di tutela, colta come servente rispetto alla tutela
di merito. Infine, nell’introduzione di un regime di stabilità limitata per il provvedimento cautelare positivo e,
soprattutto, negativo. Evidenti sono i riferimenti al
modello cautelare civilistico. In alcuni casi l’ordinanza
interviene in procedimenti amministrativi ancora in itinere, come nel caso del giudizio di maturità di non
ammissione: nei fatti la decisione finale viene superata,
salta quindi la strumentalità strutturale. Nel processo
civile non si arriva a questi risultati.
È intervenuta una metamorfosi del processo cautelare e
amministrativo in generale42.
L’esorbitanza dei poteri cautelari incide sullo strumentario o strumento delle misure cautelari: c’è da
chiedersi se la fase cautelare al centro del giudizio di
merito e del processo in genere e la frantumazione
della tutela cautelare dia luogo alla inutilità della fase
di merito.
_________________
1 G. VIRGA, L’esecutività delle sentenze di
primo grado tra giudizio di ottemperanza e
tutela cautelare, in www. giust.it/corte/cortecost_1998-406.html.
2 N. SAITTA, I giudizi nella camera di consiglio nella giustizia amministrativa,
Milano 2003, p. 420.
3 S. MENCHINI, Processo amministrativo e
tutele giurisdizionali differenziate, in Dir.
Temi Romana
Proc. Amm, 1999, p. 971
4 Prima regolato dall’abr. art. 21, comma
decimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
5 In dottrina in precedenza era stata evidenziata la eccessiva discrasia tra il contenuto
dell’ordinanza e della sentenza di merito e
si ritengono positive le norme del codice
che hanno attutito tale divaricazione tra
processo cautelare e processo di merito, v.
19
sul punto M. SANINO, Codice del processo
amministrativo, Torino 2011, pp. 254-255.
6 E. PICOZZA, Il processo amministrativo,
Milano 2008, p. 103.
7 G. FERRARI, Il nuovo codice del processo
amministrativo, Roma 2010, p. 205.
8 Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 3080 del
23.5.2006.
9 Art. 26, quinto comma, legge n. 1034 del
Saggi
1971 nel testo novellato con la legge n. 205
del 2000.
10 In precedenza la materia era regolata
dall’art. 21, L. 6.12.1971 n. 1034 che ha
sostituito l’originario settimo comma per
effetto di quanto disposto dall’art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
11 R. DE NICTOLIS, Processo amministrativo, Milano 2011, p. 659 e ss.
12 Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria
– Ordinanza sospensiva 25 febbraio 2011 n.
917, in www.giustamm.it, n. 4-2011:
sospende un diniego emersione lavoro irregolare, diniego emesso ai sensi dell’art. 1
ter, comma 2, del D.L. 1 luglio 1979 n. 78,
convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102
(condanna riportata ai sensi dell’art. 14, co.
5 ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 per essersi il
ricorrente trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5
bis dello stesso decreto, reato punito con la
reclusione da uno a quattro anni). Per tale
reato, a norma dell’art. 14, comma 5 quinquies dello stesso D.Lgs. n. 286, è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
Esistendo un orientamento non omogeneo
circa gli artt. 380 e 381 c.p.p. si ritiene
necessario attendere che l’esame dei profili
di diritto sia affrontato nella rituale sede di
merito, dinanzi al giudice di primo grado.
In senso analogo le Ordinanze
dell’Adunanza Plenaria di pari data nn.
912, 913, 914, 915 e 916 del 2011. Da
segnalare infatti anche la pronuncia
dell’Ad. Plen. del Cons. di St. n. 917/2011
del 25.2.2011 che ha ritenuto fondamentale
decidere rapidamente il merito della questione sottopostale (sempre in materia di
immigrazione clandestina).
13 Corte Costituzionale, sentenza 16 luglio
1996, n. 249 (Gazzetta ufficiale, 1ª serie
speciale, 31 luglio 1996, n. 31), in Foro it.,
1996, parte I, col. 2607: con riguardo
all’art. 31 bis, 3° comma, L. n. 109 del 1994
prevede che, nei giudizi amministrativi in
materia di lavori pubblici nei quali sia stata
chiesta la sospensione del provvedimento
impugnato, i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito.
L’udienza fissata a tal fine deve aver luogo
entro novanta giorni o, nel caso in cui
l’istanza sia proposta all’udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d’ur-
genza, entro sessanta giorni. Tutte le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che, ai sensi della norma impugnata,
la presentazione dell’istanza di decisione
della questione nel merito precluda l’esame
dell’istanza cautelare, privando il giudice
amministrativo del potere di sospendere
l’efficacia del provvedimento impugnato, e
su tale premessa interpretativa fondano tre
diverse censure di costituzionalità. La questione non è fondata nei termini di seguito
precisati. L’interpretazione della norma
impugnata, che tutte le censure presuppongono, in base alla quale la richiesta che la
causa venga decisa nel merito paralizzerebbe il procedimento cautelare, non può essere condivisa. E, invero, dallo stesso contesto dell’art. 31 bis è agevole trarre l’interpretazione opposta, secondo la quale la presentazione dell’istanza di cui all’art. 31 bis,
3° comma, non elimina il potere cautelare
del giudice, che può pur sempre sospendere
il provvedimento impugnato in presenza
dei presupposti di legge.
14 L’azione cautelare ha infatti un proprio
oggetto specifico consistente nella misura
richiesta, ed una propria causa petendi, consistente oltre che nei fatti costitutivi del diritto sui quali è richiesto un accertamento sommario, nel periculum in mora, cioè nel probabile danno, normalmente irreparabile, che
deriverebbe al richiedente nelle more del
giudizio. Vd. C. ASPRELLA, Alcuni aspetti
del procedimento cautelare uniforme alla
luce delle recenti riforme del processo civile,
in:
appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?
&ri=MjAwNzc%3D, 2011, 1. Vd. P.
CALAMANDREI, Introduzione allo studio
sistematico dei provvedimenti cautelari,
Padova 1936, p. 21 e sgg. e F.G. SCOCA,
Giustizia amministrativa, Torino 2006, p.
285.
15 L’art. 21, comma 8 della legge n. 1034
del 1971, ora abrogato dal codice, disponeva che “Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero
dal comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede
l’emanazione di misure cautelari, compresa
l’ingiunzione a pagare una somma, che
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso, il tribunale
20
amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di
consiglio. Nel caso in cui dall’esecuzione
del provvedimento cautelare derivino effetti
irreversibili il giudice amministrativo può
altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere
subordinata a cauzione quando la richiesta
cautelare attenga ad interessi essenziali
della persona quali il diritto alla salute, alla
integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni
di primario rilievo costituzionale.
L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del pregiudizio allegato, ed
indica i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. I difensori delle parti
sono sentiti in camera di consiglio, ove ne
facciano richiesta”. Sul parallelismo tra processo cautelare e di merito e le attribuzioni
giurisdizionali di annullamento e quelle di
ordine cautelare cfr. Consiglio Stato, Sez.
IV, 5 giugno 1979, in Giur. Cost. 1979, II, p.
1857: “Non è manifestamente infondata – in
riferimento agli articoli 3 comma 1, 24
comma 1, 97 comma 1, 101 comma 1 e 113
commi 1 e 2 Cost. – la questione (sollevata
per l’eventualità dell’accoglimento di quella
precedentemente dedotta con riguardo
all’art. 5 comma 5 L. n. 1 del 1978) di legittimità costituzionale dell’art. 5 comma 4
della medesima L. 3 gennaio 1978 n. 1 nella
parte in cui circoscrive l’efficacia delle ordinanze di sospensione del provvedimento
impugnato da parte dei tribunali regionali
amministrativi a non oltre sei mesi dalla
data di emanazione. Tale limitazione, che
priva l’istante di tutela per la restante durata
del processo di primo grado non appare giustificata dalla “ratio” della norma di assicurare la celere realizzazione delle opere pubbliche (il che porta ad escludere in via interpretativa la possibilità di reiterazione della
sospensione di sei mesi in sei mesi).
Sussiste altresì la violazione dell’art. 97
Cost., non corrispondendo al principio di
buon andamento dell’amministrazione che
venga data attuazione al provvedimento
amministrativo nonostante la sussistenza del
“fumus” di legittimità discendente dalla
disposta sospensione (salva la possibilità di
un’ulteriore sospensione disposta dal giudice di appello ai sensi dell’art. 33 comma 3
della L. n. 1034 del 1971). Infine in un siste-
Temi Romana
Saggi
ma di giurisdizione di annullamento non si
giustifica l’esclusione della possibilità di
anticipare in via cautelare l’effetto finale di
annullamento, dovendosi ravvisare un perfetto parallelismo fra le attribuzioni giurisdizionali di annullamento e quelle correlative a strumenti di ordine cautelare (articoli 103 e 113 Costituzione). Se poi alla disposizione dell’art. 5 dovesse riconoscersi efficacia limitata alla materia delle opere pubbliche, ne risulterebbe anche il contrasto con
l’art. 3 Cost. non apparendo giustificata la
diversità di trattamento dalle esigenze di
celerità di realizzazione delle predette opere
pubbliche”.
16 Cfr. Tribunale Firenze, 17.8.2006, in
Foro toscano-Toscana giur., 2006, p. 340, il
quale puntualizza che “avendo la modifica
legislativa dell’art. 669 octies c.p.c. reso
meramente eventuale la fase di merito, sono
necessarie la formulazione delle conclusioni
definitive già nella fase dell’urgenza”.
Tribunale di Ivrea, 28.6.2006, in Foro it.,
2007, I, p. 1965 e in Giur. merito, 2007, p.
1675, e in Dir. e giustizia, 2006, fasc. 32, p.
41; Cass., Sez. Lav., 10.8.2006, n. 18152
precisa che, in seguito alla riforma, in tema
di procedimenti cautelari, il termine perentorio previsto dall’art. 669 octies c.p.c. per
l’inizio del giudizio di merito decorre dalla
pronuncia dell’ordinanza di accoglimento
della domanda cautelare ante causam (se
avvenuta in udienza) ovvero dalla sua
comunicazione, anche se l’originario provvedimento viene confermato in sede di
reclamo. Infatti, per «ordinanza di accoglimento» di cui alla citata norma si intende
quella originaria e non quella emessa in sede
di reclamo, assumendo la prima rilevanza
fondamentale ai fini dell’instaurazione della
fase di merito e necessitando di una verifica
nel giudizio di cognizione. La seconda,
invece, non ha effetto assorbente o sostitutivo, come nel caso di conferma della misura
cautelare. La sentenza rileva, inoltre, che
nessuna norma assegni al reclamo effetti
sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l’art. 669 terdecies c.p.c. che il
reclamo sospenda automaticamente l’esecuzione del provvedimento impugnato.
17 Cass., Sez. II, 29.9.2006, n. 21140.
18 Tribunale di Napoli, 4.7.2001: “Non
rileva infatti l’eventuale conoscenza in fatto
del provvedimento stesso ed inoltre, trattandosi di giudizio ordinario, il suddetto termine è soggetto alla sospensione feriale”, in
Temi Romana
Dir. ind., 2002, p. 129.
19 Cass., Sez. Lav., 9.5.2002, n. 6672: “Il
provvedimento con il quale il tribunale, in
sede di reclamo, nega la tutela urgente
richiesta ex art. 700 c.p.c., per il suo carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione nel merito in
via ordinaria, non produce effetti di natura
sostanziale o processuale con efficacia di
giudicato e non è pertanto suscettibile di
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111
Costituzione. Né la natura del provvedimento muta per il fatto che il giudice del
reclamo possa avere valutato il fumus boni
iuris della domanda, in quanto ciò non attribuisce carattere definitivo e decisorio alla
pronuncia, potendo la domanda essere
riproposta in un giudizio in via ordinaria, e
neanche per il fatto che il giudice non abbia
fissato il termine per la proposizione del
giudizio di merito, essendo tale adempimento previsto solo in relazione ai provvedimenti che accolgano la richiesta cautelare, mentre, non potendosi escludere che alla
fase cautelare conclusasi negativamente per
il ricorrente non faccia seguito un giudizio
in via ordinaria, si giustifica la previsione
della pronuncia sulle spese, opponibile ai
sensi degli artt. 645 seg. c.p.c.
20 Cfr. sul punto L. QUERZOLA, La tutela
anticipatoria tra procedimento cautelare e
giudizio di merito, Bologna 2006, p. 6 e
sgg., che sottolinea come la norma, che per
certi si può definire “rivoluzionaria” era da
tempo auspicata in dottrina. Sul punto v.
anche A. PROTO PISANI, La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela, in Foro it., 1990,
V, p. 1. Sull’attenuazione del principio di
strumentalità vd. L. VIOLA, Riforma del
processo civile e giudizio amministrativo:
l’attenuazione del principio di strumentalità
della
misura
cautelare,
in
www.giust.amm., 2006, p. 545.
21 Per A. PROTO PISANI, Novità nella disciplina dei procedimenti cautelari in generale (1994/2005), in Foro it., 2007, V, p. 81,
si tratta di “Questione francamente oziosa è
quella di stare a discutere (come pure si è
fatto in dottrina) se i provvedimenti di cui al
6° comma dell’art. 669 octies siano ancora
da qualificare come cautelari, o invece da
inserire in una diversa categoria di «provvedimenti decisori sommari di cognizione a
contenuto anticipatorio»: la questione è
oziosa, poiché per un verso l’art. 669 octies,
21
6° comma, continua ad assoggettare i provvedimenti in esame alla disciplina dei provvedimenti cautelari in generale disposta
dagli articoli 669 bis e ss., per altro verso la
diversa qualificazione non varrebbe in ogni
caso ad attribuire ai provvedimenti in
esame attitudine a giudicato; così come il
loro accostamento ai provvedimenti ex artt.
186 bis e 186 ter non vale ad assoggettare il
regime della loro revocabilità alla disciplina generale dell’art. 177 invece che a quella speciale di cui all’art. 669 octies”.
22 C. Stato, ad. plen., 5.9.1984, n. 17, in
Cons. Stato, 1984, I, p. 971, in Foro amm.,
1984, p. 1651, in Foro it., 1985, III, p. 51,
con nota di G. SAPORITO. Vd. VIOLA,
Riforma del processo civile e giudizio
amministrativo... cit., p. 545.
23 Nella letteratura processualcivilistica vd.
L. QUERZOLA, La tutela anticipatoria tra
procedimento cautelare e giudizio di merito, Bologna 2006, p. 212. Sul legame tra
anticipazione, cautela e strumentalità, entità non contrapponibili da giustapporsi
variandone la scala di intensità, in quanto
rappresentano diversi aspetti di un medesimo fenomeno vd. M. PEDRAZZOLI, La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel
rapporto di lavoro, in Riv. Trim. dir. proc.
civ., 1973, p. 41 e sgg. e QUERZOLA, La
tutela… cit., Bologna 2006, p. 213.
24 Verrebbe da dire Che vi sia ciascun lo
dice, dove sia nessun lo sa, prendendo a
prestito le parole di Demetrio di Pietro
Metastasio musicate da Mozart (libretto di
Lorenzo Da Ponte per il Così fan tutte, con
riferimento alla fede amorosa).
25 A. DI CUIA, La Sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato nel
processo amministrativo, in www.jius.
unitn.it/cardozo/obiter dictum/dicuia.htm.
26 M. ANDREIS, La tutela cautelare, in R.
CARANTA (a cura di), Il nuovo processo
amministrativo, Bologna 2011, p. 337 e p.
340.
27 A. TRAVI, Osservazioni a Cons st., sez.
IV, 12 giugno 2003 n. 3312, in Foro it.,
2003, III, p. 681.
28 M. ANDREIS, La tutela cautelare, in Il
nuovo processo amministrativo, CARANTA
(a cura di), Il nuovo processo amministrativo cit., pp. 339-340.
29 M. SANINO, Codice del processo amministrativo, Torino 2011, p. 255.
Saggi
30 ANDREIS, La tutela cautelare… cit., p.
339.
31 ANDREIS, La tutela cautelare… cit., pp.
340-341.
32 R. GAROFOLI, La tutela cautelare degli
interessi negativi. Le tecniche del remand e
dell’ordinanza a contenuto positivo alla
luce del rinnovato quadro normativo, in Dir.
proc. amm., 2002, p. 13, il quale osserva tuttavia che l’indubbia preferenza accordata
dal legislatore per una definizione tempestiva del merito della controversia non è argomento spendibile per ridimensionare ed
attenuare il livello di incisività della misura
cautelare invocabile nel processo amministrativo; misura di cui va sempre assicurata,
invece, la più ampia ed intensa idoneità a
soddisfare le esigenze di piena tutela delle
posizioni soggettive dedotte in giudizio, a
condizione che siano rispettati i caratteri
ontologicamente propri dell’intervento interinale affidato al giudice; E.M. BARBIERI, È
bene abolire la pregiudiziale amministrativa?, in Riv. trim. appalti, 2006 pp. 807 e
sgg.; O.M. CALSOLARO, Per la pregiudiziale
amministrativa: la «doppia anima» dell’interesse legittimo (Nota a TAR Puglia, sede
Lecce, sez. II, 4 luglio 2006, n. 3710, Soc.
Stilio c. Com. Lecce), in Foro amm. TAR,
2006, p. 2652 e sgg.; R. CARANTA, Ancora
sulla pretesa pregiudizialità tra ricorso
d’annullamento e ricorso risarcitorio (Nota
a C. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5063),
in Urb. e app., 2007, pp. 83 e ss.; S. Castro,
La pregiudiziale amministrativa dell’annullamento dell’atto: tramonto dell’ennesimo
mito pubblicistico?, in Merito, 2007, fasc. 4,
p. 74.
33 D. DE CAROLIS, Tutela cautelare e atti
negativi, in M. ROSSI SANCHINI (a cura di),
La tutela cautelare nel processo amministrativo, Milano 2006, p. 125.
34 A titolo esemplificativo si segnala l’ord.
n. 655/2007 del TAR Emilia Romagna –
Bologna Sez. I, che aveva respinto l’istanza
cautelare “Ritenuto, ad un primo esame
della causa, che il ricorso non contenga
puntuali censure rilevanti l’illegittimità del
provvedimento impugnato…”. Con la pronuncia di merito, la n. 2997/2007, lo stesso
TAR accoglie invece la domanda, specificando nel corpo della motivazione che
“Nonostante il diverso avviso espresso da
questo tribunale in sede cautelare (peraltro
sulla base della sommaria deliberazione
tipica di quella fase) il Collegio ritiene che
il ricorso merita di essere accolto in quanto
risultano fondate, in particolare, le censure
riguardanti l’insufficienza della motivazione posta a base del giudizio di non ammissione e il mancato coinvolgimento della
famiglia nelle vicende scolastiche dell’alunna”.
35 R. CAPONI, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (L. n. 80 del
2005), in Foro it., 2006, V, p. 69, spec. sub 7.
36 In base a tali assunti potrebbero ritenersi applicabili pure nel processo amministrativo sia l’art. 669 sexies c.p.c., sia il precedente art. 669 quater, 2° comma, in virtù
dei quali, se la causa pende davanti al
Tribunale la domanda si propone al giudice
istruttore oppure, se questi non è ancora
designato, al presidente, cfr. A. PROTO
PISANI, Novità nella disciplina dei procedimenti cautelari in generale (1994/2005), in
Foro it., 2007, V, p. 81: “Circa l’interpretazione dell’art. 669 octies, 6° comma alla
nuova disciplina sono soggetti: a) tutti i
provvedimenti d’urgenza ex art. 700, abbiano essi (come normalmente accade) contenuto anticipatorio o (come non è escluso
dalla lettera dell’art. 700) contenuto conservativo (es., a tutela del diritto alla riservatezza, sequestro di materiale fotografico);
b) tutti gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito, previsti dal codice civile o da leggi
speciali; sia che l’anticipazione sia totale
(di tutti gli effetti della sentenza di merito)
sia che l’anticipazione sia soltanto parziale.
Viene immediatamente alla mente l’inibitoria provvisoria c.d. brevettuale, inibitoria
oggi prevista dall’art. 131 D.Lgs. 30/05
(codice della proprietà industriale), ma
subito l’interprete si scontra con la dura
realtà della modifica apportata all’art. 131
dal D.Lgs. 140/06, che assoggetta tale inibitoria ad un regime di rigida strumentalità: c)
Tutti i provvedimenti emessi a seguito di
denunzia di nuova opera o di danno temuto.
La previsione è di grosso interesse poiché ai
sensi dell’art. 1171, 2° comma, c.c. la cauzione è in ogni caso componente ineliminabile dei provvedimenti in tema di denuncia
di nuova opera: il che dimostra chiaramente
come non vi sia alcun ostacolo ontologico
all’adozione del regime di strumentalità
allentata o attenuata anche ai provvedimenti conservativi, nonché che il regime di strumentalità allentata o attenuata non sarà osta-
22
colato in modo alcuno dall’imposizione di
una cauzione ex art. 669 undecies a un provvedimento d’urgenza ex art. 700 o ad altro
provvedimento «anticipatorio» degli effetti
della sentenza. Con queste indicazioni ogni
certezza finisce, così che, fuori delle non
secondarie ipotesi sopra ricordate, l’operatore pratico prudente farà bene ad instaurare
la causa di merito nei termini previsti dall’art. 669 octies, 1° comma, sempre però che
si sia alla presenza di un vero provvedimento cautelare soggetto alla disciplina degli
artt. 669 bis e sgg.: al riguardo rinvio alle
precisazioni già effettuate nell’articolo del
1991, specie sub 11.8; R. CAPONI, La nuova
disciplina dei procedimenti cautelari in
generale (L. n. 80 del 2005), in Foro it.,
2006, V, p. 69, spec. sub 7.
37 Cons. St. Sez. III n. 4067 del 16 settembre 2011 accoglie l’istanza cautelare rinviando al TAR per la sollecita fissazione
dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55,
comma 10, c.p.a. e, specificando che “potrà
essere verificata in sede di merito la situazione familiare dell’appellante e la effettività e attualità del ricongiungimento familiare,
nonché la durata del suo regolare soggiorno
in Italia”.
38 A. MONACILIUNI, I limiti della tutela cautelare nel processo amministrativo, in
www.lexitalia.it: “La giustizia tanto più
effettiva avrà ad essere quanto più sarà in
grado di valutare immediatamente e contestualmente le diverse ragioni, emanando
decisioni il più possibile certe e definite,
evitandosi che l’alea iudiciorium, riferita
alla fase cautelare, possa significare che la
partita è giocata con dadi così piccoli, da
non rendere chiaro neppure chi «la sorte»
abbia favorito. Si obietterà che le osservazioni sopra esposte sono riferibili all’intera
gamma dei procedimenti cautelari e che rappresentano il rovescio della medaglia del
doppio grado di giurisdizione, che, tuttavia,
ha, dall’altra faccia, il vantaggio insopprimibile di garantire il vaglio successivo del
giudice dell’appello anche su dette misure
cautelari, rese in prime cure. Non è questa la
sede per approfondire il discorso in relazione alla generalizzazione dell’istituto del
doppio grado di giurisdizione ed ai suoi
effetti; quel che appare potersi qui rilevare è
come tale approfondimento andrebbe senza
dubbio esperito in una riforma del complessivo sistema giudiziario civile e penale, allo
stato incapace di assicurare effettiva giusti-
Temi Romana
Saggi
zia, che significa anche dare effettività alla
stessa, se del caso sacrificando qualcosa in
tema di garanzie meramente formali, sì da
non rendere concreto, al termine della fase
cautelare, di quella di merito, delle impugnazioni e di quant’altro ancora possibile, il
detto summum ius summa iniuria.
39 F. COCOMILE, Niente alternatività per il
controinteressato pretermesso, in Giust.
amm., 2006, p. 1283. MONACILIUNI, I limiti… cit.: “È evidente come “in luogo del
continuum si assisterà ad un susseguirsi
schizofrenico di go and stop, che poco ha da
spartire con l’effettività della tutela.[...]
Temi Romana
Inevitabilmente, in tal modo, il giudice
diviene, in qualche misura, parte della complessiva azione, con conseguente svilimento
del suo ruolo e di quell’imperium iudicis,
che dovrebbe essere preservato, al di sopra
ed al di là delle parti in causa, rappresentando la giustizia la più alta espressione della
sovranità dello Stato”.
cautelare disponga, qualora lo ritenga
necessario, il deposito documenti, con un
conseguente ampliamento della fase istruttoria cautelare che, in tal caso, è conseguenza diretta della conversione del giudizio
abbreviato in giudizio di merito.
40 Vd. TAR Lombardia – Milano, Sez. I del
15.9.2011 in merito ad procedimento di
verifica dell’inquinamento acustico e TAR
Lombardia – Milano, Sez. I del 15.9.11 che
accoglie in attesa di verifiche l’art. 119
comma 3 del codice prevede che il giudice
42 Anche se la sensazione, che può anche
essere forse di conforto per certi aspetti, è
che Plus ça change, plus c’est la même
chose (più si cambia, più è la stessa cosa),
per dirla con Alfonso KARR, in En fumant,
Paris 1861, p. 54.
23
41 V. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, cit.
Saggi
L’ascolto del minore: dovere del giudice e diritto
del figlio. Riferimenti normativi
Samantha Luponio
Avvocato del Foro di Roma
L’
L’elevazione dell’ascolto a diritto soggettivo
Ora, con l’entrata in vigore della legge n. 219/2012, che
ha riformato alcune norme sullo status filiationis,
l’ascolto del minore risulta elevato a vero e proprio
diritto soggettivo: ai diritti-doveri costituzionalmente
garantiti ai genitori dall’art. 30 (Cost.), infatti, con l’inserimento della norma dell’art. 315 bis c.c. ad opera di
tale legge, sono stati attribuiti al soggetto “figlio”, legittimo o naturale, i corrispondenti diritti soggettivi ad
essere mantenuto, istruito, educato, assistito moralmente dai genitori, il diritto a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti e, infine, il
diritto soggettivo a essere ascoltato: proprio perché il
futuro provvedimento di affidamento lo riguarda direttamente, il “figlio” non dovrà più essere considerato
solo quale individuo oggetto di protezione, ma come
soggetto portatore di un autonomo diritto soggettivo.
D’altronde anche le ricerche in ambito psicologico parlano dell’ascolto come uno dei doveri dell’adulto nei
confronti dei bisogni del bambino.
Punto di convergenza, pertanto, tra le due discipline
(ordinamento giuridico e costante giurisprudenza da un
lato ed ambito psicologico dall’altro) sta nel fatto che
in entrambe si afferma la necessità che il bambino
venga ascoltato.
Secondo Wallerstein e Tanke “i Tribunali dovrebbero
ascoltare la voce di un minore, amplificandola e anteponendola al rumore del conflitto genitoriale, solo in
questo modo è possibile assicurarsi il miglior interesse del minore”.
istituto dell’ascolto della persona minore di
età, nell’ambito dei procedimenti in materia
familiare, è stato elevato a principio generale
del nostro ordinamento interno dall’art. 12 della legge
176/1991, di ratifica della Convenzione dei Diritti del
Fanciullo di New York del 1989, secondo il quale:
“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la
sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo
grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
Il tema dell’ascolto del minore è stato poi rafforzato
dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata
con la legge 77/20031.
L’impatto di tali strumenti nell’ordinamento interno
non ha tardato a farsi avvertire.
E, infatti, la L. 54/2006, conosciuta come “legge sull’affidamento condiviso”, ha inserito nel codice civile, tra gli altri, l’art. 155 sexies in forza del quale,
prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei
provvedimenti relativi ai figli “il giudice dispone
l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli
anni 12 o anche di età inferiore ove capace di
discernimento”.
Tale audizione, per effetto dell’art. 4 della medesima
legge appena citata, è prevista, peraltro, anche nei giudizi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.
Momento processuale necessario
Nella prassi, tuttavia, nonostante questa convergenza di
pensiero, l’audizione del “figlio” minore di età nei procedimenti che lo riguardano continua a trovare non poche
difficoltà ad essere recepita come necessario momento
processuale, volto all’acquisizione di uno degli elementi
che il giudice deve tenere presente nel decidere.
24
Temi Romana
Saggi
sue emozioni e contribuisce al miglior convincimento
del giudice, senza poterlo determinare, né costituisce
una prova in senso tecnico.
L’ascolto non è assimilabile alla testimonianza, in
quanto non è diretto a recepire fatti dei quali una persona possa riferire: anzi è il suo esatto contrario, poiché
nella testimonianza sono da escludere le valutazioni e
le opinioni, mentre il minore è chiamato proprio a
manifestare il suo pensiero.
Nemmeno è assimilabile all’interrogatorio formale: la
prospettiva di confessione della parte di circostanze
alla stessa sfavorevoli è evidentemente estranea all’audizione del minore.
Poiché, secondo plurime pronunce della Corte
Costituzionale e della Cassazione, al minore va attribuita la qualità di parte in senso sostanziale, forse la
sua audizione potrebbe essere assimilata all’interrogatorio libero che, secondo autorevole dottrina (Satta,
Punzi), è volto a dare alla parte la possibilità di spiegare al giudice le proprie ragioni.
Tuttavia la soluzione preferibile sembra quella di estraneità al sistema delle prove, conferendone specificità in
ragione della sua funzione di recepire nel processo
l’opinione del soggetto vulnerabile, nel cui preminente
interesse il provvedimento verrà assunto.
L’audizione del minore, pur non essendo atto istruttorio, è però certamente un atto processuale che si caratterizza, cioè, per la sua qualità di costituire elemento
del processo di realizzazione della tutela giurisdizionale in quanto atto coordinato all’esercizio della giurisdizione in materia di diritti dei minori.
Negli anni, si sono formate varie prassi interpretative
ed applicative, alcune delle quali formalizzate in protocolli proliferati sul territorio nazionale, anche questi eterogenei sia per le previsioni sia per i soggetti firmatari.
Il quadro applicativo che ne deriva comporta incertezza nei soggetti coinvolti in tali procedimenti e, talvolta,
avvilimento dei diritti della difesa.
Finalità dell’ascolto
Con l’ascolto del minore, nei giudizi civili e precipuamente in quelli riguardanti l’affidamento del minore, ci
si propone di comprendere il ruolo che egli assume
all’interno del suo contesto di vita e di sintonizzarsi
con il suo mondo interno e la sua visione degli eventi.
Affinché ciò sia possibile, l’attenzione deve essere
rivolta non soltanto verso gli aspetti oggettivi che lo
riguardano (vissuto, situazioni ed eventi), ma anche
verso gli aspetti soggettivi, che sono relativi al modo
con cui vengono dal minore attribuiti significati alle
cose e agli eventi nonché ai comportamenti delle persone che lo circondano.
E tutto ciò per recepirne nel processo l’opinione, le
istanze e le esigenze.
Entrando nello specifico, l’ascolto può essere utile a
indicare in che modo il figlio può coordinarsi tra le due
abitazioni dei genitori, in cosa un genitore è più competente rispetto all’altro e, soprattutto, come ognuno
dei due genitori possa impegnarsi, dopo la separazione,
a gestire, insieme all’altro, la funzione educativa.
Peraltro l’audizione del bambino, da parte del giudice o
dei suoi ausiliari, può costituire un’occasione per favorire la capacità di ascolto da parte dei genitori che non
dovrebbero mai dimenticare che è loro precipuo dovere tener conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni
dei figli.
Forma dell’ascolto
In quanto atto processuale, dunque, l’ascolto del minore è soggetto al principio fondamentale in tema di
forme processuali che è quello della libertà di forma.
È noto che, se non sono richieste forme determinate, gli
atti devono essere svolti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo cui sono preordinati, inteso
evidentemente come funzione che l’ordinamento assegna a ciascuna di loro.
Quindi, atteso che la funzione dell’ascolto è certamente
quella di assicurare al giudice l’acquisizione dell’opinione del minore ed avuto riguardo alla circostanza che è
necessario che tale pensiero sia libero e consapevolmente formato ed espresso, ci si chiede quale sia la forma
No Atto Istruttorio – Sì Atto Processuale
Dal punto di vista processuale, benché l’ascolto del
minore sia stato inserito subito dopo la previsione che
il giudice, prima di emanare i provvedimenti anche
provvisori possa assumere mezzi di prova, non può
affermarsi che tale “ascolto” sia un mezzo istruttorio,
atteso che non è volto alla verifica di un fatto posto alla
base della domanda giudiziaria di parte.
La finalità dell’ascolto, infatti, è puramente informativa e riguarda le opinioni del minore, i suoi desideri e le
Temi Romana
25
Saggi
processuale più corretta per l’assunzione di tale atto.
A tal fine, per individuare la forma processuale più adeguata, occorre fare riferimento ai principi generali in
tema di giurisdizione e armonizzarli con il principio
peculiare di ogni procedimento che abbia ad oggetto i
diritti del minore.
In sintesi, contraddittorio, diritto di difesa e terzietà del
giudice debbono necessariamente contemperarsi, nel
caso concreto, con il principio del superiore interesse del
minore che costituisce criterio preminente di giudizio.
del diritto di difesa non può essere astrattamente prevista in via anticipata ma deve essere invece modulato
di volta in volta in ragione delle diverse e particolari
situazioni (si pensi ad esempio alla diversità dell’audizione di un “grande minore” di età prossima ai 18 anni
e quella di un bambino appena scolarizzato).
La presenza dei difensori delle parti non può essere
esclusa in via generale e preventiva, ma soltanto in presenza di particolari situazioni, che richiederanno adeguata motivazione.
Il contraddittorio comunque potrà essere garantito,
prima dell’audizione, con la formulazione al giudice di
particolari questioni e dopo, con la concessione di termini per l’esame dell’audizione resa, finalizzata a consentire la eventuale formulazione di specifiche istanze.
Anche per questo, la redazione del verbale di audizione dovrà essere fedele, pur se sintetica, ai fini della
piena conoscenza di quanto svoltosi in sede di audizione, altrimenti, i diritti di difesa, subirebbero un’ingiustificata e illegittima compressione.
Il minore ha diritto all’ascolto che non costituisce tuttavia l’oggetto di un suo obbligo.
È invece obbligo dell’Autorità Giudiziaria far rispettare
tale diritto, consentendo al bambino di esprimere le sue
opinioni, libere da pressioni e spontaneamente formate.
Contraddittorio e difesa delle parti
Dall’esame della normativa e della giurisprudenza si
ricava che l’opinione del bambino, nella cui sfera
vanno a incidere i provvedimenti, è uno degli elementi
su cui si forma il convincimento del giudice ma quest’ultimo, di certo, non ha l’obbligo di conformarvisi,
poiché dovrà decidere tenendo prioritariamente conto
dell’interesse del minore, potenzialmente non coincidente con l’opinione di costui.
Sui pensieri espressi dal bambino, tuttavia, il Giudice
dovrà motivare la propria decisione, così come dovrà
chiarire le motivazioni per le quali eventualmente
abbia ritenuto opportuno escludere l’audizione del
minore, in ragione – ad esempio – del suo superiore
interesse ovvero di una rilevata carenza di maturità.
La difesa delle altre parti ha tutto l’interesse a conoscere direttamente l’opinione del minore nel processo,
senza filtri che potrebbero essere devianti, sia per la
formulazione di ulteriori istanze (anche istruttorie)
nello stesso grado di giudizio, sia ai fini dell’eventuale
impugnazione.
Appare evidente che la piena attuazione del contraddittorio e del diritto di difesa esigerebbero che l’audizione
del minore avvenisse alla presenza delle altre parti
(genitori o tutore o parenti a seconda del procedimento).
Ma è altrettanto evidente che, vigendo nei procedimenti minorili il principio generale del “superiore interesse
del minore”, questo debba essere considerato anche
nella prospettiva processuale del contraddittorio e dei
diritti di difesa del bambino, che potrebbe trovarsi intimorito o non libero di esprimersi alla presenza dei
difensori delle parti.
Per la varietà di ragioni e per la diversità di scenari che
potrebbero verificarsi, a seconda delle particolarità dei
casi, è ovvio constatare che l’eventuale compressione
Omesso ascolto – problematiche processuali
Ci si è interrogati sulle conseguenze processuali dell’omesso ascolto del minore.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2238/09, a tale proposito, ha affermato l’obbligatorietà dell’audizione dei figli minori nei procedimenti riguardanti il loro affidamento, salvo che tale
ascolto possa essere in contrasto con gli interessi fondamentali del bambino e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa
giustificarne l’esclusione.
Non solo, ma la Cassazione ha altresì censurato l’omesso ascolto del minore sotto il profilo della violazione dei
principi del contraddittorio e del giusto processo.
All’ingiustificato omesso ascolto del minore, la
Cassazione ha dunque fatto conseguire l’annullamento
del decreto, con rinvio al giudice a quo.
Protocolli
Vari e anche molto difformi tra loro, sia per i soggetti
26
Temi Romana
Saggi
- con età superiore ai 12 anni.
firmatari che per il contenuto delle regole, i protocolli
sull’ascolto del minore diffusi sul territorio nazionale.
Circa la natura e funzione di tali protocolli, costituiscono piuttosto individuazione di prassi applicative condivise dai firmatari che li diffondono tra gli appartenenti
alle rispettive categorie.
Se sottoscritti da istituzioni con potere disciplinare nei
confronti degli aderenti o iscritti (come ad es. l’Ordine
degli Avvocati), costituiscono norme integrative del
codice deontologico.
I protocolli, ovviamente, non possono contrapporsi a
norme di legge, così come interpretate dalla giurisprudenza e quindi, ad esempio non possono prevedere in
via astratta, preventiva e generale:
- limitazioni al diritto di ascolto del minore;
- l’esclusione dei difensori delle parti;
- lo svolgimento dell’ascolto in forma soltanto indiretta o solo diretta.
Ascolto diretto nel Tribunale Ordinario di Roma
Alcuni Giudici evidenziano le difficoltà dell’ascolto
diretto poiché, oltre a richiedere competenze specifiche
di cui il Giudice non sempre dispone, l’accesso del
bambino all’interno del contesto giudiziario potrebbe
costituire per lui motivo di turbamento.
A ciò si aggiunga il problema dell’attendibilità o meno
di ciò che viene riportato dal minore e alla possibilità di
capire se e quanto egli sia stato sottoposto a pressioni
da parte di uno dei genitori o da parte di entrambi.
In molte sedi di Tribunale vi sono protocolli già definiti.
Presso il Tribunale Ordinario di Roma non si dispone di
un protocollo in materia ma si segue una prassi.
Il Giudice, infatti, quando procede all’ascolto diretto
del minore, osserva in genere le seguenti modalità:
- apre l’udienza con la sola presenza dei genitori e
degli avvocati e chiede ai genitori se acconsentono
a che l’audizione avvenga in loro assenza;
- mette a verbale il consenso dei genitori a rimanere
assenti;
- se i genitori non prestano il consenso e il Giudice
ritenga che la loro assenza sia necessaria per la serenità del minore e la genuinità dell’ascolto, esclude i
genitori, con provvedimento motivato;
- può comportarsi nello stesso modo con gli avvocati
o anche solo avvisarli che l’esame sarà condotto dal
Giudice e che non è ammessa la cross examination
del minore;
- si procede quindi all’accoglienza e all’informazione
del minore, invitandolo ad entrare in aula: il Giudice
si presenta e spiega con termini semplici quali siano
le sue funzioni;
- illustra al minore le ragioni dell’ascolto, gli spiega
che si tratta di un suo diritto e che si terrà conto
della sua opinione anche se poi le decisioni potranno essere diverse dalla sua volontà (se si tratta di un
minore “grandicello”, può anche spiegare come funziona il processo e cioè che ognuno esprime la propria opinione e poi il Giudice decide);
- comincia da domande di esplorazione delle aree di
vita del minore, quali la quotidianità, i rapporti scolastici, i rapporti amicali, gli sport praticati, ecc.;
- piano piano si avvicina all’oggetto del giudizio, che
per lo più è l’affidamento, cercando di capire la
Ascolto diretto e indiretto
Molto si è dibattuto e ancora si dibatte sulla possibilità
che il minore, soprattutto se infradodicenne, venga
ascoltato con la modalità dell’ascolto diretto, per tale
intendendosi l’audizione da parte del giudice in udienza, eventualmente anche da parte di un ausiliario
esperto; oppure attraverso un ascolto delegato totalmente a un esperto di fiducia del Giudice (ascolto indiretto) e che potrà essere un Giudice onorario presso il
Tribunale per i Minorenni, uno psicologo, un neuropsichiatra infantile ovvero uno psichiatra incaricato
anche nell’ambito di una CTU.
Nei giudizi di separazione giudiziale trattati dal
Tribunale Ordinario di Roma, l’ascolto del minore,
laddove effettuato, è stato spesso delegato ad un consulente tecnico d’ufficio e inserito nell’ambito di un’indagine più ampia, relativa alla valutazione della relazione
genitore/figlio, delle caratteristiche di personalità ovvero delle competenze genitoriali.
Occorre tenere presente che, presso il Tribunale
Ordinario, la classe di età dei figli di separati maggiormente rappresentata è quella dei minori in età compresa tra i 6 e i 10 anni e che occorre tenere conto delle differenti competenze evolutive del minore effettuando
una distinzione a seconda che si tratti di un minore:
- di 12 anni;
- di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni;
Temi Romana
27
Saggi
-
gestione e l’organizzazione dei rapporti familiari;
legge il verbale al minore e gli chiede se ha tradotto
bene il suo pensiero, avendo cura di sapere se c’è qualcosa che vuole far conoscere al giudice o chiedere;
conclude la conversazione salutando il minore e lo
congeda spiegandogli che deve terminare l’udienza;
richiama i genitori ed eventualmente gli avvocati,
dando lettura del verbale e chiedendo se vogliono rendere altre dichiarazioni o inserire qualcosa al verbale;
va avanti con la procedura (rinvio o riserva o termini).
una Consulenza Tecnica d’Ufficio, poiché questo sistema, pur maggiormente dispendioso in termini di tempi
e di risorse, può risultare più efficace in quanto consente di inserire le dichiarazioni del minore all’interno del
quadro relazionale allargato, di esplorare con attenzione il suo mondo affettivo e relazionale anche a livello
intrapsichico ed eventualmente di avere uno spazio psicologico per testare la modificabilità di posizioni o
relazioni disattivate, assunte nell’ambito del conflitto
tra i genitori, come le difficoltà o i rifiuti nei confronti
di un padre o di una madre.
In conclusione, può formularsi l’auspicio che tutti gli
operatori del diritto abbiano e dimostrino l’elevata sensibilità che qualsiasi minore ha diritto di esigere allorché
si tratti di decisioni che lo riguardano e che sono destinate a segnare il suo sereno sviluppo verso l’età adulta.
Conclusioni
Soprattutto con i minori infradodicenni e nei casi più
complessi sarebbe opportuno che il bambino venga
ascoltato in modalità indiretta alla presenza di figure
professionali con adeguata formazione e all’interno di
_________________
1 art. 6: “Nelle procedure che interessano
un fanciullo, l’autorità giudiziaria, prima
di adottare qualsiasi decisione deve:
a) esaminare se dispone di informazioni
sufficienti in vista di prendere una decisione nell’interesse superiore del fanciullo e,
se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro
che hanno la responsabilità di genitore;
b) quando un fanciullo è considerato dal
diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l’autorità giudiziaria:
- si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
- consulta personalmente il fanciullo, se
del caso, e se necessario in privato,
direttamente o attraverso altre persone
28
o organi, nella forma che riterrà più
appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non
sia manifestamente in contrasto con gli
interessi superiori dello stesso;
- consente al fanciullo di esprimere la
sua opinione;
c) tenere debitamente conto dell’opinione
espressa da quest’ultimo”.
Temi Romana
Saggi
Il fenomeno del pentitismo
nella prospettiva criminologica integrata
Giovanni Neri
Avvocato del Foro di Roma – Docente di Criminologia UNI I.P.U.S. Chiasso – Direttore scientifico della collana Jus & Comparative Law
1.
Premessa
La necessità di penetrare a fondo le maglie di
organizzazioni criminali particolarmente perniciose, ramificate sul territorio, nazionale e sovranazionale, e connotate da strutture piramidali difficilmente decifrabili, ha indotto la magistratura negli anni a far
frequente, se non costante, ricorso alla figura del collaboratore di giustizia.
Si tratta di un membro effettivo del sodalizio che, per
le ragioni più disparate, che possono spaziare dal mero
utilitarismo alla necessità di svincolarsi dall’associazione mafiosa, decide di cooperare con le autorità statuali rendendo dichiarazioni utili a far conoscere, comprendere ed eventualmente sconfiggere la realtà criminale d’appartenenza.
È indubbio infatti che il ricorso alla tecnica della collaborazione processuale produca effetti spesso devastanti all’interno delle organizzazioni criminali, da sempre
rese forti dall’atteggiamento omertoso dei loro membri
e della popolazione, e costrette a fare i conti con la presenza di potenziali traditori: un affiliato che decide di
rompere con la cosca malavitosa, infatti, oltre a inquinarne le strutture, rende l’associazione vulnerabile,
meno coesa e esposta al pericolo della scissione. In
altre parole, l’attività collaborativa non solo è empiricamente necessaria al riscontro di prove utilizzabili in
sede processuale, ma consente anche di sfaldare l’unione all’interno della mafia, ossia quella forma di aggregazione e reciproca fiducia che ha da sempre costituito
il punto di forza degli uomini d’onore.1
La storia moderna del pentitismo italiano ha avuto inizio negli anni Ottanta, con le dichiarazioni di Tommaso
Buscetta2 ed ha subito una graduale evoluzione che ha
trasformato delazioni eccezionali in un ordinario strumento di lotta alla mafia.
Il maggior numero di collaborazioni è stato riscontrato
nella metà degli anni Novanta, all’indomani delle celeTemi Romana
bri stragi di Capaci e di via D’Amelio. La morte dei
magistrati Falcone e Borsellino e degli agenti di scorta
infatti indussero le autorità nazionali ad inasprire le
misure di contrasto alla criminalità organizzata e ad utilizzare gli ex mafiosi come valvola di accesso ai vertici delle strutture criminali.
Tuttavia, il fenomeno negli anni ha progressivamente
assunto connotati particolarmente problematici: invero,
l’intersecarsi di sistemi tutori e premiali ha indotto sempre più i membri delle organizzazioni criminali a rendere dichiarazioni in cambio di sconti di pena, benefici
penitenziari e meccanismi di protezione dell’incolumità
personale propria e dei congiunti, ovviamente esposti a
probabili vendette trasversali di tipo esemplare.3
Di qui l’evidente necessità di arginare il ricorso a collaborazioni di scarsa utilità, se non addirittura false o
indotte dalla stessa mafia per fuorviare l’attività investigativa.
Senza contare che, in difetto di regole ben definite di
utilizzabilità delle collaborazioni rese, la magistratura
era esposta ad atteggiamenti latamente ricattatori del
pentito, che rendeva dichiarazioni incomplete e comunque eccessivamente dilazionate nel tempo.
La necessità di scoraggiare forme pretestuose di cooperazione e di contenere sia il problema delle c.d. dichiarazioni a rate, che le difficoltà derivanti dall’utilizzo
della decretazione d’urgenza, è stata alla base delle
modifiche introdotte alla legge sulle collaborazioni di
giustizia.
Nel 2001 infatti il legislatore, con la tecnica dell’interpolazione, è intervenuto sul corpo normativo previgente, con innesti, modifiche ed integrazioni, ridisegnando, al termine di travagliati lavori parlamentari, i contorni della legislazione processuale e tutoria in materia.
Il nostro lavoro si propone, da un lato, di analizzare sinteticamente i punti salienti della disciplina normativa, e
dall’altro di focalizzare, in una prospettiva criminologi29
Saggi
ca integrata, gli aspetti più problematici della vita del
collaboratore che, distaccandosi progressivamente dal
sodalizio di appartenenza, si trova a vivere inevitabili
crisi d’identità e si rifugia nella protezione offertagli
dal magistrato, dapprima nemico e poi, dopo la cesura
con il vissuto mafioso, unico tutore della sua stessa
incolumità.
riori circostanze processualmente utilizzabili e deve
garantire il silenzio sui fatti oggetto della cooperazione,
noti alla sola autorità giudiziaria e al difensore.
L’omessa o tardiva sottoscrizione del verbale inibisce
l’applicazione delle circostanze attenuanti e la fruizione dei benefici penitenziari e delle misure tutorie connesse all’attività di collaborazione. Inoltre, l’inosservanza dei termini e dei divieti imposti in fase di stesura determina l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni ivi contenute.
Il verbale viene infine inserito in un fascicolo depositato presso il procuratore della Repubblica e confluisce
per estratto in quello del pubblico ministero relativo ai
procedimenti sui fatti oggetto della collaborazione.
A scoraggiare le c.d. collaborazioni facili contribuisce
inoltre l’eliminazione di ogni forma d’automatismo
nella revoca o sostituzione della misura custodiale per
l’intervenuta attività di cooperazione con la giustizia e
la necessaria espiazione di una porzione di pena per
l’accesso ai benefici penitenziari.
Infatti, la cessazione della custodia cautelare in carcere
resta subordinata ad un vaglio che accerti l’insussistenza di attuali legami del propalante con la criminalità
organizzata e i benefici penitenziari possono essere
concessi soltanto dopo l’espiazione di un quarto della
sanzione inflitta e, in caso di condanna all’ergastolo,
scontati almeno dieci anni di pena.
L’applicazione delle misure di protezione è ad oggi
completamente disgiunta dalla concessione dei benefici penitenziari, con pregevole scissione del momento
tutorio da quello premiale, ed è gradualmente connessa
all’attualità, intensità e gravità del pericolo cui il pentito viene esposto.10
Alle tecniche ordinarie di protezione, si affiancano
misure speciali di varia natura, che possono consistere
in precipui accorgimenti di videosorveglianza, trasferimenti o piantonamenti del collaboratore in regime di
detenzione. In casi di particolare gravità viene infine
adottato uno specifico programma di protezione, con
tecniche di tutela particolarmente invasive, che spaziano dal trasferimento in luoghi protetti alla mimetizzazione anagrafica mediante il rilascio di appositi documenti di copertura.11
Il programma comprende anche forme di assistenza
legale e finanziaria del pentito, costretto il più delle
volte a interrompere l’attività lavorativa in corso: a tal
2. Il fenomeno del pentitismo. Profili giuridici
Come premesso, la legge di riforma è intervenuta sulla
normativa previgente adottando una serie di accorgimenti per lo più volti a scoraggiare il ricorso incondizionato alla collaborazione, altrimenti scontatamente
concepita come una sicura via d’accesso a misure tutorie e premiali.4
Attualmente, infatti, l’acquisto dello status di collaboratore è limitato ai soli delitti di tipo mafioso5, subordinato a stringenti requisiti di veridicità, tempestività ed
importanza delle informazioni rese, ed ha quale immediato contraltare la demenutio patrimonii del pentito.6
Espunto il requisito dell’indispensabilità, originariamente previsto in sede di riforma, la collaborazione
deve ad oggi presentare i caratteri dell’attendibilità e,
disgiuntamente, i connotati della novità o completezza.
La genuinità delle dichiarazioni è garantita dall’isolamento del propalante,7 cui viene fatto divieto di interloquire con altri dichiaranti e di intrattenere rapporti di
corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica,
salvo che per gravi esigenze relative alla vita familiare.
Inoltre, il pericolo di possibili concertazioni e dichiarazioni c.d. a rate è pressoché azzerato dalla prevista sottoscrizione del verbale illustrativo. Si tratta di un documento programmatico che deve essere redatto entro il
termine perentorio di centottanta giorni dall’intervenuta
manifestazione della volontà cooperativa e che cristallizza integralmente i contenuti della collaborazione.8
Il verbale deve contenere l’indicazione di ogni notizia
utile alla ricostruzione dei fatti e degli episodi di maggior allarme sociale di cui il dichiarante sia a conoscenza, di ogni informazione che consenta la cattura dei
complici, nonché dei dati necessari per procedere al
reperimento e alla confisca dei beni del collaboratore o
comunque a disposizione del gruppo criminale d’appartenenza.9
A conclusione delle dichiarazioni, l’aspirante collaboratore deve attestare di non essere a conoscenza di ulte-
30
Temi Romana
Saggi
proposito, è prevista la corresponsione di un assegno di
mantenimento, che garantisca al medesimo e alla sua
famiglia un dignitoso tenore di vita nel corso della collaborazione.
Il programma è automaticamente esteso ai conviventi
del pentito e a tutti coloro che, pur non coabitandovi,
potrebbero in virtù del rapporto di parentela essere
comunque esposti a vendette trasversali dell’associazione criminale tradita.
Le misure sono gradualmente modulate sulla permanente situazione di pericolo in cui il protetto si trova e possono essere revocate o modificate al venir meno delle
relative ragioni giustificatrici o per motivi disciplinari. In
particolare, la revoca è automatica in caso di dichiarazioni false o reticenti, omessa o tardiva sottoscrizione del
verbale illustrativo, mancata indicazione dei beni posseduti, violazione degli impegni assunti o commissione di
reati esemplificativi del reinserimento o collegamento
del collaboratore con la criminalità organizzata.12
Da ultimo, merita di esser segnalata la pregevole distinzione, introdotta nella legge di riforma, tra pentiti e c.d.
testimoni di giustizia, ossia cittadini completamente
estranei al circuito criminale o vittime di esso che per
ragioni di sensibilità istituzionale decidono di cooperare con l’autorità giudiziaria, così ponendo in pericolo
se stessi e i loro congiunti.
I c.d. collaboratori incolpevoli infatti possono rendere
dichiarazioni anche su delitti diversi da quelli di mafia
o terroristico eversivi,13 non soggiacciono all’acquisizione dei cespiti patrimoniali e hanno diritto a usufruire di misure assistenziali in grado di garantirgli un
tenore di vita analogo a quello precedente alla collaborazione.
tare un non agevole percorso che lo conduce al progressivo distacco dal pensare mafioso e ad una conseguente ed inevitabile crisi d’identità.
Infatti, l’uomo d’onore che decide di tradire il proprio
nucleo d’appartenenza, rinuncia nel contempo al codice di condotta che ha governato da sempre la sua vita e
cade in uno stato di evidente disorganizzazione e
destrutturazione affettiva che può mostrarsi nei modi
più disparati e con diversi gradi di intensità. Spesso si
assiste a crisi di tipo depressivo, a stati di dissociazione, a condizioni di angoscia e fantasie persecutorie,
dettate dalla paura di ritorsioni per se è per i propri cari,
e soprattutto ad uno stadio di spersonalizzazione: il collaboratore infatti passa dallo stato di uomo d’onore a
quello di inferiore, che nulla conta e nulla può, o,
mutuando dalla comune terminologia di Cosa Nostra,
di nuddu ammiscato cu nenti.15
Si trova in una condizione nuova, privo del suo lavoro,
dei suoi ingenti beni, in isolamento, affettivo e materiale, e convive con la costante esigenza di tutela, offerta
dalla magistratura e dal disposto programma di protezione: talvolta è obbligato a spogliarsi delle proprie
generalità, mimetizzarsi in luoghi che non conosce,
allontanarsi dal proprio nucleo familiare o sottoporsi ad
interventi chirurgici di plastica facciale, così eliminando
ogni collegamento con il proprio vissuto precedente.
Non sempre può contare sull’appoggio dei propri familiari, che nella maggioranza dei casi si dissociano
anche pubblicamente dalla decisione di pentirsi.
Spesso infatti le donne di mafia rinnegano i mariti e si
fanno porta voci dell’onore della famigghia, vivendo la
collaborazione del compagno come un fallimento della
progettualità familiare all’interno della società mafiosa.16
E i figli poi, se in giovane età o in fase para adolescenziale, subiscono traumi difficilmente reparabili. Del
resto, una vita nel totale anonimato e nella diffidenza,
la perdita di certezze, non sono psicologicamente superabili per un bambino, incapace di elaborare le ragioni
dello sradicamento che è costretto a subire e completamente privo di ogni passato riferimento parentale e
amicale. Obbligato improvvisamente a considerare
nemici gli abituali frequentatori della propria casa e
amici coloro che erano stati educati da sempre ad allontanare e disprezzare.
La collaborazione diviene la sola ragione di vita del
pentito e le informazioni rese vengono concepite come
3. Il fenomeno del pentitismo. Profili criminologici
Dal punto di vista criminologico, il legislatore non ha
ancorato gli effetti tutori e premiali della collaborazione all’effettiva e onesta resipiscenza del pentito e al suo
sincero ripudio per i fatti narrati, e la decisione di informare la giustizia dell’esperienza vissuta in sodalizi criminali può essere il frutto delle più disparate considerazioni utilitaristiche, che vanno dalla volontà di accedere ai benefici penitenziari, alla vendetta, al riscatto
familiare, alla paura della morte per mano della cosca.14
Qualunque siano i moventi della collaborazione, è
comunque chiaro che chi si pente è chiamato ad affron-
Temi Romana
31
Saggi
unica ancora di salvezza per se e per i propri congiunti
rimasti fedeli. Il protetto, infatti, sente di poter contare
esclusivamente sul magistrato, nemico originario e ora
il solo in grado di assicurargli la necessaria tutela.
Egli mette in discussione persino il proprio rapporto
fiduciario con il difensore, che lo assiste in genere solo
nelle prime fasi, al momento di “trattare” i benefici
derivanti dalla collaborazione, ed assume in seguito un
ruolo del tutto marginale.
Non è infrequente che il pentito, inserito nel programma, decida anche di rivolgersi ad un diverso legale,
temendone il legame con l’organizzazione criminale
d’appartenenza. Talora poi è lo stesso difensore a rinunciare all’incarico, per conflitti d’interesse o per dimostrare all’associazione cui è legato la propria devozione
e il proprio disappunto per i c.d. uomini del disonore.
In altre parole, all’avvocato difensore si sostituisce il
“magistrato protettore”, che instaura con il pentito un
rapporto di fiducia, garantendogli le necessarie tutele in
cambio di contributi veritieri nella lotta alla criminalità
organizzata17.
Infatti, ogni collaboratore, anche quello che desideri in
realtà mantenere un’identità deviante, devota ai circuiti malavitosi, non può non temere sicure ritorsioni da
parte dell’organizzazione cui apparteneva che, al contrario, lo taccia come traditore e stigmatizza la vendetta eventualmente perpetrata nei suoi confronti, come
monito per potenziali futuri collaboratori di giustizia.
Ad ogni modo, di recente, si è assistito ad un mutamento di rotta dei collaboratori, spesso delusi dall’inefficacia e dal fallimento dei programmi di protezione, inadatti a tutelarne a pieno l’incolumità specie a fronte di
gruppi criminali fortemente ramificati nel territorio
dell’intera penisola. Senza contare le perplessità derivanti dall’indubbia sorte della Commissione e dalla
mancanza di fondi statuali che hanno fortemente scoraggiato le collaborazioni in atto e talora indotto i
dichiaranti a ripensare al loro nuovo status e a ritentare
un progressivo reinserimento nei circuiti criminali,
anche a rischio della propria vita.
ALMA M., Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Sanzioni difesa e regime transitorio, in Dir. pen. proc., 2001.
ARDITA S., La nuova legge sui collaboratori e sui testimoni
di giustizia, in Cass. pen., 2001.
ARLACCHI P., Gli uomini del disonore. La mafia siciliana
nella vita del grande pentito Antonio Calderone, Milano
1991.
ARLACCHI P., Addio Cosa Nostra. La vita di Tommaso
Buscetta, Milano 1994.
BERNASCONI A., I sistemi di protezione per i collaboratori di
giustizia nella prospettiva premiale dell’ordinamento italiano e nell’esperienza statunitense, in A.A.V.V., Criminalità
organizzata e politiche penitenziarie, Milano 1994.
BERNASCONI A., La collaborazione processuale. Incentivi di
protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense, Milano 1995.
BERNASCONI A., Indissolubile il collegamento tra collaborazione con la giustizia e benefici penitenziari, in Cass. Pen.,
III, 1997.
BERNASCONI A., Le immunità occulte. Fase dell’esecuzione
penale ed ideologia premiale tra razionalizzazione e garantismo, in Politica del Diritto, Giugno, n. 2, 1997.
CAMPOSARAGNA L., La collaborazione con la giustizia in
fase esecutiva, in Dir. pen. proc., II, n. 10, 1997.
CASELLI G.C. – INGROIA A., Normativa premiale e strumenti
di protezione per i collaboratori di giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d’emergenza, in A.A.V.V., Processo penale e criminalità organizzata, a cura di V. Grevi, Bari 1993.
D’AMBROSIO L., Collaboratori di giustizia. Breve analisi
della disciplina vigente e appunti per una sua possibile riforma, in Documenti Giustizia, I, n. 3, 1995.
D’AMBROSIO L., Nuovo e contestato regolamento sulla protezione dei collaboratori di giustizia, in Dir. pen. proc., I, n.
5, 1995.
D’AMBROSIO L., Testimoni e collaboratori di giustizia,
Padova 2002.
D’AMBROSIO L. – D’AMICO S., Considerazioni sulla normativa a tutela dei collaboratori di giustizia, Roma 1992.
D’AMICO S., Il collaboratore della giustizia, Roma 1995.
DELEHAJE E., Collaboratori di giustizia e misure alternative
alla detenzione: problemi applicativi ed uniformità interpretative, in Documenti Giustizia, I, n. 5, 1995.
DELLA CASA F., Estensibile all’entourage del collaboratore
la normativa premiale sull’illimitato accesso ai benefici
penitenziari?, in Cass. Pen., III, 1997.
DI MARIA F., Il sentire mafioso, Milano 1989.
DINO A., Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni,
l’opinione pubblica, Roma 2006.
DOMINIONI O., Verso l’obbligo di “collaborare”, in
Legislazione Penale, 1983.
Bibliografia
ALFONSO R. – ROBERTI F., Pentiti: norme poco chiare favoriscono equivoci e applicazioni arbitrarie, in Diritto e
Giustizia, 7 luglio 2001, n. 26.
32
Temi Romana
Saggi
MUSCO E., La premialità nel diritto penale, in A.A.V.V., La
legislazione premiale, Milano 1987.
NATOLI G., Problematiche concernenti il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, in Diritto e Giustizia, 15
settembre 2001, n. 31.
PADOVANI T., Il traffico delle indulgenze, “Premio” e
“Corrispettivo” nella dinamica della punibilità, in Riv. It.
dir. proc. pen., 1986.
PANTALEONE, Mafia: pentiti?, Bologna 1985.
PRESUTTI A., Alternative al carcere, regime delle preclusioni
e sistema della pena costituzionale, in A.A.V.V., Criminalità
organizzata e politiche penitenziarie, Milano 1994.
PRESTIPINO S., Nuovi condizionamenti e limiti per i benefici
penitenziari a condannati pericolosi, in Giust. Pen., II, 1993.
PRINCIPATO T., Mafia donna: le vestali del sacro e dell’onore, Palermo 1997.
RIZZA S., Una ragazza contro la Mafia – Rita Adria, Palermo
1993.
ROBERTI F., Nella netta distinzione tra premio e tutela un
contributo al superamento delle distorsioni, in Guida al
Diritto – Il sole 24 ore, 24 marzo 2001, n. 11.
RUGA RIVA C., Il premio per la collaborazione processuale,
Milano 2002.
SAMMARCO A., La collaborazione con la giustizia in fase
esecutiva, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., III, 1994.
SASSANO F., La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia alla luce della legge 13 febbraio 2001, n. 45, Torino
2002.
SIEBERT R., Le donne, la mafia, Milano 1994.
SPATARO A., Per i collaboratori di giustizia legge scoraggia
collaborazioni, in Diritto e Giustizia, 10 marzo 2001, n. 9.
TOMASONE V., Rigore e genuinità della collaborazione. I
pentiti nell’applicazione della legge, in Diritto e giustizia,
2003.
VIGNA P.L., La gestione giudiziaria del pentito: problemi
deontologici, tecnici e psicologici, in A.A.V.V., Chiamata in
correità e psicologia del pentitismo nel nuovo codice di procedura penale, Padova 1992.
FALCONE G., Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza, in Difesa penale, 1992.
FIORIO C., Sempre nuove questioni di diritto penitenziario: la
collaborazione come presupposto per i benefici, in Giur.
Cost., 1993.
FUMO M., Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di
giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni, Napoli 2001.
FUMO M., Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione tra velleità di riforma e resistenze del sistema, in
Cass. pen., 2003.
GIORDANO P., Profili premiali della risposta punitiva dello
Stato, in Cass. pen., 1997.
GIORDANO F.P. – TINEBRA G., Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni.
Il regime di protezione, in Dir. pen. proc., 2001.
INGRASCI O., Donne d’onore. Storie di mafia al femminile,
Milano 2007.
IOVINO F.P.C., Legge penitenziaria e lotta alla criminalità
organizzata, in Cass. Pen., I, 1992.
LAUDATI A., La collaborazione con la giustizia ed il verbale
illustrativo dei contenuti. Un “oggetto misterioso” introdotto dalla l. 45/01, in Diritto e giustizia, 2003.
LAUDI M., Imputati pentiti (sistema di protezione), in Dig.
Disc. Pen., VI, Torino 1992.
LO VERSO G. (a cura di), La mafia dentro. Psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo, Milano 1998.
LO VERSO G. – LO COCO G., La psiche mafiosa, storie di casi
clinici e collaboratori di giustizia, Milano 2003.
MADEO L., Donne di mafia, Milano 1994.
MANCUSO P. – MELILLO G., Osservazioni sul nuovo regolamento per il programma di protezione dei collaboratori di
giustizia, in Cass. Pen., I, 1995.
MARINI L., Un nodo cruciale e trascurato: la “gestione del
pentito”, in Questioni Giustizia, n. 3, 1986.
MELLINI M., Il giudice e il pentito, Milano 1986.
MONTANARO G. – SILVESTRI F., Dalla mafia allo Stato, Torino
2005.
_________________
1 Tra le principali organizzazioni mafiose, il
minor numero di collaborazioni si riscontra
tra gli appartenenti alla ‘Ndrangheta calabrese. Questo perché il legame di sangue
creato all’interno del gruppo con matrimoni
e affiliazioni combinate rafforza l’omertà
persa e messa in pericolo in altre associazioni criminali, in primo luogo Cosa Nostra.
2 Vd. P. ARLACCHI, Addio Cosa Nostra. La
vita di Tommaso Buscetta, Milano 1994.
3 Sulla legislazione anteriore alla riforma
Temi Romana
del 2001 vd. A. BERNASCONI, I sistemi di
protezione per i collaboratori di giustizia
nella prospettiva premiale dell’ordinamento
italiano e nell’esperienza statunitense, in
A.A.V.V., Criminalità organizzata e politiche penitenziarie, Milano 1994, p. 139; ID.,
La collaborazione processuale. Incentivi di
protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense, Milano
1995; ID., Indissolubile il collegamento tra
collaborazione con la giustizia e benefici
penitenziari, in Cass. Pen., III, 1997, p.
33
3570; ID., Le immunità occulte. Fase dell’esecuzione penale ed ideologia premiale
tra razionalizzazione e garantismo, in
Politica del Diritto, Giugno 1997, n. 2, p.
193; L. CAMPOSARAGNA, La collaborazione
con la giustizia in fase esecutiva, in Dir.
pen. proc., II, 1997, n. 10, p. 1214; G.C.
CASELLI – A. INGROIA, Normativa premiale
e strumenti di protezione per i collaboratori
di giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d’emergenza, in A.A.V.V., Processo
penale e criminalità organizzata, a cura di
Saggi
V. Grevi, Bari 1993, p. 205; L.
D’AMBROSIO, Collaboratori di giustizia.
Breve analisi della disciplina vigente e
appunti per una sua possibile riforma, in
Documenti Giustizia, I, 1995, n. 3, p. 315;
ID., Nuovo e contestato regolamento sulla
protezione dei collaboratori di giustizia, in
Dir. pen. proc., I, 1995, n. 5, p. 626; L.
D’AMBROSIO – S. D’AMICO, Considerazioni
sulla normativa a tutela dei collaboratori di
giustizia, Roma 1992; S. D’AMICO, Il collaboratore della giustizia, Roma 1995; E.
DELEHAJE, Collaboratori di giustizia e misure alternative alla detenzione: problemi
applicativi ed uniformità interpretative, in
Documenti Giustizia, I, 1995, n. 5, p. 729;
F. DELLA CASA, Estensibile all’entourage
del collaboratore la normativa premiale
sull’illimitato accesso ai benefici penitenziari?, in Cass. Pen., III, 1997, p. 3582; O.
DOMINIONI, Verso l’obbligo di “collaborare”, in Legislazione Penale, 1983, p. 604; G.
FALCONE, Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza, in Difesa penale, 1992; C. FIORIO,
Sempre nuove questioni di diritto penitenziario: la collaborazione come presupposto
per i benefici, in Giur. Cost., 1993; P.
GIORDANO, Profili premiali della risposta
punitiva dello Stato, in Cass. pen., 1997;
F.P.C. IOVINO, Legge penitenziaria e lotta
alla criminalità organizzata, in Cass. Pen.,
I, 1992, p. 438; M. LAUDI, Imputati pentiti
(sistema di protezione), in Dig. Disc. Pen.,
VI, Torino 1992, p. 272; P. MANCUSO – G.
MELILLO, Osservazioni sul nuovo regolamento per il programma di protezione dei
collaboratori di giustizia, in Cass. Pen., I,
1995, p. 250; L. MARINI, Un nodo cruciale e
trascurato: la “gestione del pentito”, in
Questioni Giustizia, 1986, n. 3, p. 705; E.
MUSCO, La premialità nel diritto penale, in
A.A.V.V., La legislazione premiale, Milano
1987, p. 115; T. PADOVANI, Il traffico delle
indulgenze, “Premio” e “Corrispettivo”
nella dinamica della punibilità, in Riv. It.
dir. proc. pen., 1986, p. 398; M.
PANTALEONE, Mafia: pentiti?, Bologna
1985; A. PRESUTTI, Alternative al carcere,
regime delle preclusioni e sistema della
pena costituzionale, in A.A.V.V., Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,
Milano 1994, p. 59; S. PRESTIPINO, Nuovi
condizionamenti e limiti per i benefici penitenziari a condannati pericolosi, in Giust.
Pen., II, 1993, p. 252; A. SAMMARCO, La
collaborazione con la giustizia in fase esecutiva, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., III, 1994,
p. 871.
con la giustizia ed il verbale illustrativo dei
contenuti. Un “oggetto misterioso” introdotto dalla l. 45/01, in Diritto e giustizia, 2003.
4 Per approfondimenti vd. R. ALFONSO – F.
ROBERTI, Pentiti: norme poco chiare favoriscono equivoci e applicazioni arbitrarie, in
Diritto e Giustizia, 7 luglio 2001, n. 26, p.
46; M. ALMA, Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di
pentiti e testimoni. Sanzioni difesa e regime
transitorio, in Dir. pen. proc., 2001; S.
ARDITA, La nuova legge sui collaboratori e
sui testimoni di giustizia, in Cass. pen.,
2001; A. DINO, Pentiti. I collaboratori di
giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica,
Roma 2006; M. FUMO, Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori
di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni, Napoli 2001; F.P. GIORDANO – G.
TINEBRA, Nuova disciplina della protezione
e del trattamento sanzionatorio di pentiti e
testimoni. Il regime di protezione, in Dir.
pen. proc., 2001; G. MONTANARO – F.
SILVESTRI, Dalla mafia allo Stato, Torino
2005; C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano 2002; F.
SASSANO, La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia alla luce della legge 13
febbraio 2001, n. 45, Torino 2002; A.
SPATARO, Per i collaboratori di giustizia
legge scoraggia collaborazioni, in Diritto e
Giustizia, 10 marzo 2001, n. 9, p. 9.
9 Vd. Art. 16 quater, L. 82/91.
5 L’art. 9, L. 82/91, espunto il richiamo
all’art. 380 c.p.p., ad oggi prevede la rilevanza delle sole collaborazioni concernenti
“delitti commessi per finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’art. 51,
comma 3bis, del codice di procedura penale
e agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater
…e 600 quinquies del codice penale”.
6 Vd. V. TOMASONE, Rigore e genuinità della
collaborazione. I pentiti nell’applicazione
della legge, in Diritto e giustizia, 2003.
7 Il dichiarante deve essere collocato in
apposite sezioni dell’istituto carcerario che
ne garantiscano l’isolamento e ne tutelino
l’incolumità personale. Non è invece più
prevista la detenzione extracarceraria.
8 Vd. M. FUMO, Il verbale illustrativo dei
contenuti della collaborazione tra velleità di
riforma e resistenze del sistema, in Cass.
pen., 2003; A. LAUDATI, La collaborazione
34
10 Vd. F. ROBERTI, Nella netta distinzione
tra premio e tutela un contributo al superamento delle distorsioni, in Guida al Diritto –
Il sole 24 ore, 24 marzo 2001, n. 11, p. 45.
11 Vd. G. NATOLI, Problematiche concernenti il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, in Diritto e Giustizia, 15
settembre 2001, n. 31.
12 Nel caso di dichiarazioni false o violazioni
dei doveri imposti al pentito, può essere
disposta anche la revisione del processo nel
quale sono stati applicati sconti di pena o attenuanti per effetto della collaborazione resa.
13 Le dichiarazioni peraltro devono presentare il solo connotato dell’attendibilità, e
non anche quelli della novità o dell’importanza. Vd. anche L. D’AMBROSIO, Testimoni
e collaboratori di giustizia, Padova 2002.
14 Sugli aspetti criminologici connessi al
fenomeno del pentitismo vd. F. DI MARIA, Il
sentire mafioso, Milano 1989; G. LO VERSO
(a cura di), La mafia dentro. Psicologia e
psicopatologia di un fondamentalismo,
Milano 1998; LO VERSO – G. LO COCO, La
psiche mafiosa, storie di casi clinici e collaboratori di giustizia, Milano 2003;
P.L.VIGNA, La gestione giudiziaria del pentito: problemi deontologici, tecnici e psicologici, in A.A.V.V., Chiamata in correità e
psicologia del pentitismo nel nuovo codice
di procedura penale, Padova 1992.
15 Vd. P. ARLACCHI, Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande
pentito Antonio Calderone, Milano 1991.
16 Vd. O. INGRASCI, Donne d’onore. Storie
di mafia al femminile, Milano 2007; L.
MADEO, Donne di mafia, Milano 1994; T.
PRINCIPATO, Mafia donna: le vestali del
sacro e dell’onore, Palermo 1997; R.
SIEBERT, Le donne, la mafia, Milano 1994.
17 Esempio emblematico della forza del
legame che si crea con il magistrato è il suicidio di Rita Adria, seguito alla morte di
Paolo Borsellino. Vd. S. RIZZA, Una ragazza contro la Mafia – Rita Adria, Palermo
1993. Sul rapporto tra il collaboratore e il
magistrato vd. anche M. MELLINI, Il giudice
e il pentito, Milano 1986.
Temi Romana
Saggi
Competenza legislativa concorrente in materia
di coordinamento della finanza pubblica e vincoli
di riequilibrio finanziari anche nei confronti delle Regioni
a statuto speciale: ultime pronunce in tema
della Corte costituzionale e prospettive di riforma
Maria Giulia Putaturo Donati
Sommario: 1. – Sulla nozione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sulla competenza del legislatore statale a prevedere nei confronti delle Regioni (anche a statuto speciale) vincoli di riequilibrio
della finanza pubblica; 2. – Sulla “naturale” incidenza di norme costituenti «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» sull’autonomia finanziaria e sulle altre competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; 3. – Sulla tecnica dell’accordo nel regime dei rapporti finanziari tra StatoRegioni a statuto speciale e Province autonome; 4. – La materia del «coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario»: da competenza legislativa concorrente a competenza esclusiva dello Stato?
1.
Sulla nozione di principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica e
sulla competenza del legislatore statale a
prevedere nei confronti delle Regioni (anche a statuto speciale) vincoli di riequilibrio della finanza
pubblica
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma1, Costituzione tra le
materie oggetto di competenza legislativa concorrente
Stato-Regioni rientra quella del «coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario».
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Da qui la ripartizione, in materia, della c.d. legislazione di principio allo Stato e di quella c.d. di dettaglio
alle Regioni.
Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale,
possono essere ritenute “principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi
del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si
limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza
pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o
modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»
(sentenze n. 193 e n. 148 del 2012; conformi, ex pluriTemi Romana
mis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010; n. 297
del 2009; n. 237 del 2009) in modo che rimanga uno
spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale
(sentenza n. 182 del 2011)2.
Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi
dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l’entità del disavanzo di parte corrente
oppure – ma solo “in via transitoria ed in vista degli
specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica
perseguiti dal legislatore statale” – la crescita della
spesa corrente»3. In altri termini, la legge statale può
stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli
enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra
i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 44 del
2014; 236 del 2013; n. 182 del 2011; n. 417 del 2005
e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del
2006 e n. 449 del 2005) e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle
Regioni e degli enti locali, tali da ledere l’autonomia
finanziaria di spesa garantita dall’art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n. 169 del 2007; n. 417 del
2005; n. 36 del 2004).
Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione, da
parte della legge statale, di un limite all’entità di una
singola voce di spesa della Regione non può essere
considerata un principio fondamentale in materia di
35
Saggi
2012, n. 135 – che impone alle Regioni la soppressione o la limitazione degli enti, agenzie ed organismi
strumentali all’esercizio di funzioni fondamentali o di
funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e
Città metropolitane – ha posto in rilievo, al fine di qualificare la norma impugnata effettivamente come principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, solo il requisito dell’intervento di “limite
complessivo e globale ” alla spesa pubblica).
Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve
ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo
prefissato (sentenza n. 236 del 2012).
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale è ormai
consolidato l’orientamento secondo cui il legislatore
statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi
nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si
traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette
all’autonomia di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentenze n. 236 del 2013; n. 182 del 2011, n. 207
e n. 128 del 2010).
La Corte ha avuto modo di affermare che non è contestabile «il potere del legislatore statale di imporre agli
enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario
connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche
dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di
bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente,
in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli
enti», e che, «in via transitoria e in vista degli specifici
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possono anche imporsi limiti
complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti
autonomi (sentenze n. 82 del 2007; n. 36 del 2004).
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale,
«la stessa nozione di principio fondamentale non può
essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va
compiuto e della peculiarità della materia» (sentenze
n. 23 del 2014; n. 16 del 2010
Inoltre, la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere “di principio” di una
norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da
un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria
integrazione (sentenze n. 23 del 2014; n. 16 del 2010;
n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007).
La Corte ha sottolineato la legittimità di disposizioni di
dettaglio in “rapporto di coessenzialità e di necessaria
armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo
comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve, di conseguenza, in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art.
119 Cost. all’autonomia finanziaria delle Regioni. Ad
esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad
esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non
imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (ex
multis, sentenze n. 95 del 2007; n. 88 del 2006, nn. 449
e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).
In altre pronunce, la Corte costituzionale ha precisato
che lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi
rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). Quindi
anche allorquando le disposizioni in esame (come per la
disciplina dettata dall’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010
– come la Corte ha chiarito con la richiamata sentenza
n. 182 del 2011 – prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ciò non
esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di
allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa
(sentenza n. 139 del 20124). In caso contrario, la norma
statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n.
159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione
operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).
Può essere, in altri termini, imposto alle Regioni un
«limite globale, complessivo, al punto che ciascuna
Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle
varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti,
in modo graduato e differenziato, purché il risultato
complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (sentenze n. 229 del 2013; n. 36 del 2013; sentenza
n. 211 del 2012).
Il carattere della «transitorietà» o temporaneità dell’intervento legislativo di contenimento della spesa corrente sembrerebbe essere evidenziato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale allorquando l’incidenza sulla
spesa corrente sia immediata (da ultimo, sentenza n. 44
del 2014), non già quando si tratti di intervento con
incidenza indiretta sulla spesa corrente (si veda, a tal
proposito, la sentenza n. 236 del 2013 nella quale la
Corte, nel valutare la legittimità costituzionale dell’art.
9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
36
Temi Romana
Saggi
go indefettibile di tutti gli enti del settore pubblico
allargato di cui anche le Regioni devono farsi carico
attraverso un accollo proporzionato degli oneri complessivi conseguenti alle manovre di finanza pubblica
(ex plurimis, sentenza n. 52 del 2010).
La finanza delle Regioni a statuto speciale è, infatti, parte
della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato
aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica,
connessi anche ai vincoli europei (ex plurimis, sentenze
n. 39 del 2014; n. 60 del 2013; n. 219 del 2013, n. 198 del
2012, n. 179 del 2007; n. 425 del 2004; n. 416 del 1995;
n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto
di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004).
La Corte costituzionale, perciò, ha già ritenuto che «nel
nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma,
allo Stato sia pur sempre riservata, nell’ordinamento
generale della Repubblica, una posizione peculiare
desumibile non solo dalla proclamazione di principio
di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal
richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà
legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (articolo 120, secondo
comma). E tale istanza postula necessariamente che nel
sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, avente il
compito di assicurarne il pieno soddisfacimento» (sentenza n. 274 del 2003). (sentenza n. 219 del 2013).
Il legislatore statale può legittimamente imporre agli
enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti), ma solo, con
«disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 417
del 2005; n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del
2003 e n.n. 4 e 390 del 2004).
La Corte ha posto in rilievo che limiti finanziari per le
Regioni e gli enti locali, volti al perseguimento degli
obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della
spesa, sono in linea con la più recente interpretazione
della nozione di «coordinamento della finanza pubblica» fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale,
ormai «costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono
espressione della finalità di coordinamento finanziario»,
integrazione” con le norme di principio e, pertanto,
inderogabili (sentenza n. 355 del 1993).
In quest’ottica, sono state ricondotte «nell’ambito dei
principi di coordinamento della finanza pubblica
“norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare
in concreto la finalità del coordinamento finanziario,
che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei
livelli territoriali sub-statali” (sentenza n. 237 del 2009
e già sentenza n. 417 del 2005). (sentenze n. 44 e n. 23
del 2014; n. 52 del 2010).
La Corte ha affermato che, sebbene sia norma a contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la
finalità perseguita, in “rapporto di coessenzialità e di
necessaria integrazione” con le norme-principio [che
connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale
in ordine alla disciplina prevista per i “debiti” e i “crediti” delle soppresse unità sanitarie locali]». (sentenza
n. 108 del 2010; n. 89 del 2000).
La Corte ha messo pure in rilievo il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento e, quindi, l’esigenza
che «a livello centrale» si possano collocare anche «i
poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata»
(sentenza n. 229 del 2011; n. 376 del 2003, già citata).
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ed ha, altresì,
precisato come la piena attuazione del coordinamento
della finanza pubblica possa far sì che la competenza
statale non si esaurisca con l’esercizio del potere legislativo, ma implichi anche «l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 229 del 2011; n.
376 del 2003; in senso conforme, sentenze n. 112 del
2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008).
Le norme che pongono un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica attinente alla
spesa, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, devono ritenersi applicabili «anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di
partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle
a statuto speciale, all’azione di risanamento della finanza pubblica» (sentenze n. 120 del 2008; 169 e n. 82 del
2007). La giurisprudenza della Corte è, infatti, costante nell’affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal
rispetto dei principi di coordinamento della finanza
pubblica (da ultimo, sentenze n. 72 del 2014; n. 139 del
2012; n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011).
Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è un obbliTemi Romana
37
Saggi
vinciale» (sentenza n. 159 del 2008)].
Dall’accertata natura di principio fondamentale [in
materia «coordinamento della finanza pubblica]
discende, in base alla giurisprudenza della Corte, la
legittimità dell’incidenza della censurata disposizione
sia sull’autonomia di spesa delle Regioni (si vedano, ex
plurimis, sentenze n. 151 del 2012; n. 91 del 2011, n.
27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni tipo
di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di comunità montane (sentenze n. 326
del 2010 e n. 237 del 2009).
La Corte ha precisato che il legittimo esercizio della
competenza statale di coordinamento della finanza
pubblica è limite all’autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 190 del 2008; n.
82 del 2007).
Soltanto se il limite posto dalla legge statale non costituisce un principio di coordinamento esso si configura
come “un illegittimo vincolo all’autonomia di spesa e
finanziaria garantita dallo statuto speciale e con disposizioni non unilateralmente derogabili dalle norme di
attuazione”. Ma se si tratta di principi statali di coordinamento della finanza pubblica essi si impongono nell’esercizio dell’autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (sentenza n. 190 del 2008) .
La Corte ha, altresì, affermato che l’eventuale impatto di
una norma, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo,
Cost.), [pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza
legislativa concorrente dello Stato] sull’autonomia
finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma
quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della
legittimità costituzionale» (sentenze n. 236 del 2013; n.
40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).
Pertanto, la ormai consolidata giurisprudenza della
Corte in materia di coordinamento della finanza pubblica, consente di fare arretrare i confini delle competenze
statutarie (anche delle regioni speciali) ovvero di incidere anche su materie riconducibili a tali competenze.
Pertanto, nessuna “dispensa” per le autonomie speciali:
i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario (di cui all’art. 119 Cost.) costituiscono un limite inderogabile anche per le regioni ad autonomia differenziata.
per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare
l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva,
in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (così,
sentenze n. 326 del 2010; n. 52 del 2010, nonché sentenze n. 237 e n. 139 del 2009). Tali vincoli, riconducibili ai “princípi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica”, si impongono alle autonomie speciali solo in ragione dell’imprescindibile esigenza di assicurare l’unitarietà delle politiche complessive di spesa
che lo Stato deve realizzare – sul versante sia interno
che comunitario e internazionale – attraverso la «partecipazione di tutte le Regioni [...] all’azione di risanamento della finanza pubblica» e al rispetto del cosiddetto “patto di stabilità”. (sentenza n. 102 del 2008).
2. Sulla “naturale” incidenza di norme costituenti
«principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica» sull’autonomia finanziaria e
sulle altre competenze legislative delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome
Nell’ambito di una competenza concorrente quale è il
coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente la
Corte costituzionale ha stimato recessiva la dimensione
dell’autonomia finanziaria5 ed organizzativa della
Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi
sull’intero territorio nazionale e costituenti principi
fondamentali della materia (ex plurimis, sentenze n.
219 del 2013; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36
del 2004).
La Corte ha sottolineato che «dinanzi ad un intervento
legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell’àmbito di una
materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi
una, per quanto parziale, compressione degli spazi
entro cui possano esercitarsi le competenze legislative
ed amministrative di Regioni e Province autonome
(specie in tema di organizzazione amministrativa o di
disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante» (fra le molte, si vedano le
sentenze n. 159 del 2008; n. 169 e n. 162 del 2007; n.
353 e n. 36 del 2004).
La giurisprudenza costituzionale ha espressamente
riconosciuto che disposizioni statali di principio in
tema di coordinamento della finanza pubblica, ove
costituzionalmente legittime, possono «incidere su una
materia di competenza della Regione e delle Province
autonome (sentenze n. 229 del 2013; 188 del 2007, n. 2
del 2004 e n. 274 del 2003) [come l’organizzazione ed
il funzionamento dell’amministrazione regionale e pro-
3. Sulla tecnica dell’accordo nel regime dei rapporti finanziari tra Stato-Regioni a statuto speciale e
Province autonome
L’obbligo generale di partecipazione di tutte le
Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale,
38
Temi Romana
Saggi
statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale» (comma 2, secondo
periodo). La Corte costituzionale ha ritenuto che tale
norma riportata possiede una portata generale ed esclude – ove non sia espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva – che
le previsioni finalizzate al contenimento della spesa
pubblica possano essere ritenute applicabili alle
Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari
procedure previste dai rispettivi statuti. Tale principio è
stato successivamente ribadito dalla normativa richiamata dalle parti ed, in particolare, dall’art. 8, comma 4,
del D.Lgs. n. 216 del 2010, e dall’art. 1, commi 128 e
129, della legge n. 220 del 2010. L’estensione alle
Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta
dal legislatore, salva naturalmente ogni valutazione
sulla legittimità costituzionale di tale estensione, nei
singoli casi in cui essa sia prevista. In caso di silenzio,
resta valido il principio generale di cui al citato art. 27
della legge n. 42 del 2009. (sentenza n. 193 del 2012).
L’art. 27, infatti, pone una vera e propria «riserva di
competenza alle norme di attuazione degli statuti» speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli
enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del
2012), così da configurarsi quale autentico presidio
procedurale della specialità finanziaria di tali enti.( in
tal senso, si veda la sentenza n. 241 del 2012).
Il punto di raccordo tra autonomia finanziaria delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e
coordinamento della finanza pubblica è dato dallo strumento dell’accordo ovvero dal principio bilaterale che
caratterizza in maniera pregnante il rapporto tra regioni speciali e Stato.
Pertanto, l’applicazione del metodo dell’accordo bilaterale 8 in riferimento al patto di stabilità interno, deve
considerarsi un’espressione della descritta autonomia
finanziaria e del contemperamento di tale principio con
quello del rispetto dei limiti di spesa imposti dal cosiddetto patto di stabilità interno (“i limiti del coordinamento devono essere contemperati con la speciale
autonomia in materia finanziaria”)9.
A differenza delle regioni ordinarie, nel caso delle
Regioni speciali l’adeguamento dell’ordinamento
finanziario ai principi di coordinamento della finanza
pubblica passa non solo per la via delle norme di attuazione, ma anche attraverso la modifica statutaria da
attuarsi anche essa nel rispetto del metodo dell’accordo
e secondo i procedimenti di collaborazione previsti
dagli statuti.10
In particolare, ai sensi dell’art. 104 dello Statuto del
all’azione di risanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del 1995 e successivamente, anche se non
con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, le sentenze n. 417 del 2005 e nn. 353, 345 e 36 del
2004) deve essere contemperato e coordinato con la
speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette Regioni, in forza dei loro statuti (sentenza n. 82 del 2007). In tale prospettiva, la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare, che la previsione normativa del metodo dell’accordo tra le
Regioni a statuto speciale e il Ministero dell’economia
e delle finanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un’espressione della descritta
autonomia finanziaria e del contemperamento di tale
principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa
imposti dal cosiddetto “patto di stabilità” (sentenza n.
353 del 2004).
La Corte nella sentenza n. 82 del 2007 ha affermato che
il «metodo dell’accordo», introdotto per la prima volta
dall’ [art. 48, comma 26] legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), seguito dall’art. 28, comma 15, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), e riprodotto in tutte le
leggi finanziarie successivamente adottate [ dalla legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2000), fino alla legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007)], deve essere tendenzialmente preferito ad
altri, dato che «la necessità di un accordo tra lo Stato e
gli enti ad autonomia speciale nasce dall’esigenza di
rispettare l’autonomia finanziaria di questi ultimi».
L’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 427 (Delega al
governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione) prevede, in particolare,
che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità
interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario «nel rispetto degli statuti speciali» e «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di
attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (comma 1); b)
alle norme di attuazione statutaria è affidata la disciplina delle «specifiche modalità attraverso le quali lo
Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà per le regioni a
Temi Romana
39
Saggi
za pubblica ha trovato sanzione legislativa, attraverso
leggi ordinarie (rinforzate) volte a modificare le disposizioni statutarie in materia di ordinamento finanziario.
In particolare, in attuazione del processo di riforma in
senso federalista contenuto nella legge delega n. 42 del
2009, con legge ordinaria “rinforzata” (ovvero adottata
ai sensi dell’art. 104 dello Statuto del Trentino-Alto
Adige su concorde richiesta dello Stato e della Regione
e delle Province) del 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,
commi 106-126, si è proceduto a sostituire il Titolo VI
(Finanza della regione e delle province) dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, delineando
un nuovo sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la
Regione e le Province autonome. L’autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore
statale, dalle relative norme di attuazione introdotte dai
decreti legislativi n. 266 del 16 marzo 1992 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e
leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di
indirizzo e coordinamento) e n. 268 del 16 marzo 1992
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale) nonché dalla legge 30 novembre 1989, n.
386 (Norme per il coordinamento della finanza della
Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria).
(sentenza n.190 del 2008). Negli articoli che vanno da
69 a 86 dello statuto speciale sono regolati i rapporti
finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi
erariali. Inoltre, il primo comma dell’art. 104 dello stesso statuto stabilisce che « Fermo quanto disposto dall’articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell’art. 13
possono essere modificate con legge ordinaria dello
Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di
rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le
modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l’art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative
all’autonomia finanziaria su concorde richiesta del
Governo, della Regione o delle Province, introduce una
deroga alla regola prevista dall’art. 103, che impone il
procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire
tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. (sentenza n. 133 del 2010).
Trentino-Alto Adige, « Fermo quanto disposto dall’art.
103 le norme del Titolo VI (Finanza della Regione e
delle Province) e quelle dell’art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province».
L’art. 63, quinto comma, dello Statuto del FriuliVenezia Giulia recita: «Le disposizioni contenute nel
titolo IV (Finanze, Demanio e patrimonio della
Regione) possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del
governo e della regione e in ogni caso, sentita la
regione».
L’art. 50, quinto comma, dello Statuto Valle d’Aosta
«Entro due anni dall’elezione del Consiglio della Valle,
con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13 (disposizioni in materia di ordinamento finanziario) un ordinamento finanziario della regione».
L’art. 54, quinto comma, dello Statuto Sardegna:«Le
disposizioni del Titolo III (Finanze, Demanio e patrimonio) del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta
del governo o della regione; in ogni caso sentita la
regione».
Analoga disposizione non è contenuta nello statuto
della Regione Sicilia.
In questo quadro si collocano gli Accordi siglati tra tre
delle Regioni speciali e lo Stato tra il 2009 e il 2010.
Nello specifico, il primo ad essere siglato è stato il c.d.
«Accordo di Milano» stipulato il 30 novembre 2009 tra
il Governo e le Province autonome di Trento e di
Bolzano. Successivamente, il 29 ottobre 2010, è stato
siglato il protocollo d’intesa tra Governo e Regione
Friuli-Venezia Giulia ed, infine, l’11 novembre dello
stesso anno, quello con la Valle d’Aosta.
Al di là dei contenuti (specifici per ciascuna regione),
tali Accordi dal punto di vista procedurale seguono lo
stesso percorso. I contenuti sono, infatti, confluiti , il
primo (siglato dal Trentino-Alto Adige) nella legge n.
191 del 2009 (art. 2, commi 107 e 125) (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2010); gli altri due, nella
legge n. 220 del 2010 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di
stabilità 2011), art. 1, commi 151-159 (Accordo siglato
dal Friuli-Venezia Giulia) e commi 160-164 (il testo
siglato dalla Valle d’Aosta).
Dunque, prima ancora che tradursi nelle norme di
attuazione, la definizione bilaterale delle misure da
assumere per gli obiettivi di coordinamento della finan40
Temi Romana
Saggi
za legislativa concorrente a competenza esclusiva
dello Stato?
Il disegno di legge di revisione costituzionale
(“Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
Titolo V della parte seconda della Costituzione”)
– testo approvato dal Consiglio dei ministri del 31
marzo 2014 – reca – tra l’altro – disposizioni concernenti la revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione.
Il progetto di revisione del Titolo V – finalizzato a
garantire un effettivo bilanciamento tra interessi nazionali, regionali e locali nonché politiche di programmazione territoriale coordinate con le ampie scelte strategiche a livello nazionale – prevede: 1) il superamento
dell’attuale frammentazione delle competenze legislative tra Stato e Regioni; 2) l’introduzione di una “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale,
su proposta del Governo, può intervenire su materie o
funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, se lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o lo rende necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale; 3) l’introduzione
della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle
materie di propria competenza esclusiva, salvo alcune
eccezioni; 4) il riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare.
Le linee direttrici del progetto di riforma contemplano
– tra l’altro – l’eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” nonché la conseguente ridefinizione
delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle
“residuali” delle Regioni.
Con particolare riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»,
la stessa andrebbe ad integrare l’elenco delle materie e
delle funzioni di competenza statale “esclusiva”.
Da qui, in prospettiva, la possibile fine di tutto quel
contenzioso costituzionale volto a stabilire, in materia,
i difficili margini tra legislazione c.d. di principio e
legislazione c.d. di dettaglio.
Nei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni speciali
e le Province autonome, la giurisprudenza costituzionale sembra essere orientata a ritenere il metodo dell’accordo non già come prima lo strumento tendenzialmente preferito ad altri (sentenza n. 82 del 2007) ma «ormai
lo strumento consolidato (in quanto già presente nella
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e poi confermato da tutte le disposizioni che si sono occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare in
modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a
statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la
tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata (ex plurimis, sentenza n. 353 del
2004)» (sentenza n. 118 del 2012). In tal senso, si vedano anche le sentenze n. 241 del 2012; 215 del 2012 e n.
193 del 2012, n. 178 del 2012.
Da ultimo, si è però precisato che la procedura concertata non è costituzionalmente necessitata e che può
essere derogata in particolari contesti di grave crisi economica.
In particolare, nella sentenza n. 23 del 2014, la Corte
ha affermato che l’invocato art. 27 della legge n. 42
del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto
dall’art. 119 Cost., pur ponendo «una vera e propria
“riserva di competenza alle norme di attuazione degli
statuti” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza
n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico
presidio procedurale della specialità finanziaria di tali
enti» (sentenza n. 241 del 2012), ha il rango di legge
ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo
avente la medesima forza normativa. Ne consegue che,
specie in un contesto di grave crisi economica [quale
quello in cui si è trovato ad operare il legislatore] esso
possa discostarsi dal modello consensualistico nella
determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenza n. 193 del 2012), fermo restando il necessario
rispetto della sovraordinata fonte statutaria (sentenza
n. 198 del 2012).
4. La materia del «coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario»: da competen_________________
1 Comma così modificato dalla lettera b)
del comma 1 dell’art. 3, L.Cost. 20 aprile
2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata
L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 dell’art. 6
Temi Romana
della stessa, a decorrere dall’esercizio
finanziario relativo all’anno 2014; in dottrina, da ultimo, G.L. TOSATO, La riforma
Costituzionale sull’equilibrio di bilancio
alla luce della normativa dell’unione: l’in-
41
terazione fra i livelli europeo e interno, in
Rivista di Diritto Internazionale, fasc. 1,
2014, p. 5.
2 In dottrina, sul tema, M. BELLETTI, Forme
di coordinamento della finanza pubblica e
Saggi
incidenza sulle competenze regionali. Il
coordinamento per principi, di dettaglio e
“virtuoso” ovvero nuove declinazioni dell’unità economica e dell’unità giuridica, in
www.issirfa.cnr.it., 2013; M. BARBERO,
Rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di diritto tributario, diritto
pubblico dell’economia e finanza pubblica
(gennaio-giugno 2013), in Rivista di Diritto
Finanziario e Scienza delle Finanze, fasc.
2, 2013, p. 212; G. AMOROSO, Rassegna
delle sentenze dichiarative di illegittimità
costituzionale dell’anno 2012 - con particolare riguardo al paragrafo 22. Principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.),
Giust. civ., fasc. 1, 2013, p. 3.
3 Nella sentenza n. 36 del 2004, la Corte ha
affermato che «È ben vero che, stabilito il
vincolo alla entità del disavanzo di parte
corrente, potrebbe apparire superfluo un
ulteriore vincolo alla crescita della spesa
corrente, potendo il primo obiettivo conseguirsi sia riducendo le spese, sia accrescendo le entrate. Tuttavia il contenimento del
tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio
finanziario, ed infatti esso è indicato fin
dall’inizio fra le azioni attraverso le quali
deve perseguirsi la riduzione del disavanzo
annuo (cfr. art. 28, comma 2, lettera b, della
legge n. 448 del 1998, nonché art. 28,
comma 2 bis, della stessa legge, aggiunto
dall’art. 30, comma 8, della legge n. 488 del
1999). Non può dunque negarsi che, in via
transitoria ed in vista degli specifici obietti-
vi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, quest’ultimo
possa, nell’esercizio non irragionevole
della sua discrezionalità, introdurre per un
anno anche un limite alla crescita della
spesa corrente degli enti autonomi, tenendo
conto che si tratta di un limite complessivo,
che lascia agli enti stessi ampia libertà di
allocazione delle risorse fra i diversi ambiti
e obiettivi di spesa.».
4 Nella sentenza n. 139 del 2012, la Corte
costituzionale, nel valutare la legittimità
della disciplina dettata dall’art. 6 del D.L.
n. 78 del 2010 ha affermato: «L’art. 6 citato «consente un processo di induzione che,
partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco,
conduce all’isolamento di un principio
comune» (sentenza n. 182 del 2011). In
base a tale principio, le Regioni devono
ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non
inferiore a quello disposto dall’art. 6 per lo
Stato. Ne deriva che il medesimo articolo
«non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza
n. 182 del 2011).
5 In dottrina, F. STRADINI, Autonomia impositiva delle Regioni a statuto speciale: il
riconoscimento costituzionale e l’erosione
del primato tra Corte costituzionale e diritto comunitario, in Rivista di Diritto
Tributario, fasc. 12, 2013, p. 1201.
6 L’art. 48, comma 2, della legge n. 449 del
1997 ha previsto che le Regioni a statuto
42
speciale e le Province autonome concorressero agli obiettivi di stabilizzazione finanziaria secondo criteri e procedure stabilite
d’intesa tra il Governo e i presidenti delle
giunte regionali e provinciali nell’ambito
delle procedure previste negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.
7 Sul tema, C. TUCCIARELLI, La legge n. 42/
2009: oltre l’attuazione del federalismo
fiscale, in Riv. dir. trib., fasc. 1, 2010, p. 61;
A. GIOVANARDI, Il riparto delle competenze
tributarie tra giurisprudenza costituzionale
e legge delega in materia di federalismo
fiscale, in Riv. dir. trib., fasc. 1, 2010, p. 29.
8 Si veda, la sentenza n. 353 del 2004, nella
quale si afferma che il coinvolgimento delle
Regioni speciali nel patto di stabilità interno avviene tenendo conto delle particolari
modalità individuate dalle relative disposizioni legislative ovvero d’intesa tra il
Governo e i presidenti delle Giunte.
9 In tal senso, L. CAVALLINI CADEDDU,
“Indicazioni giurisprudenziali per il coordinamento dinamico della finanza pubblica”, in www. federalismi.it, 1; Corte costituzionale e coordinamento dinamico della
finanza pubblica, in L. CAVALLINI CADEDDU
(a cura di), Il coordinamento dinamico
della finanza pubblica, Napoli 2012.
10 G. PERNICIARO, Le fonti dell’autonomia
finanziaria delle regioni speciali. “Prima”
dei decreti legislativi di attuazione: gli
accordi bilaterali, in M. CARTABIA, E.
LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli
atti normativi del Governo, tra Corte
costituzionale e giudici, Torino 2011, pp.
427-436.
Temi Romana
Saggi
Criteri d’individuazione del titolare della qualifica
soggettiva nell’ambito delle organizzazioni complesse e
operatività della delega di funzioni, con particolare
riferimento alla responsabilità di Amministratori e Sindaci
di società
Parte I – Delega di funzioni, teorie e criteri
Francesca Zignani
Avvocato
N
ell’ambito delle c.d. organizzazioni complesse
uno dei problemi di maggior rilievo, sotto il
profilo del diritto penale, concerne l’accertamento in ordine ai criteri che presiedono all’attribuzione della responsabilità in capo alle persone fisiche, che
al loro interno vi operano. La problematica trae origine dalla circostanza che tali organizzazioni (società,
enti pubblici, le associazioni e ogni altra entità anche
non personificata) sono caratterizzate da una complessa distribuzione e ripartizioni di compiti e funzioni, le
quali possono essere attribuite in via originaria o a titolo derivativo, ed il cui omesso o inesatto assolvimento
può determinare la lesioni di beni presidiati dalla sanzione penale.
La soluzione del problema è contesa tra l’esigenza, da
un lato, di evitare che la ripartizione dei compiti e delle
funzioni suindicati si riverberi negativamente sul principio di inderogabilità del precetto penale – mediante
l’oscuramento dei meccanismi di individuazione dei
soggetti responsabili dei fatti di reato – e quella, dall’altro, tesa ad evitare l’adozione di soluzioni che
implichino forme di responsabilità c.d. “di posizione”,
contrarie al principio di legalità.
In effetti, da alcuni si ritiene che la tematica della delega di funzioni si sovrapponga a quella della ripartizione di funzioni all’interno di organizzazioni articolate.
In realtà, si tratta di un falso problema o di una prospettiva errata: un conto è individuare, infatti, le persone fisiche che, all’interno di questi organismi, sono
titolari dei poteri, dai quali deriva la loro responsabiliTemi Romana
tà in caso di violazione dei doveri inerenti la loro funzione. Altra cosa è la delega di funzioni, concernente
un momento temporale successivo e, cioè, la facoltà
dei titolari di attribuire, ad altre persone fisiche, le loro
funzioni, da cui possono derivare, per le ipotesi di
eventi di danno o di pericolo, forme di responsabilità.
Nel primo caso, si parla di assunzione a “titolo originario”, mentre nel secondo, l’assunzione avviene a
“titolo derivativo”; solo in questa ipotesi siamo in presenza di una delega o di un trasferimento di funzioni.
La distinzione chiarisce anche la differenza, per gli
enti collettivi, tra l’agire per conto dell’ente e l’agire
per conto di altra persona fisica; sebbene, in entrambi
i casi, colui che viene investito delle funzioni assume
una posizione di garanzia e, perciò, l’obbligo giuridico
di impedire eventi dannosi1.
Un primo obiettivo è quello di individuare i soggetti
sui quali, all’interno dell’organizzazione complessa,
incombe in via originaria l’obbligo giuridico di attivarsi, al fine evitare eventi dannosi a beni penalmente
tutelati.
Successivamente occorrerà affrontare, invece, la tematica della delega di funzioni (in senso stretto) ossia,
della procedura mediante la quale l’originario titolare
della posizione di garanzia trasferisce tale posizione ad
altro soggetto, operante all’interno della medesima
struttura complessa. Con riferimento alla delega si è
posto, soprattutto in passato, il problema: a) della ralativa ammissibilità, b) delle condizioni nonché c) degli
effetti che l’atto determina sotto il profilo della respon43
Saggi
sabilità penale. Attualmente, gli interrogativi predetti
trovano, per vero, agevole soluzione interpretativa in
virtù della disciplina normativa di cui al D.Lgs. 8-408, n. 812, sebbene settoriale, della delega di funzioni.
Ulteriore elemento d’indagine è costituito dalla successione nella posizione di garanzia che si verifica
quando il garante dismette la propria posizione di
garanzia, non per effetto di delega, ma per vicende
diverse come, ad esempio, l’ipotesi di avvicendamento dei ruoli di vertice, a seguito di cessione dell’azienda. In particolare, in tali contesti si pone il quesito se e
a quali condizioni, al soggetto che abbandona la condizione di garante possa nondimeno essere mosso un
addebito di responsabilità penale, per un evento occorso dopo la dismissione della relativa posizione di
garanzia e l’avvenuta assunzione di questa da parte del
subentrato.
Prima di procedere nell’esame dei vari profili appena
evidenziati, sono doverose alcune considerazioni di
premessa.
Deve darsi atto che, dopo alcuni decenni, nei quali da
più parti è stata invocata l’introduzione di una regolamentazione normativa della delega (o del trasferimento) di funzioni, il legislatore ha provveduto con la normativa poco sopra menzionata, limitando il suo intervento al settore della sicurezza del lavoro: l’art. 16, del
D.Lgs. 8-4-08, n. 81, ha contemplato una disciplina
organica della delega di funzioni.
Fino al 1996 l’analisi della tematica e della connessa
regolamentazione applicativa erano frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che rifletteva la
problematicità insita nelle ipotesi di trasferimento
della responsabilità penale. La complessità dell’indagine si coglie nella circostanza che molto spesso i reati
che vengono in rilievo (ad es., quelli concernenti la
prevenzione antifortunistica), hanno carattere di reati
“propri” e ciò pone problemi di non facile soluzione,
soprattutto, per quanto riguarda la scissione tra titolarità della qualifica e svolgimento della funzione da
parte di chi questa qualifica non possiede.
Il titolare della qualifica, atta a configurare il “reato
proprio”, assurge a garante dei beni, che con l’incriminazione s’intendono presidiare, nel senso che è tenuto,
per non incorrere nella responsabilità penale ex art. 40,
cpv, c.p., ad agire mediante la predisposizione di una
serie di accorgimenti specifici, deputati ad evitare la
lesione di quei beni o, comunque, ad evitare che ne
aumenti il rischio di lesione, oltre la soglia del consentito.
Inoltre, possono dirsi superati i contrasti sull’ammissibilità del concorso dell’estraneo nel reato proprio mentre perdura, tra gli studiosi, il contrasto tra chi propende per inquadrare il problema della delega (anche) a
livello della tipicità del reato e quelli che lo risolvono
(solo) sul piano della colpevolezza.
Il settore nel quale la delega di funzioni ha avuto la più
amplia applicazione è quello della sicurezza nei luoghi
di lavoro, la cui tematica è stata per la prima volta
presa in considerazione dall’art. 1, comma 4 ter del
D.Lgs. 19-9-94, n. 6263; tuttavia, la reticenza del legislatore a disciplinare la materia emerge evidente dalla
circostanza che la norma non indica le funzioni “delegabili”, bensì limita la statuizione solo a quelle “non
delegabili”.
Nella sfera della pubblica amministrazione l’istituto
della delega ha trovato positivo riconoscimento con
l’entrata in vigore del comma 1 bis4 dell’art. 17
D.Lgs.165/015, che ha espressamente previsto la facoltà, per i dirigenti, di delegare alcune competenze a
dipendenti che ricoprano, nell’ambito degli uffici, le
posizioni più elevate.
La nuova disciplina, essendo limitata alla materia della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non può essere automaticamente estesa ad altri settori, nei quali la problematica qui in esame assume
particolare rilievo – ai quali continueranno ad applicarsi, dunque, i principi che di seguito verranno illustrati – sebbene pare evidente che l’interprete debba
comunque tener conto delle indicazioni del legislatore
nel settore nel quale la delega di funzioni ha avuto
maggiore applicazione.
Va ancora precisato che l’indagine de qua concerne la
sola responsabilità penale dei deleganti e dei delegati,
non, invece, la responsabilità dell’ente introdotta dal
D.Lgs. 8-6-01, n. 231 (ed estesa, dall’art. 9 l. 3-8-07,
n. 123 ai reati di omicidio colposo e lesioni personali
gravi e gravissime commessi con violazione della normativa antifortunistica). Su tale aspetto, deve soltanto
osservarsi che, il titolo di riferibilità della responsabilità all’ente – previsto dagli artt. 6 (nel caso di reati
commessi da persone che ricoprono posizioni apicali)
e 7 (nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti
44
Temi Romana
Saggi
all’altrui direzione) del D.Lgs. 231/01 – deve essere
considerato, nel caso di delega di funzioni, quello previsto dall’art. 7, dovendo il delegato ordinariamente
considerarsi sottoposto all’altrui direzione.
Un’ultima premessa: la delega di funzioni si ha solo se
al delegato vengono attribuiti poteri originariamente
spettanti al delegante; non se il “delegato” era già titolare di tali obblighi. È salva la possibilità che al garante primario (per es. ad un dirigente) vengano attribuite, da parte di altro garante (per es. datore di lavoro),
ulteriori funzioni con lo strumento della delega.
Delineati gli aspetti più rilevati dell’indagine in argomento, conviene considerare analiticamente ciascuno
di essi.
Con riferimento al primo aspetto, quello cioè dell’originaria assunzione della posizione di garanzia, l’individuazione del garante, nell’ambito delle organizzazioni complesse, non è d’immediata percezione: può
non essere semplice stabilire chi sia, in concreto, il
datore di lavoro, chi l’amministratore e chi il dirigente
preposto ad uno specifico settore.
Ad un tal proposito sono tre le teorie elaborate dalla
dottrina: la teoria “formale”, quella “funzionalista” e la
teoria “organica”: ciascuna di esse tenta di individuare, all’interno della collettività indifferenziata, il soggetto in capo al quale addebitare la responsabilità per
il reato omissivo improprio.
La teoria formalista ritiene che occorra considerare il
solo dato formale: sarà titolare della qualifica soggettiva della posizione di garanzia chi è nominalmente
indicato come tale negli atti pubblici, aventi rilevanza
esterna. La tesi è criticata in quanto rischia di generare ipotesi di responsabilità “di posizione”, da considerarsi estranee al nostro ordinamento giuridico, ispirato
ad un “diritto penale del fatto”.
La teoria funzionalista ritiene che le posizioni di
garanzia siano individuate in base alla funzione effettivamente svolta nell’ambito della struttura dal soggetto titolare della qualifica soggettiva contemplata dalla
norma incriminatrice.
Rileva, non tanto l’attribuzione formale della qualità
soggettiva, quanto lo svolgimento delle mansioni
oggettive tipiche della qualifica apicale e/o dirigenziale ricoperta. Anche tale tesi, è stata oggetto di specifiche censure poiché, è stato osservato, è ben possibile
che il soggetto, il quale svolga le funzioni tipiche di
Temi Romana
una determinata qualifica (astrattamente idonea ad
integrare i presupposti del reato), non sia in possesso
di poteri tali da impedire, di fatto, gli eventi dannosi
che si pretende di addebitargli. Pertanto, non può essere gravato dall’obbligo di impedire un fatto, che egli
non ha il potere (effettivo) di impedire.
Alla luce di quanto sinora evidenziato, tende ad affermarsi la teoria organica, la quale attribuisce rilevanza
alla ripartizione dei compiti, come effettuata dall’organigramma aziendale, ossia all’atto interno che delinea
la struttura organizzativa dell’ente. Per tale teoria, il
titolare della qualifica, non va individuato sulla base di
un criterio formale o sostanziale puro, ma in base ad
un criterio misto, che coniuga entrambi i criteri. La
soluzione, soddisfa al meglio le esigenze sottese al
principio della responsabilità penale personale sancito
dall’art. 27 Cost..
Deve precisarsi, inoltre, che la problematica in argomento non si pone in tutti quei casi in cui il legislatore, nel tipizzare talune fattispecie di reato, identifica
esattamente, ora sposando la teoria funzione ora quella organica, il titolare della posizione di garanzia.
In materia di reati societari, ad esempio, è equiparato
all’amministratore il soggetto che, pur senza esserlo da
un punto di vista formale, esercita, di fatto, le funzioni
tipiche di detta qualifica. Parimenti accade con riferimento al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, come modificato dal D.Lgs. 81/08, ove il datore di
lavoro è identificato nel soggetto tenuto a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e specificando che
è considerato tale, non solo chi risulta formalmente
titolare del rapporto, ma anche chi abbia “poteri decisionali o di spesa”, che gli consentano di adottare tutte
le misure necessarie ad impedire la verificazione di
eventi dannosi o pericolosi a carico dei lavoratori.
In sostanza, è il principio di effettività che consente di
discriminare tra mera qualitas formale e sostanziale
esercizio dei poteri discendenti dalla posizione di
garanzia.
Peraltro, il principio di effettività ha ricevuto un’importante riscontro normativo nell’art. 2 D.Lgs. 81/08 –
che fa riferimento alla circostanza che il datore di lavoro esercita i poteri decisionali e di spesa – e, soprattutto, nell’art. 299 significativamente titolato “esercizio
di fatto di poteri direttivi”, il quale ha espressamente
disposto che le posizioni di garanzie relative ai sogget-
45
Saggi
ri di quello originario; con la successione viene meno,
invece, ogni potere del cedente, che non ha più alcun
obbligo di protezione e controllo e perde, altresì, ogni
potere impeditivo nonché pure gli obblighi di vigilanza. Pertanto, se il cedente, o precedente garante perde
definitivamente la qualità, che fonda l’obbligo di
garanzia, si fuoriesce dal tema della delega.
Pure nel caso di successione nelle posizioni di garanzia si pongono problemi analoghi (per il cedente e cessionario) a quelli della coesistenza di responsabilità tra
delegante e delegato.
Può osservarsi che se il cedente ha eliminato le fonti di
pericolo – o le ha adeguatamente contenute nel rispetto delle regole cautelari preventive – nessun addebito
potrà essergli mosso, nel caso di eventi dannosi ricollegabili a violazioni, successivamente verificatesi, di
regole cautelari.
Se, al contrario, il cedente non ha eliminato le fonti di
pericolo – o non le ha contrastate adeguatamente in
violazione delle regole cautelari – si pone il problema
del perdurare della sua responsabilità; problema che la
giurisprudenza di legittimità ha sempre risolto positivamente, fin dalla sentenza sul disastro di Stava del
1990, con orientamento ribadito successivamente,
escludendo che il cedente possa fare affidamento sulla
condotta del cessionario diretta ad eliminare le fonti di
pericolo.
Al fine di escludere la continuità delle posizioni di
garanzia, è necessario, dunque, che il garante sopravvenuto, abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo
create dal predecessore, eliminandole o modificandole, in modo tale che non possano essere più attribuite
al precedente garante.
Tale orientamento non è condiviso da parte della dottrina che, in particolare, evidenzia che il cedente non
ha più il controllo sui mezzi impeditivi dell’evento e,
quindi, l’evento medesimo non potrebbe essere da lui
evitato. Permarrebbe, invece, in capo al cedente un
obbligo informativo dell’esistenza delle fonti di pericolo che, se non adempiuto, determinerebbe la sua
responsabilità colposa.
Tuttavia, può osservarsi che il venir meno dei poteri
impeditivi dell’evento non esclude, come è di intuitiva
evidenza, il rapporto di causalità materiale, ove si
accerti che la condotta ha avuto efficienza (con)causale sul verificarsi dell’evento.
ti di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), d) ed e) gravano pure
su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti.
I soggetti indicati nelle lettere b), d) ed e) sono il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto.
Individuato il garante primario, sulla base dei sopradetti criteri, è possibile, in presenza di tutti gli altri presupposti (anche soggettivi) del reato, compiuto nel
contesto aziendale, muovergli un addebito, ai sensi
dell’art. 40, cpv, c.p., di responsabilità penale, eventualmente anche a titolo di concorso omissivo.
Tuttavia, la norma non esclude l’applicazione di principi formali per l’individuazione delle posizioni di
garanzia, come è evidente dall’uso dell’avverbio
“altresì”, che fa ritenere tenuti all’applicazione delle
misure di prevenzione, anche coloro che sono investiti, originariamente o per delega espressa, dei relativi
poteri e non solo coloro che di fatto dispongono di
questi poteri.
È da sottolineare che il principio di effettività è stato
esteso anche alla responsabilità penale degli enti, poiché l’art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001 individua, per la
responsabilità dell’ente, anche i reati commessi nel suo
interesse, “da persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo” dell’ente medesimo.
Un’analoga evoluzione si è avuta anche nell’attività
delle pubbliche amministrazioni, nelle quali la qualità
di datore di lavoro può oggi essere assunta (art. 2,
comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81 del 2008) dal “dirigente
al quale spettano i poteri di gestione” ovvero dal “funzionario non avente qualifica dirigenziale ... dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa”.
Estranea all’istituto della delega di funzioni è anche la
successione nelle posizioni di garanzia, che si verifica
in presenza di un trasferimento del bene (per es.
l’azienda), o della situazione giuridica (per es. una
carica sociale) o di fatto (per es. l’affidamento della
persona protetta), che fonda un obbligo di protezione o
di controllo.
Per vero, anche nel caso di successione, si pone il problema di individuare il destinatario degli obblighi nonché di accertare chi fosse tenuto al loro rispetto nel
caso di obblighi perduranti nel tempo.
Con la delega o trasferimento di funzioni s’individua,
però, un nuovo garante oppure si incrementano i pote-
46
Temi Romana
Saggi
Quanto all’elemento soggettivo, l’esistenza dei requisiti per poter configurare la colpa va verificata con criterio ex ante e, quindi, anche l’esigibilità (come l’evitabilità o la prevedibilità dell’evento) deve essere riferita al momento in cui la condotta è posta in essere, con
la conseguenza che non può interferire sulla sua esistenza una circostanza di fatto successivamente verificatasi.
Non tutti i poteri dell’imprenditore, anche quando
assuma la forma societaria, sono delegabili. È stato
osservato, ad esempio, che non sono delegabili gli
obblighi giuridici di impedire la consumazione dei
reati fallimentari e societari, né è delegabile l’aspetto
contabile della gestione dell’impresa (salvo gli incarichi meramente esecutivi, che non comportano trasferimento della posizione di garanzia).
Più in generale si è affermato che, nel campo della normale attività di gestione dell’impresa, la delega non
può incidere sulla titolarità dell’obbligo, dal momento
che l’effetto totalmente liberatorio esonererebbe il
datore di lavoro da responsabilità strettamente personali, indefettibilmente legate all’attività imprenditoriale, alle quali è possibile sottrarsi solo nel caso di accertata inesigibilità della condotta doverosa.
Neppure sarebbero delegabili, secondo un orientamento dottrinale, gli obblighi tributari, in considerazione
della natura pubblicistica del rapporto tributario e per
la natura personale del suo adempimento.
L’art. 17, D.Lgs. n. 81 del 2008, ha ribadito la non
delegabilità della valutazione dei rischi, della redazione del relativo documento e della designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi
Ciò non significa, però, che tali compiti debbano essere personalmente svolti dal datore di lavoro, il quale
potrebbe anche non disporre (e solitamente non dispone) delle necessarie competenze nelle specifiche materie, spesso di elevata complessità tecnica. Pur non
potendo delegare queste funzioni, ben potrà attribuire
a terzi, idonei e competenti, un “incarico di esecuzione”, il quale, tuttavia, non lo spoglia della posizione di
garanzia, essendo sempre a lui formalmente attribuita
la funzione non delegabile.
La responsabilità per l’atto “resta sua”, dovendo controllare in ogni caso l’operato dell’incaricato. In tal
modo, non si perviene ad ipotizzare una responsabilità
Temi Romana
di tipo oggettivo, giacché sarà sempre necessario
accertare la colpevolezza dell’agente.
È discusso se la delega possa essere validamente conferita ad un terzo estraneo all’impresa, in possesso
delle caratteristiche di idoneità per lo svolgimento dei
compiti da cedere in affido. Ad una risposta positiva
potrebbe pervenirsi sia perché un divieto in tal senso
non è previsto da alcuna norma (ed in particolare dall’art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008), sia perché il divieto
contrasterebbe con riconosciuti principi di autonomia
dell’attività d’impresa. Tuttavia, il legislatore sembra
mostrare una certa diffidenza nell’attribuzione a terzi
estranei di compiti relativi alla sicurezza: per es., nel
caso degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, l’art. 31 D.Lgs. n. 81 del 2008 esclude la possibilità, in determinati casi (comma 6), di ricorrere a persone esterne e, ove consentito, esclude l’esonero di
responsabilità del datore di lavoro (comma 5).
In ordine alla questione concernente le dimensioni dell’impresa, con più specifico riferimento al tema della
delega, la giurisprudenza è stata sino ad oggi prevalentemente orientata nel senso di ritenere valida la delega,
solo se giustificata dalle dimensioni dell’impresa e
dalla complessità della struttura aziendale.
Non sono mancate, però, decisioni che hanno ritenuto
valida la delega, anche se le dimensioni dell’impresa
non avrebbero giustificato simile conclusione. È stata
poi affermata la superfluità della delega nel caso di
impresa operante su tutto il territorio nazionale e suddivisa in numerose unità produttive, a ciascuna delle
quali erano preposti soggetti qualificati e idonei.
L’orientamento giurisprudenziale che richiede, per la
validità della delega, la sussistenza di grandi dimensioni dell’impresa è stato fortemente contrastato in dottrina; si è, anzi, sottolineato che proprio il riconoscimento normativo della possibilità di delega (che in precedenza si fondava esclusivamente su una ricostruzione
giurisprudenziale) avrebbe implicitamente escluso la
necessità di tale requisito. Peraltro, scarsamente razionale dal momento che non sono soltanto le dimensioni
a rendere necessario un assetto organizzativo fondato
sulla delega, ma, altresì, la natura dell’impresa, la sua
dislocazione sul territorio nazionale o all’estero, la
tipologia dell’attività d’impresa svolta e altre caratteristiche, che rendano non praticabile una gestione accentrata.
47
Saggi
Il legislatore, sia pure solo in relazione al settore della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha risolto il problema in senso negativo.
L’art. 16, D.Lgs. n. 81 del 2008, come già più volte
accennato, ha introdotto una disciplina completa dell’istituto della delega, richiedendo espressamente una
serie di requisiti, anche di natura formale, ma senza
che venisse fatta alcuna menzione al requisito delle
dimensioni dell’impresa che dunque, in questo settore
(ma non esistono ragioni giustificative per risolvere
diversamente il problema anche negli altri), non sembra poter essere più preso in considerazione, proprio
per la completezza della regolamentazione introdotta.
Tra l’altro, in mancanza dell’indicazione dei criteri per
individuare quando un’impresa sia da considerare di
grandi dimensioni, si attribuirebbe al giudice un’eccessiva discrezionalità valutativa.
Non sempre dottrina e giurisprudenza distinguono, in
tema dei requisiti di validità ed efficacia della delega,
tra caratteristiche che devono esistere inizialmente e
quelle che possono influire successivamente sui requisiti anzidetti.
Una delega può essere valida ed efficace, infatti, quando è conferita inizialmente. Ma in seguito può perdere
la propria efficacia (ad esempio, se il delegante interrompe la corresponsione delle disponibilità necessarie
per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza o si ingerisce nello svolgimento dei compiti del delegato). Del
resto, la delega può essere già inizialmente inefficace
allorché, esemplificando ancora, non corrisponda ad
un effettivo incarico di funzioni.
In relazione, in primis, ai requisiti che devono esistere
ab origine, deve osservarsi che il primo presupposto,
affinché possa ritenersi valida ed efficace la delega
(come già accennato), è costituito dalla necessità che
al delegato siano attribuiti i poteri decisionali e di
spesa indispensabili per adempiere al compito delegato, nell’ambito dello specifico settore di competenza,
oggetto della delega.
Il secondo presupposto, per l’esonero da responsabilità, è l’idoneità della persona prescelta. La culpa in eligendo, insita nella scelta della persona cui siano delegati i poteri, ha l’effetto di non esonerare il delegante
da responsabilità: l’idoneità del delegato a svolgere i
compiti delegati risponde all’esigenza di assicurare
l’effettività della delega. Il delegante può fare affida-
mento sulla corretta esecuzione dell’incarico solo se il
delegato sia persona idonea e adeguata a svolgere il
compito affidatogli.
Della necessaria esistenza dei suindicati requisiti,
richiesti ai fini della sussistenza di una delega valida
ed efficace, il legislatore ha tenuto conto. L’art. 16 del
D.Lgs. n. 81 del 2008, al comma 1 lett. b), richiede,
infatti, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Tali caratteristiche devono
perdurare nel tempo, poiché l’evoluzione tecnologica
potrebbe condurre a ritenere superate le competenze
specifiche del delegato. Da qui l’obbligo, oggi previsto
dall’art. 30, comma 4 (espressamente richiamato dall’art. 16, comma 3), di aggiornare, anche per quanto
attiene alle deleghe, le misure organizzative dell’impresa.
Circa i requisiti di validità ed efficacia della delega, la
lett. c) del medesimo comma 1, richiede, inoltre, che la
delega “attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate”, mentre la lett. d) rende
necessario, infine, che la delega “attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate”.
Dunque, se il delegato è posto nell’impossibilità di
adempiere ai suoi obblighi di prevenzione, perché il
delegante non glielo consente (come avviene quando
non gli attribuisce i necessari poteri di organizzazione
o non gli fornisce le risorse per approntare le strutture
impeditive necessarie, per esempio, per l’acquisto dei
mezzi di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro),
viene meno l’efficacia della delega, con conseguente
ri-attribuzione della responsabilità al delegante.
I temi della forma della delega e della prova della sua
esistenza sono tra di loro intrecciati, e riguardano
aspetti sostanziali e processuali. La giurisprudenza è
stata sino ad oggi orientata per una linea di rigore,
derivante dalla necessità di evitare facili scappatoie
dalla responsabilità penale, richiedendosi anche che
l’esistenza e il contenuto della delega debbano essere
provati da chi li deduce.
Un orientamento ancor più rigido, da sempre oggetto
di critica da parte della dottrina, è quello che richiede
la forma scritta della delega, al fine di ritenere verificato il trasferimento di funzioni con esonero da
48
Temi Romana
Saggi
responsabilità del delegante. La pretesa della forma
scritta era, peraltro, in via di superamento nella giurisprudenza di legittimità, sostanzialmente uniforme nel
richiedere, non una sorta d’inversione dell’onere della
prova, ma un accertamento rigoroso in ordine all’esistenza della delega.
Anche il suesposto orientamento non è andato esente
da censure, osservandosi che, inerendo la titolarità
della funzione al fatto tipico, l’onere di provarla non
può che incombere sull’accusa.
Invero, pare più opportuno distinguere tra i casi di
ripartizione di funzioni all’interno di organizzazioni
aziendali complesse (per i quali effettivamente non
sembra si possa discostare dagli usuali criteri di ripartizione dell’onere della prova nel processo penale), dai
casi di vera e propria delega di funzioni a soggetti
estranei ovvero a soggetti che, pur inseriti nell’organizzazione aziendale, non erano originariamente titolari di poteri impeditivi di eventi dannosi o pericolosi.
Occorre, altresì, che la delega sia espressa e che il
delegato ne accetti il conferimento. Si tratta di un
negozio di natura contrattuale, per il quale è richiesto
che il soggetto, sul quale viene trasferita la responsabilità (compresa quella penale), esprima coscientemente
il suo consenso.
La necessità che la delega sia conferita inequivocamente, deriva poi dalla circostanza che consentire
deleghe implicite, o non espresse, significherebbe
creare posizioni di garanzia “ambigue” non fondate su
condotte inequivoche, con la conseguenza del verificarsi dell’incertezza nella traslazione di responsabilità.
In quest’ottica, è necessario, inoltre, che pure i poteri
delegati siano indicati in modo specifico, proprio per
evitare incertezze ed elusioni.
Pure sul tema della forma della delega il D.Lgs. n. 81
del 2008 è intervenuto in modo preciso e rigoroso, prevedendo che la delega debba risultare da atto scritto,
recante data certa (art. 16 comma 1 lett. a)), e che la
stessa sia accettata dal delegato per iscritto (lett. e)).
La previsione della forma scritta, che sembra richiesta
per la validità della delega (e quindi ad substantiam),
potrebbe apparire, in prima battuta, non in linea con il
recepimento espresso del principio di effettività operato dagli artt. 2 e 299 D.Lgs. n. 81 del 200.
In realtà, non esiste contraddizione tra le due previsioni: una delega non valida, poiché priva dei requisiti di
Temi Romana
forma, non libera il delegante dai suoi obblighi; ma se
il delegato ha operato esercitando, in concreto, i poteri invalidamente trasferitigli, risponderà delle sue condotte.
È da precisare che la delega di funzioni non comporta
l’automatico trasferimento della responsabilità penale
derivante dall’inadempimento dell’incarico. Vi possono essere, infatti, casi nei quali la responsabilità del
delegato si “aggiunge” a quella del delegante e può,
quindi, parlarsi di responsabilità “concorrenti”. Tali
ipotesi, che non riguardano il mero incarico d’esecuzione, possono essere predeterminate dalla legge (ad
esempio, il dirigente cui sono attribuiti poteri in materia di prevenzione antinfortunistica che nomina il preposto), ovvero derivare dalla natura dell’incarico o dal
contenuto di accordi negoziali.
Il delegante continua ad essere titolare di doveri di
vigilanza e controllo dell’attività delegata ed, anzi, è
stato osservato che questi poteri non sono delegabili,
giacché diversamente opinando – ritenendo che non
sia obbligato ad intervenire nel caso di disfunzioni dell’organizzazione d’impresa da lui predisposta – l’imprenditore abdicherebbe alla sua stessa funzione.
In altri termini, il titolare originario dei poteri impeditivi non può disinteressarsi, una volta che abbia conferito una valida delega, delle modalità con cui i poteri,
inerenti a questa delega, vengono esercitati.
Vi sono poi casi nei quali il delegante ha un dovere
immediato di intervento: ciò si verifica quando abbia
notizia dell’inosservanza dei doveri da parte del delegato. Se, al contrario, li tollera qualora costituiscano
reato, potrà ipotizzarsi un concorso nel reato doloso e
una cooperazione in quello colposo.
Ed è stato chiarito che il sorgere dei doveri impeditivi
in capo al delegante è ricollegato non alla conoscenza
effettiva dell’inadempienza ma alla sua conoscibilità.
Il principio di affidamento, cui deve farsi ricorso in
queste circostanze, vale, infatti, fino a quando l’affidante non venga a conoscenza – o si crei una situazione in cui colpevolmente non sia venuto a conoscenza –
delle inadempienze dell’affidato.
Altra ipotesi in cui in capo al delegante può permanere
o insorgere successivamente la responsabilità è quella
nella quale egli continui (o inizi) ad ingerirsi nella
gestione dei compiti attribuiti al delegato. Con l’ingerenza – che deve avere l’effetto di diminuire significa-
49
Saggi
tivamente l’autonomia del delegato – il delegante
manifesta, infatti, l’intenzione di annullare gli effetti
della delega o di restringerne l’ambito applicativo.
Anche in tal caso, in cui il delegante ha “riacquistato” le
funzioni precedentemente delegate (intervento sostitutivo, omissione del conferimento di risorse, ingerenza), si
verifica nei confronti del delegante una sorta di “riattribuzione” di tutti i poteri originariamente conferiti.
In ordine ai residui poteri in capo al delegante è intervenuto l’art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, il cui comma 3
– recependo sostanzialmente i risultati dei riferiti esiti
giurisprudenziali – ha precisato che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro circa il corretto espletamento, da parte
del delegato, delle funzioni trasferite.
La medesima norma impone, con il richiamo ai sistemi di verifica e controllo indicati nell’art. 30, comma
4, del medesimo D.Lgs., un idoneo controllo sull’attuazione del sistema di delega e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità del modello organizzativo adottato.
La nuova disciplina ha confermato, dunque, l’obbligo
dell’intervento sostitutivo (conseguente a quello di
vigilanza), nel caso d’inadempimento degli obblighi
gravanti sul delegato. Nulla ha specificamente disposto sull’ingerenza, ma non sembra che possa pervenirsi su questo punto – anche per l’espresso recepimento
del principio di effettività – a conclusioni diverse posto
che l’ingerenza, come si è visto, pone nel nulla gli
effetti della delega.
Una delega valida ed efficace, avente ad oggetto funzioni delegabili e perdurante nel senso che non si è
verificato alcun caso di inefficacia sopravvenuta, vale
ad esonerare il delegante (salvo l’inosservanza del
dovere di vigilanza) da ogni responsabilità penale: è il
delegato ad assumersi la responsabilità, nel caso di
violazione degli obblighi imposti dalla legge.
Se la violazione è avvenuta per la ragione che il delegato non ha osservato le prescrizioni impartitegli, non
sorge alcun problema: risponderà lui soltanto, nei limiti già indicati.
Ci si può chiedere, invece, cosa accada nel caso in cui
il delegato osservi le istruzioni del delegante.
Trattasi d’ipotesi nella quale deve ritenersi perdurante
la responsabilità del delegante: l’aver impartito direttive erronee o difformi da quanto normativamente pre-
visto – o più semplicemente in contrasto con generiche
regole cautelari – introduce una forma di compartecipazione (dolosa o colposa), da parte del delegante che
diviene (o rimane), in prima persona, l’autore della
violazione.
Inoltre, non è da escludere la responsabilità del delegato. Sotto il profilo causale, vi è la presenza di una concausalità riferibile alla condotta di entrambi i soggetti e
non sembra, se si tratta di omissioni, che possa escludersi la posizione di garanzia (derivata) del delegato.
Posizione di garanzia che, in questo caso, ha origine
contrattuale in virtù dell’accettazione della delega (che
oggi deve avvenire per iscritto nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008: v. art. 16 comma 1 lett. e).
Per quanto concerne la colpevolezza varranno gli
usuali criteri. In particolare, se la violazione è dolosa
dovrà essere accertato che il delegato abbia quanto
meno accettato le conseguenze della sua condotta, e
non sembrano esistere ostacoli per ritenere l’esistenza
del concorso dell’estraneo nel reato proprio.
Più complessa è la soluzione nel caso di reati colposi:
se si tratta di delitti, la compartecipazione è ipotizzabile nella forma della cooperazione nel delitto colposo
(art. 113 c.p.); se trattasi di contravvenzioni – poiché
l’art. 113 prevede la cooperazione nel reato colposo
solo nel caso di delitti – il problema è di meno agevole soluzione, anche se, in questo caso, può farsi riferimento al concorso di cause colpose indipendenti.
Naturalmente dovrà essere verificata l’esistenza – oltre
che della violazione di una regola cautelare anche da
parte del delegato – di tutti gli altri presupposti, per
l’attribuzione della responsabilità a titolo di colpa (esigibilità della condotta; prevedibilità dell’evento; e
relativa evitabilità).
Un’ultima osservazione, in tema di responsabilità, va
svolta in ordine alla posizione del delegato.
Come sopra detto, nell’ipotesi di valida delega residua,
in capo al delegante, un obbligo di vigilanza, che non
è configurabile a carico del delegato. Nel caso di poteri impeditivi “ripartiti”, fra delegante e delegato,
l’inosservanza dei medesimi da parte del primo non ha
la conseguenza di rendere automaticamente responsabile dell’inadempimento anche il secondo. Il quale,
però, qualora l’inadempimento da parte del delegante
divenga conosciuto o conoscibile, dovrà rinunziare
alla delega, se la situazione è tale da impedirgli
50
Temi Romana
Saggi
l’adempimento degli obblighi su di lui incombenti.
Infine, come già precisato, l’idoneità del soggetto
delegato è un presupposto di validità della delega.
Ferma restando la responsabilità del delegante, per
culpa in eligendo, nei confronti del delegato, potrà
configurarsi, nel caso di inidoneità riconoscibile, una
responsabilità del delegato per colpa c.d. “per assunzione”, ravvisabile nella condotta di chi assume un
compito che non è in grado di svolgere.
(FINE PRIMA PARTE – SEGUE)
_________________
1 Ex art. 40, co. 2, c.p..
sicurezza nei luoghi di lavoro.
5 Norme generali sull’ordinamento del
2 Attuazione dell’art. 1 delle l. 3-8-07, n.
127, in materia di tutela della salute e della
3 Aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19-3-96, n. 242.
lavoro alle dipendenze delle amministrazio-
4 Aggiunto dall’art. 2 l. 15-7-02, n. 145.
ni pubbliche.
Temi Romana
51
Osservatorio legislativo
Sulla non equivalenza del credito per retribuzioni e quello
di regresso per t.f.r.
Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma - Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La questione – 3. La soluzione.
1.
Premessa
La querelle relativa ad una possibile – ma
negata dalla dottrina1 e dalla giurisprudenza2 –
equivalenza del credito per retribuzioni rispetto a quello vantato dall’Inps, per regresso, per il trattamento di
fine rapporto corrisposto, ai sensi dell’art. 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, ha avuto ad oggi una risposta
univoca nel senso che la originaria diatriba è stata, per
l’appunto, affrontata e risolta nel senso di ritenere,
quante volte non sia possibile soddisfare integralmente
i crediti collocati al medesimo grado, la concorrenza
degli stessi sull’attivo in distribuzione secondo un criterio di proporzionalità.
A tale risultato si è pervenuti nella convinzione che una
siffatta regola risponde alla esigenza di creare un coordinamento organico tra le disposizioni sulla ripartizione dell’attivo tenendo conto del principio della unicità
della graduatoria, sicché i crediti che partecipano al
riparto devono rispettare l’ordine delle prelazioni, fissate nel codice civile e nelle relative disposizioni che le
riconoscono, attraverso il riconoscimento che il credito
ha avuto in sede di accertamento dello stato passivo,
atteso che il curatore non può procedere operando alcuna rettifica se non tenendo conto di quel che può accadere successivamente alla intervenuta esecutività per le
vicende che possono, in termini soggettivi, comportare
delle rettifiche che possono derivare dalle pronunce
intervenute in sede di opposizione allo stato passivo, di
impugnazione ovvero di revocazione3.
La novella non ha apportato particolari modifiche per
quel attiene i privilegi se non attraverso la previsione
che nel provvedimento, con il quale il giudice ammette
un credito al passivo, deve essere anche indicato il relativo grado e, certamente, nel caso dei crediti di lavoro
quelli per retribuzioni e per il trattamento di fine rapporto hanno una pari collocazione essendo ad essi rico-
nosciuto un diritto di prelazione che si esercita su tutti
i beni mobili del debitore per il capitale, le spese e gli
interessi “…nei limiti di cui agli artt. 54 e 55 sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i
crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare secondo il grado previsto dalla legge”.
Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, gestito
dall’Inps, questo una volta effettuato il pagamento in
favore del lavoratore, per il credito ammesso al passivo, delle ultime tre mensilità delle retribuzioni rimaste
insoddisfatte, ovvero per il trattamento di fine rapporto, si surroga di diritto al lavoratore stesso o ai suoi
aventi causa nel previlegio di cui all’art. 2751 bis
cod.civ. e tale credito concorre con quelli di natura
retributiva non garantiti, in quanto esso trova collocazione nella medesima posizione e nello stesso grado di
privilegio (art. 2751 bis n. 1 art. 1203 cod.civ. e art. 2
legge n. 297 del 1982).
A tale conclusione la dottrina e la giurisprudenza sono
pervenute sul presupposto che, invero, i crediti sono
previsti dall’art. 2751 bis n. 1, che non opera, con riferimento ad essi, alcuna graduazione e, pertanto, non
prevede un ordine di precedenza, sicché i crediti per le
retribuzioni dovute al pari di quelli relativi alle indennità maturate, per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro, non possono che concorrere sull’attivo in
sede di ripartizione.
2. La questione
Ebbene si tratta di dover verificare se un siffatto argomento possa ritenersi coerente con i principi discendenti dalla direttiva Ce n. 987 del 1980, che ha previsto
l’intervento del Fondo di garanzia ed il pagamento dei
crediti di lavoro relativi al t.f.r. ed alle ultime tre mensilità di retribuzione quante volte il datore di lavoro sia
52
Temi Romana
Osservatorio legislativo
stato assoggettato a procedura concorsuale, ovvero nel
corso dell’esecuzione individuale il lavoratore non sia
riuscito a soddisfare le proprie ragioni di credito.
Ebbene, se si considera che la finalità della Direttiva
Comunitaria è quella di assicurare, in caso di insolvenza o incampienza, la piena ed integrale attuazione del
principio di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati,
appare logico e coerente ritenere che tale obiettivo deve
essere garantito non solo grazie all’accesso, per il lavoratore, al Fondo di garanzia, ma, soprattutto, mediante
la posticipazione della soddisfazione del Fondo a quella preventiva dei lavoratori.
La soluzione offerta tiene conto della ratio della normativa comunitaria e la proposta interpretazione, a
maggior ragione, non può non essere accolta in un ordinamento come quello italiano, nel quale la retribuzione
è un diritto costituzionalmente garantito e, come tale,
deve essere adeguatamente tutelato.
Ne consegue che non è sufficiente una tutela meramente formale, assicurata attraverso l’istituzione del Fondo
di garanzia, ma è necessario che, in concreto, i lavoratori subiscano il minor pregiudizio possibile dal dissesto del loro datore di lavoro, ed è in quest’ottica che la
Comunità Europea ha vincolato gli Stati Membri ad
attuare la richiamata Direttiva.
Dunque, sebbene il legislatore italiano ha adempiuto a
tale obbligo, il sistema rischierebbe di essere irrazionale, qualora garantisse, da una parte, il lavoratore del
recupero, attraverso il Fondo di garanzia, del t.f.r. e
delle somme dovute a titolo di retribuzione degli ultimi
tre mesi del rapporto di lavoro, e, dall’altra, consentisse al Fondo di concorrere, anche in caso di insufficienza di attivo, con i crediti di lavoro (art. 2782 cod.civ.),
creando così un serio e grave pregiudizio nei confronti
del lavoratore che, in sostanza, verrebbe ad essere privato della possibilità di ottenere quanto in suo diritto.
Tale effetto risulta, evidentemente, contrario alle esigenze di giustizia sociale, poiché verrebbe a fornire la
medesima tutela per situazioni sostanzialmente diverse,
atteso che non possono essere equiparate le esigenze
del lavoratore a vedersi accreditata la somma per il
lavoro svolto dal momento che la retribuzione deve
assicurare un’esistenza dignitosa (art. 36 Cost.), sicché
i crediti ammessi al passivo non possono concorrere
con le somme che il Fondo di garanzia abbia erogato
surrogandosi nei relativi diritti.
Temi Romana
Affinché il ragionamento svolto non risulti criptico, e
possano essere compresi meglio gli effetti perniciosi
derivanti dalla diversa interpretazione ad oggi data
dalla giurisprudenza e dalla dottrina, appare sufficiente
sottolineare che, nell’ipotesi in cui il Fondo si dovesse
surrogare dopo la distribuzione parziale dell’attivo realizzato, per non avere il lavoratore ottenuto sino a quel
momento il relativo ammontare, corrispondente al credito ammesso, la somma da questi riscossa, in sede di
riparto, verrebbe detratta dall’intero importo riconosciuto indistintamente nello stato passivo e, quindi,
verrebbero, attraverso la ripartizione, soddisfatte quelle ragioni creditorie non assicurate dal Fondo.
In conclusione, qualora non si accettasse la prospettata
soluzione, si rischierebbe di incorrere in una applicazione irragionevole della norma, che deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato.
La giurisprudenza ha, a tal riguardo, più volte, riconosciuto che il principio di uguaglianza deve essere inteso come obbligo del legislatore di trattare in modo
uguale situazioni in fatto uguali ed in modo non arbitrariamente diverso situazioni in fatto diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della
vita sociale ed escludendo, in tale modo, che a situazioni diverse possa essere imposta una identica disciplina
legislativa.
È, dunque, evidente che al Fondo di garanzia non può
essere applicato l’art. 2782 cod.civ., perché, sebbene
l’Istituto è previsto possa surrogarsi ex lege al lavoratore nella medesima posizione e medesimo grado del privilegio, di cui all’art. 2751 bis n. 1 cod.civ., non è
accettabile che esso concorra con il lavoratore e che
venga soddisfatto contestualmente a quest’ultimo poiché tale soluzione risulterebbe essere contraria alle esigenze di giustizia sostanziale.
3. La soluzione
La tesi che si intende proporre impone necessariamente una analisi degli argomenti svolti, in senso contrario,
dalla giurisprudenza per riconoscere l’assoluta equiparazione processuale e sostanziale tra la posizione del
Fondo di garanzia ed i lavoratori ammessi al passivo,
attesa la esigenza, prima di ogni altra cosa, di comprendere se, in effetti, le pronunce che spesso vengono
richiamate in modo acritico hanno colto la questione e,
di conseguenza, se la soluzione che si intende proporre
53
Osservatorio legislativo
in ragione di una lettura costituzionalmente orientata
della relativa disciplina4, possa essere interpretata nel
senso che essa non osta ad una normativa nazionale che
abbia inteso garantire i crediti scaduti, per le causali
espressamente previste, consentendo che ciò avvenga,
qualora non risulta una completa capienza dell’attivo,
attraverso la regola del riparto pro quota, e per grado
corrispondente, nel rispetto delle rispettive cause di
prelazione e del rango assegnato dalla legge, ponendoli in diretto confronto, sicché il risultato possa essere
realizzato attraverso un soddisfacimento recessivo
degli altri crediti in conseguenza della non ritenuta
equiparazione processuale e sostanziale tra la posizione del Fondo di garanzia e quella dei dipendenti
ammessi al passivo per altre voci di credito.
Vengono richiamate a sostegno della tesi della equivalenza alcune decisioni della Suprema Corte che, come
presto vedremo, non sono affatto significative perché
possa essere ribaltato il principio discendente dalle
modifiche apportate dalla Direttiva 2002/74, che ha
attribuito ai legislatori nazionali la possibilità di fissare
liberamente la data prima e/o eventualmente dopo la
quale si colloca il periodo in cui il pagamento di crediti
corrispondenti alle retribuzioni non pagate deve essere
posto a carico dall’organismo di garanzia pur non
impendendo – con riferimento alle retribuzioni – che il
legislatore nazionale possa limitare la garanzia del credito fissando la data a partire dalla quale deve essere
calcolato il periodo di riferimento, non avendo, certamente, inteso affermare che ciò possa e debba avvenire
a danno degli altri lavoratori che risultino creditori per
voci diverse o, altresì, per gli stessi lavoratori che pur
vedendo garantito il credito da parte del Fondo nel concorrere con questo, ove l’attivo non consenta l’intero
soddisfacimento, vedrebbero erosa quella quota di credito per la quale non è previsto l’intervento dell’organismo di garanzia, con la conseguenza che il Fondo verrebbe ad incidere sulla concreta possibilità di soddisfare i crediti diversi da quelli per i quali la legge 29 maggio 1982, n. 297, lo ha istituito, per il trattamento di fine
rapporto, individuando le condizioni per il suo intervento, ed il D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 80, lo ha esteso ai
crediti di lavoro diversi, ovvero alle ultime tre retribuzioni maturate nell’anno anteriore all’apertura della
procedura concorsuale, prevedendo l’art. 2, comma
sette, la surroga di diritto “…nel privilegio spettante sul
patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli artt. 2751
bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”, disposizione questa poi espressamente richiamata
dall’art. 1 comma tre, del D.Lgs. n.80/1992, a norma del
quale “…per le somme corrisposte dal Fondo si applica
il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo
dell’art. 2, legge citata”.
Al riguardo, certamente, non è pertinente il richiamo
che viene effettuato nei confronti della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte con riferimento all’amministrazione straordinaria delle imprese insolventi
che, invero, ha inteso affermare un principio relativamente ad una fattispecie – disciplinata dalla legge fallimentare, nel testo anteriore alla novella di cui al
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – di riparto interno nell’ambito di quella procedura nella quale, correttamente, il giudice del merito aveva escluso che il soddisfacimento dei crediti prededucibili potesse avvenire alla
stregua del criterio cronologico del “prior tempore
potior in iure”5.
La decisione richiamata, difatti, si è preoccupata di
affermare un diverso principio volto a garantire che il
Fondo, che ha anticipato il t.f.r. ad altri dipendenti ha
diritto ad essere pagato, in prededuzione, se tale collocazione, nell’ambito della procedura, spettava al credito dei lavoratori da esso soddisfatta.
Non può sfuggire, pertanto, ove si proceda ad una lettura meno acritica della decisione richiamata, che essa
ha inteso affermare un diverso principio essendo stato
posto all’attenzione della Corte se l’ammissione al passivo del credito del t.f.r., collocato in prededuzione, per
effetto del riconoscimento derivante dalla sua equiparazione ai debiti di impresa – disposta dall’art. 4 del D.L.
n. 414 del 1981, convertito nella legge n. 544 del 1981 –
dovesse avere un trattamento preferenziale rispetto al
credito del Fondo di garanzia, gestito dall’Inps, derivante dalla surroga dell’ente previdenziale per il credito pagato ad altri dipendenti ed il cui rapporto, proseguito senza soluzione di continuità con la procedura,
era cessato in un momento antecedente.
Del pari non può essere di ausilio la diversa decisione
richiamata al fine di sostenere che, in caso di concorso
dei crediti di lavoro non garantiti, con quelli maturati
dal Fondo di garanzia, per le somme erogate in sostituzione del datore di lavoro, questi ultimi non vanno soddisfatti subordinatamente al preventivo soddisfacimen-
54
Temi Romana
Osservatorio legislativo
to dei primi.
E difatti con la richiamata sentenza la Suprema Corte6,
ha inteso ribadire un principio, ancora una volta,
sostanzialmente diverso che attesta, peraltro, la erroneità della tesi che normalmente si sostiene proprio
attraverso il richiamo a tale pronuncia.
In tale decisione, nella parte motiva dedicata alla interpretazione della ratio legis, ci si accorge che la
Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato7 avendo il giudice delegato omesso di considerare il chiaro
contenuto dell’art. 2276 cod.civ. che, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge n. 297 del 1982, dispone che i
crediti relativi al trattamento di fine rapporto, nonché
all’indennità di cui all’art. 2118 cod.civ., sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione
sui beni mobili, sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai crediti chirografari e che, pertanto, i
crediti indicati dagli art. 2751 e 2751 bis cod.civ., ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, sono
anch’essi collocati sussidiariamente, nell’ipotesi in cui
l’esito dell’esecuzione sui mobili risulti incampiente,
sul prezzo degli immobili, con preferenza sempre
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
La Suprema Corte, attraverso il richiamo dell’art. 12
delle preleggi – che stabilisce, al primo comma, che
“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e
dalla intenzione del legislatore” – è pervenuta alla conclusione che l’interpretazione letterale costituisce il
principale e fondamentale canone di ermeneutica, con
la conseguenza, quindi, che quando la portata e l’ambito di applicazione di una norma giuridica siano fatti
palesi dal significato proprio dei termini usati nel testo,
non è consentito all’interprete discostarsi da esso,
quante volte questi risulti chiaro ed inequivoco, attesa
la impossibilità di ricorrere ad altri criteri ermeneutici
sussidiari per giungere ad un risultato contrastante con
il dato letterale e con la volontà del legislatore da esso
desumibile.
Ed infatti, con il provvedimento cassato, il tribunale
non aveva considerato che il legislatore, attraverso la
riformulazione dell’art. 2776 cod.civ. aveva inteso, da
un lato, contemperare l’interesse dei lavoratori dipendenti a conseguire, in ogni caso, il trattamento di fine
Temi Romana
rapporto, istituendo a tal fine il Fondo di garanzia gestito dall’Inps e, dall’altro, l’interesse di quest’ultimo a
recuperare le somme pagate in sostituzione dell’obbligato inadempiente prevedendo la surrogazione di diritto nei privilegi attribuiti dagli artt. 2751 bis e 2776
cod.civ. ai crediti relativi alle indennità di fine rapporto.
La portata della norma è, dunque, estremamente chiara, atteso che, attraverso la disposizione codicistica,
introdotta dall’art. 10 della legge 29 luglio 1975, n.
426, per come sostituita dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il legislatore ha inteso disporre che i
crediti relativi al trattamento di fine, nel caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, essi devono trovare
collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili “con
precedenza rispetto ai crediti chirografari” (in tal
senso il primo comma), ma anche prima di tutti gli altri
“crediti indicati degli artt. 2751 e 2751 bis” (in tal
senso il secondo comma) e, quindi, prima dei crediti
per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma seppur
assicurate dal n. 1 dell’art. 2751 bis cod.civ., con ciò
dimostrando, in modo inequivoco, di aver inteso riconoscere al Fondo di garanzia il diritto di privilegio, di
cui all’art. 2776 cod.civ. e, dunque, tutelare il credito
dell’Inps riconoscendogli una particolare efficacia consentendo che ad esso vengano posposti gli altri crediti
retributivi.
Nel caso esaminato, dunque, dalla Suprema Corte il
giudice del merito aveva ritenuto, erroneamente, dover
essere l’attivo realizzato utilizzato al fine di soddisfare le ragioni creditorie retributive e, quindi, successivamente quelle del Fondo che aveva erogato il t.f.r.
che, al contrario, con riferimento al ricavato dalla vendita dei beni immobili, una volta risultata infruttuosa
la soddisfazione dell’attivo realizzato dalla alienazione di quelli mobili, in ragione della operata rivisitazione dell’art. 2776 cod.civ., doveva necessariamente prevalere sulla distribuzione degli altri crediti, derivanti
dal rapporto di lavoro subordinato in quanto ad essi
posposti.
Ed allora è facile comprendere come da tale enunciazione non può ricavarsi alcuna indicazione per ritenere
che il credito del Fondo, maturato per la erogazione del
t.f.r., e gli eventuali crediti di natura retributiva dei
lavoratori dipendenti dell’impresa fallita, siano collocati nella stessa posizione e nello stesso grado di privi-
55
Osservatorio legislativo
legio, derivando dalla richiamata decisione l’esatto
contrario ovvero che il credito per il t.f.r. anticipato
debba essere soddisfatto attraverso il ricavato dalla
vendita dei beni immobili, laddove si abbia una eccedenza che consenta, per l’appunto, il soddisfacimento
di quelli di grado inferiore con preferenza, tuttavia,
prima di tutti gli altri di quello relativo al t.f.r..
Non diverse le conclusioni laddove si consideri il principio enunciato, sempre della Suprema Corte, sul relativo tema8, con riferimento, ancora una volta, ad una
particolare situazione.
Ed infatti nel caso di specie il conflitto correlato alla
regole che dovessero essere osservate nella attribuzione degli importi da ripartire non è stato risolto nel senso
di ritenere logica la distribuzione proporzionale in
favore del credito ammesso per surroga, maturato
dall’Inps, con l’altro discendente dalle diverse rispettive ragioni di credito derivanti dal rapporto di lavoro
subordinato, essendo stato caso sottoposto all’esame
dei giudici di legittimità il diverso problema relativo al
criterio di imputazione dei pagamenti, in presenza di
più debiti verso la stessa persona ed in mancanza di
diversa dichiarazione da parte del solvens, sul presupposto questi potesse imputarlo al debito più antico qualora i debiti risultassero tutti ugualmente scaduti,
garantiti ed onerosi, in applicazione dell’art. 1193,
secondo comma cod.civ.
L’Inps, difatti, aveva denunciato la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1193 cod.civ., e 111 l.f., nel
testo ante riforma, sul presupposto che l’imputazione
di cui alla richiamata norma opera solo in assenza di
altre regole, sicché essendo tutti i crediti per retribuzioni collocati sullo stesso piano ed assistiti, ai sensi dell’art. 2751 bis cod.civ., da un privilegio del medesimo
grado, doveva trovare applicazione, l’art. 2782 cod.civ.
che, in caso di insufficienza delle somme da ripartire,
prevede il soddisfacimento dei crediti posti al medesimo grado di privilegio, in proporzione del rispettivo
importo, sicché avendo i lavoratori ricevuto in precedenza un acconto prima dell’intervento questo avrebbe
dovuto essere imputato a tutte le retribuzioni arretrate
mentre a carico dell’Istituto avrebbero dovuto essere
poste le retribuzioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. n. 80
del 1992, ciò sul presupposto che i criteri di imputazione, di cui agli artt. 1193, 1194 cod.civ., si applicano
esclusivamente ai pagamenti eseguiti volontariamente
e non a quelli coattivi che hanno luogo in sede esecutiva o fallimentare.
Ebbene, anche in tal caso il principio enunciato dalla
Suprema Corte non può essere utilizzato al fine di far
discendere da esso che, in caso di concorso dei crediti
dei lavoratori subordinati e del Fondo di garanzia, per
le somme da questo anticipate in sostituzione del datore di lavoro, si ha una collocazione nella medesima
posizione e nello stesso grado di privilegio, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza trovando il relativo principio saldo ancoraggio nella legge fallimentare9 e, altresì, nella corretta interpretazione dell’istituto
della surrogazione, e dei criteri legali di imputazione,
derivanti dall’art. 1193 cod.civ., atteso che la locuzione
debito meno garantito, cui si riferisce il secondo dei
criteri legali di imputazione previsti dalla norma, non
può che essere interpretata10 nel senso che, attraverso
l’espressione utilizzata, si è inteso far riferimento a
quelle obbligazioni non assistite da una garanzia reale
o personale (privilegio, pegno, ipoteca fideiussione).
L’art. 1193 cod.civ., difatti, al secondo comma, allorché
stabilisce che il pagamento va imputato al debito meno
garantito, fa riferimento all’obbligazione che, fra quelle scadute o è assistita da una garanzia, per la sua natura giuridica o per estensione quantitativa e temporale o,
ancora, per l’ordine che occupa nella graduatoria delle
cause di prelazione, è meno efficace di altre o, infine,
all’ipotesi di obbligazione, affatto, garantita.
Discende da ciò che i criteri legali di imputazione
hanno, quindi, la funzione di una dichiarazione esplicativa del solvens o, in subordine, dell’accepiens (come
può argomentarsi dall’art. 1195 cod.civ.) a quali dei
rapporti obbligatori della medesima specie devono
essere riferiti i pagamenti eseguiti, di modo che ad ogni
atto solutorio segua, puntualmente, l’effetto di estinguere in tutto, o in parte, una determinata obbligazione.
Tale criterio è, però, estraneo al sistema concorsuale,
dal momento che l’accertamento del passivo ha la funzione di individuare i creditori che partecipano al concorso, stabilendo, per ciascuno di questi, l’esistenza del
diritto, l’ammontare dello stesso e la sua collocazione.
Il rischio dell’insufficienza dell’attivo11, quindi, grava
sul Fondo e non può essere limitato all’ipotesi in cui
non vi sia attivo da ripartire tra i creditori privilegiati,
di cui all’art. 2751 bis cod.civ., nel senso che, laddove vi è un attivo, questo non solo non può essere cor-
56
Temi Romana
Osservatorio legislativo
risposto, con preferenza al Fondo, fino all’integrale
recupero di quanto da esso erogato – siccome in contrasto con i principi che disciplinano la surroga – e, al
tempo stesso, deve lasciare ritenere esclusa la concorrenza del credito garantito con quello del lavoratore,
già dipendente dell’impresa fallita, sul presupposto
della collocazione nella medesima posizione e nell’identico grado di privilegio, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza (artt. 2751 bis e 2782,
primo comma, cod.civ.) dal momento che attraverso
l’istituzione del Fondo di garanzia il legislatore non
ha inteso assicurare il soddisfacimento di alcuni crediti a danno di altri quanto, piuttosto, ha inteso garantire determinati crediti in funzione della stessa possibilità di flessibilizzare gli obblighi discendenti dal
rapporto di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento dell’azienda dell’impresa fallita.
L’art. 5 della Direttiva del Consiglio del 12 marzo
2001, n. 23, al secondo comma, espressamente prevede
la possibile disapplicazione degli artt. 3 e 4, della
medesima Direttiva, nel caso di trasferimento attuato
nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente, quante volte gli obblighi di questi,
risultanti da un contratto di lavoro pregressi e rimasti
insoddisfatti, abbiano ricevuto una protezione almeno
equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla Direttiva 80/987 del Consiglio del 20 ottobre 1980 nel caso di insolvenza del datore di lavoro
(art. 5 secondo comma lett.a).
Ne consegue, quindi, che ove si operasse una diversa
interpretazione essa risulterebbe, necessariamente, in
contrasto con la Direttiva comunitaria in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di impresa nell’ambito di procedure che si svolgano sotto il controllo dell’Autorità pubblica compe-
tente, atteso che verrebbe meno la stessa operatività
dell’art. 105 l.f. e, nel caso del concordato preventivo
liquidatorio, dell’art. 182 l.f., che richiama la prima
norma nel senso che la conclusione degli accordi lì previsti non consentirebbero la flessibilizzazione degli
obblighi che quelle norme hanno inteso assicurare al
fine di favorire il trasferimento dell’azienda insolvente
ovvero in crisi.
Conclusivamente la garanzia non può avvenire a discapito della realizzazione degli altri crediti non assicurati
dal Fondo ed una diversa lettura della relativa disciplina normativa risulta essere in contrasto con le Direttive
comunitarie, oltre a non essere costituzionalmente
orientata, sol che si considerino i differenti effetti che
possano conseguire dal diverso momento in cui è intervenuto il Fondo.
Ed infatti ove due o più lavoratori partecipino ad un
primo riparto, senza aver richiesto l’intervento dell’organismo di garanzia, si vedranno attribuire una somma
in proporzione dell’intero credito ammesso al passivo,
mentre gli altri subirebbero la percentuale riduzione in
ragione della partecipazione, in sede di distribuzione,
anche del Fondo.
Le irragionevoli conseguenze per tali creditori risulterebbero più che evidenti ove in un successivo riparto
non fosse loro assicurato l’intero soddisfacimento del
credito, atteso che, nella formulata ipotesi, quei lavoratori che non avevano ancora richiesto l’intervento del
Fondo riuscirebbero a realizzare un maggior soddisfacimento dato dal credito riscosso, in occasione del
piano di riparto, e dall’importo ricevuto dal Fondo, che
surrogandosi rimarrebbe incapiente.
Appare, dunque, evidente che una diversa conclusione
non può essere condivisa perché in contrasto con i principi comunitari e costituzionali.
_________________
1 G. BOZZA, La ripartizione dell’attivo, in Il
nuovo diritto fallimentare, a cura di A.
JORIO - M. FABIANI, Bologna 2011, p. 591.
3 A. SILVESTRINI, in M. NIGRO - A.
SANDULLI, La riforma della legge fallimentare, II, Torino 2006, p. 673.
2 Cass., 29 agosto 1996, n. 7933, in Il fallimento, 1997, p. 69; Tribunale Parma, 20
febbraio 2003, ivi, 2003, p. 901.
4 È emanata in attuazione della Direttiva
80/987 del Consiglio, del 20 ottobre 1980,
relativa alla tutela dei lavoratori subordina-
Temi Romana
57
ti in caso di insolvenza del datore di lavoro,
poi modificata dalla Direttiva 2002/74 del
Parlamento Europeo del Consiglio, del 23
settembre 2002
5 Cass., 3 marzo 2011, n. 5141, in Il fallimento, 2011, p. 1367.
Osservatorio legislativo
6 Cass., 29 agosto 1996, n. 7933, in Il fallimento, 1997, p. 70; Tribunale Roma, 9 ottobre 1996, in Mass.giur.lav., 1997, p. 575.
7 Tribunale Viterbo, 4 giugno 1992.
8 Cass., 21 febbraio 1997, n. 1586, in
Mass.giur.lav., 1998, p. 575, ripreso da
Tribunale Roma, 9 ottobre 1996, con nota di
A. CAIAFA, Fondo di garanzia ex l.n.297 del
1982, concorso di crediti e riparto.
9 Il decreto del giudice delegato che rende
esecutivo lo stato passivo ne stabilisce, difatti, la intangibilità e consente di individuare i
legittimati alla partecipazione al concorso,
con la conseguenza che, in sede di ripartizione, non possono essere proposte questioni
relative all’esistenza o all’ammontare dei crediti ammessi o, ancora, all’esistenza o all’ammontare dei crediti ammessi o, ancora, all’esi-
stenza di distinte cause di prelazione: Cass.,
19 marzo 1996, n. 2321, in Il fallimento,
1996, p. 973; Cass., 11 marzo 1996, n. 1982,
ibidem, 1996, 666 Cass., 13 dicembre 1995,
n. 12790, ibidem, 1996, p. 361; Cass., 11 gennaio 1995, n. 257, ibidem, 1995, p. 1098;
Cass., 24 maggio 1994, n. 5073, ibidem,
1995, p. 247; Cass., 3 giugno 1993, n. 6228,
ibidem, 1993, p. 1233; Cass., 19 novembre
1979, n. 6039, in Giust.civ., 1980, I, p. 1126.
10 Cass., 30 maggio 1983, n. 3708, in
Giur.it., 1984, I, 1, p. 290, che propone una
interpretazione diversa della espressione
contenuta nell’art. 1193 cod.civ.; in senso
contrario, Cass., 1 giugno 1974, n. 1572,
ibidem 1975, I, 1, p. 266; Cass., 7 febbraio
1975, n. 474, ibidem 1975, I, 1, p. 836.
11 La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che, qualora l’attivo falli-
58
mentare sia insufficiente a soddisfare, integralmente, gli stessi debiti di massa, occorre stabilire, tra questi, una graduazione
secondo l’ordine dei privilegi fissati dal
codice civile e che in assenza di questi lo
stesso credito chirografario prevale su tutti
gli altri non prededucibili, pure se privilegiati, Cass., 20 dicembre 1990, n. 12075, in
Il fallimento, 1991, p. 670; Cass., 29 gennaio 1982, n. 569, in Dir. fall., 1982, II, p.
651. Per la dottrina si veda: G. ALESSI, I
debiti di massa nelle procedure concorsuali, Milano 1987, p. 76; V. DEL VECCHIO, La
gradualità dei crediti verso la massa nel
fallimento, in Il fallimento, 1983, p. 1600;
U. AZZOLINA, Il fallimento, Torino 1961, II,
885; R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Milano 1974, III, p. 1656, A.
CAIAFA, I rapporti di lavoro e le procedure
concorsuali, Padova 1994, p. 56.
Temi Romana
Osservatorio legislativo
La disciplina del contratto a termine dopo il decreto Poletti
e la legge di conversione
Andrea Lutri
Avvocato del Foro di Roma
N
egli ultimi anni il Mercato del lavoro, complice la crisi o, più probabilmente, in conseguenza della crisi, è stato oggetto di una serie di
interventi normativi che, complessivamente considerati, hanno attutato un processo di “liberalizzazione”
della regolamentazione del rapporto di lavoro fino a
qualche anno fà difficilmente ipotizzabile.
Dapprima il Legislatore ha “delegato” alle parti sociali
il compito di intervenire su un impianto normativo evidentemente troppo rigido per garantire alle imprese
quella necessaria “flessibilità” divenuta, con il tempo,
indispensabile per adattare la propria organizzazione
alle mutevoli esigenze del mercato, individuando nella
contrattazione di prossimità lo strumento più adeguato
per tale processo di rinnovamento. Tale delega se non
si può affermare che sia rimasta inattuata, sicuramente
non ha realizzato in pieno i propri intenti.
Di qui l’esigenza, avvertita come non più rimandabile
da parte del Legislatore e dei governi che si sono succeduti, di intervenire in maniera incisiva sulla normativa del lavoro, ultimamente facendo sempre più ricorso
alla decretazione d’urgenza, per garantire quella giusta
dose di flessibilità, in entrata ed in uscita, che consenta
alle imprese di investire sul personale o di intervenire
sull’organico aziendale adattandolo alle esigenze della
produzione, senza le temute ripercussioni in termini di
sanzioni previste dall’ordinamento.
In questo panorama di riforme il contratto a termine è
l’istituto che ha registrato, nel breve periodo, il maggior numero di modifiche che, globalmente considerate, hanno sostanzialmente riscritto la normativa fondamentale che è e resta il D.Lgs. 368/01.
È chiaro che il Legislatore non può non recepire quelle
che sono le indicazioni provenienti dal Mercato del
lavoro ed i dati ci dicono, oggi, che i due terzi delle
assunzioni nel nostro Paese sono a tempo determinato.
Non si tratta di una peculiarità soltanto italiana: in
Temi Romana
molti Paesi europei sono state adottate nel corso degli
anni riforme volte a favorire la diffusione di forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro “standard”, a
tempo indeterminato, accomunate dal carattere della
temporaneità nella prospettiva di garantire una maggiore flessibilità “in entrata”.
Per comprendere a fondo questa tendenza basta fare un
cenno all’esperienza del c.d. mini job tedesco.
Si tratta di lavori retribuiti con uno stipendio massimo
di 450 euro mensili e con un limite di ore (almeno formalmente) di 15 ore settimanali (il 1° di gennaio del
2013 è stato approvato l’aumento da 400 a 450 €).
Tale strumento di lavoro flessibile garantisce, inoltre,
alle aziende un regime tributario vantaggioso.
L’imprenditore paga il 2% al fisco e il 28% alla previdenza sociale (il 15% al fondo pensioni e il 13% per la
malattia), perciò il contributo totale assomma al 30%.
Il lavoratore viene esonerato dal versamento di imposte
ma può effettuare una contribuzione volontaria nella
misura del 4,5% dei propri emolumenti destinandoli al
fondo pensione ed inoltre ha diritto a ferie pagate, congedi per maternità ed all’accesso alla tutela approntata
per il licenziamento.
Tornando alla realtà italiana, negli ultimi anni abbiamo
assistito ad una proliferazione indiscriminata di false
partite IVA, di collaborazioni coordinate e continuative,
anche a progetto, sospette, di associazioni in partecipazione con apporto lavorativo utilizzate dalle imprese
con il solo scopo di ridurre il costo del lavoro mascherando dietro tale forme di collaborazione autonome,
rapporti di lavoro in tutto e per tutto subordinati.
Per contrastare tale fenomeno, il legislatore nazionale,
attraverso la legge n. 92/2012, provò ad incentivare la
“flessibilità in entrata” svincolando il contratto a termine dalla necessità di indicare la causa giustificatrice
(che ha rappresentato nel tempo il principale motivo di
contenzioso), ma per un periodo di tempo troppo breve
59
Osservatorio legislativo
(dodici mesi e peraltro limitato solo al primo contratto
a termine tra le parti, non prorogabile) e caricando questo istituto di una serie di fattori di rigidità (quali la previsione di un periodo di stacco tra un contratto e l’altro
più lungo di quello previsto nella legislazione precedente, portato da 10 o 20 giorni a 60 o 90 giorni, gli
accordi sindacali sulla “acausalità ” nella percentuale
del 6%, l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego dello sforamento del termine), finalizzati ad evitarne un’utilizzazione abusiva, che, di fatto, hanno
impedito a tale contratto di esplicare in pieno la funzione di ripresa dell’occupazione.
Gli interventi normativi che si sono succediti dopo la
legge Fornero hanno avuto il comune proposito di eliminare tali fattori di rigidità al fine di rendere il contratto a termine uno strumento realmente “flessibile” di
reperimento della manodopera per le imprese, sulla
considerazione che il contratto a termine oggi rappresenta il principale strumento di assunzione.
In tale quadro di riferimento il D.L. n. 34/2014 è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine eliminando la causale, che, come anticipato, ha costituito fino
ad oggi, il principale motivo di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e ha
regolamentato in maniera più larga rispetto alla legge
Fornero la percentuale consentita di assunzioni a tempo
determinato, facendo salva la possibilità per le parti
sociale di modificare questa percentuale rendendola
aderente alle esigenze del mercato di riferimento.
Come precisato dal Ministero del lavoro con i chiarimenti del 14 marzo 2014, con l’entrata in vigore del
decreto legge il datore di lavoro può sempre instaurare
rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale,
nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di
lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre
ammessa, fino ad un massimo di 8 volte (oggi, con la
legge di conversione, 5 volte) nei trentasei mesi.
Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto
che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la
quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
Nell’introdurre il limite del 20% di contratti a termine
che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al
proprio organico complessivo, il decreto fa comunque
salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.Lgs.
368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle
sostituzioni e alla stagionalità.
Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine.
È, indubbiamente, una novità di grande portata, in linea
con la Direttiva europea sul contratto a tempo determinato e che rompe con un passato ove il mancato rispetto delle stesse aveva avuto un forte impatto negativo
sulla vita delle imprese.
Il Decreto Poletti liberalizza i contratti a termine ma
resta ancora la possibilità di superare i pochi limiti residui con accordi sindacali.
Ancora una volta la formulazione del testo normativo
(come è accaduto per le norme che lo hanno preceduto)
ha prestato il fianco a dubbi ed incertezze in gran parte
(ma non tutte) superate dalla legge di conversione.
La legge n. 78 del 2014, che ha convertito con modifiche la disciplina approntata dal D.L. 34/2014, ha
apportato novità di rilievo alla disciplina introdotto
dalla decretazione di urgenza.
Resta fermo il limite temporale di 36 mesi, così come
resta ferma la percentuale del 20%.
Tuttavia, il legislatore interviene disciplinando le
modalità di computo, ai fini della determinazione del
limite percentuale, precisando che si tiene conto del
solo personale a tempo indeterminato in forza dal 1
gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a termine.
Inoltre il legislatore prevede che i datori di lavoro
(l’espressione datori di lavoro ha sostituito la precedente formulazione che faceva riferimento alle imprese,
creando in tal modo incertezza nell’individuazione del
soggetto destinatario della norma in parola) che occupano fino a cinque dipendenti possono sempre stipulare un contratto a tempo determinato.
Altra novità di notevole portata riguarda l’aspetto sanzionatorio. In caso di sforamento del limite percentuale è prevista soltanto una sanzione amministrativa per
ciascun lavoratore eccedente (nella misura del 20 o
50% percento della retribuzione, a seconda che la violazione del limite percentuale riguardi uno o più lavoratori a tempo determinato).
60
Temi Romana
Osservatorio legislativo
Alla violazione del precetto non seguirà alcuna conseguenza sulla natura del rapporto, con esclusione, pertanto, della sanzione della conversione del rapporto a
termine in un rapporto a tempo indeterminato.
È previsto, tuttavia, un c.d. periodo di grazia entro il
quale il datore di lavoro che abbia in corso rapporti a
termine in misura superiore al limite fissato dalla legge
deve provvedere a rientrare nel suddetto limite, salvo
che un contratto collettivo applicabile all’azienda non
disponga un limite percentuale o un termine più favorevole al datore di lavoro, e tale termine è fissato nel 31
dicembre del corrente anno.
Nel caso di mancato adeguamento alla disposizione
normativa al datore di lavoro inadempiente è preclusa
la possibilità di stipulare nuovi contratti a termine dal 1
gennaio 2015, ma non trova applicazione la sanzione
amministrativa sopra menzionata (né, ovviamente, si
applica la sanzione della conversione).
Premessa l’applicazione della normativa in esame soltanto ai contratti a termine stipulati successivamente
alla sua entrata in vigore, viene fatta salva la vigenza dei
limiti percentuali già previsti dalla contrattazione collettiva, in sede di prima applicazione, se diversi da quelli
introdotti dalla norma in parola, fino alla loro scadenza.
I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, inoltre, continuano a dispiegare i
loro effetti fino alla scadenza.
Restano fuori dal limite del contingentamento:
a) i contratti a termine stipulati nella fase di avvio di
nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) i contratti a termine stipulati per ragioni di carattere
sostitutivo;
c) i contratti a termine stipulati per specifici spettacoli
o specifici programmi televisivi o radiofonici;
d) i contratti a termine stagionali;
e) i contratti a termine stipulati con lavoratori di età
superiore ai 55 anni.
Sono, inoltre, esclusi dalla normativa in esame il personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di
attività di supplenza e ATA per il quale non si applica
né il limite percentuale né quello temporale (36 mesi).
Analogo discorso per i contratti a tempo determinato
stipulati dagli enti, pubblici o privati, di ricerca, con
lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o coordinamen-
Temi Romana
to e direzione della stessa. In tali ipotesi i contratti a termine che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca potranno avere una durata
pari a quella del progetto di ricerca cui si riferiscono.
A tali ipotesi derogatorie della disciplina di cui alla normativa in esame si aggiungano i contratti a termine con
i lavoratori in mobilità, per i quali non trovano applicazione né il limite percentuale né quello temporale (trentasei mesi).
Come anticipato il legislatore interviene nuovamente
sull’istituto della proroga dei contratti a termine, questa
volta in senso peggiorativo rispetto alla disciplina prevista dal Decreto legge convertito.
Il numero di proroghe consentito viene ridotto dalle
originarie 8 a 5 e resta sempre condizionato al limite
complessivo dei trentasei mesi.
Le proroghe, inoltre, sono ammesse sempre che si riferiscano alla stessa attività lavorativa prevista dal contratto prorogato.
Da ultimo si segnala che il legislatore della riforma
interviene anche sul diritto di precedenza, già previsto
nella precedente disciplina del contratto a termine, per
i lavoratori occupati con contratto a termine per un
periodo superiore ai sei mesi riguardo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di
lavoro nei dodici mesi successivi alla cessazione del
rapporto per l’espletamento delle stesse mansioni svolte dai lavoratori a termine, ampliando l’effettività e la
portata del diritto di precedenza.
Viene previsto, infatti, per le lavoratrici madri un diritto
di precedenza sia per le assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro nei successivi dodici mesi dalla cessazione del rapporto a termine (purché si tratti di assunzioni per l’espletamento delle stesse mansioni svolte da queste ultime).
Inoltre il periodo di congedo per maternità intervenuto
l’esecuzione di un contratto a termine con la medesima
azienda, concorre a determinare il periodo di attività
utile per il conseguimento del diritto di precedenza.
Altra novità di rilievo è l’obbligo per il datore di lavoro di portare a conoscenza del lavoratore assunto a termine il diritto di precedenza, con la previsione che tale
comunicazione formale sia espressamente richiamata
nel contratto scritto di assunzione a tempo determinato.
Non sono tuttavia previste specifiche sanzioni in caso
di violazione del precetto normativo.
61
Note a sentenza
La depenalizzazione della colpa lieve
nell’attività medico-chirurgica
La Cassazione applica la legge Balduzzi e depenalizza la colpa lieve
Roberta Mencarelli
Avvocato del Foro di Roma
Sez. IV - Ud. 29 gennaio 2013 (Dep. 9 aprile 2013 n. 268) - Pres. Brusco - Rel. Blaiotta - P.M. D`Ambrosio
È
missiva ma riscontrava, altresì, la colpa anche per non
aver preventivato la complicanza e per non aver organizzato l’esecuzione dell’intervento in una clinica
attrezzata a far fronte alla possibile lesione di vasi sanguigni, profilo quest’ultimo, tuttavia, espressamente
escluso dal Tribunale di prime cure e non oggetto di
impugnazione.
esclusa la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, e quindi la conseguente
responsabilità penale per omicidio colposo, del
sanitario che nello svolgimento della propria attività si
attenga alle linee guida ed alle buone pratiche terapeutiche accreditate.
Il caso
La sentenza in commento ripropone il dibattuto problema della responsabilità medica, affrontando in particolare il tema della rilevanza della c.d. colpa lieve ai fini
della responsabilità penale dell’esercente una professione sanitaria.
La vicenda in esame riguarda una paziente che si era
recata presso una clinica privata per effettuare un intervento di ernia discale recidivante nel corso del quale,
tuttavia, venivano lesionate da parte del chirurgo la
vena e l’arteria iliaca.
A causa della grave emorragia che ne seguiva, il chirurgo esecutore dell’intervento disponeva il ricovero della
paziente presso nosocomio attrezzato per un urgente
intervento vascolare riparatorio che tuttavia non consentiva di scongiurarne la morte.
Il medico, esecutore dell’atto chirurgico, veniva quindi
chiamato a rispondere di omicidio colposo per aver
erroneamente eseguito l’intervento.
Più precisamente, il Tribunale di Roma ne affermava la
responsabilità per aver violato la regola precauzionale
enunciata nella letteratura medica di non agire in profondità superiore a 3 centimetri e di non procedere ad
una pulizia radicale del disco erniario per evitare la
complicanza connessa alla lesione dei vasi che corrono
nella zona dell’intervento.
La Corte D`Appello di Roma non solo confermava la
condanna del medico in relazione alla condotta com-
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
Tra i motivi di ricorso addotti dal ricorrente è segnalata, ex art. 606 n. 1 lett. b), tra gli altri, l’inosservanza
dell’art. 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189 che ha
operato una parziale abolizione della fattispecie di omicidio colposo attraverso l’esclusione della rilevanza
della colpa lieve nel caso in cui il sanitario si attenga
alle linee guida ed alle buone pratiche terapeutiche.
Nel caso di specie, si tratta quindi di stabilire se esista
una buona pratica chirurgica che imponga di non introdurre l’ago a più di 3 centimetri e se, con riguardo alle
linee guida accreditate, vi sia colpa non lieve.
Evidente è la portata innovativa della pronuncia che,
sorta da controverse interpretazioni giurisprudenziali
della colpa nell’esercizio della professione medica,
richiama l’attenzione su due aspetti di nuovissima
emersione: la distinzione tra colpa lieve e colpa grave
ai fini della rilevanza penale della condotta medica e la
valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche.
Per ciò che concerne la colpa nell’esercizio della professione medica, il più antico orientamento giurisprudenziale prevedeva che la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria si configurasse solo
ed esclusivamente nei casi di colpa grave ossia nei casi
in cui il sanitario avesse, nell’espletamento della sua
attività professionale, commesso un errore inescusabi62
Temi Romana
Note a sentenza
le dovuto alla mancata applicazione delle cognizioni
generali e fondamentali attinenti alla professione o alla
carenza di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi operatori che il medico deve essere
sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella
mancanza di prudenza o di diligenza.
Si trattava, in particolare, di quel costante indirizzo giurisprudenziale che riteneva possibile invocare, anche
nell’ambito penale, l’applicazione dell’art. 2236 c.c.
che limita il rilievo della colpa alle sole situazioni di
colpa grave 1 attesa la presunta ordinarietà dei problemi
tecnici di speciale difficoltà caratteristici dell’attività
medica.
Il suddetto orientamento scaturiva dalla necessità che
venisse garantita, in tal modo, la coerenza del sistema
giuridico che non avrebbe giustificato una responsabilità penale laddove non fosse stato ravvisabile, ai sensi
dell’art. 2236 c.c., nemmeno un illecito civile.
Ne era derivata da parte della giurisprudenza maggioritaria degli anni ’60 e ’70 un’ampia applicazione della
clausola di cui all’art. 2236 c.c. con l’esclusione della
responsabilità penale del medico nei casi di mera culpa
levis senza che però venisse effettuato un effettivo
vaglio circa la speciale difficoltà della concreta prestazione professionale2.
Tuttavia, poiché i giudici avevano finito con l’assumere un atteggiamento di irragionevole indulgenza anche
nei casi di grave leggerezza del medico con una evidente disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri consociati responsabili di fatti colposi anche al limite della
colpa lieve3, il citato orientamento aveva sollevato forti
critiche tanto da parte della dottrina4 che della giurisprudenza che ne avevano eccepito il contrasto con il
principio costituzionale di uguaglianza al punto dal
richiedere un intervento della Consulta.
La Corte Costituzionale5 rigettava tuttavia la sollevata
illegittimità giustificando l’applicazione dell’art. 2236
c.c. nella sola ipotesi in cui la prestazione comportasse la
soluzione di “problemi tecnici di particolare difficoltà”.
L’applicazione di tale indulgente orientamento, peraltro, si limitava esclusivamente alla colpa derivante da
imperizia laddove, invece, la Corte statuiva che per
l’imprudenza e la negligenza, era richiesto un giudizio
“improntato a criteri di normale severità”6.
Nonostante fosse intervenuta anche la Consulta,
l’orientamento appena illustrato continuava ad essere
Temi Romana
fonte di pressanti critiche soprattutto da parte della dottrina che lo riteneva troppo indulgente avendo, lo stesso, allargato a dismisura i casi di esclusione della
responsabilità penale del medico.
Conseguentemente, negli anni ’80 si affermava una
nuova ed opposta corrente giurisprudenziale che recideva totalmente qualsiasi collegamento tra l’ambito
penale e civile della colpa giungendo ad affermare che,
ai fini della responsabilità penale del sanitario, alcun
rilievo assumesse la distinzione tra colpa grave e colpa
lieve, che poteva tutt’al più rilevare ai fini esclusivi
della quantificazione della pena.
In tal modo, l’art. 2236 c.c. ha perso qualsiasi rilievo
nell’ambito penale atteso che, alla stregua del nuovo
orientamento, la colpa professionale deve essere valutata sempre e comunque sulla base delle regole generali in tema di colpa contenute nell’art. 43 c.p.7
Nonostante l’affermazione di tale nuovo orientamento,
tuttavia, la corrente giurisprudenziale più risalente nel
tempo, ossia quella più “indulgente”, non è stata mai
totalmente abbandonata, come dimostrano alcune sentenze richiamate dalla stessa Corte, sent. n. 39592/07,
n. 16328/11 e n. 4391/12, che hanno fatto dell’art. 2236
c.c. una regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare la perizia del medico nei casi di emergenza o in quelli che implichino la soluzione di problemi di particolare difficoltà tecnica8.
Dato il controverso panorama giurisprudenziale, a fare
chiarezza è intervenuta la L. 189/12, il c.d. Decreto
Balduzzi, la quale ha formalizzato l’orientamento giurisprudenziale c.d. più favorevole per il medico, prevedendo tuttavia limiti più stringenti all’operatività dello
stesso.
Più precisamente, il legislatore ha distinto colpa lieve e
colpa grave ed ha statuito che non c’è responsabilità
penale in caso di colpa lieve qualora il medico si sia
attenuto alle linee guida e alle pratiche terapeutiche
accreditate presso la comunità scientifica salvo che,
tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, lo stesso abbia commesso un errore rimarchevole.
Vale a dire, come ribadito dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 35922 del 2012, che alla stregua
della nuova legge, le linee guida accreditate operano
come vademecum nella valutazione della responsabilità penale medica ma non esulano il sanitario dalla
responsabilità penale derivante dalla commissione di
63
Note a sentenza
un errore grave.
Con riferimento al primo profilo ossia alla distinzione
tra colpa lieve e colpa grave, va preliminarmente osservato che la novella non solo non ha dato una definizione delle due figure ma non ha nemmeno tratteggiato
una linea di confine tra le stesse lasciando sostanzialmente invariato il panorama giuridico precedente ed
anzi complicando non poco la situazione.
Ed infatti, benché la valutazione della gravità della
colpa non sia affatto estranea all’esperienza giuridica
penalistica come risulta dall’art. 133 c.p. e dagli artt. 43
e 61 n.3 c.p. e benché il nostro ordinamento annoveri in
numerose disposizioni l’istituto della colpa grave, inter
alia, nel Codice Civile, nel Codice della Navigazione,
nel Codice di Procedura Penale, nel codice di procedura Civile, nessuno di essi ne fornisce una espressa definizione.
A ciò deve aggiungersi che nemmeno la giurisprudenza e la dottrina sono approdate ad una unanime nozione di “colpa grave” in quanto, in sede applicativa, la
gravità della colpa non ha mai costituito un discrimen
tra fatto punibile e fatto non punibile bensì un semplice fattore di gradazione della pena.
Poiché per tali ragioni il grado della colpa è stato
affrontato dalla prassi giudiziale solo tangenzialmente
al pari degli altri parametri di commisurazione della
pena, l’emanazione del nuovo art. 3 c.1 del decretosanità e la statuizione della pronuncia in commento
che, sulla base della distinzione tra colpa grave e lieve,
segnano l’essere e il non essere reato, sollevano non
pochi problemi di natura interpretativa ed applicativa
avendo il legislatore utilizzato la locuzione “colpa
grave” senza che vi sia una distinzione con grandi
rischi di arbitrio giudiziale.
Ed infatti, non ci si può esimere dal rilevare che il
nuovo riferimento alla colpa grave risulta assolutamente slegato a qualsivoglia profilo di speciale difficoltà
tecnica a differenza di quanto previsto dall’art. 2236
c.c. che sì limitava e limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo e colpa grave ma solo qualora la
prestazione implichi la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
Ne consegue che la nuova disposizione legislativa
potrebbe rivelarsi illegittima nella misura in cui prevede una limitazione della responsabilità colposa in capo
al medico pur in assenza di adeguati presupposti di
complessità e difficoltà della prestazione in violazione
del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost e del diritto
alla salute (art. 32 Cost).
Ed invero, potrebbero configurarsi molteplici fattispecie concrete in cui in assenza di problemi clinici di particolare complessità, risulti irragionevole limitare la
punibilità alla sola colpa grave per il sol fatto che il
sanitario abbia ottemperato alle linee guida.
In definitiva, quindi, in caso di rispetto delle linee
guida, potrebbe risultare ragionevole limitare la
responsabilità penale ai soli casi di imperitia lata solo
ove si dimostrasse che le linee guida siano idonee ad
esaurire gli aspetti di “buona tecnica medica”.
Ove, al contrario, si riconosca che la perizia medica
possa esigere specifiche condotte, anche al di là delle
linee guida accreditate, non potrà affermarsi che il
rispetto delle stesse sia idoneo ad escludere, iuris et de
iure, un residuo giudizio anche di imperitia levi, per
violazione di altre regole di perizia ulteriori e differenti rispetto alle linee guida.9
Data la rischiosità della situazione così come appena
illustrata, la Corte di Cassazione con la pronuncia in
commento ha cercato di arginare il problema indicando
i fattori di cui l’interprete deve tener conto ai fini della
qualificazione della colpa ed ha, a tal fine, indicato: la
misura della divergenza tra la condotta effettivamente
tenuta e quella che era da attendersi sulla base della
norma cautelare cui ci si doveva attenere, la misura del
rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente ed infine la consapevolezza da parte
dell’agente di tenere o meno una condotta pericolosa.
Venendo ora al secondo elemento, anch’esso di nuovissima emersione, ossia la valorizzazione delle linee
guida e delle virtuose pratiche terapeutiche accreditate
presso la comunità scientifica, la Suprema Corte stessa
riconosce che attraverso il riferimento alle citate linee
guida il legislatore ha dimostrato di aver compreso la
delicatezza del problema e ne ha indicato la soluzione
proponendo un modello di terapeuta attento la sapere
scientifico, rispettoso delle direttive formatesi alla stregua di solide prove di affidabilità diagnostica e di efficacia terapeutica ed immune da tentazioni personalistiche giustificando, in tal modo, l’attribuzione di rilievo
penale alle sole condotte connotate da colpa non lieve.
Si tratta senza alcun dubbio di una importante enunciazione normativa che non solo pone il legislatore in piena
64
Temi Romana
Note a sentenza
sintonia con i più recenti approdi della giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione ma che grazie al riferimento all’accreditamento presso la comunità scientifica ha mostrato che il legislatore è ben consapevole del
fatto che non trattandosi di vere e proprie norme cautelari, le stesse sono sottratte alla certezza e in quanto tali
la loro osservanza non esime tout court il personale sanitario da una eventuale responsabilità colposa.
Orbene, è opportuno in primo luogo fornire una definizione di linee guida al fine di consentire all’interprete
di individuare quali regole possano essere definite tali.
In proposito, una definizione ampiamente accreditata
di “linee guida” è quella fornita dall’Institute of medicine degli stati Uniti d’America secondo cui “clinical
practice guidelines are systematically developed statements to assist practitioner and patient decisions about
appropriate health care for specific clinical circumstances”.10
La genericità di tale definizione mostra come il genus
delle linee guida sia assolutamente vasto ed onnicomprensivo fino a comprendere al suo interno species del
tutto eterogenee11 quali regole di carattere etico, direttive di natura deontologica e prescrizioni giuridiche12.
Dalla circostanza che le la fonte, la struttura e le finalità delle linee guida possono essere le più disparate
discende, come espressamente affermato anche dalla
Suprema Corte nella pronuncia in commento, l’impossibilità di calarle de plano e in modo acritico all’interno del giudizio penale di colpa ma l’obbligo, al contrario, per l’interprete di adeguarle al caso concreto.
Fondamentale conseguenza dell’appena citata statuizione è che, quindi, così come la violazione dei protocolli
clinici non comporta automaticamente la responsabilità
del medico, allo stesso modo il rispetto delle linee guida
non esime il medico dalla responsabilità in caso di esito
infausto del trattamento sanitario laddove si accerti che,
in concreto, fosse esigibile e doveroso un trattamento
alternativo seppur contrario ai protocolli clinici13.
Ed infatti potrebbe ben accadere che il sanitario applichi correttamente le linee guida, inquadri correttamente il caso concreto ma commetta un errore nell’adattamento delle direttive al caso concreto.
Ed ebbene, in tal caso la giurisprudenza di legittimità
prevede che il sanitario incorrerà in responsabilità
penale solo qualora l’errore commesso sia stato non
lieve.
Temi Romana
Come è evidente ictu oculi, la valutazione della rilevanza penale o meno della condotta è tutt’altro che agevole. Si tratta infatti di verificare se, con riferimento al
caso concreto, esistano meno direttive accreditate, se
l’intervento medico sia stato eseguito entro i confini
tracciati dalle linee guida e infine, qualora si versi in
questa specifica situazione, se il medico nell’esecuzione dell’intervento abbia tenuto una condotta connotata
da colpa lieve o grave configurandosi il reato solo in
quest’ultimo caso.
Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente quale fosse l’intento del legislatore quando ha introdotto la legge Balduzzi così come emergono, in modo
altrettanto evidente, le difficoltà cui gli interpreti
andranno incontro nell’applicazione delle nuove disposizioni.
Con riferimento al primo profilo, palese è che la motivazione che ha spinto il legislatore a depenalizzare la
colpa lieve del medico non può che essere legata alla
volontà di evitare di penalizzare la più diligente delle
prestazioni professionali.
A tal fine, il legislatore ha esteso alla colpa medica per
imperizia il favorevole regime previsto dall’articolo
2236 del Codice civile.
Tale “estensione” è stata tuttavia effettuata facendo
salvo un duplice profilo di differenziazione rispetto alla
disciplina civilistica e cioè, da un lato, è stato mantenuto fermo il requisito del necessario rispetto da parte del
medico dei precetti dettati dalla comunità scientifica (le
linee guida o buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica), e dall’altro, non è stata richiesta, ai fini
dell’applicazione della nuova regola penale di favore,
la presenza del requisito della speciale difficoltà tecnica della prestazione eseguita dal medico (requisito che,
come è noto, è espressamente richiamato nel già citato
articolo 2236 del Codice civile).
Per quanto riguarda invece le difficoltà che gli interpreti si troveranno ad affrontare, i problemi concernono
l’individuazione delle c.d. linee guida accreditate, la
scelta del medico se sia preferibile seguirle o meno ed
infine ma soprattutto, l’individuazione delle ipotesi in
cui la condotta del medico sia connotata da colpa grave
e quindi integri gli estremi del reato.
Orbene, a parere di chi scrive, da un’interpretazione
non solo della norma bensì anche della pronuncia in
commento, affinché vi sia illiceità penale con conse-
65
Note a sentenza
guente punibilità, occorrerà che il grado della colpa sia
tanto elevato da configurare una colpa macroscopica e
grossolana in cui nessun altro medico dello stesso livello professionale, nella situazione data, sarebbe incorso.
In altre parole, il sanitario non sarà punito a titolo di
imperizia unicamente per il fatto di aver perseverato
“indebitamente” nell’applicazione delle linee guida o
delle pratiche accreditate dalla comunità scientifica a
fronte di un quadro clinico del paziente che valutato
esattamente secondo le leggi dell’arte avrebbe dovuto
imporre di discostarsene, bensì solo allorquando tale
perseveranza si manifesti in presenza di una situazione
del malato che avrebbe immediatamente orientato
qualsiasi altro sanitario verso un diverso approccio diagnostico o terapeutico.
In conclusione, quindi, alla luce del nuovo panorama
normativo e giurisprudenziale, sicuramente la diligenza ad oggi richiesta al medico non è più quella media
del buon padre di famiglia bensì quella specifica dell’homo eiusdem professionis et condicionis che rende
quindi più doveroso e puntuale l’atto medico ma, allo
stesso tempo, il sanitario gode di una tutela molto maggiore che lo esonera dalla responsabilità penale qualora abbia agito nel rispetto delle nuove prescrizioni.
_________________
1 Sez. IV 21 ottobre 1970, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1973, p. 259 e sgg., Sez. IV 17
aprile 1971, MOLINARI, in Cass. pen., 1972,
p. 1669, Sez. IV 15 febbraio 1978,
VIOLANTE, in Cass. pen., 1980, p. 1559,
Sez. IV 12 dicembre 1988, CAPAREZZA, in
Giust Pen., 1989, II, c. 689.
2 G. CIVELLO, Responsabilità medica e rispetto delle linee guida tra colpa grave e colpa
lieve, in Archivio penale, 2013, I, pp. 1-27.
6 G. IADECOLA, Colpa professionale, in S.
CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto
pubblico, Milano 2006, p. 962.
7 Sez. IV 9 giugno 1981 n. 150650, FINI, in
CED Cass.; Sez. IV 22 ottobre 1983
n.160826, ROVACCHI, in CED Cass., Sez.
IV 2 giugno 1987, BOSCHI, in Cass. Pen.
p.67, Sez. I, 21 marzo 1988, MONTALBANO,
in Cass. pen., 1989, p. 1242, Sez. IV 8
novembre 1988, ANGELILLI, in Cass. Pen.
1990, p. 245.
pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche”, Institute of medicine, Guidelines for clinical practice: from
developement to use, Washington D.C.,
1992; E. TERROSI VAGNOLI, Le linee guida
per la pratica clinica: valenze e problemi
medico-legali, in Riv. It. med. leg., 1999, p.
189 e sgg.
11 M. BILANCETTI, La responsabilità civile
e penale del medico, Padova 2006, p. 744.
3 A. CRESPI, La colpa grave nell’esercizio
dell’attività medico chirurgica, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1973, p. 255.
8 Principio recentemente ribadito in Cass.
Sez. IV 22 novembre 2011, GRASSO et. al.,
in Cass. Pen. 2012, 6, p. 2069.
M. BONA – G. IADECOLA, in La responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie.
Profili penali e civili, Milano 2009, p. 81.
4 Per una definizione dei vari gradi della
colpa F. CARRARA, Programma del corso di
diritto criminale, p. gen. IX,. Firenze 1902,
p. 88, 119 e sgg.
9 CIVELLO, Responsabilità medica cit., p.
20.
12 M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee guida
nell’esercizio della pratica clinica, in Dir.
pen. proc., 1996, p. 891.
5 Cfr. Corte cost. n. 166/1973.
10 “Raccomandazioni di comportamento
clinico prodotte attraverso un processo
sistematico allo scopo di assistere medici e
66
13 Si veda a titolo esemplificativo della
consolidata giurisprudenza in merito Cass
Temi Romana
Note a sentenza
Quando il potere diventa arbitrio
Angelo Miele
Avvocato del Foro di Roma
A
vrei voluto occuparmi della Corte di cassazione penale e – sicuramente – non per tesserne
l’elogio, ma mi è parso più urgente trattare una
vicenda che ha dell’allucinante e, oltretutto, attiene al
corretto agire delle istituzioni e, in definitiva, della
democrazia nel nostro Paese.
Intendo, cioè trattare un aspetto della sentenza costituzionale n. 1/2014 del 4 dicembre 2013, pubblicata in
G.U. il 15 gennaio del corrente anno, che ha dichiarato
incostituzionale la vigente legge elettorale (il c.d.
Porcellum) nelle parti in cui prevedeva il premio di
maggioranza e le liste bloccate. Preciso subito che i
rilievi che appresso farò non riguardano la decisione
dichiarativa d’illegittimità e non perché quest’aspetto
della sentenza fosse del tutto esente di un qualche rilievo ma perché la critica sarebbe inutile in quanto la
decisione è inoppugnabile (art. 136 Cost.).
Mi occuperò, quindi, solo di quella parte della sentenza nella quale la Corte si lascia andare (è proprio il caso
di dire così, ancorché l’espressione sia un tantino irriguardoso) ad un post dictum che invade un campo ad
Essa non pertinente, quale l’effetto retroattivo della
decisione.
Ha affermato, cioè, che la dichiarazione d’incostituzionalità di alcune norme della legge elettorale (come
detto, premio di maggioranza e liste bloccate) produrrà
i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova
consultazione elettorale e, quindi, non tocca in alcun
modo gli atti posti in essere durante il vigore delle
norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto; e ciò perché
– dice la Corte – il principio di retroattività (che pure
riconosce connesso alle sentenze di annullamento) vale
soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti.
Ed il rapporto – sempre secondo la Corte – si è esaurito, nel caso di specie, con la proclamazione degli eletti, che avviene a conclusione della consultazione elettorale.
Temi Romana
Tuttavia, a prescindere dalla contraddizione nella quale
la Corte è caduta (ha ritenuto, cioè, rilevante la questione d’incostituzionalità sollevata nel 2013 dalla
Cassazione nel maggio 2013 quando si erano addirittura concluse le legislature del 2006 e 2008 sotto la
vigenza del Porcellum) resta il rilievo fondamentale
secondo cui le norme annullate non possono vivere
ancora nei suoi effetti, allorché si svolgano le votazioni parlamentari, perché, secondo dottrina e giurisprudenza ormai pacifiche, la cessazione di efficacia delle
norme dichiarate incostituzionali vale come divieto
assoluto di farne comunque applicazione, anche a
situazioni e rapporti pregressi, purché non esauriti (nel
nostro caso finché dura la legislatura).
Ed è incontestabile, infatti, che l’accertamento della
esistenza di una maggioranza, che legittimi ogni volta
il provvedimento parlamentare, è necessario non solo –
come invece ha ritenuto la Corte – ai fini della proclamazione degli eletti ma sempre che si tratti di deliberare, vuoi per l’adozione del regolamento interno, vuoi
per qualsiasi provvedimento da adottare a maggioranza
semplice o a maggioranza qualificata (art. 64 della
Costituzione): onde riemerge continuamente la necessità di non tener conto di maggioranze calcolate secondo le norme annullate.
Forse la Corte si è accorta della erroneità della sua opinione (ripeto: è mera opinione che esula dalla portata
del decisum), perché, traendo il classico coniglio dal
cilindro, ha fatto ricorso al principio della continuità
dello Stato e dei relativi organi, anche del Parlamento,
i quali non possono essere posti nel nulla, né smettere
di funzionare. Ma, si tratta, questa della continuità, di
una troppa, che non conferisce alcuna forza argomentativa all’opinione, anzi, mette maggiormente in risalto
l’errore nel quale la Corte è incorsa: invero, non è in
contestazione l’esistenza del Parlamento, si tratta, invece, del regolare funzionamento di esso, posto che i suoi
componenti sono in parte (non è una bazzecola) il risultato di nomina illegittima.
67
Note a sentenza
Si dirà che il Parlamento potrebbe subire una specie di
cosmesi, cioè vedersi eliminata dal computo della maggioranza la componente relativa al premio di maggioranza; esemplificando si potrebbe dire che il Pd, invece che 340 seggi potrebbe contare solo di quelli depurati dal premio di maggioranza. Ammesso che ciò sia
possibile, della qual cosa dubito, resta però il fatto che
– tenuto conto della posizione del Movimento grillino,
dichiaratosi contrario a partecipare a qualunque alleanza con coloro che dovrebbero andare “tutti a casa”, e
tenuto conto altresì che è fallito il progetto delle larghe
intese – il Parlamento non è in grado di funzionare
regolarmente, per difetto di una stabile maggioranza,
tanto più che l’attuale Governo a direzione Renzi ambisce a promuovere la riforma costituzionale che, com’è
noto, postula maggioranze qualificate e, com’è altrettanto noto, postula tra tutte le forze politiche una condivisione di valori e di principi, allo stato mancante (ne
fa prova il fatto storico che la revisione della
Costituzione è stata all’ordine del giorno da oltre un
trentennio, più volte tentata sempre fallita).
Forse qualcosa si potrebbe attuare ma all’insegna di
compromessi al ribasso, se non addirittura facendo
ricorso a pratiche gattopardesche (tutto cambia, affinché tutto resti come prima).
Il presidente della Repubblica, ostinandosi a non fare
l’unica cosa che è necessario fare siccome il
Parlamento non è in grado di funzionare regolarmente,
cioè sciogliere le Camere a sensi dell’art. 88 della
Costituzione, non fa certamente l’interesse del Paese.
Per altro non è chiaro il motivo di questo comportamento di Napolitano: mantenere al potere i suoi compagni, ovvero usare questo Governo per tener fede agli
impegni assunti personalmente con Angela Merkel?
(come non è chiaro l’atteggiamento di Berlusconi nel
sostenere la continuità di questa legislatura). Ai posteri
svelare il mistero.
Ma, nell’una o nell’altra ipotesi, è evidente che il
Presidente della Repubblica ha recepito l’assistenza
della Corte costituzionale, la quale, come si è sopra
evidenziato, ha mostrato ancora una volta di avere
una propensione a invadere il campo, non suo, della
politica.
Quello che, però, qui mi preme dire – e concludo – è
che si sta esponendo il Paese a un grave pericolo, quello dell’annullamento, per illegittimità costituzionale,
dei provvedimenti che il Parlamento ha emesso e continua ad emettere dopo la pubblicazione su G.U. della
sentenza d’incostituzionalità del Porcellum.
Usando una nota metafora statunitense: l’albero avvelenato non può che dare frutti marci.
Sia chiaro: ho affrontato questo tema – per me doloroso perché rivelatore della pochezza culturale o dell’arbitrio degli attuali detentori del potere, di qualunque
potere – per obbedire alla mia coscienza di cittadino di
questa, nonostante tutto, amata, cara e bella Italia.
68
Temi Romana
Cronache e attualità
L’Avvocatura Pubblica quale strumento per la realizzazione
dei principi di legalità, economicità, efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa
Stefania Ricci
Avvocato dell’Avvocatura Regione Lazio
1.
L’avvocato pubblico: professionista e funzionario pubblico
Nell’ambito della professione forense, l’avvocato pubblico rappresenta un’eccezione. Una norma
specifica, l’articolo 23 della legge professionale n.
247/2012, disciplina gli avvocati degli enti pubblici per
garantirne caratteristiche identiche a quelle dei liberi
professionisti.
Il rispetto dei principi e delle garanzie professionali è
anche l’obiettivo che persegue il regolamento degli
uffici legali pubblici, approvato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’adunanza del
13 dicenbre 2013, che prevede presupposti e requisiti
per la creazione di tali uffici nonché per l’iscrizione
degli avvocati negli elenchi speciali.
La figura dell’avvocato pubblico è particolare perché al
ruolo di avvocato professionista affianca quello di pubblico funzionario.
Questa duplice veste di professionista e funzionario
pubblico dipendente, se da un lato pone problemi contrattuali e organizzativi nel rapporto avvocato/amministrazione-“datore di lavoro”, dall’altro connota in
modo particolare il rapporto avvocato/amministrazione-“cliente”.
L’avvocato pubblico, infatti, ha quale unico ed esclusivo “cliente” l’ente di cui è dipendente e che è chiamato a difendere ed assistere legalmente nel momento in
cui entra in conflitto con altri soggetti. Essendo un
dipendente, quindi incardinato nell’ente, non è soggetto solamente agli obblighi derivanti dal contratto di
lavoro e dai doveri posti dal codice deontologico, ma
partecipa della funzione dell’ente ed è chiamato a curare l’interesse pubblico attributo dalla legge all’ente.
La cura di un interesse pubblico, impone all’ente di
indirizzare tutta l’attività, amministrativa, tecnica, contabile, organizzativa, contrattuale, e tutti i rapporti sia
Temi Romana
pubblicistici che privatistici, a perseguire quell’interesse, e ciò anche quando l’attività o i rapporti diventano
patologici e generano contenzioso. Quando accade ciò
al funzionario subentra l’avvocato, la cui attività è in
continuità con quella del funzionario.
In tutto il contenzioso, anche se di diversa natura, civile, amministrativa o penale, l’interesse pubblico rimane una costante, pur spostandosi sullo sfondo della fattispecie dedotta in giudizio.
Sicché, nel momento in cui l’avvocato pubblico difende
l’attività svolta dal funzionario, nel difendere la specifica situazione, sostanzialmente difende in modo diretto o
indiretto l’interesse pubblico. Questa è la caratteristica
della sua attività che la rende del tutto peculiare.
Infatti, diversamente dall’avvocato libero professionista
che è chiamato a tutelare i diritti del privato cittadino o
a dimostrare che non ha leso diritti altrui, l’avvocato
pubblico deve far valere le ragioni dell’amministrazione per dimostrare che l’interesse pubblico è stato soddisfatto. Mentre il primo difende un soggetto che cura il
proprio interesse, il secondo difende il funzionario che
cura l’interesse altrui, ossia quello della collettività.
2. Il principio di legalità come obiettivo dell’attività dell’avvocato pubblico
La difesa dell’attività del funzionario non è fine a se
stessa ma è finalizzata a dimostrare il perseguimento
degli interessi della collettività e la legittimità dell’azione e, quindi, a dimostrare il rispetto del principio
di legalità.
Il punto di riferimento dell’attività dell’avvocato quindi è il principio di legalità inteso come limite esterno
all’attività, ossia rispetto del fine e dei limiti del potere
stabiliti dalla legge (conformità formale alla legge), e
come limite interno all’attività, cioè conformità delle
modalità di esercizio del potere alla disciplina sostan69
Cronache e attualità
ziale (conformità sostanziale dell’attività alla legge).
In realtà, anche l’avvocato libero professionista, quando difende l’ente pubblico, deve seguire la stessa logica dell’avvocato pubblico e difendere la situazione
dedotta in giudizio in funzione della difesa dell’interesse pubblico, tuttavia, esegue una prestazione contrattuale e professionale in base ad un contratto d’opera
intellettuale (species del genus contratto di lavoro autonomo) che lo lega all’ente e nei cui confronti, quindi,
risponde a titolo di responsabilità contrattuale. La sua
attività è sganciata da quella del funzionario.
L’avvocato pubblico, invece, sebbene con modalità e su
piani diversi, svolge un’attività di cura dell’interesse pubblico che è in continuità con quella del funzionario, perché essendo dipendente dell’ente, così come il funzionario, è tenuto al rispetto delle norme che vincolano il fine
dell’ente stesso e stabiliscono le modalità d’azione.
Ciò comporta che per l’attività specificatamente professionale, ferma restando la responsabilità contrattuale, risponde anche a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, qualora non abbia agito nell’interesse
dell’ente provocando in tal modo un danno erariale.
Se l’avvocato pubblico non svolge un’adeguata o tempestiva difesa dell’ente, per esempio non propone
opposizione ad un decreto ingiuntivo nei termini di
legge, essendo un pubblico dipendente, può incorrere
in un’azione di responsabilità amministrativo-contabile, oltre che in provvedimenti disciplinari o di tipo economico scaturenti dalla responsabilità contrattuale,
mentre l’avvocato libero professionista risponde solo
nei confronti dell’ente per inadempimento contrattuale.
Obiettivo dell’attività di difesa in giudizio, quindi, è
dimostrare che l’amministrazione ha rispettato il principio di legalità perché ha perseguito l’interesse pubblico attribuito dalla legge ed ha seguito, nelle modalità di
azione, le regole ed i parametri dettati dalle norme per
l’esercizio del potere.
Mentre nel contenzioso amministrativo, dove si discute dell’esercizio del potere, la difesa dell’interesse pubblico è immediata, nel contenzioso civile avviene in via
indiretta attraverso la difesa degli interessi propri e
strumentali dell’ente che si configurano nell’attività
privatistica.
Nei giudizi amministrativi la legittimità dell’azione
può essere messa in discussione per violazioni di regole procedimentali, cioè per vizi formali. In tal caso l’av-
vocato, in ossequio all’art. 21 octies L. 241/90, deve
dimostrare che quei vizi non inficiano la sostanza del
provvedimento perché la scelta dell’amministrazione
non avrebbe potuto essere diversa.
Altre volte, invece, si contesta la correttezza della scelta discrezionale, sicché, sulla base di motivazioni scarne, si prospettano vizi sostanziali, quali il difetto di
motivazione o l’eccesso di potere. L’avvocato allora,
senza incorrere in una motivazione postuma, deve replicare evidenziando, attraverso la produzione documentale che l’iter logico-giuridico seguito ha portato ad una
scelta corretta, satisfattiva dell’interesse pubblico.
Nel contenzioso civile, invece, in primo piano compaiono gli interessi propri dell’organizzazione, cioè dell’ente che si avvale della posizione di autonomia negoziale, mentre l’interesse pubblico attribuito rimane
sullo sfondo.
In questi giudizi l’avvocato deve rappresentare che
l’amministrazione nei rapporti privatistici ha rispettato
le norme civilistiche che disciplinano proprietà, obbligazioni, contratti, e tuttavia nel fare ciò, evidenzia che
l’interesse pubblico è stato perseguito perché anche gli
strumenti privatistici vengono utilizzati dall’ente per la
cura dell’interesse pubblico affidatogli, come sancisce
l’art. 1 della L. 241/90.
L’attività dell’avvocato pubblico però non consiste solo
nella difesa giudiziale ma anche nell’assistenza legale
finalizzata a superare criticità nell’azione dell’ente, che
si possono determinare fin dalla fase procedimentale.
È questo forse l’ambito in cui l’avvocato pubblico collabora maggiormente al rispetto del principio di legalità
perché può orientare operato dell’amministrazione suggerendo percorsi alternativi a quello giudiziario e più
garanti dell’interesse pubblico, come l’adozione di provvedimenti di autotutela o integrativi o confermativi ma
con una motivazione più articolata o la riedizione corretta del potere piuttosto che l’impugnazione di sentenze
sfavorevoli o, ancora, in campo civilistico, segnalando
l’inopportunità di opposizioni a ingiunzioni di pagamento quando il debito sussiste o predisponendo schemi di
transazioni che prevengano sentenze di condanna.
3. La realizzazione dei principi fondamentali di
economicità efficacia ed efficienza
La duplice veste di avvocato e pubblico dipendente non
è rilevante solo per gli aspetti di legalità ma anche per
70
Temi Romana
Cronache e attualità
il buon andamento dell’attività stessa i cui corollari
sono l’economicità l’efficacia e l’efficienza.
A partire dalla Legge n. 241/1990 “buon andamento”
dell’attività amministrativa ha assunto il significato di
raggiungimento del miglior risultato possibile. In questa accezione rientrano pienamente le così dette tre
“E”, cioè l’economicità, l’efficacia e l’efficienza, criteri mutuati dal mondo aziendale per essere applicati alla
gestione delle pubbliche amministrazioni in modo da
avvicinarla ad un modello più snello, quale è quello
privatistico.
La legge sul procedimento espressamente sancisce i
criteri di economicità ed efficacia, da cui quello di efficienza si ricava.
L’economicità consiste nell’utilizzare la minore quantità di risorse possibili in modo che i costi della gestione
amministrativa, non solo non superino i benefici previsti, ma siano anche adeguati ad essi. Il principio di economicità, quindi, deve essere coniugato con quello di
proporzionalità, nella sua valenza economica, poiché
richiede che i costi della gestione non siano mai superiori a quelli necessari al perseguimento delle finalità
pubbliche.
Il principio di efficacia misura il rapporto tra risultati
ottenuti ed obiettivi prestabiliti. L’efficacia, quindi,
attesta la capacità della P.A. di raggiungere gli obiettivi programmati.
L’efficienza non è sinonimo di efficacia poiché mette in
relazione la quantità di risorse impiegate con il risultato raggiunto e scaturisce, perciò, dalla combinazione di
efficacia ed economicità. L’attività della P.A., infatti,
può essere efficace, perché raggiunge i risultati previsti, ma inefficiente perché utilizza troppe risorse oppure, viceversa, inefficace, per il mancato raggiungimento dell’obiettivo, ma efficiente perché il risultato è
comunque adeguato alle risorse impiegate.
Essendo inseriti nel novero dei principi fondamentali
dell’azione amministrativa, efficacia economicità ed
efficienza sono parametro di valutazione (in termini di
legittimità) dell’attività dell’amministrazione e, quindi,
anche dell’attività dell’avvocatura interna ad un ente.
Dal punto di vista dell’economicità (rapporto tra
risorse utilizzate e risultati ottenuti) non v’è dubbio
che, nei casi in cui il contenzioso dell’ente non sia
occasionale ma abbia frequenza e consistenza elevate,
l’avvocatura pubblica, essendo una struttura dell’ente,
Temi Romana
consente di contenere i costi della difesa giudiziale che
sarebbero sicuramente più alti se fosse affidata ad
avvocati del libero foro.
Infatti, da un lato i costi di gestione della singola struttura (utenze, servizi, attrezzature informatiche) incidono in modo proporzionale alle dimensioni dell’ente per
cui, tanto più l’ente è grande tanto più sono ammortizzate, dall’altro lato, i costi degli avvocati, essendo
dipendenti dell’ente, sono limitati agli stipendi previsti
dai contratti collettivi.
Per stabilire se l’avvocatura pubblica assicura o meno
l’economicità occorre, quindi, verificare i risultati ottenuti con le risorse impiegate.
Non è superfluo chiarire che per risultato non può
intendersi l’esito favorevole del giudizio perché è noto
che l’obbligazione dell’avvocato è un’obbligazione di
mezzi e, quindi, il punto di riferimento per la verifica
del risultato è il rapporto tra il costo generale sostenuto
per la gestione del contenzioso e la quantità di contenzioso gestito.
La quantità di contenzioso dell’ente è fondamentale per
valutare se l’avvocatura interna risponde al criterio di
economicità.
Sicuramente in un ente di piccole dimensioni - come
per esempio un comune con un basso numero di abitanti in cui è raro che si crei un contenzioso giudiziario non è economico dedicare una struttura unicamente
all’attività legale perché i costi non verrebbero ammortizzati. In tal caso può essere più conveniente incaricare all’occorrenza un avvocato del libero foro. Quando,
invece, l’ente ha dimensioni grandi, un ufficio dedicato come un’avvocatura interna diventa una soluzione
economicamente vantaggiosa.
L’analisi dei costi, sebbene sia la prima operazione da
compiere è, tuttavia, un’analisi superficiale, che
potrebbe non essere sufficiente per stabilire se per l’ente avere un’avvocatura interna è economicamente utile.
Occorre verificare, infatti, anche se le cause sono state
effettivamente trattate o solamente prese in carico dall’avvocatura, se quindi l’avvocatura ha un ruolo attivo
o solo di intermediario con i professionisti esterni.
Sicché, all’analisi dei costi va associata l’analisi dei
risultati raggiunti.
Più significativa è la verifica dell’efficacia dell’avvocatura pubblica, ossia se sia stata capace di raggiungere gli obiettivi programmati e, quindi, il rapporto tra
71
Cronache e attualità
risultati ottenuti e gli obiettivi prestabiliti sia positivo.
L’obiettivo dell’ente che istituisce una propria avvocatura è assicurare la trattazione al proprio interno degli
affari legali. L’avvocatura, infatti, è una struttura “dedicata” alla cura dei giudizi in cui l’amministrazione è
attore o convenuto. Si può dire, quindi, che l’obiettivo
è raggiunto al massimo grado se tutti i giudizi presi in
carico vengono poi assegnati, studiati, seguiti, conclusi, senza lasciare priva di attenzione alcuna vicenda
controversa.
L’efficacia dell’avvocatura si può misurare proprio
nella quantità di affari legali concretamente trattati
rispetto a quelli complessivamente entrati. Sicché,
un’avvocatura si può ritenere tanto più efficace quanto
più riesca a controllare gli affari legali presi in carico.
Per ottenere questo risultato è necessario innanzitutto
un ufficio adeguatamente organizzato, composto da
personale qualificato e mezzi idonei, per poter materialmente esaminare, valutare, schedare, conservare
tutti gli atti, giudiziari e non, che entrano al protocollo.
Gli affari, in base all’oggetto, possono essere assegnati
ad un legale oppure al personale amministrativo o trattati come affari generali o archiviati, ciò che conta ai
fini dell’efficacia è che a ognuno sia data la corretta
destinazione e possano essere conosciuti e monitorati
al fine di avere il controllo di tutto il contenzioso.
Fondamentale, per assicurare l’efficacia di un’organizzazione di persone e mezzi, è il coordinamento.
Nell’avvocatura pubblica tale attività compete all’avvocato preposto alla sua direzione il quale deve organizzare la struttura ottimizzando le risorse umane e
strumentali disponibili. A tal fine il coordinatore deve
valutare l’importanza della questione e l’interesse dell’ente, stabilire come deve essere trattata, se è necessaria l’attività difensiva o di solo studio o è sufficiente il
monitoraggio, oppure se rientra tra le ipotesi di difesa
da parte dei funzionari (controversie tributarie o le
opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed ai verbali di
accertamento di violazione al codice della strada) deve
assegnare gli affari legali in base alle competenze e
attitudini del personale e distribuire i compiti in modo
razionale così da ottenere, con le professionalità e i
mezzi a disposizione, il miglior risultato possibile in
termini di efficacia.
Una buona organizzazione è garanzia di efficacia, ma
poiché le avvocature pubbliche fanno parte della pub-
blica amministrazione soffrono degli stessi suoi mali e
spesso non sono adeguatamente organizzate rispetto
alle competenze e al carico di lavoro che sopportano.
Accade però che alle disfunzioni organizzative pongono rimedio gli avvocati e i dipendenti amministrativi
che, proprio per la peculiarità dell’attività, scandita dai
termini perentori, si fanno carico personalmente di
adempimenti e di attività che esulano dalle loro competenze pur di portare a compimento la pratica assegnata.
Quasi sempre, quindi, l’efficacia dell’avvocatura, ossia
il raggiungimento dei risultati attesi, anche quando
manca un’organizzazione adeguata, è comunque garantita dagli avvocati e dai funzionari.
L’ultimo e più importante passaggio dell’analisi dell’attività dell’avvocatura interna all’ente è quello relativo all’efficienza che scaturisce dalla combinazione
dell’efficacia e dell’economicità poiché indica il rapporto tra risorse impiegate e risultato raggiunto.
L’analisi mostra l’impegno economico dell’ente per
l’effettiva trattazione al suo interno degli affari legali.
Efficienza dell’avvocatura significa, quindi, adeguatezza dei costi sostenuti alla quantità e qualità del contenzioso concretamente trattato.
Il risultato positivo o negativo emerge dal confronto
con i presumibili costi delle cause calcolati con le tariffe forensi, ossia il parametro ufficiale per la quantificazione del compenso degli avvocati del libero foro.
Perché l’analisi sia rappresentativa della realtà occorre
considerare non solo la quantità delle cause trattate ma
anche la qualità.
Sicché l’avvocatura pubblica è efficiente quando riesce
a provvedere complessivamente alla difesa dell’ente a
costi inferiori a quelli di mercato.
In linea generale si dovrebbe poter dire che tanto più
l’ente è articolato per struttura e competenze, e quindi
produce un contenzioso ingente e diversificato, tanto
più l’avvocatura interna è potenziale strumento di efficienza dell’azione amministrativa, fermo restando che
sia ben organizzata ed adeguatamente fornita di risorse
umane e strumentali altrimenti la complessità e quantità di affari trattati potrebbe essere al contrario causa di
inefficienza.
Certamente l’efficienza dell’azione è favorita dal rapporto che l’avvocatura pubblica, essendo una struttura
dell’ente, ha con le altre strutture amministrative.
Gli avvocati interni, infatti, facendo parte dell’ammini-
72
Temi Romana
Cronache e attualità
strazione ne conoscono meccanismi e procedure, spesso conoscono personalmente i colleghi funzionari, il
che snellisce le relazioni, semplifica i contatti e crea le
condizioni per poter ottenere in modo rapido e utile le
informazioni e i documenti necessari allo studio del
caso e alla predisposizione degli atti difensivi.
D’altro canto anche i funzionari, nei rapporti con gli
avvocati interni possono omettere alcune formalità,
necessarie, invece, nei rapporti con l’esterno.
La collaborazione che si può creare tra colleghi dello
stesso ente, sebbene con ruoli diversi, ottimizza le
risorse ed al tempo stesso migliora il risultato inteso
Temi Romana
come trattazione complessiva delle cause ma incide
anche sulla crescita professionale del personale perché
determina uno scambio di esperienze utile sia all’avvocato che al funzionario.
Questo aspetto è molto importante perché la collaborazione tra avvocatura interna e le altre strutture dell’ente nella gestione del contenzioso migliora la professionalità del personale e la qualità del lavoro e, quindi,
dimostra ancora le potenzialità dell’avvocatura pubblica come strumento di garanzia del principio di legalità
e dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
73
Cronache e attualità
Convegno Roma – Camera dei Deputati Complesso di Vicolo Valdina Sala del Cenacolo
16 gennaio 2014 – Relazione
La mediazione in Europa e in Italia
Esperienze a confronto in uno studio del Parlamento Europeo
Il ruolo della mediazione nel sistema giudiziario italiano
Giorgio Santacroce
Primo Presidente della Corte di Cassazione
1.
Parto da alcuni dati confortanti, dai quali è
possibile trarre delle considerazioni utili a
inquadrare e approfondire il senso e la portata
del ripristino (ma c’è chi ha parlato di una vera e propria “resurrezione” o addirittura di un “blitz del governo”) della mediazione obbligatoria attuato dal c.d.
decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98),
dopo la battuta d’arresto impressa all’istituto dalla
Corte costituzionale con la sentenza del 23 ottobre
2012, n. 272. La quale – dichiarando l’illegittimità
costituzionale del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per essere andato oltre il perimetro fissato nell’art. 60 della
legge delega del 18 giugno 2009, n. 69 – aveva sì cancellato dall’ordinamento l’obbligatorietà del ricorso
alla mediazione assunta dal legislatore delegato quale
profilo caratterizzante della disciplina in un numerus
clausus di controversie civili, ma non aveva toccato il
merito della scelta della mediazione e del suo ruolo,
essendo l’obbligatorietà venuta meno solo perché non
trovava riscontro nei principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega, ispirati alla volontarietà dell’iniziativa e all’intento di promuoverne la diffusione
mediante la previsione di incentivi di carattere fiscale.
Considerato che ora l’obbligatorietà non fa più perno su
una delega, parrebbe di poter escludere che la nuova
mediazione obbligatoria sia in conflitto con le conclusioni del giudice delle leggi, anche se non sarebbe stato male
che la nuova disciplina, dopo il maquillage che ha subito, fosse stata condensata in un testo normativo sganciato dalla precedente delega e disancorato quindi dalla
medesima collocazione topografica, così da apparire frutto di una scelta autonoma e nuova del legislatore.
Il primo dato positivo è che, passata la tempesta, la
mediazione riprende slancio e, a confermarlo, sono le
Camere di commercio, secondo le quali nel solo mese
di ottobre gli organismi di mediazione camerali iscritti
di diritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia
hanno registrato un vero e proprio boom di richieste
con il deposito di 1.537 procedure. Un aumento
dell’84% rispetto alle 835 procedure depositate fino al
21 settembre scorso, quando il ricorso preventivo alla
mediazione era rimasto solo facoltativo. Considerato
che il totale delle procedure iscritte nel periodo di non
obbligatorietà (tra il dicembre 2012 e il settembre
2013) è stato pari a 5.635, le 1.537 depositate nel mese
di ottobre rappresentano il 27,3% di tutti i procedimenti depositati nei nove mesi di mediazione “solo” volontaria. Insomma, dopo il crollo verificatosi a seguito
della sentenza della Corte costituzionale, che aveva
bocciato l’obbligatorietà della mediazione, il numero
delle richieste torna a crescere.
Un secondo elemento positivo è che il TAR del Lazio
ha respinto il 10 dicembre scorso la richiesta di sospensiva dell’obbligatorietà della nuova disciplina avanzata
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA).
Anche se non si è in presenza di una declaratoria di
rigetto per manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’obbligatorietà della
mediazione, che pure è stata risollevata dall’OUA
dinanzi al TAR del Lazio negli stessi termini e con le
stesse censure dedotte prima della decisione della
Consulta dell’ottobre del 2012, il rigetto della richiesta
di sospensiva e il rinvio al giudizio di merito della questione di costituzionalità fanno ben sperare.
Dalla Corte di appello di Milano giunge poi la notizia
74
Temi Romana
Cronache e attualità
zione professionale”.
L’attenzione degli ispettori è stata puntata, quindi, da
un lato, sulla verifica dei requisiti certificati o autocertificati (tranne la polizza assicurativa, che va presentata in copia), accertando l’effettiva corrispondenza della
documentazione prodotta alla realtà e, dall’altro, si è
soffermata sui corsi e sui tirocini per l’aggiornamento
biennale, obbligatorio per la permanenza nell’elenco
ministeriale, tenuto conto che lo svolgimento dei corsi
e dei tirocini è stato piuttosto problematico nel periodo
in cui la mediazione ha perso il carattere dell’obbligatorietà.
Ma non è tutto. Le indicazioni della direttiva ministeriale investono anche la corretta applicazione delle
norme regolamentari in ordine alla designazione del
mediatore, irrigidite ora dal D.M. n. 145 del 2011 che
ha modificato il D.M. n. 180 del 2010, prevedendo che
gli affari di mediazione siano assegnati con criteri
“inderogabili” fissati dal regolamento dell’organismo e
“rispettosi” della competenza professionale del mediatore, in base anche al suo titolo di studio.
del primo via libera alla mediazione c.d. endoprocessuale. Con ordinanza del 29 ottobre 2013, la Corte
distrettuale ha disposto il rinvio delle parti davanti a un
organismo per il tentativo di conciliazione. L’oggetto
della lite riguarda un credito contestato nel suo ammontare derivante dall’assegno di mantenimento di divorzio. Nel provvedimento si precisa che la materia familiare non preclude ex se l’accesso alla mediazione
quando si controverte di situazioni patrimoniali e, quindi, di diritti disponibili. È interessante notare come l’ordinanza faccia riferimento a un contesto relazionale nel
quale il giudice punta su un rapporto “destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi
[perché divorziati], sono tuttavia ancora genitori”: il
che spinge il giudice a orientarsi verso il perseguimento dell’interesse “preminente” dei figli minori, valorizzando le opportunità mediative offerte dal sistema.
Ma le notizie buone non sono finite. Sono partiti finalmente i controlli sugli organismi di mediazione, sia a
campione che su sollecitazione e, ancora, sia per l’accreditamento che sulla professionalità dei mediatori. Il
Ministero della Giustizia ha stretto la vigilanza sugli
organismi di mediazione per garantirne la qualità, l’imparzialità e l’economicità del servizio. E lo ha fatto nel
solco delle linee guida individuate con una direttiva del
5 novembre scorso e precisate con una circolare del 27
novembre successivo.
Ora è noto a tutti che la previsione del tentativo di
mediazione come condizione di procedibilità della
domanda giudiziale per la risoluzione di determinati
gruppi di controversie ha provocato un’impennata del
numero degli organismi di mediazione (che sono arrivati a 1.009) e degli enti di formazione per i mediatori
(che alla fine di novembre erano 403). Una crescita che
era andata avanti senza controlli, trattandosi di strutture iscritte nei registri tenuti dal Ministero della
Giustizia in base al possesso di determinati requisiti
(adeguata capacità organizzativa e finanziaria, polizza
assicurativa di importo non inferiore a 500 mila euro,
requisiti di onorabilità dei soci e degli amministratori,
garanzie di indipendenza e riservatezza nello svolgimento della mediazione, possesso di una laurea triennale, ecc.). La giusta preoccupazione del Ministero è
sempre stata che il procedimento di mediazione si svolga in modo da assicurare ai cittadini che debbano o
intendano avvalersene “un elevato livello di prepara-
Temi Romana
2. Fin qui la cronaca di questi ultimi mesi. Ma le indicazioni che si traggono da queste notizie – nel segnalare emblematicamente una ripartenza della mediazione
per i tratti di novità che la caratterizzano e per l’attenuarsi di quel clima di preconcetta ostilità che aveva
accolto il suo debutto nel marzo 2010 – consentono di
entrare nel vivo di quella che è stata ribattezzata la fase
2 dell’istituto, in vigore dal 21 settembre scorso (ma
c’è chi dice dal 20, non essendoci accordo sulla sua
data di decorrenza) e di mettere in luce le potenzialità
effettive dell’istituto. Un fenomeno, la mediazione, che
trae origine da quella law explosion che si è registrata
all’improvviso in tutta Europa e che si è avvertita in
misura massiccia in Italia, nel momento in cui si è passati da una giustizia d’élite a una giustizia di massa,
caratterizzata dall’emergere e dal riconoscimento di
una pluralità di nuovi diritti (tutela delle minoranze,
questioni di genere, ecc.), fonte di un numero illimitato di controversie dalla durata incontrollabile, e si è
stati costretti a prendere atto che l’impegno dei giudici
statali non poteva spingersi più in là di tanto, né si potevano aumentare le risorse per farvi fronte.
È da questo momento che si è cominciato a parlare di
ADR (Alternative Dispute Resolutions). La CEPEJ le
75
Cronache e attualità
ha individuate come metodo generale di composizione
delle controversie, al pari della conciliazione e dell’arbitrato, “alternative” al processo di cognizione dinanzi
al giudice statale. Le ADR hanno trovato un esplicito
riconoscimento nelle istituzioni dell’Unione europea,
per effetto della direttiva del Consiglio d’Europa del 21
maggio 2008, relativa alla mediazione delle controversie transfrontaliere: la quale – precisa espressamente –
può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale. È da qui che si è fatta lentamente strada in
Italia la mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali, come canale privilegiato per chiudere le liti e strumento centrale per l’efficienza del sistema giudiziario civile, che è uno degli
elementi in base ai quali si misura l’affidabilità di un
Paese nel panorama internazionale.
Essendo chiamata a svolgere questo ruolo propulsivo la
mediazione ha il sapore – come qualcuno ha detto – di
una vera e propria rivoluzione di qualitá etica. Perché
essa, come metodo negoziale di composizione delle
controversie, non va vista solo e prevalentemente come
uno strumento di commodus discessus dalla giustizia
civile statale, cioè come un innegabile mezzo deflattivo atto a decongestionare il carico di lavoro dei giudici professionali, ma rappresenta anche uno strumento
di accesso alla giustizia, in quanto espressione tangibile di “quel movimento mondiale per rendere i diritti
effettivi”, che è stato alla base del grande progetto di
Access to justice di matrice nordamericana, promosso
da Mauro Cappelletti alla fine degli anni settanta e
ripreso piú recentemente da Varano. La flessibilità
dello strumento, favorendo la composizione delle controversie in modo semplice, rapido e informale, svolge
una funzione di rete di contenimento rispetto all’abuso
del processo, ma opera anche di sponda per ampliare
l’accesso a soluzioni del conflitto che dispongano di
plurime vie d’uscita, non limitate all’arbitrato o all’innesco dei procedimenti giudiziari, consentendo alla
mediazione di dimensionarsi rispetto a contrasti che la
logica del processo potrebbe non riuscire a mettere
completamente a fuoco.
La stessa Commissione europea non ha mancato di rilevare come i programmi di Alternative Dispute
Resolutions siano nati “per creare una forma di pacificazione sociale su base più consensuale e appropriata
di un ricorso al giudice”, spingendo le parti verso una
soluzione amichevole e bonaria. È quindi estremamente riduttivo confinare le forti potenzialità di sviluppo
sociale della mediazione al mero sfoltimento dei processi civili, oppure fare i conti sul numero di liti che
alleggeriranno i nostri tribunali, senza dare evidenza
alla portata avanguardista dell’istituto.
Anche se forse è la meno valorizzata, la pacificazione è
sicuramente la più importante funzione che la mediazione è chiamata ad assolvere dal punto di vista antropologico e culturale, perché essa guarda fondamentalmente
in avanti e agisce sul rapporto complessivo tra le parti,
puntando a far riscoprire, attraverso l’accordo tra esse,
le virtù del consenso e della negoziazione paritaria.
La mediazione, insomma, fa scoprire un modo diverso
di porsi dinanzi alle dinamiche del conflitto che contrappone le parti. Ancor prima di assumere rilievo giuridico, il contrasto tra le parti – si fa osservare – va analizzato a livello psicologico, puntando sulle caratteristiche comportamentali e le competenze psicologiche che
il mediatore deve possedere per una gestione ottimale
del contrasto stesso. L’opera del mediatore non può
essere, quindi, frutto di improvvisazione. Donde una
valorizzazione della sua neutralità, come ferma volontà di sviscerare tutti i più segreti risvolti del conflitto,
senza emettere giudizi. Al mediatore si richiede di essere qualcosa di diverso dal giudice, il quale ha spesso
una visione parziale della controversia che è chiamato
a dirimere perché vede solo la punta di un iceberg, laddove al mediatore è richiesto di cogliere tutto l’iceberg,
di capire cioè tutti i veri bisogni, spesso non manifesti,
delle persone coinvolte nella controversia.
Per meglio addentrarsi nella deontologia del mediatore,
è utile prendere le mosse dalle competenze che il
mediatore deve possedere per aiutare le parti a raggiungere un accordo.
Quella del mediatore – si sa – è una figura professionale trasversale rispetto alle competenze sia giuridiche
che tecniche. Il decreto legislativo del marzo 2010 ha
previsto per chi riveste il ruolo del mediatore che questi non debba necessariamente essere un giurista, così
come in una lite di tipo tecnico non deve necessariamente essere un esperto della materia oggetto della lite,
anche se le conoscenze giuridiche e tecniche possono
indubbiamente facilitargli il compito. L’attività del
mediatore, insomma, può essere definita come un’atti-
76
Temi Romana
Cronache e attualità
vità meta-giuridica, perché coinvolge competenze tipiche di un “diplomatico” di carriera, dovendo spaziare
dalla comunicazione alla psicologia, dal diritto all’economia e a molti altri ambiti di interesse.
A parte le garanzie di indipendenza, imparzialità e
riservatezza richieste agli organismi di mediazione per
l’iscrizione nel registro, è risaputo che il procedimento
di mediazione può avere inizio soltanto dopo la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte
del mediatore designato. A stabilirlo è l’art. 14 comma
2 lett. a) del decreto legislativo n. 28 del 2010. Va da sé
che l’adempimento di quest’obbligo, che appare meramente formale, mira in realtà a responsabilizzare contestualmente gli organismi di mediazione e la scelta dei
mediatori. Si richiede cioè una particolare cura agli
organismi nella scelta del mediatore (e non soltanto con
riferimento al profilo dell’imparzialità), rifuggendo da
semplicistici meccanismi di turnazione automatica.
Il mediatore deve saper condurre la mediazione in
modo non solo trasparente, ma anche scrupoloso e
coscienzioso e deve gestire la stessa, facendo rispettare
alle parti obblighi di correttezza e di rispetto reciproco,
in modo che il procedimento possa avere il più alto
grado di probabilità di riuscita. Da qui l’obbligo di
migliorare le proprie capacità tecniche attraverso un
continuo aggiornamento teorico e pratico, anche attraverso un continuo confronto con i colleghi mediatori,
possibilmente anche di altri Paesi.
della sperimentazione e valutare il da farsi.
Ma molte altre sono le novità introdotte. Mi limito a
indicare le principali in rapida sintesi, non solo per
inquadrare meglio l’esatta portata delle modifiche
intervenute, ma anche per far capire che certe modifiche, pur in assenza di una cultura della mediazione,
possono assicurare una certa effettività al sistema,
responsabilizzando le parti sull’utilità della ricerca di
una soluzione consensuale nella risoluzione di una
certa tipologia di cause.
La prima novità rilevante è la centralità del ruolo degli
avvocati, cui viene riconosciuto lo status di mediatori
di diritto. Le parti dovranno usufruire dell’assistenza
tecnica di un legale lungo tutto il corso della procedura
e, in caso di accordo, si stabilisce che gli avvocati, sottoscrivendo il verbale di accordo, possano attestare e
certificare la sua conformità a norme imperative e di
ordine pubblico. Così facendo, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’assistenza legale, bisogna
aggiungere, scatta per la conciliazione obbligatoria e
quella disposta dall’Autorità giudiziaria, ma non per i
casi di mediazione facoltativa
Al Guardasigilli bisogna dare atto di aver insistito molto
opportunamente nella sua direttiva del novembre scorso
sulle “priorità operative” da osservare in materia di
mediazione, identificate essenzialmente nella centralità
del ruolo dei mediatori e nella trasparenza di chi amministra la mediazione. Il riferimento accennato al possesso di “un elevato livello di preparazione professionale”
è pienamente condivisibile. Così come è opportuno che
si assicuri “l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle
parti coinvolte nel procedimento”, verificando la sussistenza di eventuali commistioni di interessi nella gestione degli organismi di mediazione, che spesso non hanno
sedi proprie e, quindi, condividono a diverso titolo, gli
spazi di altre attività (da quelle professionali a quelle
associative). Non è un caso che agli avvocati sia stato
fatto divieto, con la modifica del codice deontologico
forense, di fissare la sede dell’ente presso lo studio legale (e viceversa), e che sia stata richiamata l’attenzione
sul fenomeno delle convenzioni e degli accordi stipulati fra organismi, avvocati o consulenti, stabilendo nella
3. Chiarito il ruolo della mediazione e del mediatore,
giova far notare che le nuove disposizioni seguono in
via generale le indicazioni contenute nel capitolo V
dedicato all’amministrazione della giustizia contenuto
nella Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle
riforme istituzionali istituito lo scorso 30 marzo dal
Presidente della Repubblica. Ed è un segnale di strategia positivo che si sia puntato, sotto l’aspetto della
cura, più su misure organizzative che solo processuali,
incidendo sia sulle controversie in entrata che su quelle per così dire “storiche” perché risalenti nel tempo.
Caratteristica della nuova mediazione è, in ogni caso, la
sua versione sperimentale. Essa è infatti a tempo.
L’obbligo di passare per il tentativo di accordo amichevole sarà in vigore per quattro anni. A stretto giro di
boa, già al termine del secondo anno, il Ministero della
Giustizia dovrà attivare un monitoraggio degli esiti
Temi Romana
77
Cronache e attualità
circolare del 27 novembre che queste convenzioni
“devono ritenersi non consentite”.
Anche le tempistiche della procedura risultano cambiate. Il primo incontro, che opera come una sorta di filtro
a scopo esplorativo, è totalmente gratuito e deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da
parte dell’organismo di mediazione. In questo incontro
di esordio (da molti ribattezzato come “incontro informativo”) il mediatore è tenuto a chiarire alle parti la
funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e a invitare le stesse e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilità di iniziare e avviare la procedura di
mediazione. Già dal primo incontro, pertanto, qualora
fosse dichiarata l’indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo sperimentato e fallito consentirà alle parti di adire il giudice, senza che esse siano
tenute a versare alcun compenso all’organismo di
mediazione.
Peraltro, in assenza di giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il
giudice può desumere argomenti di prova al momento
della decisione nel successivo giudizio (art. 8 comma 4
bis). Il giudice, inoltre, se la parte costituita, nei casi in
cui è previsto obbligatoriamente l’esperimento del procedimento di mediazione (art. 5) non vi ha partecipato
senza giustificato motivo, è tenuto a condannarla al
versamento di una somma corrispondente all’importo
del contributo unificato che sarebbe dovuto per la presentazione della medesima domanda in giudizio.
Indipendentemente dalla fondatezza o meno della
domanda proposta in mediazione dal ricorrente, insomma, la mancata partecipazione all’incontro fissato per
esperire il tentativo di mediazione si traduce automaticamente in una sanzione che verrà applicata dal giudice nel successivo, eventuale giudizio di merito. Resta
da stabilire se il giudice debba formulare la condanna
già dalla prima udienza o debba procedervi all’interno
del provvedimento con cui definisce il procedimento
davanti a lui.
L’idea di questo previo incontro di programmazione è
apparsa a molti un po’ macchinosa e forse inutile per chi
ha già una cultura dell’istituto ed è apparsa, in ogni caso,
defatigatoria, sia perché la verifica della mediabilità
della controversia non necessita di un ulteriore subprocedimento, sia per i tempi contenuti nei quali deve pervenirsi al risultato della procedura, positivo o negativo che
sia. Se però si parte dalla constatazione che molte persone non sanno che cosa sia la mediazione né a che cosa
serva, l’incontro può rivelarsi senz’altro utile.
L’intero procedimento non può andare poi oltre tre
mesi, a fronte dei quattro mesi precedenti (art. 6
comma 1), che aveva suscitato polemiche fra quanti
ritenevano di essere costretti ad attendere un tempo
troppo lungo dopo il deposito della domanda di mediazione per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
L’aver ridotto questo periodo di un solo mese però non
è che abbia risolto granché.
L’art. 4 prevede inoltre un limite geografico all’operatività degli organismi di mediazione, visto che la relativa domanda deve essere presentata depositando
un’istanza presso un ente del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (si noti che
una norma analoga è stata inserita in materia di liti condominiali con la riforma del condominio in vigore dal
18 giugno scorso). Si tratta di un’autentica novità. Per
la prima volta trova accesso nella procedura di mediazione un criterio di competenza per territorio, attingendo dalla previsione del codice di rito, nel senso che chi
presenta la domanda di mediazione è tenuto a individuare innanzitutto il luogo dove andare a ricercare l’organismo di mediazione da adire. In questo modo vengono incentivate le adesioni e sono destinate a diminuire le mancate adesioni motivate da una collocazione
territoriale non di gradimento della parte chiamata in
mediazione. Nello stesso art. 4 si prevede anche che, in
caso di più domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolga davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la
prima domanda.
Un’altra novità riguarda il catalogo delle controversie
che debbono essere oggetto di mediazione, che si è
allargato fino a comprendere l’estensione dell’obbligatorietà anche al risarcimento dei danni derivanti dalle
professioni sanitarie e non più soltanto mediche.
Restano fuori, invece, le controversie relative al risarcimento danni derivante dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, così come è stata esclusa la pregiudizialità
anche nell’ambito dei procedimenti sommari di accertamento tecnico preventivo. Una mancanza, quella
delle cause di risarcimento derivanti da incidenti stradali, che è stata rimarcata da tutti gli operatori del settore, i quali hanno evidenziato come in molti casi rela-
78
Temi Romana
Cronache e attualità
tivi a istanze di questo tipo le compagnie assicuratrici
fossero propense a non presentarsi. È anche vero però
che queste controversie, spesso di modesto valore economico, sono quelle che sembrerebbero prestarsi, più
di altre, a essere definite con soluzioni transattive o
conciliative, per cui la loro esclusione lascia francamente perplessi.
Nuovo e per più versi rafforzato è, invece, il ruolo del
giudice, al quale è stato attribuito il potere di effettuare
nel corso del processo l’esperimento del previo tentativo di mediazione anche nelle cause per le quali esso
non è previsto come obbligatorio, individuando così
nuovi e più generalizzati spazi di composizione delle
controversie. Modificando la locuzione “il giudice può
invitare le parti” in “il giudice può disporre l’esperimento del tentativo di mediazione”, l’invito del giudice diviene oggi un vero e proprio obbligo per le parti,
senza alcuna possibilità per loro di declinare cortesemente l’invito e di proseguire nel giudizio ordinario,
come avveniva in passato. Si introduce così, attraverso
la mediazione delegata, una condizione di procedibilità
sopravvenuta per ordine del giudice che si affianca alle
altre tre forme di mediazione previste dalla legge: il
tentativo volontario, quello obbligatorio in tutte le
materie di cui all’art. 5 comma 1 bis, e quella delle
clausole di mediazione statutarie o contrattuali fondata
sul fair-play negoziale, che contengano un patto stipulato tra le parti per vincolarsi reciprocamente nella scelta di un percorso mediativo per l’eventuale ipotesi di
una controversia.
La scelta del legislatore del 2013 di introdurre una
forma di mediazione endoprocessuale rimessa al potere discrezionale del giudice può diventare così un’ulteriore spinta alla diffusione dell’istituto, facendo assumere al magistrato un ruolo rilevante e strategico nella
gestione delle cause a lui assegnate. Il secondo comma
dell’art. 5 prevede espressamente che “Fermo restando
quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di appello, valutata la natura della causa, lo stato di istruzione
e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del tentativo del procedimento di mediazione”,
aggiungendo che “in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale anche in sede di appello”. La
nuova normativa, insomma, allarga gli orizzonti della
Temi Romana
mediazione, collocando il giudice in una posizione di
sostanziale “facilitatore” di accordi conciliativi, con
chiari intenti deflativi del contenzioso arretrato, considerato che i nuovi meccanismi sono immediatamente
applicabili a tutti i processi civili pendenti.
L’obbligatorietà della mediazione è destinata a correre,
dunque, su due binari: il primo prevede l’obbligatorietà per legge, ristretta solo ad alcune materie e limitata
nel tempo per una fase di sperimentazione; l’altro si
affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per
questo, non è vincolato né nei contenuti né nei tempi
della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del giudice.
Inutile dire che, grazie alle novità introdotte, ci si augura che il ripristino della mediazione/conciliazione non
susciti più le critiche che hanno accompagnato la sua
previsione originaria, sminuendo il senso e la portata
dell’istituto: che sono realisticamente quelli di prestarsi ad allargare la prospettiva del giudice e a preservare
le future relazioni tra le parti, visto che la mediazione
si colloca a metà strada tra i metodi negoziali che non
coinvolgono terzi (come la transazione) e i metodi in
cui il terzo coinvolto ricalca, quanto a qualità soggettiva e a tipo di attività, la figura di un giudice sui generis (come avviene nell’arbitrato).
4. Due parole ancora, prima di concludere, sulla obbligatorietà e sui rischi paventati di una nuova pronuncia
di illegittimità costituzionale da parte del giudice delle
leggi.
Non credo, francamente, che questi rischi ci siano. La
direttiva comunitaria del 21 maggio 2008, relativa alla
mediazione delle controversie transfrontaliere, non
manca di evidenziare l’inesistenza di ostacoli nel diritto comunitario “a una legislazione nazionale che preveda il ricorso alla mediazione obbligatoria oppure
soggetto a incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto
di accesso al sistema giudiziario” (considerando n. 14
e art. 5, comma 2). Ma nello stesso ordine di idee si colloca anche una sentenza della Corte di Giustizia (quella del 18 marzo 2010, in cause riunite C-317/08, C318/08 e C-320/08) dove, sia pure con riferimento ai
servizi di comunicazioni elettroniche, si avverte espressamente che “l’imposizione di una procedura extragiudiziale non deve considerarsi… sproporzionata rispet-
79
Cronache e attualità
ad onta della sua natura obbligatoria, dipenderà essenzialmente dall’atteggiamento delle parti verso l’istituto
e, più ancora dall’atteggiamento degli avvocati. A scanso di apparire un po’ retorico, la strada da intraprendere e da perpetuare non può seguitare ad essere quella di
una preconcetta ostilità verso un istituto che è utilizzato e sta prendendo piede in tutto il mondo (due mesi fa,
ricevendo una delegazione di alti magistrati del
Bangladesh, ho appreso che anche in quella nazione
lontana ci si sta orientando verso la mediazione come
modo di risoluzione alternativo delle controversie civili) ma deve essere quella della reciproca rispettosa considerazione e della valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti in conflitto.
to agli obiettivi perseguiti allorché, da un lato, non esiste un’alternativa meno vincolante alla predisposizione
di una procedura obbligatoria, dato che l’introduzione
di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi, e
dall’altro non sussiste una sproporzione manifesta tra
tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal
carattere obbligatorio della procedura di conciliazione
extragiudiziale”.
Quel che conta, insomma, è che non sia impedito alle
parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema
giudiziario.
Va da sé, comunque, che il successo della mediazione,
80
Temi Romana
Passeggiata in libreria
n° 1-2
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
In libreria
“CODICE DELL’UDIENZA FALLIMENTARE”
Antonio Caiafa DIKE GIURIDICA EDITRICE, ROMA
pp. 660, euro 25,00
Nell’epoca della “nevrosi” del legislatore si pone all’interprete l’esigenza di avere, per
ciascuna materia di riferimento, un quadro legislativo chiaro e puntuale delle norme di
applicazione quotidiana. La collana degli Oscar Dike vuole offrire al giurista una serie ben
ordinata di testi legislativi di facile e maneggevole consultazione, arricchita, per le norme
più importanti, dai testi storici delle disposizioni. Per conseguire l’auspicato fine, gli Oscar
Dike sono curati da Maestri indiscussi del diritto italiano e presentano la comodissima
veste del codice tascabile.
Direttore Responsabile: Mauro VAGLIO
Direttore Scientifico: Alessandro CASSIANI
Capo Redattore: Samantha LUPONIO
Comitato Scientifico:
Paola BALDUCCI, Antonio BRIGUGLIO, Luigi CANCRINI,
Pierpaolo DELL’ANNO, Antonio FIORELLA, Giovanni Maria FLICK
Giorgio LOMBARDI, Carlo MARTUCCELLI, Ugo PETRONIO
Eugenio PICOZZA, Giulio PROSPERETTI, Giorgio SPANGHER
Alfonso STILE, Federico TEDESCHINI, Roberta TISCINI,
Giancarlo UMANI RONCHI, Romano VACCARELLA
Comitato di Redazione:
Mauro VAGLIO, Pietro DI TOSTO, Antonino GALLETTI
Riccardo BOLOGNESI, Fabrizio BRUNI, Antonio CAIAFA
Alessandro CASSIANI, Domenico CONDELLO, Antonio CONTE
Mauro MAZZONI, Aldo MINGHELLI, Roberto NICODEMI
Matteo SANTINI, Mario SCIALLA, Isabella Maria STOPPANI
“PROCESSO AMMINISTRATIVO E TUTELA CAUTELARE”
Maria Vittoria Lumetti CEDAM, ASSAGO
pp. 736, euro 60,00
Si tratta della prima opera, dopo l’entrata in vigore del codice processuale
amministrativo, che affronta in maniera sistematica e globale tutta la problematica del
processo cautelare amministrativo in ogni fase e grado del giudizio, compresi il
processo di ottemperanza, la revocazione, l’accesso, il silenzio, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, il giudizio risarcitorio, la sospensione della sentenza
pendente ricorso in Cassazione e in Adunanza plenaria, la rimessione alla Corte di
giustizia e alla Corte costituzionale. Il libro, alimentato dalla passione che il processo
amministrativo è ancora in grado di suscitare ed arricchito dall’esperienza quotidiana
nelle aule giudiziarie, si propone di offrire una visuale completa della tutela cautelare
nel processo amministrativo, anche in raffronto con altri processi e alla luce delle
innovazioni recate dal codice e dal diritto comunitario.
“ABUSO SESSUALE SUI MINORI.
SCENARI, DINAMICHE, TESTIMONIANZE”
Giuliana Olzai ANTIGONE, TORINO
pp. 375, euro 28,00
Coordinatori:
Antonio ANDREOZZI, Andrea BARONE, Camilla BENEDUCE
Domenico BENINCASA, Marina BINDA, Ersi BOZEKHU
Francesco CASALE, Francesco CIANI, Benedetto CIMINO, Irma CONTI
Antonio CORDASCO, Alessandro CRASTA, Carmelita DE FINIS
Annalisa DI GIOVANNI, Ruggero FRASCAROLI, Maria Vittoria FERRONI
Fabrizio GALLUZZO, Alessandro GENTILONI SILVERI, Mario LANA
Paola LICCI, Andrea LONGO, Giuseppe MARAZZITA, Franco MARCONI
Alessandra MARI, Gabriella MAZZEI, Arturo MEGLIO, Chiara PACIFICI
Ginevra PAOLETTI, Chiara PETRILLO, Tommaso PIETROCARLO
Aurelio RICHICHI, Sabrina RONDINELLI, Serafino RUSCICA
Marco Valerio SANTONOCITO, Massimiliano SILVETTI, Luciano TAMBURRO
Federico TELA, Antonio TESTA, Federica UMANI RONCHI, Clara VENETO
Segretario di redazione: Natale ESPOSITO
L’orrore degli orrori, quello che nessuno ha voglia di scoprire. L’abuso sessuale sui
bambini e le bambine è forse l’ultimo tabù rimasto, quello su cui gravano ancora una
forte condanna da parte dell’opinione pubblica e una pesante sanzione di mass media e
rappresentanti politici. Su questo reato odioso cerca di far luce il volume di Giuliana
Olzai, laureata in Statistica e specializzata in Metodi e tecniche per la ricerca sociale,
che ha analizzato i 288 procedimenti giudiziari del Tribunale penale di Roma nel
quadriennio 2000-2003 riguardanti proprio gli abusi sui minori di 14 anni.
Con un lavoro accurato, l’autrice ha seguito i percorsi processuali delle denunce, ha
ripercorso l’iter giudiziario compiuto dalle vittime che denunciano una violenza,
perpetrata quasi sempre da persone che conoscono bene, con le quali hanno spesso un
legame affettivo. Un’analisi che cerca di aiutare il lettore a comprendere come questo
stretto legame fra vittima e carnefice abbia un effetto diretto sull’invasività e la gravità
degli abusi, sulla ripetizione delle violenze così come sul tempo che trascorre prima
che il bambino o la bambina abbia il coraggio di denunciare.
“MANUALE PRATICO DEI MARCHI E BREVETTI” (CON CD ROM)
Andrea Sirotti Gaudenzi MAGGIOLI EDITORE, SANTARCANGELO DI ROMAGNA
pp. 666, euro 74,00
Progetto grafico: Alessandra GUGLIELMETTI
Disegno di copertina: Rodrigo UGARTE
____________
Temi Romana - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 320 del 17 luglio 2001 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via C. T. Masala, 42 - 00148 Roma
L’opera, aggiornata al D.L. 1/2012 convertito con modifiche in L. 27/2012 che modifica il codice della
proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) e alla recente giurisprudenza, caratterizzata da un’impostazione
sistematica degli argomenti, ripercorre con taglio agile tutti i principali temi legati alla proprietà
industriale, offrendo all’operatore tutti i necessari strumenti pratici. Il testo è suddiviso in sette parti
con i rispettivi capitoli e paragrafi che analizzano in modo completo ed esaustivo le materie di
“marchi, segni distintivi e brevetti per invenzioni e modelli”.
2014
n° 1-2
Temi Romana
n° 1-2
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ANNO LXII
GENNAIO – GIUGNO 2014